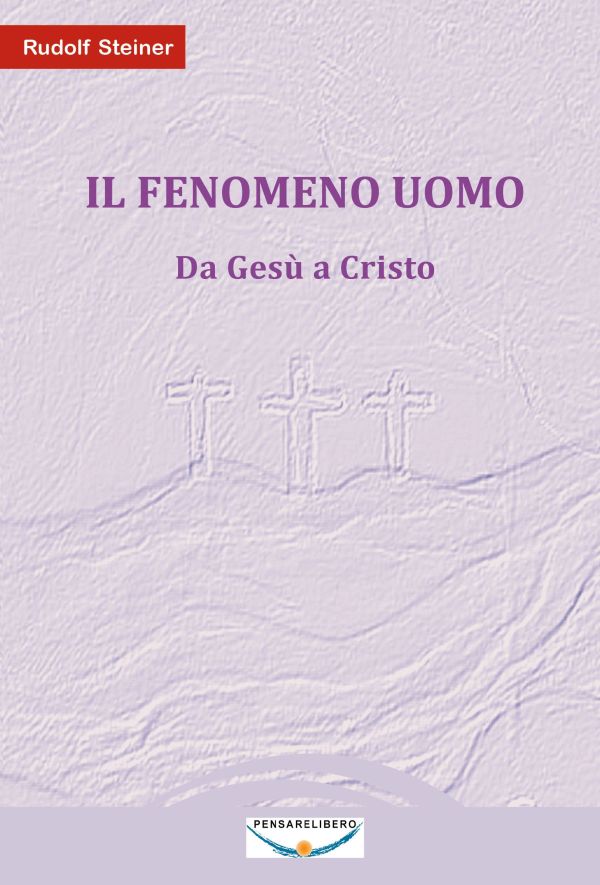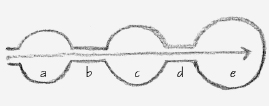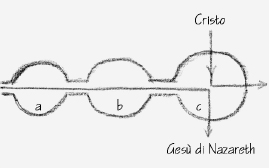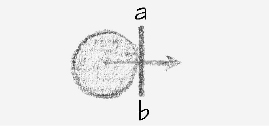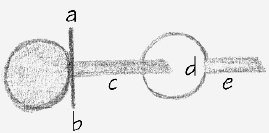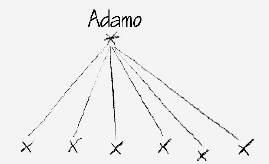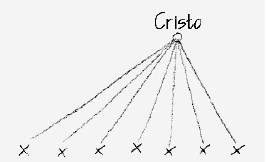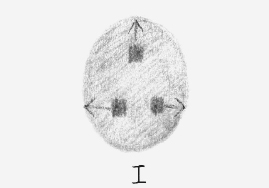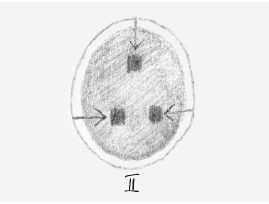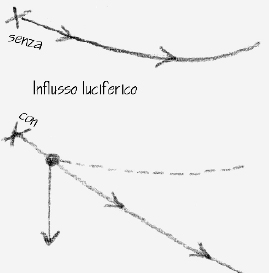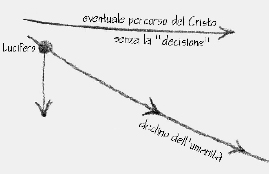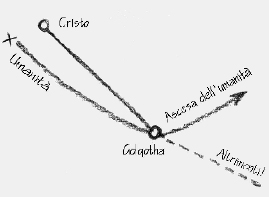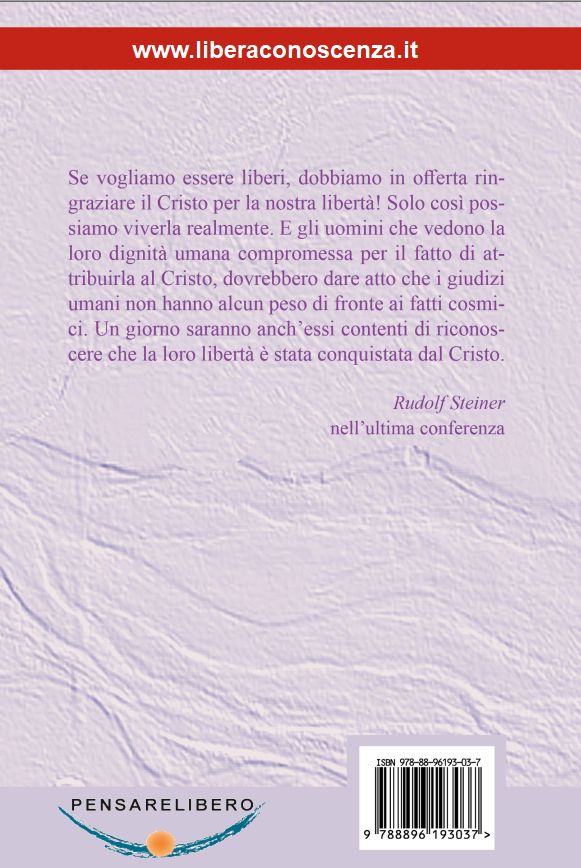Prefazione
Questa serie di conferenze occupa un posto particolare nella produzione intellettuale di Rudolf Steiner, che negli anni precedenti aveva posto le basi per la spiegazione scientifico-spirituale dei misteri delle forze formanti del corpo fisico. Queste conferenze hanno il loro fulcro nella descrizione del “corpo del fantoma” del Cristo risorto.
A ogni “incarnazione”, a ogni costruzione di un corpo fisico, sono all’opera le forze formanti o costitutive a disposizione dell’uomo in quanto architetto del proprio corpo. Tali forze sono tra l’altro forze intellettive: come lo scultore imprime una forma al blocco di marmo in base ai suoi pensieri, alle sue forme pensiero – dove la statua rappresenta la forma e il pensiero divenuti visibili –, così anche l’uomo scolpisce artisticamente il proprio corpo.
Un’umanità più antica, ispirata dalla rivelazione divina, era ancora in grado di parlare del “peccato originale”, con cui intendeva il deperimento delle forze formanti del corpo fisico. Quell’umanità sapeva ancora che per costituire un corpo umano con le innumerevoli cesellature necessarie a renderlo uno strumento adeguato per un uomo in grado di camminare, parlare e pensare, l’uomo aveva bisogno di un’infinità di forze intellettuali e formanti. Ma nel corso dei millenni, con l’aumento del legame col mondo della materia, queste forze si erano sempre più degradate.
Lo spirito cristico è il Logos divino, il Verbo cosmico, l’organismo concettuale del mondo, reale a livello spirituale. In lui trovano la propria unità non solo tutti i pensieri finali dell’evoluzione, ma anche tutti i pensieri vitali e formanti del corpo fisico, che funge da strumento per conseguire gli obiettivi evolutivi. La cosiddetta “risurrezione” del Cristo è il suo grande atto d’amore, il ripristino di tutte le forze formanti che stanno alla base del corpo umano. Il Cristo mette queste forze a disposizione di ogni uomo: Egli stesso è nel suo spirito pensante, in qualità di Logos cosmico, la totalità di queste forze formanti. L’uomo che si unisce a Lui nello spirito e nell’anima può far sì che queste forze formanti diventino la luce del proprio spirito pensante, il calore del proprio ardente amore e la potenza delle proprie azioni che plasmano la vita.
Nel suo sforzo di tener conto della scienza moderna, la teologia dei nostri tempi ha praticamente perso di vista la realtà della risurrezione. Il dogma del materialismo, in base al quale la materia – la costituzione biologica dell’uomo – determina tutto ciò che si presume sia spirituale o animico l’ha intimidita al punto tale che essa non osa neanche più avanzare l’affermazione opposta, vale a dire che lo spirito è sempre e ovunque il creatore di tutto ciò che avviene nel mondo della materia, nei fenomeni percepibili mediante i sensi. In fondo il cristianesimo tradizionale ha adottato qualcosa di assolutamente non cristiano da Aristotele: la convinzione che l’uomo non esista prima del concepimento, che la sua anima faccia la propria comparsa solo nel momento in cui si forma il corpo. Solo un piccolo passo separa questa idea dal materialismo, dalla convinzione che l’anima dipenda in tutto e per tutto dal corpo.
Eppure: laddove è all’opera l’uomo, è sempre uno spirito che stabilisce cosa deve accadere nel suo corpo, e non il contrario. Anche una macchina non è altro che spirito umano cristallizzato, in cui una somma di pensieri diventa non solo visibile ma anche operante. Ma finora nessuna macchina è stata in grado di produrre anche un solo pensiero. Perfino il calcolatore “più intelligente” può restituire solo ciò che vi è stato “immesso” dall’uomo. Magari ha la capacità programmata di mescolare i dati immessi, ma non certo di produrne di propri o di nuovi!
In queste conferenze il pensiero condizionato dal cervello viene definito “incompetente” quando si tratta di decidere su questioni come la “risurrezione”, comprensibile solo a un pensiero indipendente dal cervello. Molti però sono convinti che un simile pensiero non esista, che non ci possa essere, e questo spiega anche come mai negli ultimi tempi sia cresciuta una generazione di uomini che, pur sentendosi legati all’antroposofia di Steiner, ritengono che in essa tutti gli elementi cristologici abbiano unicamente a che fare con la forma esteriore, con la veste terminologica. Credono che Rudolf Steiner si sia servito di questa terminologia solo per farsi capire dal suo pubblico, ma che avrebbe potuto esporre la sua scienza dello spirito anche senza riferimenti al “Cristo”.
La terminologia usata finora per esprimere la realtà del cristianesimo può ovviamente essere sostituita da un’altra. Ma se il linguaggio di altre ideologie o religioni fosse altrettanto adatto per la sua formulazione, il cristianesimo sarebbe una concezione del mondo, una specie di spiritualità, e non un dato di fatto, un evento storico. Tuttavia l’affermazione fondamentale di Steiner riguardo al cristianesimo è appunto che non si tratta di una dottrina, bensì di una realtà, di un fatto.
Lo spirito delle conferenze contenute in questo libro ci permette forse di aggiungere che dal punto di vista teorico della conoscenza è vero che ciò che viene concepito come al di là dello spirito umano non costituisce un’effettiva realtà per l’uomo. Questo non significa però che lo spirito umano non sia suscettibile di evoluzione, che in virtù del pensiero non sia in grado di rendere reali ed efficaci dentro di sé realtà spirituali sempre nuove. E neppure vuol dire che quello umano sia l’unico spirito che esiste. Così nei tempi antichi il concetto di “Cristo” o di “Logos” veniva riferito a uno spirito che nei suoi impulsi vitali e nelle sue forze animiche era infinitamente più esteso di quanto non lo sia quello umano al suo attuale stadio evolutivo. Ed era proprio questo che si intendeva con l’appellativo “spirito divino”: uno spirito infinitamente più evoluto di quello umano, che di conseguenza può essere visto come prospettiva dell’evoluzione dello spirito umano stesso. Così per il singolo uomo anche il Cristo diventa una realtà spirituale nella misura in cui lo trasforma sempre più in una forza di pensiero e di amore del proprio spirito stesso.
Proprio per il loro prendere sul serio l’essenza del cristianesimo al di là di ogni malintesa tolleranza, queste conferenze furono già allora particolarmente osteggiate. In proposito Rudolf Steiner si esprime così in una conferenza del 7 maggio 1923:
A sua volta al corpo fisico dell’uomo venne procurata un’adeguata freschezza, di modo che gli esseri umani possano attraversare l’ulteriore evoluzione della Terra essendo in grado di scendere dai mondi animico-spirituali per abitare in corpi fisici. Questo è stato l’effetto reale del mistero del Golgota. Ho già spesso accennato al fatto che questo effetto va in una simile direzione – tra l’altro anche in un ciclo di conferenze tenute a Karlsruhe dal titolo Da Gesù a Cristo, che sono state attaccate più di tutte le altre proprio perché, a partire da un senso del dovere esoterico, illustravano delle verità che molti non vorrebbero veder svelate. Si può addirittura affermare che l’ostilità nei confronti della scienza dello spirito da parte di certi ambienti abbia avuto inizio proprio da quel ciclo di conferenze.
Con il peccato originale dell’uomo si intende il progressivo indebolimento del suo spirito rispetto alle forze della materia o della natura. Ogni vera redenzione dell’uomo può quindi consistere soltanto nel fatto che il suo spirito diventa sempre più forte e acquisisce una sempre maggiore capacità di intervenire creativamente in tutti i settori della vita. In questo consiste anche l’esperienza della libertà: solo uno spirito forte può essere libero di fronte alle forze della natura e non in loro balìa. La questione della redenzione è quindi nello stesso tempo anche la questione della libertà: come può l’uomo rendere sempre più forte e creatore il proprio spirito? La risposta è semplice: continuando a far evolvere il proprio pensiero, lo spirito diventa sempre più creativo e libero. Questo a sua volta presuppone un esercizio quotidiano.
Nelle sue conferenze su Il cristianesimo come fatto mistico, agli inizi del ventesimo secolo Steiner aveva attribuito un valore particolare al termine “mistico”, nel senso di invisibile, per distinguerlo dal cristianesimo tradizionale, esteriormente visibile come forma culturale. Lo stesso Steiner ha potuto imparare, continuando a evolvere, che all’uomo non possono bastare il misticismo e la spiritualità allo stato puro. Il Logos cosmico si è fatto carne proprio perché l’uomo è spirito incarnato e in lui tutto ciò che è mistico deve diventare una realtà visibile. Così in seguito, durante e dopo la prima guerra mondiale, Steiner non si è mai stancato di sottolineare che la vita culturale moderna è diventata una vuota “retorica” proprio perché ha perduto la forza necessaria per intervenire in modo creativo in tutti gli ambiti della vita. Nell’economia di oggigiorno, tanto per fare un esempio, è risaputo che le necessità oggettive hanno un peso di gran lunga maggiore di quello di tutti gli ideali umani.
Così per Steiner la questione fondamentale di una moderna scienza dello spirito ha riguardato sempre meno la trasmissione di verità teoriche per la sfera mistico-privata della vita, per andare sempre più in direzione della convivenza umana, dell’organizzazione sociale della vita e del mondo. La domanda è quindi: come può la scienza dello spirito contribuire a rendere l’uomo sempre più forte, sempre più capace di plasmare in maniera dignitosa e filantropica ogni campo della vita sociale attraverso la continua evoluzione del suo spirito? Anche la fondazione della Società antroposofica durante il convegno di Natale del 1923/24 era stata fatta con l’intenzione di rendere la scienza dello spirito accessibile a tutti quelli in cerca di nutrimento spirituale, rendendosi conto che esistono anche persone che si sentono chiamate ad agire nella vita pubblica e professionale come “rappresentanti” della corrente culturale scientifico-spirituale.
È quindi possibile definire la “triarticolazione sociale” di Rudolf Steiner come la sua cristologia applicata, divenuta vita. Allora le forze del fantoma, le forze plasmanti dello spirito umano diventano sempre più caratterizzanti ed efficaci in tutti i settori della vita. Allora il “corpo spirituale” dell’umanità viene edificato come organismo unitario nell’equilibrio armonico fra libertà individuale e solidarietà collettiva. Gli ideali di libertà e amore smettono di essere coltivati in privato come piante da serra, non vengono più goduti solo in situazioni avulse dalla vita come consolazione o svago, ma diventano linfa vitale di ogni questione interpersonale, in grado di intervenire con determinazione negli avvenimenti del mondo.
Pietro Archiati
(nell’estate 2006)
Prima conferenza
L’uomo è libero nel pensiero
Non nella volontà
Karlsruhe, 5 ottobre 1911
Queste conferenze sono destinate a fornirci un’idea dell’evento cristico nella misura in cui esso è legato a un fenomeno storico, alla manifestazione del Cristo nella persona di Gesù di Nazareth.
Talmente tante altre questioni della vita spirituale sono connesse a questa, che proprio grazie alla scelta di un simile tema potremo procurarci una visuale molto ampia nell’ambito della scienza dello spirito e della sua missione. Tale tema ci aiuterà appunto a spiegare qual è il significato del movimento scientifico-spirituale per la vita culturale odierna.
D’altra parte avremo anche occasione di conoscere il contenuto della religione e il modo in cui esso dev’essere destinato alla collettività umana, di conoscerlo nel rapporto con quanto ci dicono le fonti più profonde della vita spirituale, le fonti nascoste della scienza dello spirito, su quello che dev’essere alla base di ogni religione e di ogni aspirazione a una concezione del mondo.
Alcune delle cose di cui dobbiamo parlare sembrano discostarsi parecchio dal tema, ma tutto ci ricondurrà al nostro compito principale.
Ciò a cui è stato appena accennato può anche essere esposto fin dall’inizio in modo più preciso se, per la comprensione della nostra vita religiosa attuale da un lato e per l’approfondimento scientifico-spirituale di tutta la vita animica dall’altro, gettiamo uno sguardo sull’origine sia della vita religiosa che di quella spirituale esoterica negli ultimi secoli.
È infatti proprio negli ultimi secoli dell’evoluzione spirituale europea che abbiamo due direzioni che hanno formato in maniera estrema
• da un lato l’esagerazione del principio di Gesù e
• dall’altro non l’esagerazione, ma la più accurata e coscienziosa conservazione del principio del Cristo.
Nel momento in cui poniamo davanti alle nostre anime queste due correnti, nell’esagerazione del principio di Gesù troviamo un grande errore, un traviamento pericoloso nella vita spirituale degli ultimi secoli; mentre dall’altra parte abbiamo un movimento profondamente significativo, che cerca ovunque la retta via ed evita accuratamente la via sbagliata.
Quindi, già in riferimento a questa valutazione di due movimenti completamente diversi fra loro, dobbiamo annoverarne l’uno fra i più gravi errori e l’altro fra le aspirazioni più serie alla verità.
Il movimento che ci deve interessare anche in rapporto a un’osservazione scientifico-spirituale cristiana, e a cui in un certo senso ci possiamo riferire come a un errore straordinariamente pericoloso, è quello che nella normale vita esteriore viene chiamato “gesuitismo”.
Nel gesuitismo abbiamo una pericolosa esagerazione del principio di Gesù. E in quello che esiste da secoli in Europa come rosicrucianesimo abbiamo invece un movimento cristiano che cerca ovunque accuratamente le vie della verità.
Nella vita comune, fin da quando esiste in Europa una corrente gesuitica, si è sempre parlato del gesuitismo. E già solo per questo a chi voglia studiare la vita spirituale partendo dalle sue origini più profonde deve interessare sapere in che misura il gesuitismo equivale a una pericolosa esagerazione del principio di Gesù.
Tuttavia, se vogliamo occuparci di una vera caratteristica del gesuitismo, dobbiamo da un lato apprendere come i tre principi fondamentali di tutta l’evoluzione cosmica, a cui si accenna nei modi più diversi nelle varie concezioni del mondo, si esplichino a livello pratico anche nella nostra vita esteriore.
Oggi vogliamo prescindere del tutto dal significato e dalla descrizione più profondi delle tre correnti fondamentali della vita e dell’evoluzione, per esaminarle invece così come appaiono allo sguardo esteriore.
In primo luogo abbiamo quella che possiamo chiamare la nostra vita animica nella misura in cui è una vita conoscitiva.
Qualunque cosa si dica contro il carattere astratto di una conoscenza unilaterale, di un anelito unilaterale alla verità, per quanto si possa criticare la mancanza di contatto con la realtà in certi ideali scientifici, filosofici o scientifico-spirituali, colui che sa chiaramente che cosa vuole e che cosa può volere sa che il termine “conoscenza” abbraccia ciò che appartiene alle aspirazioni più profonde e radicate della nostra vita dell’anima.
Infatti, sia che la cerchiamo attraverso il pensiero o mediante la sensazione, il sentimento, la conoscenza significa sempre un orientamento su tutto ciò che ci circonda nel mondo e anche su noi stessi.
Così che, sia che ci vogliamo accontentare delle esperienze più semplici dell’anima, sia che vogliamo farci coinvolgere nelle spiegazioni più complicate sui segreti dell’esistenza, ci dobbiamo dire: per noi la conoscenza rappresenta una questione vitale di primaria importanza. È per mezzo della conoscenza che ci creiamo l’immagine del contenuto del mondo in cui dopotutto viviamo e che costituisce il nutrimento di tutta la nostra anima.
Dobbiamo includere nell’ambito della conoscenza già la primissima impressione sensibile e tutta la vita sensibile, come pure le massime astrazioni dei concetti e delle idee. Ma nella conoscenza va annoverato pure ciò che nell’anima ci sprona a distinguere fra il bello e il brutto. Poiché, anche se in un certo senso è vero che i gusti non si discutono, il fatto di essersi procurati un giudizio relativo al gusto e di essere in condizione di distinguere fra bello e brutto è comunque una conoscenza.
E anche i nostri impulsi morali, ciò che ci spinge a fare il bene e a evitare il male, vanno sentiti come idee morali, come stimoli conoscitivi o emotivi. Sì, anche quella che chiamiamo la nostra “coscienza”, per quanto possa generare impulsi ancora indeterminati, fa parte di ciò che è compreso nel termine “conoscenza”.
Ma ogni uomo dovrà anche ammettere che per così dire sotto la superficie di questa vita spirituale che abbracciamo con la conoscenza c’è ancora qualcos’altro, che già per la vita quotidiana la nostra vita animica ci mostra varie cose che non appartengono alla nostra vita cosciente.
In un primo tempo possiamo far riferimento al modo in cui generiamo costantemente la nostra vita animica mattutina, quando ci ridestiamo dal sonno rinvigoriti e ristorati, e a come dobbiamo dirci che nello stato di sonno abbiamo procurato alla nostra anima qualcosa che non rientra nel campo della nostra conoscenza, della nostra vita cosciente, e in cui la nostra anima lavora piuttosto al di sotto del livello cosciente.
Ma anche per quanto riguarda la vita quotidiana in stato di veglia dobbiamo ammettere di essere mossi da impulsi, istinti e forze che, pur propagandosi nel campo della coscienza, lavorano e funzionano a un livello subcosciente. Ci rendiamo conto che lavorano al di sotto della coscienza quando affiorano alla superficie che separa la nostra vita cosciente da quella subcosciente.
E in fondo anche la vita morale ci mostra l’esistenza di una simile vita animica subconscia.
Nella vita morale vediamo infatti nascere in noi questi o quegli ideali. E basta anche poca conoscenza di sé per potersi dire che, nonostante tali ideali sorgano nella nostra vita animica, non sempre sappiamo quale rapporto abbiano con le più profonde domande dell’esistenza, in che modo i nostri grandi ideali morali siano presenti nella volontà di Dio, nella quale devono in definitiva avere le loro radici.
È come se la nostra vita animica subcosciente potesse essere paragonata a ciò che avviene nelle profondità di un mare. Queste profondità del mare della vita animica lanciano le loro ondate verso la superficie e ciò che viene scagliato nello “spazio aereo”, e che potremmo paragonare alla normale vita animica cosciente, viene portato a coscienza, a conoscenza. Ma tutta la vita cosciente ha le proprie radici in una vita animica subconscia.
In fin dei conti tutta l’evoluzione dell’umanità può essere capita solo se si presuppone l’esistenza di una tale vita animica subconscia. Che cosa significano tutti i progressi della vita culturale se non che dalla vita animica subcosciente è stato portato a galla ciò che da tempo viveva sotto la superficie e che ha preso forma solo nel momento in cui è affiorato? È quello che avviene per esempio quando un’idea inventiva prende la forma dell’impulso alla scoperta.
Occorre allora riconoscere come secondo elemento della nostra vita animica la vita animica subcosciente, che esiste in noi esattamente come quella cosciente.
Se paragoniamo questa vita animica subconscia con ciò che in un primo tempo è sconosciuto – ma non inconoscibile – dobbiamo porle davanti un terzo elemento.
Questo terzo elemento risulta senz’altro anche a un’osservazione generale nel momento in cui ci si dice: dirigendo lo sguardo verso l’esterno in base ai sensi o alla ragione o anche in base alla vita spirituale, si conoscono diverse cose. Ma riflettendo più scrupolosamente su tutta la conoscenza, bisogna tuttavia ammettere che dietro ciò che sappiamo del mondo intero si cela qualcos’altro che non è inconoscibile, ma che in ogni epoca va definito come qualcosa di ancora ignoto.
Ciò che ancora non si conosce si trova sotto la superficie di ciò che è noto: nel regno minerale, in quello vegetale e in quello animale, e appartiene sia alla natura esteriore che a noi stessi. Fa parte di noi nella misura in cui assorbiamo ed elaboriamo nella nostra organizzazione fisica le sostanze e le forze del mondo esteriore. E nella misura in cui abbiamo dentro di noi una porzione di natura, abbiamo anche una parte ignota della natura.
Nel mondo in cui viviamo dobbiamo quindi distinguere tre elementi:
• la nostra vita spirituale cosciente, vale a dire ciò che rientra nella coscienza, poi
• ciò che si trova al di sotto della soglia della coscienza come nostra vita animica subconscia, e infine
• ciò che vive in noi come vita sconosciuta della natura e nel contempo come vita umana ignota, come parte della grande natura sconosciuta.
Questa triplicità risulta direttamente da un’osservazione sensata del mondo, a prescindere da tutte le designazioni dogmatiche, da tutte le tradizioni filosofiche o scientifico-spirituali, nella misura in cui queste si rivestono di definizioni concettuali o si esprimono in schemi.
Se ci si chiede in che modo lo spirito umano abbia sempre espresso il fatto che i tre elementi appena descritti non esistono solo nel suo ambiente ma anche nel mondo intero a cui esso appartiene, ci si deve rispondere: l’uomo l’ha espresso
• dando il nome di “Spirito” a ciò che si fa conoscere sull’orizzonte della conoscenza;
• definendo “Figlio” o “Logos” quello che agisce nella vita animica subcosciente e da questa lancia in alto solo le sue onde; e
• chiamando “principio del Padre” quello che fa parte della natura a noi ignota e di quella parte del nostro essere affine alla natura. Lo spirito umano l’ha sempre definito così poiché sentiva che questo era il terzo elemento che integrava gli altri due.
Oltre a quello che abbiamo presentato come il principio dello Spirito, del Figlio e del Padre, valgono naturalmente e hanno la loro giustificazione anche le altre distinzioni che sono sempre state fatte nelle varie concezioni del mondo. Si potrebbe tuttavia dire che i concetti o le distinzioni più popolari risultano nel momento in cui ci poniamo di fronte a quanto è appena stato descritto.
Ora chiediamoci: qual è il modo migliore in cui possiamo illustrare il passaggio dalla vita animica subconscia, che rientra nel principio del Figlio, a ciò che appartiene allo Spirito, e quindi si svolge direttamente nella vita animica cosciente?
Il modo migliore per cogliere questo passaggio consiste nel renderci conto che proprio nella vita spirituale ordinaria dell’uomo – nella coscienza – giocano chiaramente dal subconscio quegli elementi che, rispetto agli elementi dell’intelletto e del sentimento, dobbiamo chiamare elementi della volontà.
A tal scopo è sufficiente interpretare in maniera corretta la frase biblica: «Lo spirito è pronto» – ove si accenna al fatto che tutto quel che viene compreso con la coscienza appartiene all’ambito dello spirito – «ma la carne è debole», con cui si intende tutto ciò che si trova perlopiù nel subconscio.
Per quanto concerne la natura della volontà, basta che l’uomo rifletta su ciò che sorge dal subconscio per poi ricadere nella nostra vita cosciente quando, dopo che le “onde” sono affiorate dal mare più profondo della vita animica, ce ne formiamo dei concetti coscienti. Solo nel momento in cui trasformiamo in concetti e in idee ciò che è radicato come forze animiche trainanti negli elementi oscuri della vita animica, esso diventa il contenuto dello Spirito. Altrimenti rimane un contenuto nel campo del Figlio.
E mentre la volontà sale nella vita dell’intelletto per mezzo del sentimento, vediamo chiaramente di fronte a noi le onde che dal mare del subconscio si infrangono nella coscienza.
Possiamo quindi dirci che nella triade della vita animica, abbiamo negli elementi “intelletto” e “sentimento” qualcosa che appartiene alla vita animica cosciente, ma il sentimento scende già nel campo della volontà. E più ci avviciniamo agli impulsi volitivi, alla vita volitiva, più ci immergiamo nel subconscio, in quelle zone oscure nelle quali ci caliamo completamente quando la coscienza si spegne del tutto nella vita del sonno profondo senza sogni.
Il genio della lingua è molto più avanti dello spirito umano cosciente e per questo spesso dà il nome giusto a delle cose che probabilmente verrebbero definite in modo sbagliato se l’uomo avesse pieno potere sul linguaggio per mezzo della coscienza. Ecco allora che per esempio certi sentimenti vengono espressi nel linguaggio in modo tale che già la parola comunichi l’affinità fra sentimento e volontà. E così nella nostra lingua usiamo la parola “volontà” anche quando non intendiamo esprimere un impulso volitivo ma solo un contenuto sentimentale. Il genio della lingua usa questo termine per certi sentimenti profondi di cui non ci si rende ben conto.
È quello che si verifica per esempio quando parliamo di “controvoglia”. In questo caso non occorre affatto avere lo stimolo di fare l’una o l’altra cosa, non è necessario effettuare il passaggio alla volontà, ma nella vita animica subcosciente si esprime l’affinità esistente fra sentimenti profondi di cui non ci si rende più conto e l’area della volontà.
Per il fatto che l’elemento volitivo discende nel campo della vita animica subcosciente dobbiamo ammettere che quest’ambito volitivo è in un rapporto con l’uomo, con la sua essenza individuale e personale, del tutto diverso da quello in cui si trova nel campo della conoscenza, nel campo dello spirito.
E quando nella nostra distinzione usiamo le parole “Spirito” e “Figlio” possiamo dire che è possibile destare in noi l’idea che l’uomo debba rapportarsi allo Spirito e al Figlio in due modi diversi. Come va intesa questa affermazione?
È facile capirla anche già nella vita comune. Certo, sul campo della conoscenza si discute nei modi più diversi, ma bisogna dire che, se solo gli uomini si intendessero sui concetti e le idee da loro formulati a proposito dell’ambito della conoscenza, la controversia legata alle questioni conoscitive andrebbe via via svanendo.
Ho già sottolineato diverse volte che abbiamo smesso di litigare sulle questioni della matematica per il fatto che le abbiamo portate al livello della coscienza, mentre continuiamo a discutere sulle cose che non abbiamo ancora portato al livello della coscienza e in cui lasciamo agire i nostri impulsi, istinti e passioni subconsci.
E con questo si è già accennato al fatto che il campo della conoscenza è qualcosa di più universalmente umano rispetto al subconscio.
Quando ci troviamo di fronte a un altro uomo, qualunque sia il rapporto che abbiamo con lui, dobbiamo dirci: il campo della vita spirituale cosciente è qualcosa su cui dev’essere possibile un’intesa fra individuo e individuo.
E una vita animica sana si esprime nel desiderio, nella speranza di potersi intendere con l’altro sulle questioni della vita spirituale, della vita animica cosciente. Saremmo in presenza di una vita animica malata nel caso in cui svanisse la speranza di andare d’accordo con l’altro sulle cose della conoscenza, della vita spirituale cosciente.
Invece l’elemento volitivo e tutto ciò che c’è nel subconscio, quando ci muove incontro nell’altra persona, si presenta come qualcosa su cui in definitiva non possiamo intervenire, ma che dobbiamo considerare come il più intimo santuario dell’altro.
Prendiamo solo in considerazione quanto è sgradevole per una vita interiore sana la sensazione che la volontà di un’altra persona venga soppressa. Ci si renda conto che la disattivazione in un’altra persona della vita cosciente per mezzo dell’ipnosi o di un altro metodo violento suscita un’impressione spiacevole a livello non solo estetico ma anche morale, che si prova una simile impressione quando si vede la volontà di una persona agire direttamente su quella di un’altra.
L’unico atteggiamento sano consiste nell’esercitare ogni influsso sulla volontà altrui solo attraverso la conoscenza.
È tramite la conoscenza che le anime devono intendersi fra loro. Ciò che uno vuole deve prima trasferirsi nella coscienza per agire nella conoscenza dell’altro, e toccare la volontà dell’altro solo passando per la conoscenza. Solo questo può apparire soddisfacente nel senso ideale più elevato in una vita animica sana. E ogni tipo di influenza coatta esercitata da una volontà su un’altra deve suscitare un’impressione sgradevole.
In altre parole: nella misura in cui è sana, la natura umana tende a sviluppare la vita comunitaria nel campo dello spirito, e ad apprezzare e rispettare come un santuario inviolabile il campo del subconscio che si esprime nell’organizzazione umana, destinato a riposare nella personalità, nell’individualità del singolo e a cui ci si può accostare solo attraverso la porta della conoscenza cosciente. Questo perlomeno è quanto dovrebbe sentire una coscienza moderna dei nostri tempi se sa di essere sana.
Nelle conferenze successive vedremo se le cose sono state così anche per tutte le epoche dell’evoluzione umana. Ma ciò che è appena stato detto può farci riflettere direttamente e con chiarezza su quello che, perlomeno per la nostra epoca, è dentro di noi e al di fuori di noi.
Questo è in relazione con il fatto che in fondo il campo del Figlio – tutto ciò che indichiamo come Figlio o come Logos – dev’essere vissuto in ognuno di noi come questione individuale, del tutto personale, e che il campo dello Spirito è invece il terreno comune su cui si può lavorare da uomo a uomo.
Ciò che è appena stato detto viene espresso nel modo più significativo e grandioso in tutti i racconti che il Nuovo Testamento ci offre sulla figura del Cristo Gesù e sui suoi primi discepoli e seguaci.
Vediamo – e lo possiamo ricavare da tutto ciò che abbiamo potuto dire a proposito dell’evento cristico – come in sostanza i seguaci che erano andati incontro al Cristo Gesù quand’era in vita abbiano perso la testa quando è finito sulla croce, quando ha finito per morire di una morte che nella terra in cui aveva avuto luogo l’evento cristico veniva considerata l’unica espiazione possibile per i crimini più gravi commessi da uomo.
E anche se quella morte in croce non ha avuto su tutti il medesimo effetto che ha avuto su Saulo, poi diventato Paolo – che quando era ancora Saulo ne aveva tratto la conseguenza: «Chi muore di una simile morte non può essere il Messia o il Cristo!» –, se sugli altri discepoli ha prodotto un’impressione per così dire più blanda, è comunque evidente che gli scrittori dei vangeli volevano dar l’impressione che il Cristo Gesù avesse perso tutta l’influenza che esercitava sui cuori delle persone della sua cerchia per il fatto di soccombere all’infamia della morte sulla croce.
Ma vediamo che a questo messaggio è collegato qualcos’altro, e cioè che l’influenza acquisita dal Cristo Gesù, e che dovremo descrivere in modo ancor più preciso in queste conferenze, è ritornata dopo la “risurrezione”.
Oggi possiamo pensare quel che vogliamo della risurrezione, ne parleremo nei prossimi giorni nel senso della scienza dello spirito e allora, se solo lasceremo agire su di noi le narrazioni dei vangeli, ci renderemo conto di una cosa: che per quelli di cui si racconta che il Cristo sia apparso loro dopo la risurrezione, Egli è diventato in un modo del tutto speciale e diverso ancor più presente di quanto non lo fosse stato prima.
Già nella discussione sul Vangelo di Giovanni ho lasciato intendere che è impossibile che una conoscente di Gesù di Nazareth non l’abbia riconosciuto tre giorni dopo e abbia potuto scambiarlo per qualcun altro, a meno che Egli non le sia apparso in un aspetto trasformato. I vangeli vogliono assolutamente suscitare l’impressione che il Cristo sia apparso in un’altra forma.
Ma oltre a questo vogliono anche dire che nell’interiorità dell’anima umana doveva esserci una certa ricettività affinché il Cristo trasformato potesse agire su di essa. E su quella ricettività non bastava l’azione di ciò che appartiene al campo dello spirito, ma ci voleva anche l’effetto prodotto dalla visione diretta dell’esistenza dell’Entità cristica.
Se ci chiediamo che cosa c’è in questione qui, dobbiamo risponderci: quando abbiamo di fronte a noi un uomo, ciò che agisce su di noi è molto più di quanto accogliamo nella nostra coscienza. Nell’istante in cui un uomo o un altro essere agisce su di noi, la nostra vita interiore subisce l’effetto di elementi subconsci prodotti dall’altro essere senza che passino per la coscienza, e che possono essere creati solo perché l’altro ci appare come entità nella propria realtà.
Ciò che il Cristo ha prodotto da essere a essere subito dopo la cosiddetta risurrezione era qualcosa che agiva nella vita animica cosciente dei discepoli a partire dalle loro forze animiche inconscie, dalla loro conoscenza del Figlio.
Da qui le differenze nelle descrizioni del Cristo risorto, da qui la diversità delle caratteristiche dei modi in cui il Cristo ha agito sull’uno o sull’altro, o è apparso a questo o a quello a seconda della loro natura. Si tratta di effetti prodotti dall’Entità cristica sul subconscio delle anime dei suoi discepoli. Sono qualcosa di assolutamente individuale e non dobbiamo essere urtati dal fatto che tali apparizioni non vengano descritte in maniera uniforme ma eterogenea.
Ma allorché quello che il Cristo doveva diventare per il mondo ha dovuto portare a tutti gli uomini qualcosa che li accomunasse, è stato necessario che dal Cristo non provenisse solo quest’azione individuale, l’effetto del Figlio, ma che venisse da Lui rinnovato anche l’elemento dello Spirito, che può creare comunione nella vita umana. Questo viene caratterizzato dal fatto che, dopo aver agito sulla natura del Logos degli uomini, il Cristo manda lo Spirito sotto forma di Spirito rinnovato ovvero “Santo”.
In tal modo viene creato l’elemento comune, contraddistinto dalla seguente affermazione: dopo aver ricevuto lo Spirito, i discepoli cominciarono a parlare nelle lingue più diverse. Così si fa riferimento all’elemento comune a tutti presente nella discesa dello Spirito Santo.
E c’è anche un altro elemento con cui si indica la differenza fra questa venuta e la semplice trasmissione della forza del Figlio. Negli Atti degli Apostoli si racconta infatti come determinate persone da cui si sono recati gli apostoli, pur avendo già ricevuto il battesimo «In nome del Signore Gesù» – accennato nel testo a livello simbolico con l’imposizione delle mani –, abbiano dovuto ricevere in aggiunta lo “Spirito”.
Per questo dobbiamo dirci che proprio nella descrizione dell’evento cristico ci viene fatta notare in modo incisivo la differenza fra quell’effetto che dev’essere definito il vero effetto cristico – che agisce sugli elementi animici subcoscienti e deve quindi avere un carattere personale e intimo – e l’elemento spirituale che rappresenta qualcosa di comune.
Questo aspetto dell’evoluzione cristiana l’hanno voluto rispettare con il massimo scrupolo possibile, nei limiti della debolezza umana, coloro che si sono dati il nome di rosicruciani. Hanno voluto far sì che dappertutto, perfino nelle sfere più alte dell’iniziazione, si agisse esclusivamente su ciò che è a disposizione di tutti nell’evoluzione umana, vale a dire sullo spirito.
L’iniziazione dei Rosacroce era un’iniziazione spirituale. Non è mai diventata un’iniziazione della volontà, poiché la volontà dell’uomo veniva rispettata come qualcosa di sacro nell’interiorità dell’anima.
Per questo l’uomo veniva elevato a quell’iniziazione che lo doveva condurre attraverso gli stadi dell’immaginazione, dell’ispirazione e dell’intuizione, fino al punto da riconoscere dentro di sé che cosa doveva essere prodotto dall’evoluzione dell’elemento spirituale. Non si doveva agire sull’elemento volitivo.
Ma non confondiamolo con l’indifferenza nei confronti della volontà! Escludendo l’azione diretta sulla volontà, si esercitava in maniera indiretta la più pura azione spirituale passando per lo spirito. Quando ci intendiamo con l’altro su come addentrarci sul sentiero della conoscenza dello spirito, dal sentiero spirituale promanano la luce e il calore che possono ravvivare anche la volontà – ma sempre mediante lo spirito, mai in un altro modo.
Per questo nel rosicrucianesimo vediamo rispettati nel senso più alto quegli elementi dell’essenza cristiana che vengono espressi in maniera duplice:
• da un lato nell’elemento del Figlio, nell’azione del Cristo che penetra profondamente nel subconscio umano,
• e dall’altro nell’azione dello Spirito che si estende su tutto ciò che deve rientrare nell’orizzonte della nostra coscienza.
Dobbiamo certamente far entrare il Cristo nella nostra volontà, ma per i rosacroce il modo in cui gli uomini devono intendersi fra loro sul Cristo nella vita può consistere solo nella capacità dell’anima di penetrare conoscitivamente sempre più nell’invisibile.
Quelli normalmente noti con il nome di “gesuiti” presero la via opposta, in reazione a certe altre correnti spirituali presenti in Europa.
La differenza fondamentale, radicale, fra la via spirituale giustamente definita “cristiana” e quella “gesuitica” che sottolinea il principio di Gesù è questa: la via gesuitica mira ad agire ovunque direttamente sulla volontà, vuole effettuare un intervento diretto sulla volontà.
Ne abbiamo un esempio eloquente già nel modo in cui viene formato l’allievo del gesuitismo. Il gesuitismo non va preso alla leggera – non solo in generale, ma anche a livello esoterico –, poiché ha le sue radici nell’esoterismo. Non è però radicato nella vita spirituale riversatasi tramite il simbolo della Pentecoste, ma vuole radicarsi direttamente nell’elemento Gesù del Figlio, vale a dire nella volontà. E per questo ingigantisce l’elemento Gesù della volontà.
Questo ci appare nel momento in cui ci occupiamo di quella che dev’essere chiamata la componente esoterica del gesuitismo: gli “esercizi spirituali”. Come sono strutturati?
L’importante è che ogni allievo del gesuitismo esegua degli esercizi che conducono nella vita dello spirito, ma nella volontà, e che in ambito esoterico giungano alla volontà attraverso una rigorosa disciplina, si potrebbe dire mediante un addestramento. Ciò che conta è che questa disciplina della volontà non scaturisca solo dalla superficie della vita, ma da stadi più profondi, poiché l’allievo viene condotto spiritualmente, ma nella direzione a cui abbiamo accennato.
Se prescindiamo dagli esercizi di preghiera propedeutici a quelli esoterici del gesuitismo, e prendiamo in esame questi esercizi spirituali nella loro caratteristica principale, dobbiamo dire che l’allievo deve innanzitutto evocare un’immaginazione vivente del Cristo Gesù come re del mondo – si noti bene: un’immaginazione. E chi non aveva fatto questi esercizi e non aveva sperimentato nella propria anima la trasformazione che tali esercizi animici significano per l’uomo nel suo complesso, non veniva ammesso agli effettivi gradi del gesuitismo. Ma queste rappresentazioni immaginative del Cristo Gesù come re del mondo dovevano essere precedute da qualcos’altro.
Lì l’uomo deve immaginarsi – in profonda solitudine e in isolamento – l’immagine di un uomo che viene creato nel mondo e soccombe al peccato e quindi anche alla possibilità delle pene più terribili. E viene prescritto rigidamente come dev’essere l’immagine di un uomo che, se lasciato a se stesso, soggiace ai tormenti di tutte le punizioni possibili.
Le prescrizioni sono estremamente rigide e, senza che altri concetti e idee entrino nell’anima, il futuro gesuita deve vivere dentro di sé l’immagine dell’uomo abbandonato da Dio, esposto ai castighi più terribili, e il sentimento che gli fa dire: «Quello sono io quando sono venuto al mondo e ho abbandonato Dio, esponendomi alla possibilità delle pene più tremende!» Questo deve provocare il timore dell’abbandono da parte di Dio e l’avversione per l’uomo così com’è di natura.
Allora, in un’ulteriore immaginazione, all’immagine dell’uomo abietto abbandonato da Dio deve aggiungersi quella del Dio misericordioso che poi diventa il Cristo e con le sue azioni sulla Terra espia ciò che l’uomo ha perpetrato allontanandosi dal sentiero divino.
All’immaginazione dell’uomo abbandonato da Dio devono farsi incontro tutta la misericordia e l’amore dell’essere cristico, a cui solo va attribuito il fatto che l’uomo non sia esposto a tutti i castighi che agiscono sull’anima. E con la stessa vitalità con la quale prima nell’anima del novizio gesuita si è dovuto radicare l’aborrimento per l’abbandono del sentiero divino, ora in lui deve trovar posto il sentimento dell’umiltà e della contrizione nei confronti del Cristo.
Una volta provocate nell’allievo queste due qualità del sentimento, l’anima deve trascorrere diverse settimane nella pratica di rigorosi esercizi, nei quali si raffigurano nell’immaginazione tutte le immagini della vita di Gesù – dalla nascita alla morte in croce e alla risurrezione. E poi nell’anima nasce tutto ciò che deve sorgere quando l’allievo, con la sola eccezione del tempo necessario a nutrirsi, vive in assoluto isolamento, non lasciando agire sull’anima nient’altro che le immagini della vita misericordiosa di Gesù descritte dal Vangelo. Questo non viene immaginato solo in pensieri e concetti, ma deve agire sull’anima mediante rappresentazioni vivide e sostanziose.
Solo chi sa come l’anima viene trasformata dalle immaginazioni che agiscono in maniera del tutto vitale sa anche che in simili condizioni si può trasformare l’anima in qualcosa di completamente diverso. E tali immaginazioni, proprio perché si estendono in assoluta unilateralità dapprima sull’uomo peccatore, poi solo sul Dio misericordioso e infine soltanto sulle immagini del Nuovo Testamento, rafforzano la volontà grazie alla legge della polarità. Queste immagini producono quindi un effetto diretto, poiché ogni riflessione su di esse va doverosamente evitata. Rimane allora soltanto una rappresentazione delle immaginazioni che ho appena descritto.
Ne consegue che negli ulteriori esercizi il Cristo Gesù – e adesso si può parlare esclusivamente di Gesù e non più del Cristo – viene immaginato come il re universale del mondo, nell’esaltazione dell’elemento Gesù.
“Gesù” è solo un elemento di questo mondo, poiché per il fatto che il Cristo si è dovuto incarnare in un corpo umano, il puro spirito ha preso parte al mondo fisico, ma di fronte a questo coinvolgimento nel mondo fisico troviamo le parole monumentali e significative: «Il mio regno non è di questo mondo».
Si può sottolineare l’elemento Gesù facendo di Gesù un re di questo mondo, rendendolo quello che sarebbe diventato se non avesse resistito al tentatore che gli voleva dare «Tutti i regni del mondo e la loro magnificenza».
Gesù di Nazareth sarebbe dovuto diventare un re che, a differenza degli altri sovrani che possiedono solo un pezzo della Terra, avrebbe avuto il pianeta intero come regno. Si immagini dunque questo re rappresentato in questo modo, con il suo potere regale ingrandito al punto che tutta la Terra faccia parte del suo regno. Allora lo si rappresenta in quell’immagine che deve derivare dagli altri esercizi che hanno già irrobustito a sufficienza la volontà dell’allievo dei gesuiti.
E per preparare quest’immagine del “re Gesù”, di questo dominatore di tutti i regni della Terra, occorre raffigurarsi in un’immaginazione “Babilonia” e la pianura circostante come immagine vivente, e Lucifero con la sua bandiera che troneggia su Babilonia.
Questa immagine va rappresentata con grande precisione, poiché è una rappresentazione quanto mai efficace: il re Lucifero con la sua bandiera e le sue schiere di angeli luciferici, seduto tra fuoco e fumo, che invia i suoi angeli alla conquista dei regni della Terra. E in un primo tempo tutto il pericolo che emana dalla bandiera di Lucifero dev’essere immaginato da solo, senza gettare neppure uno sguardo su Gesù. L’anima dev’essere completamente assorbita dall’immaginazione del pericolo che promana dalla bandiera di Lucifero, deve imparare a percepire come il più grande pericolo per l’esistenza terrena quello che verrebbe provocato dalla vittoria della bandiera di Lucifero.
E dopo che quest’immagine ha fatto il suo effetto, il suo posto dev’essere preso dall’altra, quella della “bandiera di Gesù”. A tale scopo l’allievo deve raffigurarsi Gerusalemme e la pianura che la circonda, il re Gesù con intorno le sue schiere e l’immagine di come le invii, di come sconfigga e sbaragli le schiere di Lucifero, diventando il re di tutta la Terra. È la vittoria della bandiera di Gesù su quella di Lucifero!
Queste sono le immagini che rafforzano la volontà e che vengono presentate all’anima dell’allievo dei gesuiti. È questo che trasforma del tutto la sua volontà, che fa sì che in essa – poiché egli vi è stato educato in modo esoterico-tecnico – vi sia un’astrazione da tutto il resto e una dedizione all’idea: «Il re Gesù deve diventare il signore della Terra! E noi che facciamo parte del suo esercito dobbiamo usare tutti gli strumenti atti a fare di Lui il dominatore della Terra. Questo promettiamo noi che apparteniamo all’esercito radunato sulla pianura di Gerusalemme contro l’esercito di Lucifero sulla piana di Babilonia». E la massima onta per un soldato del re Gesù consiste nel disertare la bandiera!
Questo che è riassunto in un unico atto volitivo è qualcosa che può dare un’enorme forza alla volontà. Per descriverlo dobbiamo chiederci: che cosa è stato toccato direttamente nella vita animica? L’elemento che dev’essere considerato sacro, su cui non si deve intervenire, e cioè la volontà.
Nella misura in cui negli insegnamenti gesuitici si interviene sulla volontà, facendo sì che “Gesù” si intrometta in pieno nell’elemento volitivo, si assiste a una pericolosa unilateralità del concetto di Gesù. Pericolosa perché in tal modo la volontà diventa forte al punto da poter agire direttamente anche su quella degli altri. Laddove infatti la volontà diventa così forte per mezzo di immaginazioni, cioè mediante strumenti occulti, acquisisce anche la facoltà di esercitare un’influenza diretta sugli altri. Lo stesso vale anche per tutte le altre vie esoteriche a cui può ricorrere una simile volontà.
Fra le molte correnti degli ultimi secoli ne vediamo quindi due in particolare:
• una che ha esaltato l’elemento Gesù e vede nel re Gesù l’unico ideale del cristianesimo e
• un’altra che si attiene esclusivamente all’elemento Cristo e lo distingue con cura da quello che va oltre. È una corrente che è anche stata molte volte denigrata poiché non si scosta dalla convinzione che il Cristo abbia mandato lo “Spirito” per fare il proprio ingresso nei cuori e negli animi degli uomini attraverso di lui.
Nell’evoluzione culturale degli ultimi secoli non esiste quasi contrasto più grande di quello fra il gesuitismo e il rosicrucianesimo, poiché il primo non contiene nulla di ciò che per il secondo è il massimo ideale del rispetto del valore e della dignità umani, e poiché il rosicrucianesimo ha sempre voluto preservarsi da ogni influenza che potesse anche debolmente essere definita come un elemento gesuitico.
Con questo ho voluto mostrarvi come perfino nella vita ordinaria un elemento così elevato come il principio di Gesù possa venir esasperato, diventando quindi pericoloso, e come sia necessario immergersi nelle profondità dell’Entità cristica se si vuol capire come la forza del cristianesimo debba consistere nella massima stima della dignità e del valore dell’uomo e nel non entrare mai con passi goffi in quello che l’uomo deve considerare il suo più intimo santuario.
Per questo la mistica cristiana, e soprattutto il rosicrucianesimo, vengono contestati così veementemente dall’elemento gesuitico: perché si sente che il vero cristianesimo va cercato in modo diverso da quello in cui solo il “re Gesù” riveste un ruolo. Ma, attraverso le immaginazioni a cui vi ho accennato e gli esercizi che vi ho descritto, la volontà diventa talmente forte da poter vincere perfino le obiezioni mosse dallo spirito.
Seconda conferenza
I vangeli come
autoesperienza dell’uomo
Karlsruhe, 6 ottobre 1911
Ieri ho cercato di delineare un tipo di iniziazione non in accordo con la nostra valutazione della natura umana, di un’iniziazione che rappresenta un’acquisizione di certe facoltà occulte, come quella che troviamo nel gesuitismo e che, a fronte di concezioni occulte affinate e purificate, non possiamo considerare buona.
D’ora in poi il mio compito consisterà nel presentare la via dei Rosacroce come quella che davvero fa sua la valutazione della natura umana che noi possiamo riconoscere come nostra. Ma per questo è necessario che prima ci intendiamo su alcuni concetti.
Da spiegazioni fatte più volte sappiamo che l’iniziazione rosicruciana è in sostanza un ampliamento di quella cristiana, al punto che la si può chiamare iniziazione “cristiano-rosicruciana”. E in precedenti cicli di conferenze sono state confrontate
• l’iniziazione puramente cristiana con i suoi sette stadi e
• l’iniziazione rosicruciana, anch’essa caratterizzata da sette stadi.
Ma ora occorre far notare che il principio del progresso dell’anima umana va assolutamente salvaguardato anche rispetto all’iniziazione.
Sappiamo che l’iniziazione rosicruciana ha avuto inizio intorno al tredicesimo secolo e che a quei tempi ha dovuto essere riconosciuta come l’iniziazione giusta per l’anima umana più progredita da parte di quelle individualità preposte alla guida delle sorti più profonde dell’evoluzione umana.
Ma già da questo deve risultare evidente che l’iniziazione dei Rosacroce tiene conto dell’evoluzione dell’anima umana e che perciò deve considerare in modo particolare il fatto che tale evoluzione ha proseguito il suo cammino dal tredicesimo secolo, ragion per cui le anime che oggi vanno condotte all’iniziazione non possono più avere lo stesso punto di vista che avevano allora.
Desidero sottolinearlo particolarmente, poiché ai nostri tempi c’è una forte tendenza a voler apporre un marchio o un’etichetta a qualunque cosa. Per via di questa brutta abitudine, e non per un motivo fondato, è nata una definizione della nostra corrente scientifico-spirituale che a poco a poco potrebbe generare delle situazioni spiacevoli.
Pue essendo giusto che all’interno della nostra corrente scientifico-spirituale si può ritrovare quello che dev’essere chiamato “il principio del rosicrucianesimo”, e che dalla nostra corrente si può risalire alle fonti di questo movimento; e pur essendo vero, da un lato, che quelli che si addentrano nelle fonti del rosicrucianesimo per mezzo del nostro attuale approfondimento scientifico-spirituale possono chiamarsi “rosacruciani”, dall’altro lato va sottolineato che dal di fuori non si ha alcun diritto di definire rosicruciano il tipo di corrente scientifico-spirituale da noi instaurato. E questo per il semplice motivo che così facendo si imprimerebbe consciamente o inconsciamente un marchio sbagliato alla nostra corrente.
Non ci troviamo più al punto in cui stavano i rosicruciani dal tredicesimo secolo in poi, ma teniamo conto del progresso dell’anima umana.
Per questo quella che viene illustrata nel mio libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? come la via più adatta per ascendere alle sfere spirituali non va assolutamente confusa con quella che può essere chiamata la “via rosicruciana”. Con la nostra corrente si può dunque penetrare nel vero rosicrucianesimo, ma la sfera della nostra corrente spirituale, che abbraccia un campo molto più vasto di quello del rosicrucianesimo, vale a dire quello dell’intera scienza dello spirito, non può essere definita rosicruciana.
La nostra corrente dev’essere chiamata la scienza dello spirito di oggi, la scienza dello spirito del ventesimo secolo. E soprattutto gli estranei incorrerebbero più o meno inconsciamente in una sorta di equivoco se definissero senz’altro “rosicruciano” il nostro orientamento.
Ma dev’essere nostra, come una conquista eminentemente rosicruciana dalla nascita nel tredicesimo secolo della moderna vita spirituale occulta, quella in base alla quale tutta l’iniziazione odierna deve apprezzare e riconoscere nel senso più profondo della parola come qualcosa di autonomo nell’interiorità umana quello che, come abbiamo già accennato ieri, viene definito il più sacro centro della volontà dell’uomo. E poiché per mezzo dei metodi occulti descritti ieri la volontà dell’uomo viene per così dire sopraffatta, asservita e condotta in una determinata direzione, è necessario che il vero occultismo si opponga energicamente a un tale orientamento.
Prima di occuparci di una caratteristica del rosicrucianesimo e dell’iniziazione del giorno d’oggi, vogliamo citare qualcosa che a sua volta è diventato determinante, per cui perfino l’iniziazione rosicruciana del tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e anche del sedicesimo e diciassettesimo secolo verso la nostra epoca ha dovuto nuovamente subire delle modifiche.
Il rosicrucianesimo dei secoli passati non poteva ancora infatti contare su un elemento spirituale che da allora ha fatto il proprio ingresso nell’evoluzione dell’umanità, e del quale già oggi non si può più fare a meno negli elementi fondamentali di tutte quelle correnti spirituali che sorgono sul terreno dell’occultismo e quindi in qualsiasi corrente scientifico-spirituale.
Per ragioni che appariranno all’anima ancor più precisamente nel corso di queste conferenze, per molti secoli quella che oggi deve costituire il punto di partenza della nostra conoscenza scientifico-spirituale, la dottrina della reincarnazione e del karma, delle ripetute vite terrene, non ha fatto parte degli insegnamenti esteriori generali del cristianesimo.
Questa dottrina della reincarnazione e del karma non è quindi entrata subito nel suo senso più completo nei primi stadi dell’iniziazione rosicruciana nel tredicesimo secolo. Si poteva arrivare fino al quarto, quinto stadio del rosicrucianesimo, si potevano attraversare i cosiddetti “stadi inferiori” dell’iniziazione rosicruciana, lo studio rosicruciano, l’acquisizione dell’immaginazione, della scrittura occulta, la scoperta della pietra filosofale e perfino la sperimentazione parziale di quella che viene chiamata morte mistica. Si poteva giungere fino a questo grado, si potevano acquisire conoscenze occulte estremamente elevate, senza aver bisogno di piena chiarezza sulla dottrina così illuminante della reincarnazione e del karma.
Attualmente però dobbiamo renderci conto che grazie al pensiero progredito dell’umanità sono sorte delle forme di pensiero per mezzo delle quali, se pensiamo con coerenza a ciò che già oggi si può pensare facilmente a livello generale esteriore, possiamo senz’altro arrivare a riconoscere le vite ripetute e quindi anche l’idea del karma.
Quello che viene detto per bocca di Strader nel mio secondo dramma rosicruciano, La prova dell’anima, e cioè che oggi il pensatore più coerente, se non vuole rompere con tutto ciò che è stato prodotto dalle forme di pensiero degli ultimi secoli, deve arrivare ad ammettere il karma e la reincarnazione, è qualcosa che ha le proprie radici nelle profondità della vita spirituale odierna. E poiché si è preparato lentamente ed è radicato nel profondo della nostra vita spirituale, sta spuntando a poco a poco in modo autonomo anche nella vita spirituale dell’Occidente.
È curioso come in singoli pensatori eccellenti stia sorgendo spontaneamente la necessità di riconoscere la verità delle ripetute vite terrene.
Basta richiamare l’attenzione su qualcosa che, volontariamente o no, viene dimenticato del tutto nella nostra letteratura odierna, e che vediamo manifestarsi in maniera stupenda nell’Educazione del genere umano di Lessing. Lessing, un grande spirito del diciottesimo secolo, tira al culmine della sua esistenza le somme dei suoi pensieri e scrive L’educazione del genere umano e giunge come per ispirazione all’idea delle ripetute vite terrene.
Così l’idea delle molteplici vite si inserisce nella vita moderna come per intima necessità. E di questa idea si deve tener conto, perlomeno in modo diverso da come si fa nella nostra storia della letteratura o nella nostra vita culturale moderna. Lì infatti la si prende in considerazione secondo la nota ricetta per cui con i vecchi, se sono stati intelligenti, bisogna chiudere gli occhi su certe cose. E quindi, pur apprezzando Lessing nelle sue creazioni precedenti, si crede di dover ritenere che nei suoi ultimi anni la sua mente abbia vacillato un po’, dato che è giunto all’idea delle ripetute vite terrene.
Ma nell’epoca moderna questa idea ci si presenta sporadicamente anche in altri ambiti. Ne ha parlato Drossbach, uno psicologo del diciannovesimo secolo, nei termini in cui era possibile farlo a quei tempi. Senza occultismo, ma solo attraverso l’osservazione di ciò che la natura offre, Drossbach ha cercato come psicologo di indagare l’idea delle ripetute vite terrene.
E poi una piccola società, nel periodo a cavallo fra la prima e la seconda metà del diciannovesimo secolo, all’approssimarsi degli anni cinquanta, ha messo in palio un premio per il miglior scritto sull’immortalità dell’anima. Si è trattato di un fatto molto singolare nella vita culturale tedesca, solo che non ha avuto grande risonanza. Una piccola cerchia indice un premio per lo scritto migliore sull’immortalità dell’anima. E guarda un po’, lo scritto premiato di Widenmann si occupa dell’argomento in modo da intendere l’immortalità dell’anima nel senso delle ripetute vite terrene, seppure in maniera ancora imperfetta, come doveva essere negli anni cinquanta del secolo scorso, quando le forme pensiero non si erano ancora sviluppate fino al punto dovuto.
Si potrebbero citare varie situazioni in cui questa idea delle ripetute vite terrene è sorta come qualcosa di simile a un postulato, a un’esigenza del diciannovesimo secolo. Per questo anche nel mio breve scritto Reincarnazione e karma e poi anche nel mio libro La scienza occulta nelle sue linee generali è stato possibile fondare l’idea delle ripetute vite terrene e del karma con le forme di pensiero della scienza, sviluppando queste ultime in relazione all’individualità umana in opposizione alla specie animale.
Di una cosa dobbiamo renderci conto: che c’è un’enorme differenza non nell’idea stessa delle ripetute vite terrene, ma fra il modo in cui si è arrivati concettualmente a questa idea in Occidente e quello in cui per esempio tale idea viene sostenuta dal buddismo.
È interessante dare un’occhiata al modo in cui Lessing è giunto a questa idea delle ripetute vite terrene nella sua Educazione del genere umano. Il risultato non è solo simile, ma è addirittura uguale a ciò che nel buddismo sono le ripetute vite terrene. Però la via percorsa da Lessing è completamente diversa, e prima che lui ci arrivasse non la si conosceva affatto. Ma lui come ci è arrivato?
Lo si può vedere con precisione se si studia a fondo L’educazione del genere umano. Ci si può dire: nell’evoluzione dell’umanità si nota un nettissimo progresso. Lessing lo esprime così: questo progresso è un’educazione dell’umanità da parte delle potenze divine.
Poi aggiunge: la divinità ha dato in mano all’uomo un primo libro elementare, l’Antico Testamento, per mezzo del quale si è fondato un certo stadio dell’evoluzione umana. E quando il genere umano è progredito gli è stato dato il secondo libro elementare, il Nuovo Testamento. Nella nostra epoca Lessing scorge qualcosa che va oltre il Nuovo Testamento: la capacità autonoma dell’anima umana di sentire il vero, il buono e il bello. Questo per lui rappresenta il terzo stadio dell’educazione divina del genere umano.
Questo pensiero dell’educazione del genere umano da parte degli esseri divini è realizzato in maniera grandiosa. E a quel punto in Lessing è sorto il pensiero: qual è l’unica possibilità di spiegare questo progresso?
Se deve aver senso il fatto che nell’umanità vi sia un progresso, questo non può essere spiegato altrimenti se non facendo sì che ogni anima prenda parte a tutti i periodi culturali dell’umanità.
Non avrebbe infatti alcun senso che un’anima vivesse solo nel periodo culturale dell’Antico Testamento e un’altra soltanto in quello del Nuovo Testamento. Ha senso solo che tutte le anime vengano condotte attraverso tutte le epoche culturali e prendano parte a tutti gli stadi di educazione dell’umanità. In altre parole: solo se l’anima attraversa ripetute esistenze terrene la progressiva “educazione del genere umano” ha il suo giusto significato.
L’idea delle ripetute vite terrene scaturisce quindi dalla mente di Lessing come qualcosa che si riferisce a ogni uomo, dal momento che alla base del suo pensiero c’è la profonda convinzione che un’anima incarnatasi ai tempi dell’Antico Testamento ha assimilato quel che c’era da assimilare allora. Ma se ricompare in un’epoca successiva, porterà in essa i frutti della sua vita passata e nella prossima ancora i frutti che avrà raccolto nella seconda vita e così via. È così che si intrecciano fra loro gli stadi successivi dell’evoluzione.
E le conquiste di un’anima non sono solo a suo favore, ma a vantaggio di tutta l’umanità, che diventa un grande organismo. Allora per Lessing la reincarnazione è necessaria affinché l’umanità intera possa progredire. L’evoluzione storica riguarda da vicino tutta l’umanità, ed è da lì che Lessing prende le mosse e viene portato ad ammettere la reincarnazione.
Le cose stanno diversamente quando cerchiamo la stessa idea nel buddismo. Lì l’uomo ha a che fare solo con se stesso, unicamente con la sua anima. Lì la singola anima si dice: «Sono stata trasferita nel mondo della maya, dell’illusione, è la concupiscenza che mi ci ha portata e, come singola anima, nelle incarnazioni che si susseguono mi libero dalle incarnazioni terrene». È una questione della singola individualità, qui lo sguardo è rivolto a questa individualità singola.
Questa è la grande differenza nel cammino:
• se si considera la cosa dall’interno dell’uomo, come nel buddismo
• o dall’esterno, come Lessing, che abbraccia con lo sguardo tutta l’evoluzione dell’umanità.
Il risultato è lo stesso, ma in Occidente si è percorsa una strada completamente diversa. Mentre il buddista si limita alla singola anima individuale, lo sguardo dell’uomo occidentale è puntato sulle faccende dell’umanità intera. L’uomo occidentale si sente legato a tutti gli altri uomini come in un organismo unitario.
Da dove proviene questa necessità di dirigere il proprio pensiero non solo sui singoli individui, ma di aver sempre in mente il fatto che le questioni più importanti riguardano l’umanità intera?
Questa necessità gli viene dall’aver assorbito nella sua sfera affettiva, nel suo mondo dei sentimenti, le parole del Cristo Gesù sulla fratellanza umana al di là di tutte le nazionalità, di tutte le caratteristiche razziali, dell’umanità intera come di un grande organismo.
Per questo è interessante vedere come anche nel secondo personaggio di cui ho parlato, Drossbach, il pensiero – in modo ancora imperfetto, poiché le idee scientifiche della prima metà del diciannovesimo secolo non avevano ancora prodotto le forme pensiero corrispondenti – non segua la via buddista, ma quella cosmico-universale. Drossbach parte da idee scientifiche e osserva l’anima in ambito cosmico. E non può figurarsela se non nell’immagine del seme che attraversa la forma esteriore per riapparire di nuovo in forma esteriore, come “reincarnata”.
Questa idea nasce in modo un po’ fantastico in Drossbach, convinto che il mondo stesso debba trasformarsi, mentre Lessing ha pensato indubbiamente a periodi di tempo brevi e precisi. E nel suo scritto premiato sull’immortalità dell’anima Widenmann ha un’idea assolutamente esatta sulla questione della reincarnazione.
Così queste idee compaiono sporadicamente grazie a questi geni. Ed è giusto che tali idee sorgano nonostante il corso incompleto del pensiero, e non solo in questi geni ma anche in altri. Questa è infatti la grande svolta compiuta dall’evoluzione dell’anima umana dal diciottesimo al ventesimo secolo, per cui ci dobbiamo dire: chi oggi comincia a studiare l’andamento del mondo deve prima di tutto acquisire quelle forme pensiero che oggigiorno conducono in modo completamente naturale alla credibilità e all’accettazione della reincarnazione e del karma.
Fra il tredicesimo e il diciottesimo secolo il pensiero umano non era ancora così progredito da poter giungere da solo a riconoscere la reincarnazione. Ma bisogna sempre partire dalla base su cui il pensiero umano si trova di volta in volta nella sua forma più evoluta. Per questo oggi si deve prendere come punto di partenza il pensiero in grado di considerare logica – cioè ipoteticamente giusta – l’idea delle ripetute vite terrene dal punto di vista scientifico. È in questo modo che progrediscono i tempi.
Senza descrivere già oggi la via rosicruciana, cominceremo a mettere in evidenza il carattere essenziale sia di quella che della via odierna alla conoscenza.
In generale possiamo dire che questo elemento caratteristico consiste nel fatto che chiunque fornisca consigli e istruzioni per l’iniziazione deve apprezzare in senso profondo l’autonomia e l’intangibilità della sfera volitiva dell’uomo.
Per questo ciò che più conta è fare in modo che, attraverso una particolare cultura morale e spirituale, la struttura del corpo fisico, del corpo eterico, del corpo astrale e dell’Io assuma una forma diversa da quella che ha per natura. E le istruzioni fornite sia per la cura dei sentimenti morali che per la concentrazione del pensiero, per la meditazione, tendono tutte in definitiva alla stessa meta: ad allentare la struttura spirituale che connette il corpo eterico con il corpo fisico dell’uomo, di modo che il nostro corpo eterico non sia più così saldamente inserito nel corpo fisico come avviene in natura.
Tutti gli esercizi mirano a questo distacco, a questo allentamento del corpo eterico. Ma in tal modo si produce un nuovo collegamento anche fra il corpo astrale e quello eterico. Per via del fatto che nella nostra vita consueta il corpo eterico e quello fisico sono tra loro strettamente collegati, nell’esistenza quotidiana il nostro corpo astrale non può avvertire tutto ciò che avviene nel corpo eterico.
Il corpo eterico ha la propria sede in quello fisico, e per questo il nostro corpo astrale e il nostro Io percepiscono solo attraverso il corpo fisico tutto ciò che esso lascia arrivare a essi dal mondo e ciò che permette loro di pensare mediante lo strumento del cervello. Il corpo eterico è troppo innestato in quello fisico per poter essere vissuto dall’uomo nella vita normale come un’entità autonoma, come uno strumento indipendente di conoscenza e anche come uno strumento di sentimento e volontà.
Gli sforzi di concentrazione del pensiero, così come vengono insegnati oggi e come venivano insegnati dai Rosacroce, gli sforzi della meditazione, la purificazione delle sensazioni morali, tutto questo porta all’indipendenza da parte del corpo eterico, come viene descritto nel libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori?. Così che, come usiamo gli occhi per vedere e le mani per afferrare, giungiamo anche a servirci del corpo eterico e dei suoi organi per guardare non nel mondo fisico ma in quello spirituale.
Il modo in cui raccogliamo e concentriamo in se stessa la nostra vita interiore lavora in direzione dell’autonomia del corpo eterico.
È però necessario che prima, perlomeno a titolo di prova, ci permeiamo praticamente dell’idea del karma, cosa che facciamo quando creiamo una certa armonia delle forze animiche morali e affettive. Un uomo che fino a un certo grado non sappia formulare il pensiero: «In definitiva la colpa di ciò che mi spinge a fare qualcosa è mia», non potrà progredire bene. Occorre prendere le mosse da una certa imperturbabilità e da una comprensione, seppure ipotetica, del karma.
Ben difficilmente potrà fare progressi un uomo che non si liberi affatto del proprio Io, che sia attaccato al suo modo limitato di sentire al punto da attribuire sempre agli altri e mai a se stesso la colpa dei suoi insuccessi, un uomo sempre pervaso dalla sensazione che il mondo o una parte del suo ambiente sia contro di lui, uno che, detto alla buona, è un individuo insopportabile che non riesce ad andare oltre a ciò che può essere superato sistemando con il proprio pensiero ordinario quanto si può imparare dalla scienza dello spirito in generale.
È quindi bene che, per lo sviluppo dell’equanimità e della quiete interiore, ci rendiamo conto che se qualcosa non ci riesce, soprattutto nel cammino esoterico, dobbiamo dare la colpa a noi stessi e non agli altri. Questo contribuisce in massima parte al progresso. Quello che invece ci fa progredire di meno è il voler continuamente cercare la colpa nel mondo esterno, il voler sempre cambiare metodi e così via. Questo è molto più importante di quanto forse appare!
Quando non riusciamo a progredire è sempre meglio verificare in ogni istante quanto poco siamo cresciuti nella capacità di cercare i motivi dentro di noi. Il giorno in cui decideremo di cercare la causa sempre dentro di noi avremo fatto un importante passo avanti. Allora vedremo che progrediamo non solo nelle cose più distanti ma anche in quelle della vita esteriore.
Quelli che conoscono un po’ queste cose potranno testimoniare in qualsiasi momento che, grazie all’idea di cercare dentro di sé la colpa di ogni insuccesso, si trova qualcosa che rende la vita esteriore facile e sopportabile. Se riusciamo davvero a concepire questa idea, possiamo affrontare più facilmente quello che ci circonda, superare anche molti atteggiamenti ipocondriaci o scontrosi, molte lamentele o rimostranze, e andare più tranquillamente per la nostra strada.
Dovremmo infatti tener presente che in ogni vera iniziazione moderna chiunque dia un consiglio ha il dovere assoluto di non entrare nel più intimo santuario dell’anima. Per quanto riguarda l’interiorità della nostra anima siamo noi a dover fare qualcosa, e non siamo autorizzati a lamentarci di non ricevere i consigli giusti. I consigli possono essere quelli giusti, ma se non prendiamo la decisione indicata può darsi che le cose vadano per il verso sbagliato.
Una volta che abbiamo scelto – e la scelta può scaturire solo da una decisione seria –, questa equanimità e questa calma costituiscono un buon terreno su cui basare la meditazione per dedicarsi ai sentimenti e ai pensieri.
E poi, riguardo a tutto ciò che si fonda sul terreno rosicruciano, è importante che in tutte le meditazioni, concentrazioni e così via ci venga indicato non qualcosa che può equivalere a un dogma, ma qualcosa di universalmente umano.
Sulla cattiva strada descritta ieri si prendono le mosse da quello che in un primo tempo viene dato all’uomo solo come contenuto personale. E questo contenuto può essere dimostrato soltanto mediante la conoscenza esoterica, se non è da dar per scontato fin dall’inizio?
Su un simile terreno deve mettersi ciò che si fonda sul principio rosicruciano. Dobbiamo presumere di non essere affatto in grado di scorgere qualcosa fin dal principio se ci basiamo unicamente su documenti esteriori, per esempio nel caso di ciò che si è verificato come evento del Golgota. Queste cose le dobbiamo infatti apprendere solo attraverso il cammino interiore, non le possiamo dare per scontate già in partenza.
Per questo si prendono le mosse dall’universalmente umano, da ciò che può essere giustificato di fronte a ogni anima.
Uno sguardo nel macrocosmo, ammirare la manifestazione della luce nel Sole e sentire che quello che il nostro occhio vede della luce è solo il suo velo esteriore, la rivelazione esteriore o, come si dice nell’esoterismo cristiano, la “magnificenza”, lo splendore della luce, e poi abbandonarsi al pensiero che dietro la luce sensibile debba celarsi qualcosa di completamente diverso.
Questo è l’universalmente umano: pensare la luce diffusa nello spazio, guardarla e poi rendersi conto che in questo elemento della luce diffusa deve vivere qualcosa di spirituale che intreccia attraverso lo spazio questo tessuto della luce – concentrarsi su questo pensiero, vivere in esso. Allora abbiamo qualcosa di universalmente umano che viene presentato non per mezzo di un dogma, ma mediante un sentimento universale.
E ancora: sentire nella natura il calore, sentire come con il calore fluttui nel mondo qualcosa in cui vive lo spirito. E poi, partendo da una certa affinità nel nostro organismo con i sentimenti di amore, concentrarsi su come il calore possa essere spirituale, su come viva pulsando attraverso il mondo.
Poi immergersi in ciò che possiamo imparare dalle intuizioni forniteci dalla moderna dottrina scientifico-spirituale e in seguito consultare gli esperti in questo campo su come ci si può concentrare nel modo giusto su pensieri che siano universali, cosmici.
E poi ancora: affinamento, purificazione dei sentimenti morali, per mezzo dei quali giungiamo a comprendere che ciò che sentiamo a livello morale è una realtà, e grazie ai quali superiamo il pregiudizio che le nostre sensazioni morali siano qualcosa di transitorio. Così che ci sia chiaro che quello che sentiamo adesso continua a vivere come impronta morale, come sostanza morale. Allora l’uomo impara a sentire la responsabilità di sapersi inserito nel mondo con i suoi sentimenti morali.
In fondo tutta la vita esoterica è rivolta verso questo universalmente umano, ma oggi dobbiamo mostrare dove arriviamo se ci dedichiamo in questo modo a degli esercizi che partono dal punto che possiamo raggiungere con la nostra natura umana se solo ci abbandoniamo a essa in un autoesame assennato.
Se partiamo da lì, allora arriviamo ad allentare il legame fra il corpo fisico e quello eterico e ad acquisire una conoscenza diversa dal solito. In un certo senso diamo alla luce un secondo uomo, in modo da non essere più così strettamente connessi con il corpo fisico, così che nei momenti più belli della vita il nostro corpo eterico e quello astrale sono come inseriti in un involucro esterno e noi sappiamo di esserci affrancati dallo strumento del corpo fisico. È questo che raggiungiamo.
Ma poi veniamo condotti a vedere il corpo fisico nella sua vera essenza e a renderci conto di quel che provoca in noi quando siamo inseriti in esso. È soltanto quando in un certo senso ne siamo usciti che ci accorgiamo di tutti gli effetti prodotti su di noi dal corpo fisico.
Come il serpente che può osservare dal di fuori la pelle che ha cambiato, mentre di solito la sente come parte di sé, così anche noi impariamo attraverso il primo stadio dell’iniziazione a sentirci liberi dal nostro corpo fisico e quindi a conoscerlo. In quel momento si insinuano in noi sensazioni molto particolari che in un primo tempo possono essere descritte nel seguente modo.
Sulla via dell’iniziazione ci sono talmente tante esperienze che non è ancora stato possibile descriverle tutte. Nel mio libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? trovate alcune informazioni, ma molte cose ancora mancano.
La prima cosa che possiamo sperimentare, e che può sperimentare quasi chiunque passi dalla vita esteriore al sentiero della conoscenza, è la possibilità di dirsi a livello emotivo: questo corpo fisico così come mi appare non è opera mia. Davvero non sono stato io a creare questo corpo fisico attraverso il quale sono stato portato a diventare quello che sono nel mondo. Se non lo avessi, l’Io, che in questo momento considero il mio grande ideale, non sarebbe legato a esso. Sono diventato quello che sono solo grazie al fatto di aver ricevuto questo corpo fisico legato a me.
Da tutto ciò sorge dapprima una specie di rancore, una sorta di amarezza nei confronti delle potenze cosmiche per il fatto di essere diventati così. È facile dire: «Non voglio provare questo risentimento». Ma quando ci si presenta davanti agli occhi l’opprimente maestosità di ciò che siamo diventati per via del legame con il nostro corpo fisico, il sentimento che ci coglie ha una forza travolgente. E allora proviamo qualcosa come astio, odio e amarezza contro le potenze cosmiche per averci fatti diventare così come siamo.
Dobbiamo dunque essere già abbastanza progrediti nella nostra formazione spirituale per superare l’amarezza e dirci a uno stadio superiore che siamo noi con tutto il nostro essere, con tutta la nostra individualità, calatasi già da tempo nelle incarnazioni, i responsabili dell’evoluzione del nostro corpo fisico.
Quando superiamo questa amarezza, ci troviamo di fronte la sensazione già spesso descritta: ora so che sono io stesso quello che appare come forma modificata della mia esistenza fisica! Solo che non sapevo nulla della mia entità fisica, perché ne sarei stato travolto.
A quel punto siamo giunti all’importante incontro con il “guardiano della soglia”.
Ma quando arriviamo fin lì, quando attraverso il rigore dei nostri esercizi impariamo quanto è appena stato detto, allora usciamo dalla natura umana generale per riconoscerci nella nostra figura attuale come risultato delle precedenti incarnazioni. Ma capiamo anche come possiamo provare il dolore più profondo e come dobbiamo risalire da esso per superare la nostra esistenza presente.
E in chiunque sia progredito abbastanza da aver provato questi sentimenti in tutta la loro intensità e da aver visto il guardiano della soglia, sorge necessariamente una figura immaginativa, un’immagine che non si dipinge arbitrariamente per mezzo di ciò che è contenuto nella Bibbia, come avviene nel gesuitismo, ma che egli sperimenta grazie a ciò che è, a ciò che ha sentito come universalmente umano.
In tal modo l’uomo fa naturalmente la conoscenza dell’immagine dell’Uomo ideale divino, che come noi vive in un corpo fisico e che in quel corpo fisico sente come noi tutto ciò che esso può produrre.
La tentazione, l’immagine della tentazione descrittaci nei vangeli sinottici, la descrizione di come il Cristo Gesù viene condotto sulla montagna, della promessa di tutti i regni della Terra, della tentazione di volersi attenere alle realtà esteriori, di voler restare attaccati alla materia – in breve, della tentazione di fermarsi dal guardiano della soglia senza oltrepassarlo – tutto questo ci appare nel grande affresco ideale che ci verrebbe incontro anche se non avessimo sentito mai parlare dei vangeli: il Cristo Gesù sulla montagna con accanto il tentatore.
E allora sappiamo che chi ha scritto la storia della tentazione ha descritto la sua esperienza personale, che ha visto “nello spirito” il Cristo Gesù e il tentatore. E allora sappiamo che è vero nello spirito che colui che ha scritto i vangeli ha descritto qualcosa che anche noi potremmo sperimentare pur non sapendo nulla dei vangeli.
Veniamo quindi condotti a un’immagine uguale a quella che troviamo nei vangeli e conquistiamo così quello che è contenuto in essi. Tutto viene preso dalle profondità della nostra natura, e non con la forza. Partiamo dall’universalmente umano, diamo di nuovo alla luce i vangeli attraverso la nostra vita interiore e ci sentiamo un tutt’uno con i loro autori.
Allora emerge in noi una nuova sensazione, una specie di stadio ulteriore del cammino interiore. Sentiamo come il tentatore comparso in quella scena assuma le dimensioni di un essere potente che sta dietro tutti i fenomeni del mondo.
Sì, facciamo la conoscenza del tentatore, ma a poco a poco impariamo anche ad apprezzarlo in un certo senso. Impariamo a dire: «Il mondo che si estende davanti a noi – che sia illusione o qualunque altra cosa – ha la sua legittimità, ci ha rivelato qualcosa». Allora emerge un secondo elemento che può di nuovo essere descritto come una sensazione ben concreta in tutti quelli che soddisfano le condizioni di un’iniziazione rosicruciana.
Sorge la sensazione di appartenere allo spirito che vive in tutte le cose e con cui dobbiamo fare i conti. Ma non possiamo cogliere questo spirito se non ci abbandoniamo a esso, cosa che ci fa paura. Proviamo un terrore attraverso il quale deve passare ogni vero conoscitore, una percezione della grandezza dello spirito cosmico diffuso nel mondo. Ci sta davanti e noi sentiamo la nostra impotenza e abbiamo anche la sensazione di quello che siamo diventati nel corso dell’evoluzione della Terra o del mondo. Sentiamo la nostra esistenza impotente, così lontana da quella divina.
Allora abbiamo paura dell’ideale a cui dobbiamo diventare uguali e dell’entità dello sforzo che ci deve portare fin là. Come l’insegnamento esoterico deve farci sentire le dimensioni complessive dello sforzo, così dobbiamo anche intendere la paura come una lotta da intraprendere, una lotta con lo spirito del mondo.
E quando percepiamo la nostra piccolezza e la necessità di lottare per raggiungere il nostro ideale e diventare tutt’uno con ciò che è all’opera nel mondo, quando ce ne spaventiamo, solo allora possiamo mettere da parte anche la paura e incamminarci lungo la via che porta al nostro ideale.
Ma mentre abbiamo queste forti sensazioni ci si presenta un’altra immaginazione significativa. Al nostro occhio chiaroveggente appare una specie di immagine spirituale, che ci si presenterebbe anche se non avessimo mai letto il Vangelo, anche se al genere umano non fosse mai stato dato un libro di quel genere.
Veniamo condotti nella solitudine, che appare chiaramente al nostro occhio interiore. E veniamo guidati dinanzi all’immagine dell’uomo ideale che, in un corpo umano, prova con intensità infinita tutte le paure che noi stessi sentiamo in quel momento. Abbiamo davanti a noi l’immagine del Cristo nel Getsemani, di come provi in misura amplificata la stessa paura che anche noi dobbiamo sperimentare sul sentiero della conoscenza, quella paura che gli fa sudare sangue dalla fronte. Abbiamo questa immagine a un determinato punto del nostro cammino spirituale – senza documenti esteriori.
E sulla via dello spirito ci stanno davanti in un certo senso due imponenti pilastri:
• il quadro della tentazione vissuta a livello spirituale e
• la scena del Monte degli ulivi, anch’essa vissuta a livello spirituale.
E allora capiamo le parole: «Vegliate e pregate, vivete nella preghiera per non cedere alla tentazione di fermarvi in un punto, ma continuate sempre ad andare avanti» (Mt 26,41).
Questo vuol dire fare l’esperienza del Vangelo: vivere tutto in modo da poterlo descrivere come hanno fatto gli autori dei vangeli.
Non c’è bisogno infatti di ricavare dal Vangelo le due immagini che vi ho appena descritto: le possiamo prendere dalla nostra interiorità, dal santuario della nostra anima.
Allora non è necessario che venga un maestro a dirci: «Devi immaginarti il racconto della tentazione o la scena sul Monte degli ulivi». È sufficiente considerare ciò che possiamo sviluppare nella nostra coscienza sotto forma di meditazione, di purificazione dei sentimenti universalmente umani e via dicendo.
Allora, senza che nessuno ci costringa, possiamo ricavare le immaginazioni contenute nei vangeli.
• La via della corrente spirituale gesuitica che abbiamo descritto ieri presupponeva la conoscenza dei vangeli per sperimentare ciò che è descritto in essi.
• La via presentata oggi indica come, intraprendendo il sentiero della vita spirituale, sperimentiamo dapprima a livello interiore ciò che è in relazione con la nostra vita, e poi a partire da noi stessi le immagini descritte nei vangeli.
Terza conferenza
Gesù vero uomo, cristo cosmico.
Il concetto di fede
Karlsruhe, 7 ottobre 1911
Quello di cui ci dobbiamo occupare in primo luogo è il rapporto fra la coscienza religiosa universale e quel sapere, quella conoscenza che l’uomo può attingere in generale dai mondi superiori.
Per il nostro tema viene presa particolarmente in considerazione la conoscenza della relazione fra il Cristo Gesù e i mondi superiori, acquisibile mediante forze chiaroveggenti più elevate. Voi tutti sapete che finora per la maggior parte degli uomini l’evoluzione del cristianesimo è stata tale da non permettere loro di giungere ai misteri dell’evento cristico con la propria conoscenza chiaroveggente.
In altre parole: dobbiamo ammettere che il cristianesimo è entrato in moltissimi cuori umani e fino a un certo grado è stato riconosciuto anche nella sua essenza da innumerevoli anime, senza che quei cuori e quelle anime siano stati in grado di guardare nei mondi superiori per ricavare dalla conoscenza di tali mondi una visione chiaroveggente di quello che si è verificato per l’umanità con il mistero del Golgota e tutto ciò che è in relazione con esso.
Per questo, dalla tendenza religiosa e conoscitiva verso il Cristo dell’uomo che non sa ancora niente della ricerca sovrasensibile dobbiamo distinguere con precisione ciò che si può sapere attraverso la coscienza chiaroveggente stessa o ricevendo per qualche ragione le informazioni dei ricercatori chiaroveggenti relative ai misteri del cristianesimo.
Ora tutti ammetterete che, nel corso dei secoli successivi al mistero del Golgota, uomini di ogni grado di formazione spirituale si sono trovati a professare in modo intimo e profondo i misteri del cristianesimo. E da quanto è stato detto nelle varie conferenze degli ultimi tempi, avrete ricavato in definitiva l’impressione che si tratti di un fatto del tutto naturale.
Solo nel ventesimo secolo infatti, com’è stato più volte sottolineato, avrà luogo in un certo senso un rinnovamento dell’evento cristico, dal momento che le forze conoscitive umane in generale inizieranno a subire uno sviluppo superiore, così che nei prossimi tre millenni sempre più uomini avranno la possibilità di acquisire una visione diretta del Cristo Gesù anche se sprovvisti di una particolare preparazione esoterica.
Ma fino a oggi questo non era possibile. Finora ci sono state solo due o, come scopriremo forse già oggi, tre fonti di conoscenza dei misteri cristiani per coloro che non si elevavano artificialmente a osservazioni chiaroveggenti.
Una fonte era costituita dai vangeli e da tutto ciò che proviene dalle comunicazioni in essi contenute o dalla tradizione immediatamente successiva. L’altra fonte di conoscenza scaturiva dal fatto che c’erano sempre persone chiaroveggenti in grado di guardare nei mondi superiori e di portare agli altri la propria conoscenza dei fatti legati all’evento cristico – e dal fatto che a costoro si aggregavano altri uomini, per così dire sulla base di un “Vangelo perenne” che poteva far ingresso sempre nel mondo attraverso i chiaroveggenti. Queste sembrano essere dapprima le due uniche fonti nell’evoluzione dell’umanità cristiana precedente.
E adesso, dal ventesimo secolo in poi, ne comincia un’altra, che si manifesta nel fatto che in un numero sempre maggiore di persone si verifica un ampliamento, un incremento delle forze conoscitive che non provengono dalla meditazione, dalla concentrazione e da altri esercizi. Come abbiamo ripetuto diverse volte, sempre più individui saranno in grado di rinnovare per se stessi l’evento di Paolo a Damasco. Avrà allora inizio un’epoca di cui potremo dire che fornisce una modalità di visione diretta del significato dell’Entità del Cristo Gesù.
A questo punto ovviamente vi chiederete: ma allora qual è la differenza fra ciò che è sempre stato possibile per la coscienza chiaroveggente, fra la visione del Cristo Gesù che abbiamo descritto ieri come conseguenza dell’evoluzione esoterica, e ciò che, a partire dal nostro ventesimo secolo, gli uomini saranno in grado di vedere nei prossimi tre millenni senza questa evoluzione esoterica?
La differenza è notevole, e sarebbe sbagliato credere che quello che oggi il chiaroveggente scorge dell’evento cristico nei mondi superiori grazie alla sua evoluzione chiaroveggente e ciò che i chiaroveggenti hanno visto a proposito di questo evento cristico a partire dal mistero del Golgota sia la stessa cosa che diverrà visibile per un numero sempre più grande di persone. Si tratta di due cose completamente diverse.
E se vogliamo sapere in che misura queste due cose sono diverse fra loro, dovremo prima chiedere alla ricerca chiaroveggente per quale motivo a partire dal ventesimo secolo il Cristo Gesù penetrerà sempre più nella coscienza ordinaria degli uomini.
Il motivo è il seguente:
Come all’inizio della nostra era nella Palestina del mondo fisico si è verificato un avvenimento in cui il Cristo ha avuto il ruolo principale, un evento significativo per tutta l’umanità, così nel corso del ventesimo secolo, verso la fine del ventesimo secolo, si verificherà di nuovo un evento importante, ma questa volta non nel mondo fisico, bensì nei mondi superiori, e in un primo tempo precisamente in quello che chiamiamo il mondo dell’eterico.
E questo avvenimento avrà per l’evoluzione umana un’importanza altrettanto fondamentale di quella avuta dall’evento della Palestina all’inizio della nostra era.
Proprio come dobbiamo dire che per il Cristo stesso l’evento del Golgota ha il significato che con questo evento un essere divino è morto, e ha vinto la morte – vedremo poi in che modo va ciò inteso, prima non era mai successo e dopo è un fatto compiuto –, così avrà luogo un avvenimento di profonda importanza, non solo nel mondo fisico ma anche in quello eterico.
E per il fatto che si compie questo evento, che si compie un evento con il Cristo stesso, si crea la possibilità per gli uomini di vedere il Cristo, di guardarlo. Di che evento si tratta?
Non è altro che il passaggio al Cristo nel ventesimo secolo di un certo incarico relativo all’evoluzione umana, un passaggio che avverrà in una forma superiore a quella di prima. La ricerca occulta e chiaroveggente ci insegna che nella nostra era subentra un fatto importante: il Cristo diventa il signore del karma per l’evoluzione dell’umanità.
Questo è l’inizio di quanto viene espresso anche nei vangeli con le parole: «Egli ritornerà per provocare la “crisi” o per giudicare i vivi e i morti».
Nel senso della ricerca spirituale questo evento non va inteso come un episodio unico che si verifica nel mondo fisico, ma come qualcosa che è in relazione con tutta l’evoluzione futura dell’umanità. E mentre finora il cristianesimo e l’evoluzione cristiana hanno rappresentato una specie di preparazione, adesso succede il fatto importante che il Cristo diventa il signore del karma, che in futuro starà a lui decidere qual è il nostro conto karmico, qual è il rapporto fra il nostro dare e avere nella vita.
Ciò che viene detto ora è da molti secoli una conoscenza comune dell’occultismo occidentale e nessun occultista che sappia queste cose lo negherà. Ma è soprattutto negli ultimi tempi che lo si è di nuovo constatato con tutti gli strumenti accurati della ricerca occulta. Ed ora vogliamo farci un’idea precisa di quanto è appena stato detto.
Interrogate tutti quelli che sanno qualcosa di vero su queste cose e ovunque troverete la conferma di un fatto, che tuttavia per essere espresso in un certo senso richiede il nostro punto attuale di evoluzione scientifico-spirituale, poiché tutto quello che può rendere il nostro animo adatto ad accettare un simile fatto ha dovuto prima essere realizzato. Per questo anche voi, se le volete cercare, potete trovare informazioni al riguardo nella letteratura occulta. Io però non tengo in nessun conto la letteratura, ma voglio solo citare i fatti corrispondenti.
Nella descrizione di determinati rapporti – anche nella misura in cui è stata fornita da me – è stato necessario tratteggiare la realtà che viene presa in considerazione quando l’uomo varca la soglia della morte. Ora c’è un gran numero di uomini, in prevalenza quelli che hanno preso parte all’evoluzione culturale occidentale – queste cose non sono infatti uguali per tutti –, che sperimentano un fatto ben preciso nell’istante in cui dopo la morte avviene la separazione del corpo eterico.
Sappiamo che nell’attraversare la porta della morte l’uomo si separa dal corpo fisico. In un primo momento mantiene ancora per un po’ il legame con il corpo eterico, ma poi con l’Io e con il corpo astrale si separa anche dal corpo eterico. Sappiamo che porta con sé un estratto del suo corpo eterico, ma sappiamo anche che in sostanza il corpo eterico prende altre strade, che viene trasmesso all’elemento cosmico universale. O si dissolve del tutto, cosa che però si verifica solo in condizioni imperfette, oppure si comporta in modo da continuare ad agire come una forma in sé chiusa di effetti.
Dopo aver abbandonato questo corpo eterico, l’uomo entra nella regione del “kamaloka” (luogo della brama), nel periodo di purificazione del mondo animico. Ma prima di questo ingresso nel periodo di purificazione dell’anima ha luogo un’esperienza molto speciale, a cui finora non si è accennato poiché, come dicevo, la cosa doveva prima maturare. Ma adesso queste cose possono essere accolte in pieno da tutti quelli che vogliono davvero valutare ciò che stiamo prendendo in considerazione in questa sede.
Allora l’uomo sperimenta l’incontro con un’entità ben precisa che gli presenta il suo conto karmico. E questa individualità, che per così dire rappresentava per gli uomini una specie di contabile delle potenze karmiche, per molti di loro finora era stata la figura di Mosè.
Da qui la formula medievale che deriva dal rosicrucianesimo: nell’ora della morte – non viene detto esattamente così, ma non è questo che conta adesso – Mosè presenta all’uomo il “registro dei peccati” e nello stesso tempo gli indica la “legge tagliente” che avrebbe dovuto seguire, così che possa vedere di quanto se ne è discostato.
La cosa importante è che nel corso della nostra epoca questo incarico passa al Cristo Gesù, che apparirà sempre più all’uomo come il suo “giudice”, il suo giudice karmico. Questo è l’evento sovrasensibile. Proprio come
• nel mondo fisico all’inizio della nostra era ha avuto luogo l’evento della Palestina,
• così nella nostra epoca avviene il passaggio della carica di giudice al Cristo Gesù nel mondo immediatamente al di sopra del nostro.
Ed è questo fatto che agisce nel mondo fisico in modo che l’uomo possa sviluppare la sensazione che con tutto ciò che fa crea qualcosa di cui dovrà render conto al Cristo.
E questa sensazione, che ormai compare in maniera del tutto naturale nel corso dell’evoluzione dell’umanità, si trasformerà in modo da permeare l’anima di una luce che emana gradualmente dall’uomo stesso e che illuminerà la figura del Cristo nel mondo eterico. E quanto più si creerà questa sensazione, che avrà un significato ancora superiore a quello della “coscienza” astratta, tanto più nei prossimi secoli la figura eterica del Cristo diventerà visibile.
Nei prossimi giorni descriveremo questo fatto con maggior precisione e vedremo che con ciò abbiamo presentato un evento del tutto nuovo, un avvenimento che agisce nell’evoluzione cristica dell’umanità.
Adesso descriviamo l’evoluzione cristiana nel mondo fisico per la coscienza non chiaroveggente chiedendoci se, oltre alle due vie presentate, non ce ne sia per caso una terza.
In realtà c’è sempre stata una terza via per tutta l’evoluzione cristiana. Doveva esserci perché l’evoluzione dell’umanità non si orienta secondo le opinioni degli uomini, ma concorda con i fatti oggettivi.
Nel corso dei secoli si sono avute molte opinioni sul Cristo Gesù, altrimenti i concili, i sinodi e i teologi non avrebbero avuto così tanti motivi di discussione. E forse non esiste un’altra epoca che abbia avuto tante opinioni diverse sul Cristo come la nostra.
Ma i fatti non dipendono dalle opinioni degli uomini, bensì dalle forze effettivamente presenti nell’evoluzione dell’umanità. Questi fatti potrebbero essere riconoscibili per un maggior numero di uomini anche grazie alla semplice osservazione di quanto ci è stato tramandato per esempio nei vangeli, se soltanto si avesse la pazienza e la perseveranza di considerare le cose in modo davvero privo di pregiudizi, se non si fosse precipitosi e faziosi nell’osservazione dei fatti oggettivi.
La maggior parte degli uomini tendeva tuttavia a farsi un’immagine del Cristo non in base ai fatti, ma in base ai propri desideri, a quello che considerava il proprio ideale. E in un certo senso bisogna dire che i teosofi di tutte le coloriture lo fanno anche oggi. Se per esempio nella letteratura scientifico-spirituale è diventato di moda parlare di individualità più evolute che hanno guadagnato un certo vantaggio nell’evoluzione umana, si tratta di una verità che non può essere negata da chi pensa in modo concreto.
Un pensiero concreto deve ammettere il concetto di “maestro”, di individualità a un livello superiore di evoluzione, e perfino quello di “adepto” (iniziato). Solo un pensiero che non crede all’evoluzione non ammetterebbe tali concetti.
Se ora prendiamo in esame il concetto di maestro o di adepto, dobbiamo dire che una tale individualità è passata attraverso molte incarnazioni e che per mezzo di esercizi, di “un’esistenza piena di dedizione”, ha raggiunto qualcosa di diverso dagli altri in anticipo sull’umanità, procurandosi delle forze che il resto del genere umano acquisirà solo in futuro.
Ora è ovvio e giusto che chi ottiene dalla conoscenza scientifico-spirituale una simile visione di un’individualità di questo genere provi un sentimento di sommo rispetto per l’individualità dei maestri, degli adepti e via dicendo.
E adesso da un simile concetto innalziamoci a una vita così venerabile come ci appare quella del Buddha, in modo da ammettere nel senso della conoscenza scientifico-spirituale: «Buddha dev’essere considerato uno dei massimi adepti». Allora potremo acquisire per il nostro animo e il nostro sentimento un contenuto animico e un atteggiamento nei confronti di una simile individualità.
Quando lo scienziato spirituale si avvicina alla figura del Cristo Gesù sulla base di questa conoscenza e di questo sentimento scientifico-spirituali, sorge in lui naturalmente la necessità – e non si può affatto negare che è del tutto comprensibile che essa sorga – di collegare il suo Cristo Gesù allo stesso concetto ideale che si era fatto di un maestro, di un adepto o di un Buddha. E forse si sentirà spinto a dire: anche Gesù di Nazareth va visto come un grande iniziato!
Questo pregiudizio stravolgerebbe però la conoscenza del vero Essere cristico. Sarebbe solo un preconcetto, seppur comprensibile. Chi infatti è entrato in rapporto intimo e profondo con il Cristo, come potrebbe fare a meno di mettere il portatore dell’essenza cristica sullo stesso piano dei maestri, degli adepti, per esempio del Buddha? Deve sembrarci del tutto comprensibile. Forse per una persona simile il non farlo equivarrebbe a screditare Gesù di Nazareth.
Ma in tal modo si viene distolti dall’attenersi ai fatti, perlomeno a quelli che trapelano dalla tradizione.
Una cosa potrebbe risultare chiara a chiunque dai fatti tramandatici, se solo, nonostante tutte le opinioni dei concili e tutto quello che è stato scritto da singoli individui in qualità di padri o dottori della Chiesa, si occupasse di quanto emerge da un’osservazione spassionata della tradizione, da quanto trapela da essa: che Gesù di Nazareth non può essere definito un “adepto”.
Chiunque potrebbe infatti chiedersi: dove troviamo nella tradizione qualcosa che ci faccia applicare a Gesù di Nazareth il concetto di adepto quale lo conosciamo nell’insegnamento scientifico-spirituale?
Proprio agli albori del cristianesimo veniva sottolineato che colui che portava il nome di Gesù di Nazareth era un uomo come tutti gli altri, un debole uomo come gli altri. E coloro che più si avvicinano al senso di ciò che è venuto nel mondo sono quelli che affermano: «Gesù era un vero uomo». Se osserviamo correttamente la tradizione, vediamo quindi che in essa non c’è nulla che faccia pensare al concetto di adepto.
E se vi ricordate di quanto è stato detto nelle conferenze passate sull’evoluzione di Gesù di Nazareth – sull’evoluzione del bambino Gesù in cui fino ai dodici anni ha vissuto Zarathustra e sull’evoluzione dell’altro fanciullo Gesù, in cui poi Zarathustra ha vissuto fino ai trent’anni –, vi direte: lì si ha a che fare con un uomo particolare per il cui essere la storia e l’evoluzione del mondo hanno fatto i più grandi preparativi, procurando due corpi umani e facendoli abitare dall’individualità di Zarathustra, l’uno fino ai dodici anni e l’altro dai dodici ai trenta.
Ci diremo allora: per via del fatto che quelle due figure di Gesù erano delle “individualità” così importanti, anche Gesù di Nazareth era a un livello alto, era asceso alla stessa via su cui prosegue di incarnazione in incarnazione l’individualità di un iniziato.
Ma a trent’anni, quando l’individualità del Cristo entra nel corpo di Gesù di Nazareth, l’Io di quest’ultimo ne abbandona immediatamente il corpo! E dal momento del battesimo di Giovanni – se adesso prescindiamo dal Cristo – abbiamo a che fare con un uomo che può essere definito nel vero senso della parola un “semplice uomo”, solo che si tratta del portatore del Cristo. Dobbiamo allora distinguere fra
• il portatore del Cristo e
• il Cristo stesso in questo portatore.
In quel corpo che è il portatore del Cristo non dimorava nessuna individualità umana che avesse conseguito un’evoluzione particolarmente elevata, dal momento che era stato abbandonato dall’individualità di Zarathustra. Lo stadio di evoluzione mostrato da Gesù di Nazareth derivava dal fatto che in lui viveva l’individualità di Zarathustra. Ma, come sappiamo, quella natura umana è stata abbandonata dall’individualità di Zarathustra.
È per questo che, non appena l’individualità del Cristo prese possesso di quella natura umana, questa gli mandò incontro tutto ciò che di solito proviene dalla natura umana – il “tentatore”. Ed è anche per questo che il Cristo è stato in grado di attraversare tutta l’angoscia che ci viene descritta negli avvenimenti sul Monte degli ulivi.
Non potrà giungere a una vera conoscenza dell’essere del Cristo chi trascura il fatto che Egli non ha abitato in un uomo che aveva raggiunto un particolare livello di iniziazione, ma in un uomo semplice che si distingueva dagli altri solo perché era l’involucro umano abbandonato in cui aveva vissuto Zarathustra.
Il portatore del Cristo era un vero uomo, non un adepto. Ma solo riconoscendolo ci si potrà schiudere un poco la visione sulla natura complessiva dell’evento del Golgota e della Palestina.
Se concepissimo il Cristo Gesù semplicemente come un iniziato di alto livello, lo dovremmo collocare all’interno di una serie di altre nature di adepti. Noi non lo facciamo. Ci potrebbero essere persone che ci dicono che non lo facciamo perché fin dall’inizio, per via di qualche preconcetto, vogliamo porre il Cristo Gesù al di sopra di tutti gli altri adepti, come un adepto ancor più elevato. Chi lo dicesse non saprebbe che cosa dobbiamo annunciare nella nostra epoca come risultato della ricerca esoterica.
Non si tratta di sottrarre qualcosa agli altri adepti. Nella concezione del mondo della quale dobbiamo far parte in base ai risultati spirituali del presente sappiamo altrettanto bene degli altri, sappiamo che esisteva come contemporaneo del Cristo Gesù un’altra importante individualità a proposito della quale possiamo dire che si trattava di un vero adepto.
E se non ci occupiamo con precisione dei fatti ci riesce addirittura difficile distinguere interiormente questo essere umano dal Cristo Gesù. Questo contemporaneo infatti gli assomiglia molto:
• Quando per esempio sentiamo che l’arrivo di questo contemporaneo del Cristo Gesù viene annunciato prima della sua nascita attraverso un’apparizione celeste, ci viene in mente l’annunciazione di Gesù nei vangeli;
• quando sentiamo che di questo contemporaneo non si poteva dire che discendesse solo da seme umano, ma che doveva essere definito figlio degli dei, questa affermazione ci ricorda di nuovo l’inizio del Vangelo di Matteo e di Luca;
• quando sentiamo dire che la nascita di quell’individualità ha sorpreso la madre, che ne è rimasta sconvolta, ci rammentiamo della nascita di Gesù di Nazareth e degli eventi di Betlemme narrati nei vangeli;
• quando poi sentiamo raccontare che, crescendo, questa individualità sorprendeva tutto il suo ambiente per via delle sagge risposte alle domande dei sacerdoti, ci ricordiamo della scena di Gesù dodicenne nel tempio. E
• quando ci viene addirittura detto che questa individualità si è recata a Roma, dove si è imbattuta nel corteo funebre di una fanciulla, ha bloccato il corteo e ha ridestato la morta, anche questo ci ricorda il risveglio di un morto nel Vangelo di Luca.
E di questa individualità contemporanea del Cristo Gesù ci vengono narrati innumerevoli miracoli, se di miracoli vogliamo parlare. Sì, è talmente simile al Cristo Gesù che si racconta che sia apparsa agli uomini dopo la morte, come il Cristo Gesù è apparso ai discepoli dopo la propria morte.
E se da parte cristiana vengono addotti tutti i motivi possibili per parlar male di questa individualità o perfino per negarne l’esistenza storica, questo non è più sensato dei pretesti accampati contro la storicità del Cristo Gesù stesso.
Questa individualità è Apollonio di Tiana, e di lui parliamo come di un vero adepto che è stato contemporaneo del Cristo Gesù.
Se ora ci chiediamo: in che cosa consiste la differenza fra l’esperienza del Cristo Gesù e quella di Apollonio? dobbiamo capire bene il carattere dell’esperienza di Apollonio.
Apollonio di Tiana è un’individualità che ha attraversato molte incarnazioni, che ha conquistato forze elevate e che mostra un certo culmine nell’incarnazione verificatasi all’inizio della nostra era. Questa individualità che vediamo attraversare molte incarnazioni in epoche anteriori è presente sulla scena terrestre quando vive nel corpo di Apollonio di Tiana, ed è con lei che abbiamo a che fare.
E poiché sappiamo che l’individualità umana è coinvolta nella costruzione del corpo umano, che non si tratta semplicemente di una dualità, ma che l’individualità umana elabora la forma del corpo in base al proprio Sé, dobbiamo dirci che il corpo di Apollonio di Tiana era strutturato nella sua forma nel senso di quell’individualità.
Non così possiamo dire per quanto riguarda il Cristo Gesù. Il Cristo è entrato nel corpo fisico, eterico e astrale di Gesù di Nazareth solo quando questi ha avuto trent’anni, non si è quindi plasmato questo corpo fin dall’infanzia. Il rapporto fra l’individualità del Cristo e il corpo è quindi completamente diverso da quello che abbiamo nel caso di Apollonio.
Se nello spirito rivolgiamo il nostro sguardo verso l’individualità di Apollonio di Tiana, ci diciamo: è una questione che riguarda solo questa individualità, la vita di Apollonio di Tiana si svolge come una questione unicamente sua. Se volessimo rappresentare graficamente, con un disegno esteriore l’andamento di una simile vita, lo potremmo fare nel modo seguente:
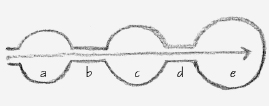
La linea orizzontale indica l’individualità che rimane uguale a se stessa. Allora in a abbiamo una prima incarnazione, in b una vita fra la morte e una nuova nascita, poi in c una seconda incarnazione, in d una vita fra la morte e una nuova nascita, in e una terza incarnazione e così di seguito. Ciò che attraversa tutte queste incarnazioni, l’individualità umana, è come il filo della vita umana al di fuori degli involucri, al di fuori dell’involucro del corpo astrale, di quello eterico e di quello fisico. Ma anche fra la morte e una nuova nascita si trova al di fuori di quello che resta del corpo eterico e di quello astrale. Per questo il filo della vita è sempre indipendente dal cosmo esteriore.
Invece per descrivere l’essenza della vita del Cristo dobbiamo procedere diversamente. Dobbiamo dire: se guardiamo le incarnazioni precedenti di Gesù di Nazareth, in un certo senso anche questa vita del Cristo si sviluppa così in un primo tempo. Ma se tracciamo il filo della vita, dobbiamo dire: nel trentesimo anno della vita di Gesù di Nazareth l’individualità abbandona questo corpo, così che d’ora in poi abbiamo solo l’involucro del corpo fisico, del corpo eterico e del corpo astrale.
Ma le forze sviluppate dall’individualità non si trovano negli involucri esteriori, bensì nel filo della vita dell’Io, che passa di incarnazione in incarnazione. Quindi le forze che appartengono all’individualità di Zarathustra, presente nel corpo di Gesù di Nazareth come preparazione, escono insieme all’individualità di Zarathustra.
Per questo diremo: l’involucro rimasto è una normale organizzazione umana. Nella misura in cui prendiamo in considerazione l’individualità, non si tratta di un’organizzazione umana che potrebbe essere definita di un iniziato, ma si tratta di un semplice uomo, di un debole uomo.
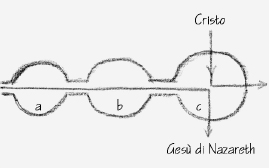
E ora subentra l’evento oggettivo: mentre di solito il filo della vita prosegue semplicemente come in a e in b, arrivato a c prende una via laterale. Ma in cambio, tramite il battesimo nel Giordano, in quella triplice organizzazione entra l’Entità cristica.
Questa Entità cristica vive come tale dal momento del battesimo nel Giordano fino al trentatreesimo anno, fino all’evento del Golgota, come abbiamo spesso descritto.
Ma allora chi riguarda la vita del Cristo Gesù dai trenta ai trentatré anni? Non è una questione di un’individualità passata di incarnazione in incarnazione, ma di quell’individualità che dal cosmo si è calata nel corpo di Gesù di Nazareth. Riguarda un’individualità, un’Entità, che prima di allora non era mai stata legata alla Terra, che dal cosmo si è unita a un corpo umano.
In questo senso gli avvenimenti che hanno luogo fra il trentesimo e il trentatreesimo anno della vita di Gesù, cioè fra il battesimo nel Giordano e il mistero del Golgota, sono gli eventi dell’essere divino chiamato Cristo, e non di un uomo. Quella che si verifica non è quindi una faccenda che riguarda la Terra, ma una che interessa il mondo sovrasensibile. Infatti non aveva niente a che fare con un uomo.
In segno di questo, l’uomo che aveva occupato quel corpo fino al trentesimo anno lo ha abbandonato.
Quello che lì accade allora, ha a che fare con quegli eventi verificatisi prima che un filo della vita come quello umano entrasse in un’organizzazione fisica. Dobbiamo tornare indietro fino all’antica epoca lemurica, l’epoca in cui per la prima volta delle individualità umane sono scese dalle altezze divine per incarnarsi in corpi terreni – fino all’evento che nell’Antico Testamento ci viene indicato come la “tentazione del serpente”.
Si tratta di un evento molto singolare, delle cui conseguenze hanno sofferto tutti gli uomini mentre si incarnavano. Se infatti questo evento non si fosse verificato, tutta l’evoluzione dell’umanità sulla Terra sarebbe stata diversa, gli esseri umani sarebbero passati di incarnazione in incarnazione in uno stato molto più perfetto. Ma per via di questo avvenimento sono rimasti irretiti più profondamente nella materia, e questa condizione viene descritta allegoricamente come “peccato originale”.
È però stato il peccato originale a chiamare l’uomo alla sua attuale individualità, così che egli, passando come individualità di incarnazione in incarnazione, non è responsabile del peccato originale.
Sappiamo che del peccato originale sono responsabili gli spiriti luciferici, per questo dobbiamo dirci: prima che l’uomo divenisse uomo in senso terrestre, ha avuto luogo l’evento divino, sovrumano, attraverso il quale all’uomo è stato imposto un più profondo irretimento con la materia. È vero che grazie a questo evento l’uomo è giunto alla forza dell’amore e della libertà, ma gli è stato imposto qualcosa che con le sue sole forze non si sarebbe potuto addossare.
Questo irretimento nella materia non è stata opera umana, ma divina, realizzata prima che gli uomini potessero prender parte al proprio destino. Si è trattato di un accordo fra le potenze superiori dell’evoluzione progressiva e quelle luciferiche. Dovremo occuparci in modo ancor più dettagliato di tutti questi eventi, ma oggi ci limiteremo a osservarne i tratti principali.
Quello che accadde a quei tempi aveva bisogno di un contrappeso. Il fatto sovrumano del peccato originale, verificatosi nell’uomo, necessitava di un bilanciamento, qualcosa che a sua volta non fosse per così dire una faccenda degli uomini ma una faccenda degli esseri divini fra di loro.
Vedremo che questa vicenda doveva svolgersi al di sotto della materia, nella stessa misura in cui l’altra se n’era svolta al di sopra, prima che l’uomo venisse irretito nella materia. Il divino doveva immergersi nella materia tanto a fondo quanto vi aveva immerso gli uomini.
Lasciando agire su di voi questo fatto con tutto il suo peso, capirete che questa incarnazione del Cristo in Gesù di Nazareth era una questione che riguardava il Cristo stesso.
E a che scopo è stato coinvolto l’uomo? Dapprima per assistere al modo in cui la divinità compensa il fatto del peccato originale, come ne crea la controazione.
Non lo si sarebbe potuto fare nella personalità di un adepto, poiché questa è risalita da sola dalla caduta nella materia. Lo si poteva fare solo in una personalità che fosse del tutto un “vero uomo”, che come uomo non fosse superiore ai propri simili. Li ha superati prima di compiere i trent’anni, ma dopo non più.
Grazie a quello che è successo, l’evoluzione dell’umanità ha quindi preso parte a un evento divino come al suo inizio in epoca lemurica. E gli uomini sono stati partecipi di una vicenda svoltasi fra gli dei, hanno potuto vederla perché gli dei sono ricorsi al mondo fisico per attuare quella loro faccenda.
Per questo, invece di qualsiasi altra formula, è molto meglio dire che il Cristo offrì agli dei quell’espiazione che poteva offrire solo in un corpo fisico umano. E per gli uomini si è trattato di assistere a un evento divino.
Ma con ciò era successo anche qualcosa per la natura umana. Gli uomini l’hanno semplicemente sentito nella loro evoluzione. E in tal modo si è aperta la terza via, che divenne possibile oltre alle due indicate. Questa terza via è stata spesso segnalata da uomini che si sono calati a fondo nella loro cristianità.
Della vasta schiera che potrebbe essere nominata desidero citare solo due persone che hanno testimoniato in maniera eccellente il fatto che il Cristo – che dal ventesimo secolo in poi potrà essere visto per mezzo delle facoltà umane ulteriormente evolute – possa essere riconosciuto, sentito e sperimentato grazie alle sensazioni che prima dell’evento del Golgota non erano possibili nella stessa forma.
Uno è per esempio quello spirito che in tutta la sua evoluzione animica può essere considerato un accanito oppositore di quello che abbiamo descritto come gesuitismo: Blaise Pascal, che occupa una posizione di rilievo nell’evoluzione spirituale, come uno spirito che ha abbandonato tutto ciò che nelle antiche chiese è emerso sotto forma di danni, ma che non ha neppure assorbito nulla dal razionalismo moderno.
Come tutti i grandi spiriti, anche lui in fondo è rimasto solo con i suoi pensieri. Ma che cosa c’è alla base delle sue idee all’inizio dell’era moderna?
Dagli scritti che ci ha lasciato, soprattutto dai suoi interessanti Pensieri (Pensées) – facilmente accessibili a tutti in quanto pubblicati da edizioni correnti (Ed. BUR, [NdT])– si vede che cosa riteneva che sarebbero dovuti diventare gli uomini se nel mondo non ci fosse stato l’evento cristico.
Nell’intimo della sua anima Pascal si è domandato: che cosa ne sarebbe stato degli uomini se nessun Cristo fosse intervenuto nell’evoluzione dell’umanità? E si è risposto: lo possiamo sentire nel fatto che nell’anima l’uomo va incontro a due pericoli.
Il primo consiste nel riconoscere il dio come identico alla propria natura: conoscenza divina nella conoscenza umana. Dove porta? Se sorge in modo che l’uomo riconosca il dio in se stesso, porta all’orgoglio, alla superbia, all’arroganza. E l’uomo finisce per annullare le proprie forze migliori perché le indurisce nella superbia e nell’orgoglio.
Questa conoscenza di Dio sarebbe sempre stata possibile, anche senza la venuta di un Cristo, anche se l’evento cristico non avesse agito come impulso in tutti i cuori umani. Gli uomini avrebbero sempre potuto conoscere Dio, ma questa conoscenza nel loro petto li avrebbe resi superbi.
Oppure ci sarebbero stati uomini che si sarebbero chiusi alla conoscenza di Dio, che si sarebbero rifiutati di conoscerlo. Il loro sguardo si sarebbe posato su qualcos’altro: sull’impotenza umana, sulla miseria umana. E da questo sarebbe necessariamente derivata la disperazione. Questo sarebbe stato l’altro pericolo, il rischio corso da quelli che non volevano conoscere Dio.
Pascal sostiene la possibilità di due sole vie: orgoglio e superbia o disperazione.
Allora nell’evoluzione dell’umanità ha fatto il proprio ingresso l’evento cristico, facendo sì che ogni uomo ricevesse una forza che gli facesse sentire non solo la divinità, ma anche quell’essere divino che è stato uguale agli uomini, che ha vissuto con loro.
L’unica cura per l’orgoglio è dirigere lo sguardo sul dio che si è steso alla croce, fare in modo che l’anima guardi all’essere divino che si è piegato alla morte in croce. Questo è però anche l’unico rimedio a tutta la disperazione, poiché quest’umiltà non rende deboli, ma dà una forza che trascende e guarisce ogni disperazione.
Secondo Pascal, il Salvatore, il Redentore appare nell’anima umana come mediatore fra l’orgoglio e la disperazione. È qualcosa che ogni uomo può sentire, anche senza chiaroveggenza. Ed è la preparazione per il Cristo che a partire dal ventesimo secolo diventerà visibile per tutti gli uomini, che sorgerà nel petto di ogni uomo come salvatore dall’orgoglio e dalla disperazione e che prima non poteva essere sentito in questo modo.
E il secondo testimone che desidero citare dalla vasta schiera di coloro che sentivano ciò che è tipico di ogni cristiano è Vladimir Soloviev, già nominato in altre occasioni.
Anche lui accenna a due forze nella natura umana, fra le quali deve far da mediatore il Cristo personale. Soloviev dice che l’anima umana ha nostalgia di due cose: della saggezza e dell’immortalità o del perfezionamento morale. Entrambe tuttavia non fanno parte fin dall’inizio della natura umana. Essa infatti condivide le peculiarità di tutti gli esseri di natura, e la natura non porta all’immortalità bensì alla morte.
E questo grande pensatore contemporaneo illustra servendosi di belle riflessioni come anche la scienza esteriore dimostri che la morte si diffonde su ogni cosa. Se guardiamo nella natura esteriore, essa risponde alla nostra conoscenza: la morte esiste! Eppure in noi vive il desiderio di immortalità. Per quale motivo? Perché in noi vive l’anelito al perfezionamento, e per rendercene conto è sufficiente uno sguardo all’anima umana. Soloviev dice che com’è vero che la rosa rossa è dotata del colore rosso, così è vero che l’anima umana è dotata dell’anelito al perfezionamento.
Ma un’aspirazione al perfezionamento senza desiderio di immortalità sarebbe una menzogna dell’esistenza, sostiene Soloviev, poiché sarebbe assurdo che l’anima finisse con la morte come ogni esistenza naturale. Ma ogni esistenza naturale ci risponde che la morte esiste. Per questo, secondo questo filosofo, l’anima umana è costretta a trascendere l’esistenza naturale e a cercare altrove la risposta.
A questo punto Soloviev aggiunge: guardate gli studiosi di scienze naturali. Che risposta vi danno quando vogliono insegnare il rapporto della natura? Dicono che ovunque regna un ordine meccanico naturale in cui l’uomo è inserito. E che cosa vi rispondono i filosofi? Un vuoto e astratto mondo di pensieri pervade tutti i fatti della natura come elemento spirituale riconoscibile a livello filosofico. Nessuna delle due rappresenta una risposta se l’uomo prende coscienza di sé e partendo da questa coscienza chiede che cos’è il perfezionamento.
Quando diviene consapevole di dover avere la nostalgia del perfezionamento, dell’immortalità, e quando richiede la forza che possa soddisfare questo anelito, gli si apre la visione su un regno che dapprima si presenta come una domanda, come un enigma per l’anima umana senza la cui soluzione essa può considerarsi solo una menzogna: il regno della grazia al di sopra del regno della natura.
Il regno della grazia non può essere collegato all’esistenza da nessuna filosofia, da nessuna scienza, poiché le forze della natura agiscono meccanicamente, mentre quelle del pensiero hanno solo realtà di pensiero. Ma esiste qualcosa che è dotato di piena realtà per mettere l’anima in relazione con il regno della grazia?
Questo qualcosa è il Cristo personale che opera nel mondo! Solo il Cristo vivente può dare la risposta, non quello puramente pensato. Secondo Soloviev il Cristo puramente pensato lascia l’anima da sola, poiché essa non è in grado di dare alla luce da sola il regno della grazia. La risposta reale, e non concettuale, ci viene fornita da ciò che trascende la natura, da ciò che esiste come realtà quanto la natura stessa, cioè dal Cristo personale, storico.
Ed ora questo filosofo giunge alla risposta più estrema, più arguta che potesse essere data alla fine dell’epoca che si chiude appena prima che nel ventesimo secolo le porte si aprano a quello che così spesso vi è stato accennato: ci sarà una visione del Cristo che avrà inizio nel ventesimo secolo.
Avvertendo questo fatto, la coscienza descritta in modo classico da Pascal e Soloviev veniva chiamata “fede”. Anche altri le hanno dato questo nome.
Per quanto concerne l’anima umana, con il concetto di fede si può arrivare a un singolare conflitto in due direzioni. Date un’occhiata all’evoluzione del concetto di fede ed esaminate la critica relativa a tale concetto. Oggi si è così progrediti da dire che la fede dev’essere guidata dal “sapere”, che una fede non basata sul sapere va scartata. La fede dev’essere per così dire deposta e sostituita dal sapere.
Nel Medioevo erano appunto i mondi superiori a costituire l’oggetto della fede, che veniva considerata come qualcosa di legittimo. Questo è anche il punto nevralgico del protestantesimo: vedere la fede come qualcosa di legittimo accanto al sapere. Così la fede è qualcosa che promana dall’anima umana e che viene posta al fianco del sapere che dev’essere comune a tutti.
È anche interessante vedere che un filosofo come Kant, da molti ritenuto grande, non sia andato oltre questo concetto di fede. Il suo concetto di fede tende infatti a ritenere che tutto ciò che l’uomo deve conquistare riguardo a cose come Dio, l’immortalità e via dicendo deve risplendere in lui da regioni completamente diverse, da una fede allo stato puro, e non dal sapere.
Il concetto di fede arriva al suo massimo sviluppo con il filosofo che vi ho appena citato, con Soloviev, che appare il più importante prima dell’apertura della porta, come se già indicasse il nuovo mondo. Il suo concetto di fede infatti è completamente diverso da tutti quelli che l’hanno preceduto.
Dove ha portato l’umanità il concetto di fede finora esistito? L’ha condotta alla richiesta ateistico-materialistica della semplice conoscenza del mondo esteriore – nel senso luterano-kantiano o in quello del monismo del diciannovesimo secolo – di quel sapere che si vanta della conoscenza e considera la fede come qualcosa che fino a un certo punto l’anima umana si è creata necessariamente a partire dalla propria debolezza.
Il concetto di fede è arrivato fin lì poiché veniva ritenuto qualcosa di puramente soggettivo. Mentre nei secoli precedenti la fede era ancora richiesta come una necessità, il diciannovesimo secolo l’ha osteggiata poiché essa si pone in contrapposizione al sapere che deriva dall’anima umana come qualcosa di universalmente valido.
E ora arriva un filosofo che in un certo senso riconosce il concetto di fede per conquistare un rapporto con il Cristo fino a quel momento impossibile, un filosofo che vede la questione in modo tale da riconoscere in quella fede, nella misura in cui si riferisce al Cristo, come un fatto della necessità, del dovere interiore. Il principio di Soloviev non è infatti: “credere o non credere”, ma per lui la fede diventa di per sé una necessità.
Questo filosofo ritiene che siamo obbligati a credere nel Cristo, perché altrimenti dovremmo annullarci e definire una menzogna la nostra esistenza. La fede si presenta nell’anima umana come la sua vera natura, proprio come la struttura cristallina in una sostanza minerale. Per questo l’anima deve dirsi: se riconosco la verità di me stessa e non la menzogna, allora devo realizzare la fede dentro di me, sono costretta alla fede. Ma ci posso arrivare solo con la mia azione libera.
È in questo che Soloviev vede per così dire l’elemento distintivo dell’azione del Cristo, nel fatto che la fede è una necessità e nel contempo un’azione moralmente libera. All’anima viene detto in un certo senso: se non ti vuoi estinguere non puoi far altro che guadagnarti la fede, ma con una tua libera azione.
E come Pascal anche questo filosofo mette in relazione con il Cristo Gesù storico quello che l’anima sperimenta per non sentirsi una menzogna, con l’ingresso del Cristo Gesù nell’evoluzione dell’umanità per mezzo degli eventi della Palestina.
Per questo Soloviev dice: se Cristo non fosse entrato nell’evoluzione umana come lo si deve pensare dal punto di vista storico, non avrebbe portato l’anima a sentire sia la necessità legittima della fede che la libera azione interiore, e così l’anima umana nell’epoca postcristiana sarebbe stata costretta ad annullare se stessa, a dirsi «Io non sono» anziché «Io sono».
Secondo questo filosofo l’evoluzione nell’era postcristiana avrebbe comportato una compenetrazione dell’anima umana da parte della convinzione «Io non sono». Ma nell’istante in cui l’anima si decide ad agire per attribuirsi l’esistenza non può far altro che ricondursi al Cristo Gesù storico.
E con ciò abbiamo constatato l’esistenza di una terza via anche per il progresso generale esteriore sul cammino della fede.
• Attraverso i messaggi dei vangeli chi non è in grado di guardare direttamente nel mondo spirituale può giungere a riconoscere il Cristo.
• Può arrivare al riconoscimento del Cristo anche per mezzo di ciò che la coscienza chiaroveggente gli ha sempre detto.
• Ma in effetti c’erano tre vie: oltre alle prime due esiste anche quella della conoscenza di sé che, come i testimoni citati possono mostrarci di aver sperimentato insieme a migliaia di altre persone, porta a rendersi conto che l’autoconoscenza umana nell’era postcristiana è impossibile senza collocare il Cristo Gesù accanto all’uomo, che l’anima deve negare se stessa oppure, se si vuole affermare, lo deve fare affermando nel contempo anche il Cristo Gesù.
Nei prossimi giorni vedremo come mai le cose non stavano così in epoca precristiana.
Quarta conferenza
L’evento cristico
Come fatto spirituale
Karlsruhe, 8 ottobre 1911
Se ricordate come abbiamo concluso la nostra riflessione di ieri, forse potete riassumerne il risultato con queste parole: dagli eventi in Palestina, dal mistero del Golgota in poi, fino all’inizio di quell’epoca che è stata descritta a sufficienza e al cui ingresso ci troviamo attualmente, l’evento cristico era tale per cui l’uomo in generale poteva arrivare lungo strade diverse a sperimentare in qualche modo l’impulso cristico prima della vera e propria iniziazione.
Abbiamo detto che una di queste vie generali era quella dei vangeli, del Nuovo Testamento. Da tutto ciò che è stato detto possiamo infatti desumere che il contenuto dei vangeli, se lo accogliamo adeguatamente nella nostra anima lasciandolo agire su di noi, fa davvero emergere un’esperienza interiore per ogni singolo individuo. Tale esperienza interiore può appunto essere definita “l’esperienza del Cristo”.
Poi abbiamo detto che l’altra via per il non iniziato consisteva nell’occuparsi di ciò che l’esoterista, in un certo senso l’iniziato, poteva trasmettere dai mondi spirituali. Così anche chi si trovava ancora sulla soglia dell’iniziazione poteva giungere all’evento cristico non solo grazie ai vangeli tramandati, ma anche per mezzo delle continue rivelazioni dai mondi spirituali.
Ieri abbiamo poi citato una terza via, quella dell’approfondimento interiore dell’animo, facendo notare che nella nostra anima questa via deve prendere le mosse dai sentimenti, poiché l’uomo, se sente dentro di sé solo la scintilla divina può essere spinto all’orgoglio e alla superbia, mentre se non diventa consapevole del rapporto con Dio può essere portato alla disperazione.
Dopo di che abbiamo visto come in effetti, dagli eventi della Palestina in poi e in considerazione di essi, l’oscillare fra la disperazione da una parte e l’orgoglio e la superbia dall’altra faccia nascere in noi l’esperienza del Cristo.
È stato anche fatto notare come tutto questo cambierà per l’evoluzione dell’umanità nei prossimi tre millenni, a partire dall’inizio della nostra epoca. Abbiamo segnalato l’importante evento che fa seguito al mistero del Golgota, ma che sarà visibile solo nei mondi sovrasensibili.
Ma abbiamo anche accennato al fatto che le facoltà umane subiranno un incremento e che a partire dalla nostra epoca un numero sufficientemente grande di persone giungerà a vedere il Cristo, così che quella che finora è esistita legittimamente nel mondo come “fede” verrà sostituita da quella che può essere chiamata la “visione” del Cristo.
Ora sarà nostro compito descrivere ulteriormente nel corso delle conferenze come dal modo consueto dell’esperienza cristica, come esperienza dell’animo, si apra in maniera del tutto adeguata la via a quella che possiamo chiamare l’iniziazione cristiana.
Nei prossimi giorni dovremo parlare più dettagliatamente della struttura dell’iniziazione cristiana, e avremo anche il compito di descrivere in maniera più approfondita la natura dell’evento cristico. In questi giorni dovremo quindi farci un’immagine dell’iniziazione cristiana e dell’evento cristico dal battesimo di Giovanni fino al compimento del mistero del Golgota.
Se prendete in considerazione le osservazioni fatte finora, è possibile che sorga in voi la domanda, del tutto legittima: qual è allora il rapporto fra il cristianesimo esteriore, fra l’evoluzione cristiana che vediamo nella storia, e l’evento cristico stesso?
A chiunque sia nel presente con la propria coscienza, che abbia attraversato particolari esperienze affettive di natura mistica o abbia alle spalle gli stadi iniziali dell’esoterismo, deve sembrare strano che per tutti gli uomini un certo tipo di esperienza animica, l’esperienza cristica interiore, debba dipendere da un fatto storico, dagli eventi della Palestina e del Golgota, e che prima di allora per l’anima di ogni uomo non fosse possibile ciò che questi eventi hanno permesso.
Di questo fatto avevano chiaramente coscienza le guide dei primi cristiani e anche i primi cristiani stessi. E per prepararci ai prossimi giorni è bene che oggi forniamo qualche cenno su come questo appariva negli animi dei primi cristiani.
Si potrebbe facilmente credere – cosa che in seguito è diventata sempre più una sorta di opinione ortodossa e molto unilaterale – che fra gli uomini dell’epoca precristiana e quelli dell’era postcristiana ci fosse una radicale differenza. Che questa convinzione sia unilaterale lo potete già dedurre dalle parole di Agostino: «Questa che ora si chiama religione cristiana c’era anche presso gli antichi, e non mancò dall’inizio del genere umano, fino a quando lo stesso Cristo venne nella carne, e da allora la vera religione, che già esisteva, cominciò a chiamarsi cristiana».
Ai tempi di Agostino si era quindi coscienti che fra le epoche precristiane e quelle postcristiane non c’era quella differenza radicale che presumono l’ortodossia e il fanatismo.
Anche Giustino martire presenta una versione del tutto singolare nei suoi scritti. Giustino, riconosciuto come martire e padre della Chiesa anche dalla Chiesa, si dilunga sul rapporto di Socrate e Platone con il Cristo. In quest’ultimo vede veramente ancora con una certa chiarezza ciò che abbiamo descritto ieri nella relazione fra il Cristo e Gesù di Nazareth, e in tal senso espone anche la sua idea dell’Essere cristico. In base al suo tempo, dice quello che anche noi oggi potremmo ripetere con le stesse parole: il Cristo o il Logos si era incarnato nell’uomo Gesù di Nazareth.
A quel punto si chiede se il Logos non sia stato presente anche nelle personalità eccellenti dell’era precristiana, se in epoca precristiana il Logos sia stato del tutto estraneo all’uomo. A questa domanda Giustino martire risponde di no. Non è affatto così, sostiene, anche Socrate e Platone erano uomini in cui ha vissuto il Logos, solo che non l’hanno posseduto completamente.
Solo grazie all’evento cristico l’uomo può fare dentro di sé la piena esperienza del Logos nella sua forma originaria e perfetta.
Da questo brano di un personaggio riconosciuto in tutto e per tutto come padre della Chiesa apprendiamo in primo luogo che i primi cristiani erano a conoscenza di ciò «che era sempre esistito», come dice Agostino, e che ora è entrato in forma più elevata nell’evoluzione della Terra per mezzo del mistero del Golgota.
In secondo luogo apprendiamo una risposta proveniente dai primi secoli cristiani alla domanda che noi stessi abbiamo dovuto sollevare oggi. Anche gli uomini che, come Giustino martire, erano ancora vicini all’evento del Golgota, che avevano molte più conoscenze sulla natura di quegli uomini che, come Platone e Socrate, erano lontani da loro solo pochi secoli, quegli uomini allora pensavano: è pur vero che è vissuto un uomo eccellente come Socrate, ma costui, pur avendo fatto l’esperienza del Logos, non poteva ancora viverlo dentro di sé pienamente, nella sua forma più intensa. E questo è importante.
È per così dire come una testimonianza proveniente dai tempi antichi di come allora si sentisse veramente che – a prescindere dall’evento del Golgota – fra i secoli precristiani e quelli postcristiani c’era qualcosa che distingueva gli uomini vissuti prima di Cristo da quelli vissuti dopo di Lui. E in un certo senso – altre cose ce ne fornirebbero innumerevoli prove – è possibile dimostrare storicamente che nella coscienza dei primi secoli si sapeva che la natura umana si è modificata e ha assunto un’altra costituzione.
Praticamente se nel terzo secolo dopo Cristo si guardava indietro agli uomini del terzo secolo avanti Cristo, ci si poteva dire: anche se a modo loro erano in grado di penetrare a fondo nei segreti dell’esistenza, quello che può verificarsi negli uomini postcristiani in loro non poteva aver luogo!
Quindi l’affermazione di Giovanni il Battista: «Cambiate la vostra concezione del mondo, la vostra visione del mondo, poiché i tempi sono cambiati!» e la conferma della scienza dello spirito si trovavano con forza e intensità anche nei primi secoli postcristiani. Dobbiamo renderci ben conto che se si vuole capire l’evoluzione dell’umanità occorre abbandonare l’opinione sbagliata secondo la quale l’uomo è sempre stato così com’è oggi.
A prescindere dal fatto che non si potrebbe collegare alcun senso alla reincarnazione, in base a tutto ciò che ci è stato tramandato e che ci viene mostrato dalla scienza dello spirito bisogna dirsi che gli uomini dei tempi antichi hanno davvero posseduto quella che oggi si trova solo nel subconscio, vale a dire una certa chiaroveggenza, che poi sono discesi da quella vetta di chiaroveggenza e che il punto più basso di quell’involuzione, dove si sono sviluppate le forze che hanno nascosto le facoltà chiaroveggenti, corrisponde all’epoca in cui ha avuto luogo il mistero del Golgota.
Sul piano materiale gli uomini credono che una minima quantità di sostanza possa influenzare una gran massa di liquido. Se per esempio versate una goccia di una certa sostanza in un liquido, questa si espande nella materia liquida, colorandola tutta. In ambito materiale chiunque può rendersene conto.
Ma è impossibile capire la vita spirituale senza rendersi conto anche sul piano spirituale di ciò che si nota così facilmente su quello materiale.
La nostra Terra non è semplicemente il corpo materiale che vedono i nostri occhi, ma è dotata anche di un involucro spirituale. Come noi abbiamo un corpo eterico e un corpo astrale, così anche la nostra Terra possiede questi corpi superiori. E come una piccola quantità di sostanza si espande in un liquido, così ciò che si è sprigionato spiritualmente dal fatto avvenuto sul Golgota si è propagato nell’atmosfera spirituale della Terra, l’ha permeata e da allora è contenuto in essa.
Da quel momento quindi alla nostra Terra è stato trasmesso qualcosa che prima non aveva. E poiché le anime non vivono semplicemente circondate ovunque dalla materia, ma sono come gocce che vivono nel mare dell’elemento spirituale terreno, da allora gli uomini sono immersi nell’atmosfera spirituale della nostra Terra, pervasa dall’impulso cristico.
Le cose non stavano così prima del mistero del Golgota, e questa è la grande differenza fra la vita precristiana e quella postcristiana. Se non si riesce a immaginare che avvenga qualcosa del genere nella vita spirituale, non si è ancora in condizione di concepire davvero il cristianesimo come “fatto mistico” il cui pieno significato può essere conosciuto e riconosciuto solo nel mondo spirituale.
Chi risale alle dispute, sotto un certo aspetto sgradevoli, sulla natura e sulla personalità di Gesù di Nazareth e sulla natura e sull’individualità del Cristo, potrà sentire ovunque nelle concezioni gnostiche e mistiche dei primi secoli cristiani come gli individui migliori che a quei tempi si adoperavano per la diffusione del cristianesimo avessero effettivamente un atteggiamento di timorosa venerazione nei confronti di quel fatto mistico del cristianesimo.
E proprio nei primi maestri cristiani, nonostante a volte siano abbastanza astratti nelle loro parole e nelle loro frasi, si nota chiaramente che atteggiamento di timoroso rispetto abbiano per tutto ciò che è avvenuto per l’evoluzione del mondo attraverso il cristianesimo, come in un certo senso si ripetano in continuazione: in effetti il debole intelletto umano e le deboli forze umane del sentimento non bastano per esprimere l’enorme importanza e profondità di ciò che è accaduto con il mistero del Golgota.
È questa incapacità di esprimere veramente le verità più alte che devono essere toccate che attraversa come un soffio magico i primi insegnamenti cristiani. E leggendo questi scritti si può trarre un buon insegnamento anche ai nostri giorni. Vi si può imparare a coltivare una certa umiltà nei confronti delle supreme verità.
E, se si possiede la necessaria umiltà e modestia di fronte a ciò che si può conoscere ora, alle soglie di un’epoca cristiana diversa da quella dei primi secoli del cristianesimo, si arriva a potersi dire: certo, sarà possibile conoscere di più. Ma chiunque oggi voglia osare parlare dei misteri del cristianesimo dovrebbe essere cosciente del fatto che ciò che possiamo dire oggi sulle più profonde verità dell’evoluzione dell’umanità risulterà imperfetto già nel giro di poco tempo.
Dato che vogliamo arrivare gradualmente a una descrizione più profonda del cristianesimo, è necessario che già ora sottolineiamo quale dev’essere l’atteggiamento interiore dell’uomo nei riguardi del mondo spirituale se vuole accogliere o addirittura diffondere le verità che possono affluire a noi a partire dal diciannovesimo secolo e dagli inizi del ventesimo.
Anche se non si parla tanto del concetto di “grazia”, occorre però esercitarlo molto nella pratica. Oggi ogni occultista si rende conto che questo concetto di grazia deve far parte a un livello particolare della sua pratica di vita interiore. In che senso?
Nel senso che oggi si possono svolgere delle ricerche – indipendentemente dai vangeli e da ogni informazione tramandataci sulle verità più profonde in relazione al cristianesimo –, ma tutto ciò che è legato a una certa brama di conoscenza, alla smania di arrivare il più in fretta possibile a una determinata somma di concetti, finisce per portare, se non all’errore vero e proprio, quantomeno a una deformazione della verità.
Sbaglierebbe di sicuro chi si dicesse: «Dal momento che ho una preparazione esoterica, devo fornirmi chiarimenti su come conoscere per esempio le Lettere di Paolo o il Vangelo di Matteo nel loro contenuto», sbaglierebbe chi lo volesse fare con la convinzione di venirne a capo a un certo punto.
È possibile penetrare umanamente questi documenti, ma oggi non si può ancora conoscere tutto ciò che si può sapere. Proprio per il ricercatore spirituale vi è infatti una regola aurea in proposito: aver pazienza e aspettare finché non vorremo più essere noi a capire le verità, ma saremo pronti a lasciarle venire da noi.
Allora qualcuno si potrà accostare alle Lettere di Paolo e si sentirà pronto a riconoscere questo o quello poiché ne ha la percezione nel mondo spirituale grazie al suo occhio aperto. Ma se nello stesso momento volesse comprendere un altro brano, magari immediatamente successivo, non ci riuscirebbe. Al giorno d’oggi è necessario reprimere questa brama di conoscenza.
Occorre piuttosto dirsi: la grazia mi ha portato un certo numero di verità, e io aspetterò con pazienza che me ne giungano altre.
Oggi è davvero necessario un atteggiamento “passivo” nei confronti delle verità più di quanto non lo fosse vent’anni fa. Occorre che prima i nostri sensi maturino del tutto perché poi le verità possano entrare in noi nella loro giusta forma. Questo è un insegnamento pratico in riferimento allo studio dei mondi spirituali, soprattutto per quanto riguarda l’evento cristico.
È assolutamente sbagliato credere di poter afferrare ciò che deve invece affluire in modo ricettivo. Dobbiamo infatti aver coscienza che possiamo essere quello che dobbiamo essere solo nella misura in cui le potenze spirituali ci riterranno degni di essere questo o quello. E tutti i nostri sforzi nel senso di meditazioni, contemplazioni e così via hanno in definitiva l’unico scopo di aprirci gli occhi, non di farci cogliere le verità che ci devono arrivare e a cui non dobbiamo correr dietro.
In un certo modo i nostri tempi sono maturi affinché quelli che nella loro evoluzione animica sviluppano attraverso la passività una fervida disposizione d’animo, così come abbiamo descritto, si rendano conto di quanto è stato detto prima e che oggi sta in cima alle nostre considerazioni: che dal fatto avvenuto sul Golgota è scaturito qualcosa di simile a una sostanza spirituale in gocce.
Oggi le anime hanno la maturità necessaria per rendersene conto. E non avremmo molte cose portate dai tempi nuovi se le anime non volessero maturare in questo modo.
Mi basta richiamare la vostra attenzione su una cosa: se l’anima di Richard Wagner non fosse maturata in un certo modo ricettivo, se lui non avesse intuito in un certo modo il mistero del Golgota, il fluire di ciò che penetrava goccia a goccia nell’atmosfera dell’umanità terrena, non avrebbe potuto regalarci il Parsifal. Lo si può leggere in Richard Wagner laddove parla del significato del sangue di Cristo.
E nella nostra epoca possiamo trovare molti spiriti di questo tipo che ci mostrano come ciò che si libra nell’atmosfera venga afferrato dalle anime in cui penetra.
E la scienza dello spirito esiste perché in effetti oggi molte anime, più di quante lo sappiano, hanno la possibilità di ricevere dal mondo spirituale influssi simili a quelli descritti. Ma per farlo queste anime hanno bisogno di una facilitazione mediante la comprensione del mondo spirituale. In sostanza nessuno dal cuore immaturo trova accesso alla scienza dello spirito, nessuno che non abbia un desiderio più o meno sincero di conoscere alcuni aspetti di quanto è appena stato illustrato.
Può anche darsi che alcuni siano spinti a entrare nel movimento scientifico-spirituale dalla curiosità o da sentimenti analoghi, ma coloro che vi vengono condotti con cuore sincero provano il desiderio di aprire la loro anima a ciò che si prepara a partire dal nostro tempo verso l’epoca futura dell’evoluzione dell’umanità.
Oggi gli uomini hanno bisogno della scienza dello spirito perché le anime diventeranno qualcosa di diverso da quello che erano ancora poco tempo fa. Come hanno subito un grande cambiamento nel periodo in cui ha avuto luogo l’evento del Golgota, così ne vivranno uno altrettanto grande nel nostro secolo e in quelli successivi.
E la nascita del movimento scientifico-spirituale è in relazione col fatto che le anime, pur non avendone chiara coscienza, hanno la vaga sensazione che nella nostra epoca avvenga qualcosa di analogo.
Per questo è diventato necessario che proprio sul terreno dell’evoluzione scientifico-spirituale venisse dato inizio a un certo confronto con i fondamenti dei vangeli. E se, grazie a una sincera sensazione interiore, riuscite a convincervi che nell’evento cristico, così com’è stato presentato ieri, c’è qualcosa di vero, troverete comprensibile quel che è successo nella spiegazione dei vangeli.
Capirete allora che con la nostra interpretazione scientifico-spirituale dei vangeli è stato fatto qualcosa di molto diverso da quelle dei secoli passati. Se infatti si prendono in mano i cicli di conferenze già stampati o ci si ricorda delle conferenze che si ricollegano ai vangeli, si vedrà che ovunque si è risaliti a veri significati che non possono più emergere se ci si basa sull’odierno testo dei vangeli.
In parole povere questo non significa altro che dalle attuali traduzioni dei vangeli l’uomo non può più giungere a quello che i vangeli vogliono effettivamente indicare. Così come sono oggi, sono in un certo senso inutilizzabili.
Che cosa è successo quindi per una spiegazione dell’evento cristico e cosa deve succedere?
Coloro che si avvicinano alla comprensione del Cristo lungo la via scientifico-spirituale devono rendersi conto che i vangeli sono stati scritti da persone che potevano osservare l’evento cristico spiritualmente, con l’occhio spirituale, che perciò non volevano scrivere una biografia esteriore, ma hanno preso le antiche scritture iniziatiche – trovate una descrizione più dettagliata di questi nessi nel mio libro Il cristianesimo come fatto mistico – e hanno fatto notare come ciò che era avvenuto nelle profondità dei misteri si è verificato nell’evento cristico attraverso il passaggio divino dell’evoluzione dell’umanità sul piano della storia.
Quindi quello che è accaduto in piccolo a chi veniva iniziato ai misteri si è verificato in grande sul piano della storia universale con l’Entità che chiamiamo Cristo, senza la preparazione necessaria per gli altri uomini e senza la segretezza dei misteri. Ciò che prima poteva essere conosciuto solo dagli occhi degli iniziati nel più profondo santuario dei misteri si è svolto sotto gli occhi di tutti.
Si tratta nuovamente di qualcosa che i primi maestri cristiani hanno sentito con timore reverenziale. Quando si rivolgevano a ciò che i vangeli dovevano essere, allora nei veri maestri cristiani nasceva il sentimento della loro indegnità a coglierne il nocciolo e il vero significato.
Ma lo stesso fatto ha prodotto anche qualcos’altro che è legato alla necessità di interpretare oggi i vangeli così come lo si fa nel movimento scientifico-spirituale. Se avete seguito le spiegazioni dei vangeli fatte qui, avrete notato che innanzitutto alla loro base non è stato posto quanto ci viene fornito dai libri dei vangeli a noi tramandati.
Quel che ci viene comunicato da tali libri viene infatti in un primo tempo considerato qualcosa di completamente inaffidabile.
Invece leggendo la cronaca dell’akasha si risale alla scrittura spirituale, così come viene descritta da coloro che erano in grado di leggere spiritualmente. E quando poi viene fatto notare un qualsiasi passaggio, solo allora si osserva nella relativa spiegazione la frase della tradizione così come si trova nei libri. E si va poi a verificare se e in che misura coincide con la forma che può essere ristabilita dalla cronaca dell’akasha, dal vangelo spirituale.
Così il Vangelo di Matteo, quello di Marco e quello di Luca vanno ristabiliti dalla cronaca dell’akasha. E solo il confronto fra la tradizione e la forma originaria ci mostra come leggere questo o quel brano. Ogni tradizione fondata unicamente sul senso letterale sbaglia necessariamente strada e cade in errore.
In futuro i vangeli dovranno non solo essere spiegati, ma anche ripristinati nella loro vera forma originaria.
Se allora qualcuno dirige lo sguardo su ciò che viene ripristinato, non può più dire: «Questo può essere vero o non vero». Se infatti si mostra la concordanza, risulta chiaro che solo la lettura della cronaca dell’akasha può garantire il testo giusto dei vangeli. Allora i vangeli diventano una prova che ciò che è citato alla lettera è giusto. Questo è già stato mostrato in numerosi passaggi.
Eccone un esempio: mettiamo che durante la condanna del Cristo Gesù gli sia stato chiesto se fosse un re inviato da Dio o che altro, e lui abbia risposto: «Tu lo dici!»
A questo punto, se riflette onestamente e non vuole spiegare i vangeli secondo i metodi dei professori del giorno d’oggi, chiunque dovrà dire: in effetti a questa risposta del Cristo Gesù – «Tu lo dici!» – non si può collegare nessun significato, né di sentimento né di intelletto.
Se infatti consideriamo la cosa dalla prospettiva del sentimento dobbiamo chiederci: perché parla in modo così vago da non poter capire che cosa voglia intendere con «Tu lo dici!»? Se intende dire: «È giusto», allora non ha senso, poiché le parole di chi lo interroga non vogliono esprimere un’affermazione ma una domanda. Come può quindi essere una risposta sensata? E se si considera la faccenda dalla prospettiva dell’intelletto, come si può pensare che colui che ci dev’essere presentato come qualcuno in possesso di grande saggezza scelga una simile formulazione per le sue risposte?
Ma se queste parole vengono presentate così come sono nella cronaca dell’akasha, forniscono un significato del tutto diverso. Nella cronaca dell’akasha non troviamo infatti: «Tu lo dici!», ma: «La risposta la puoi dare solo tu!».
Vuol dire, se lo capiamo bene: alla tua domanda dovrei dare una risposta che l’uomo non può mai dare in riferimento a se stesso, ma che può essere data solo da chi gli sta di fronte. Non posso dire se sia vero o meno. Riconoscere questa verità non dipende da me, ma da te. Tu devi dirlo, solo allora avrà un significato!
Adesso potete dire: «Può essere vero o non vero». Certo, se si vuole giudicare in astratto si ha ragione. Ma se si osserva tutta la scena e ci si chiede: «Posso capire meglio quello che c’è in essa prendendo il resoconto dalla cronaca dell’akasha?», chiunque si renderà conto che la scena può essere capita solo in questo modo.
E allora potrà dirsi che solo l’ultimo scrivano o traduttore di questo brano non ha più capito la cosa, poiché è difficile, e quindi ha trascritto un’inesattezza. Chi sa quante cose nel mondo vengono trascritte in modo impreciso non si stupisce del fatto che qui abbiamo a che fare con un resoconto inesatto.
Non dovremmo allora avere il diritto, adesso che sta cominciando una nuova epoca dell’umanità, di ricondurre i vangeli alla loro forma originaria, dimostrabile dalla cronaca dell’akasha?
Lo stato delle cose si vede chiaramente, e può anche essere dimostrato storicamente, se si osserva a questo proposito il Vangelo di Matteo. È sufficiente che riflettiamo sulla storia.
Il meglio di quanto è stato detto sull’origine del Vangelo di Matteo lo potete leggere già nel terzo volume della Dottrina segreta di H.P. Blavatsky, che però va giudicata e valutata nel modo giusto.
C’è un padre della Chiesa, un certo Girolamo, che ha scritto verso la fine del quarto secolo. Da quanto scrive apprendiamo ciò che viene senz’altro confermato dalla ricerca scientifico-spirituale: in origine il Vangelo di Matteo era stato scritto in ebraico e questo padre della Chiesa ne ha avuto in mano una copia – oggi diremmo “un’edizione” – in cui la lingua, pur presentando lettere ebraiche, non era più quella originaria, quella ebraica comunemente usata allora. È un po’ come se oggi scrivessimo in lettere greche una poesia di Schiller; ed è un testo simile che dev’essersi trovato di fronte il padre della Chiesa Girolamo, a partire dalla lingua originaria in cui era stato redatto il Vangelo di Matteo.
Ma questo padre della Chiesa aveva ricevuto dal proprio vescovo l’incarico di tradurre il Vangelo di Matteo per i suoi cristiani. Solo che nell’eseguire quella traduzione si è comportato in modo estremamente strano. Prima di tutto ha pensato che fosse pericoloso tradurre il Vangelo di Matteo così com’era, poiché esso conteneva delle cose che quelli che le avevano possedute fino ad allora come la loro più sacra scrittura volevano tenere nascoste al mondo profano. Girolamo inoltre riteneva che, se fosse stato tradotto così com’era, quel Vangelo avrebbe prodotto distruzione anziché edificazione.
Che cos’ha fatto allora questo padre della Chiesa? Ha omesso le cose che secondo lui e secondo la Chiesa avrebbero potuto esercitare un effetto distruttivo e le ha sostituite con altre!
Ma dai suoi scritti ricaviamo anche altro, e questo è l’aspetto più preoccupante dell’intero processo: Girolamo sapeva che il Vangelo di Matteo può essere capito solo da chi è iniziato in determinate cose occulte, e ammetteva pure di non far parte di un simile genere di iniziati. Significa quindi che ha tradotto il Vangelo di Matteo pur riconoscendo di non capirlo! E così oggi noi abbiamo questo Vangelo nella versione di uno che non lo capiva, ma che poi si è talmente abituato a quella forma da dichiarare eretica qualsiasi affermazione sul Vangelo di Matteo che non fosse contenuta nella sua. Sono tutti fatti assolutamente veri.
Ma quello che ci interessa ora e che dobbiamo sottolineare è chiederci perché quelli che nei primissimi tempi del cristianesimo si attenevano soprattutto al Vangelo di Matteo l’abbiano comunicato solo a individui iniziati al significato segreto di determinate cose.
Si può capire come mai sia successa una cosa simile solo impratichendosi un po’ del carattere dell’iniziazione dal punto di vista scientifico-spirituale. Di queste cose vi è già stato parlato sovente in questo o in quel contesto, e precisamente vi è stato detto che l’iniziazione – cioè quando l’uomo consegue per mezzo suo la facoltà chiaroveggente – porta l’uomo a impossessarsi di determinate verità fondamentali a proposito del mondo.
Queste verità fondamentali sono tali per cui in un primo momento sembrano assurde alla coscienza ordinaria. In base a quello che l’uomo può capire nella vita di ogni giorno, accade che di fronte alle somme verità questa coscienza ordinaria possa solo dire che sono paradossali.
Ma non solo: se l’uomo non preparato venisse a conoscenza delle somme verità, vale a dire di quelle verità accessibili all’iniziato, o per averle indovinate – cosa che in un certo caso sarebbe possibile – o perché gli sono state rivelate in uno stato di imperfezione, anche se fossero le verità più elementari sarebbero estremamente pericolose per lui. Anche se si rappresentasse quanto c’è di più puro e di più elevato a proposito del mondo, questo avrebbe un effetto devastante su di lui e sul suo ambiente.
E per questo chi oggi possiede le somme verità sa anche che la via non può essere quella di chiamare a sé qualcuno e comunicargli i massimi segreti del mondo. Quelle che sono le somme verità non possono essere trasmesse attraverso una bocca che le esprime e un orecchio che le ascolta. Il modo in cui comunicare le somme verità è quello in cui chi vuole essere un discepolo viene preparato lentamente e gradualmente, e questa preparazione avviene in modo che la conclusione definitiva, la comunicazione dei segreti, non possa aver luogo da bocca a orecchio, ma così che a un certo momento il discepolo arrivi grazie alla preparazione a un punto in cui il mistero, il segreto si svela davanti a lui, senza aver bisogno di essere pronunciato da una bocca o udito da un orecchio. Deve nascere nell’anima attraverso ciò che è successo fra maestro e discepolo.
Non può esistere un mezzo per estorcere le ultime cose o gli ultimi segreti a un iniziato, poiché nessuno può essere costretto, con nessuno strumento del mondo fisico, a rivelare con la propria bocca qualcosa dei segreti superiori. Così sono per l’appunto i segreti superiori.
E anche se a qualcuno che si trova in uno stato immaturo venissero svelati per bocca di un altro quelli che devono nascere dall’anima come segreti superiori, la cosa risulterebbe fatale anche per l’altro, poiché per il resto delle sue incarnazioni sarebbe completamente in potere di chi lo ha ascoltato. Ma una cosa simile non può verificarsi se il maestro svolge solo una funzione di preparazione e lascia che il discepolo generi le verità dalla propria anima.
Quando lo si sa ci si rende anche conto del motivo per cui il Vangelo originario di Matteo non poteva essere trasmesso senza esitazione. Non lo si poteva comunicare perché gli uomini non erano maturi per accoglierne il contenuto. Se non lo era Girolamo, il padre della Chiesa, non lo erano neppure gli altri. Per questo coloro che erano originariamente in possesso di quelle comunicazioni, gli Ebioniti, non le hanno trasmesse poiché, se percepite da individui immaturi, quelle cose sarebbero state talmente distorte da provocare ciò che secondo le parole del padre della Chiesa Girolamo sarebbe stato distruzione e non edificazione. Girolamo se ne rendeva conto, ma ha accettato di comunicare al mondo in un certo modo il Vangelo di Matteo, il che significa che quella scrittura è stata comunque comunicata in un certo modo e ha agito nel mondo. Se ora ci guardiamo intorno e osserviamo come ha agito, a partire dalle verità occulte riusciremo a comprendere diverse cose.
Chi, stando sul terreno dell’occultismo, sarebbe disposto ad ammettere che tutte le persecuzioni e via discorrendo nel mondo cristiano possano essere in relazione con il principio del Cristo Gesù stesso? Chi si trova sul terreno dell’occultismo non dovrebbe allora dirsi che nell’evoluzione esteriore dev’essere confluito qualcosa che non può essere nel senso dell’evoluzione cristiana? In breve, ci dev’essere un enorme equivoco.
Ieri abbiamo discusso di come per esempio nell’ambito del cristianesimo si debba parlare di Apollonio di Tiana, ci siamo rappresentati la grandezza e l’importanza di questo personaggio e l’abbiamo definito addirittura un “adepto”. E invece, se sfogliamo la letteratura cristiana originaria, troviamo dappertutto accuse contro Apollonio di Tiana, come se tutto ciò che ha fatto e realizzato fosse stato compiuto sotto l’influsso del diavolo.
Siamo di fronte a qualcosa che va definito un travisamento, non solo un malinteso, della personalità e delle azioni di Apollonio di Tiana. È solo uno dei tanti casi. Lo capiamo solo rendendoci conto che i vangeli sono stati tramandati in un modo che ha necessariamente condotto a dei malintesi e che attualmente, sul terreno dell’occultismo, abbiamo il compito di ritornare al vero significato del cristianesimo, contro il quale il primo periodo di insegnamento ha commesso molti errori. E ci risulterà comprensibile che il cristianesimo dovrà vivere la sua prossima epoca in modo diverso da quelle precedenti.
D’altra parte è stato detto che alcune cose di cui si è parlato qui hanno potuto essere affrontate solo perché ci sono persone che hanno preso parte alla nostra evoluzione scientifico-spirituale degli ultimi anni o che sono dotate della buona volontà di aderire alla nostra evoluzione scientifico-spirituale, avendo nell’anima i valori di sentimento e di affetto adeguati affinché ciò che viene loro comunicato possa agire sulle loro anime.
Dato che in sostanza fra il mistero del Golgota e l’epoca odierna le anime hanno attraversato perlomeno un’incarnazione di apprendistato, oggi è già possibile parlare dei vangeli senza paura di causare danni.
Vediamo quindi il fatto particolare che i vangeli dovevano essere comunicati, ma il cristianesimo poteva essere compreso solo nella sua forma più imperfetta. I vangeli hanno stimolato un metodo di ricerca mediante il quale essa non riesce più a capire che cosa è storico e che cosa non lo è, per cui alla fine tutto può anche essere negato.
Allora nei cuori e nelle anime dovrà entrare quella che dev’essere considerata la forma originaria. Ed essa dovrà creare una nuova forza, affinché ciò che ora muoverà incontro agli uomini possa essere accolto da coloro che hanno potuto sentire degnamente gli eventi dal battesimo di Giovanni fino a quello del Golgota.
Così un’interpretazione dell’evento cristico dal punto di vista occulto costituisce una preparazione necessaria per le anime che nel futuro prossimo dovranno fare l’esperienza del nuovo, che dovranno guardare il mondo con nuove facoltà. E l’antica forma dei vangeli conseguirà il proprio valore completo solo quando si imparerà a leggere in base alla cronaca dell’akasha, la sola in grado di restituirglielo.
In particolare, il pieno significato dell’evento del Golgota potrà essere pienamente esposto soltanto mediante la ricerca spirituale. Le conseguenze di questo evento per le anime umane potranno essere conosciute solo quando si sarà in grado di comprenderne il significato originario a partire dalla scienza esoterica.
Questo ci aspetta nei prossimi giorni, per quanto possibile in un breve ciclo di conferenze: far luce su tutto ciò che l’anima umana può sperimentare dentro di sé sotto l’influsso dell’impulso cristico, per poi salire a una conoscenza di quanto si è verificato in Palestina e sul Golgota, in un senso ancor più profondo di quello possibile fino a ora.
Quinta conferenza
La forma del corpo e l’io:
Nell’ellenismo, nel buddismo
E nell’ebraismo
Karlsruhe, 9 ottobre 1911
Se considerate che dalle nostre conferenze è emerso che l’impulso cristico dev’essere visto come quello che va più in profondità nei processi evolutivi dell’umanità, troverete senza dubbio ovvio che per comprendere il pieno significato e tutta la portata di questo impulso cristico sia necessario anche un certo impegno delle nostre forze spirituali.
In ampie cerchie è diffusa la brutta abitudine di dire che le cose più elevate del mondo devono essere capite nel modo più semplice. E se qualcuno è costretto a esprimersi in maniera complicata sulle fonti dell’esistenza, le sue parole vanno respinte per il motivo che la verità dev’essere semplice.
In definitiva è senz’altro semplice, ma se vogliamo conoscere le cose più elevate a un determinato grado, è facile rendersi conto che prima dobbiamo percorrere una via per giungere a quella comprensione. E così dovremo raccogliere diverse cose per poter di nuovo familiarizzare da un certo punto di vista con tutta la grandezza e con tutto il significato dell’impulso cristico.
Ci basta dare una scorsa alle Lettere di Paolo per trovare che l’apostolo, di cui sappiamo che ha cercato di inserire nella cultura umana proprio l’elemento sovrasensibile dell’Essere cristico, ha per così dire avvicinato tutta l’evoluzione dell’umanità al concetto, all’idea del Cristo. Certamente, se lasciamo che le Lettere di Paolo agiscano su di noi, alla fine ci troviamo di fronte a qualcosa che, per via della sua enorme semplicità e della profonda incisività delle parole e delle frasi, esercita un’impressione estremamente significativa.
Ma questo avviene solo per il fatto che Paolo stesso attraverso la sua iniziazione ha raggiunto quella semplicità che non è il punto di partenza del vero, ma solo la sua conseguenza, il suo obiettivo. Se vogliamo penetrare in ciò che in definitiva viene espresso da Paolo a proposito dell’Essere cristico con parole meravigliose e di monumentale semplicità, dovremo già avvicinarci nel nostro modo scientifico-spirituale a una comprensione della natura umana per il cui ulteriore sviluppo è venuto sulla Terra l’impulso cristico.
Osserviamo le conoscenze di cui già disponiamo sulla natura umana, così come si manifesta allo sguardo veggente. Allora dividiamo la vita umana in quelle due parti che notiamo a proposito dei processi temporali: il periodo fra la nascita, o il concepimento, e la morte e il periodo che intercorre fra la morte e una nuova nascita.
Se dapprima ci rappresentiamo l’uomo così com’è nella vita fisica, sappiamo che lo sguardo spirituale lo vede come un insieme di quattro elementi in evoluzione: il corpo fisico, il corpo eterico, il corpo astrale e l’Io. E sappiamo che per comprendere l’evoluzione umana dobbiamo familiarizzare con la verità esoterica in base alla quale questo Io, che percepiamo nei sentimenti e nelle sensazioni quando prescindiamo dal mondo esteriore e cerchiamo di vivere in noi stessi, per lo sguardo spirituale passa di incarnazione in incarnazione.
Ma sappiamo anche che questo Io è per così dire avvolto – sebbene “avvolto” non sia l’espressione giusta, per il momento possiamo usarla – dalle altre tre componenti della natura umana, e cioè dal corpo astrale, da quello eterico e da quello fisico.
Del corpo astrale sappiamo che sotto un certo aspetto è un accompagnatore dell’Io attraverso le varie incarnazioni. Anche se durante il kamaloka gran parte del corpo astrale dev’essere eliminata, esso rimane tuttavia attraverso le incarnazioni come una sorta di corpo energetico che tiene insieme i progressi morali, intellettuali ed estetici che abbiamo accumulato nel corso di un’incarnazione.
Quello che è effettivo progresso viene tenuto unito dalla forza del corpo astrale, passa da un’incarnazione all’altra e viene in un certo senso collegato all’Io, che va di incarnazione in incarnazione come il nostro elemento eterno fondamentale.
Sappiamo inoltre che gran parte del corpo eterico viene eliminata subito dopo la morte, ma che ce ne rimane un estratto che ci portiamo di incarnazione in incarnazione. Avviene che nei primi giorni successivi alla morte abbiamo una specie di visione retrospettiva, come un grande affresco in cui vediamo la nostra vita passata, e che portiamo con noi il compendio di quella visione retrospettiva, l’estratto, come risultato eterico. Quanto resta del corpo eterico viene trasmesso in una forma o nell’altra al mondo eterico universale, a seconda dell’evoluzione dell’individuo in questione.
Se volgiamo gli occhi alla quarta componente dell’essere umano, vale a dire al corpo fisico, in un primo momento sembra che esso scompaia semplicemente nel mondo fisico. Questo potrebbe addirittura essere dimostrato esteriormente nel mondo fisico, poiché per lo sguardo esteriore questo corpo fisico viene portato in un modo o nell’altro al dissolvimento.
A questo punto la domanda che chiunque si occupi di scienza dello spirito dovrebbe porsi è: non è forse tutto maya, illusione, anche ciò che ci può dire la conoscenza fisica esteriore a proposito del destino del nostro corpo fisico?
E per chi ha cominciato a capire la scienza dello spirito la risposta non è poi così lontana. Una volta iniziato a comprendere la scienza dello spirito, ci si dice: «Tutto ciò che ci offre l’apparenza sensibile è maya, illusione. Come ci si può aspettare che sia realmente vero, nonostante si imponga in modo così rozzo, che il corpo fisico scompaia senza lasciare traccia dopo essere stato affidato alla tomba o al fuoco? Forse dietro la maya esteriore che si impone all’apparenza sensibile si nasconde qualcosa di molto più profondo?». Procediamo oltre nella nostra indagine.
Tenete conto che per capire l’evoluzione della Terra dobbiamo conoscere le precedenti incarnazioni del nostro pianeta, che dobbiamo studiare l’incarnazione saturnia, solare e lunare della Terra. Dobbiamo dire che, come ogni singolo individuo, anche la Terra ha attraversato le sue incarnazioni e che quello che è il nostro corpo fisico è stato preparato nell’evoluzione umana fin dall’epoca saturnia della Terra.
Mentre per quanto riguarda l’antica epoca di Saturno non si può affatto parlare di corpo eterico, corpo astrale e Io nel senso odierno, già a quei tempi viene posto il germe per il corpo fisico, viene in un certo senso incorporato nell’evoluzione.
Durante l’era solare della Terra questo germe subisce una trasformazione e alla sua forma trasformata viene inserito il corpo eterico. Nel corso dell’era lunare della Terra il corpo fisico subisce ulteriori trasformazioni e, oltre al corpo eterico che risulta anch’esso modificato, gli viene annesso il corpo astrale. E nell’epoca terrestre gli viene incorporato l’Io.
A questo punto, se l’apparenza sensibile fosse vera, dovremmo dirci che ciò che ci è stato annesso durante l’era saturnia – il nostro corpo fisico – si decompone o brucia semplicemente dissolvendosi negli elementi esteriori, dopo che attraverso milioni e milioni di anni, nel corso delle ere saturnia, solare e lunare, sono stati fatti i più importanti preparativi da parte di entità sovrumane, cioè divino-spirituali, per realizzare questo corpo fisico!
Ci troveremmo allora davanti al fatto singolare che, attraverso tre o quattro stadi planetari – Saturno, Sole e Luna – un’intera schiera divina lavori alla creazione di un elemento universale come il nostro corpo fisico e poi lo destini a svanire ogni volta che un uomo muore nel corso dell’epoca terrestre. Sarebbe uno strano spettacolo se la maya avesse ragione, e, del resto, l’osservazione esteriore non conosce nient’altro.
E ora chiediamoci: la maya può aver ragione?
Dapprima sembra tuttavia che in questo caso la conoscenza iniziatica dia ragione alla maya, poiché stranamente l’osservazione spirituale pare coincidere con essa.
Se esaminate quella che dalla conoscenza scientifico-spirituale ci viene descritta come l’evoluzione dell’uomo dopo la morte, in effetti in questa descrizione non si tiene quasi conto del corpo fisico. Si dice che ci si libera del corpo fisico, che viene abbandonato agli elementi della Terra. Poi si parla del corpo eterico, del corpo astrale e infine dell’Io, ma non ci si occupa più del corpo fisico.
Sembra che con il silenzio della conoscenza scientifico-spirituale si dia ragione alla conoscenza della maya. Così sembra. E in un certo senso è legittimo che la scienza dello spirito parli in questo modo, per il semplice motivo che tutto il resto dev’essere lasciato a una spiegazione più profonda della cristologia.
Non possiamo infatti parlare in modo corretto di ciò che, per quanto riguarda il corpo fisico, va oltre la maya se prima non abbiamo spiegato a sufficienza l’impulso cristico e tutto ciò che vi è connesso.
Se in un primo tempo osserviamo questo corpo fisico come è apparso alla coscienza dell’uomo in un momento decisivo, ci risulta qualcosa di molto singolare. Cominciamo a esaminare i tipi di coscienza caratteristici di tre popoli, tre diverse forme di coscienza umana, e vediamo quale coscienza sia prevalsa in un’epoca decisiva dell’evoluzione dell’umanità in relazione al nostro corpo fisico.
Osserviamo dapprima i greci. Sappiamo che si tratta di quel popolo importante che ha avuto il suo periodo evolutivo di spicco nella quarta epoca culturale postatlantidea.
Sappiamo che per noi questa quarta epoca culturale postatlantidea inizia intorno al settimo, ottavo e nono secolo prima della nostra era e termina nel tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo secolo della nostra era, dopo l’evento della Palestina. Sulla base delle comunicazioni, delle tradizioni e dei documenti esteriori possiamo anche facilmente giustificare quanto è appena stato detto.
Vediamo che le prime notizie un po’ meno vaghe sull’ellenismo risalgono a malapena al sesto e settimo secolo prima della nostra era, mentre dalle epoche precedenti ci giungono solo indicazioni leggendarie.
Ma sappiamo anche che ciò che costituisce la grandezza del periodo storico dell’ellenismo risulta da un’epoca ancora antecedente, quando si aveva a che fare anche lì con il terzo periodo culturale postatlantideo. Le ispirazioni di Omero risalgono all’epoca che precede il quarto periodo postatlantideo. Ed Eschilo, vissuto in tempi così antichi che gran parte delle sue opere è andata completamente perduta, ci rimanda a drammi misteriosofici di cui ci offre solo un’eco.
Così il terzo periodo culturale postatlantideo si estende nell’epoca greca, ma è il quarto che si esprime pienamente in essa. Dobbiamo dire che la meravigliosa cultura greca è l’espressione più pura del quarto periodo culturale postatlantideo.
Da questo ellenismo ci risuona una massima singolare che ci permette di guardare nel profondo dell’uomo che aveva dei sentimenti completamente greci, la massima dell’eroe: «Meglio essere un mendicante in Terra che un re nel regno delle ombre!»
È una frase che rivela le più profonde sensazioni dell’anima greca. Si potrebbe dire: tutto quel che ci è rimasto in Termini di bellezza e grandezza classica, di elaborazione dell’ideale umano nel mondo esteriore dell’epoca greca, ci risuona in un certo modo da quella frase.
Ricordando i tempi greci, ci ricordiamo del portentoso sviluppo del corpo umano nella ginnastica greca, nei grandi giochi greci che ai nostri giorni vengono imitati in maniera caricaturale da chi non ha la più pallida idea di ciò che è stata veramente la Grecia.
Occorre tener conto del fatto che ogni tempo deve avere i propri ideali, se si vuole capire come questo sviluppo del corpo fisico, nella sua forma nel mondo fisico, fosse un privilegio particolare dello spirito greco, e come inoltre l’impronta dell’ideale artistico plastico, questo incremento della figura umana esteriore nella scultura, dovesse a sua volta essere un privilegio dell’ellenismo.
E se inoltre prendiamo in considerazione lo sviluppo della coscienza umana, come quella per esempio che regnava in un Pericle, dove l’uomo da un lato guardava all’universalmente umano e dall’altro stava coi piedi ben piantati per terra, sentendosi signore e re nell’ambito della propria città, se lasciamo agire su di noi tutto ciò, dobbiamo dirci che il vero amore era rivolto alla forma umana come la vediamo nel mondo fisico, e che anche l’estetica era diretta allo sviluppo di quella forma.
Laddove si amava e si capiva così profondamente quella parte dell’uomo presente nel mondo fisico, poteva anche sorgere il pensiero: quando ciò che dà all’uomo questa bella forma nel mondo fisico viene tolto alla natura umana, rimane un residuo che non può essere apprezzato quanto ciò che viene sottratto all’uomo nella morte.
Questo fortissimo amore per la forma esteriore portava necessariamente a considerare con pessimismo quanto resta dell’uomo dopo aver varcato la porta della morte.
E per quel che riguarda l’anima greca, possiamo capire perfettamente come lo stesso occhio che guardava con tanto amore la forma esteriore si sentisse triste quando l’anima doveva pensare: questa forma viene tolta all’individualità umana, che continua a vivere senza di essa.
Se prendiamo dapprima quello che è emerso in questo modo in forma di sentimento, dobbiamo dirci: nell’ellenismo abbiamo quell’umanità che amava e apprezzava sopra ogni cosa la forma esteriore del corpo fisico e provava tutta la tristezza possibile quando questo corpo tramontava nella morte.
Prendiamo ora in esame un altro tipo di coscienza, sviluppatosi più o meno nello stesso periodo. Esaminiamo la coscienza del Buddha, che poi è passata da lui ai suoi seguaci.
Ci troviamo più o meno di fronte all’opposto dell’ellenismo. Ci basti ricordare che l’essenza delle quattro grandi verità del buddismo viene espressa in questa affermazione: l’individualità umana viene portata dalla brama di vita in questa esistenza nella quale è avvolta dalla forma fisica esteriore. In che tipo di esistenza? In una rispetto alla quale la dottrina del Buddha deve dire: la nascita è dolore, la malattia è dolore, la morte è dolore!
Fa parte dell’essenza del buddismo il dirsi che, attraverso tutto ciò che ci circonda come un involucro corporeo esteriore, la nostra individualità, che con la nascita discende da altezze spirituali divine a cui fa ritorno dopo aver varcato la porta della morte, viene consegnata alla sofferenza e al dolore dell’esistenza.
E in definitiva per l’uomo può esserci solo quella salvezza espressa nelle quattro grandi verità sacre del Buddha: liberarsi dall’esistenza esteriore, buttar via l’involucro esteriore, vale a dire, trasformare l’individualità al punto da renderla in grado di abbandonare il più presto possibile tutto ciò che è involucro esteriore, cioè il corpo fisico.
Notiamo che qui è all’opera il sentimento opposto a quello provato dai greci.
Quanto intensamente il greco amava e apprezzava l’involucro corporeo esteriore, provando tristezza al momento della separazione da esso, altrettanto poco il seguace del Buddha apprezzava quell’involucro, considerandolo qualcosa di cui sbarazzarsi il più presto possibile. E a questo era connessa la lotta contro l’impulso all’esistenza avvolta da un involucro corporeo esteriore.
Adesso approfondiamo ancora un poco questi pensieri del Buddha. Vediamo quella che nel buddismo è una sorta di concezione teorica delle incarnazioni umane che si susseguono.
Non si tratta tanto di quel che pensa il singolo della teoria del Buddha, quanto di ciò che è penetrato nella coscienza del seguace del buddismo. Anche questo l’ho spesso descritto dicendo che forse non c’è occasione migliore per sentire che cosa doveva provare un seguace del buddismo rispetto alle ripetute incarnazioni dell’uomo, se non quella di immergersi in quello che ci è stato tramandato come il discorso fra il re Milinda e il saggio buddista Nagasena.
Al re Milinda viene insegnato dal saggio buddista Nagasena che, essendo lui arrivato su un carro, deve riflettere se il carro abbia qualcos’altro oltre le ruote, il timone, la cassetta, il sedile e così via.
«Se sei venuto su un carro, grande re» dice Nagasena a Milinda «pensa che tutto ciò che hai davanti a te nel carro non è nient’altro che le ruote, il timone, la cassetta, il sedile, e che non c’è altro se non una parola che riassume le ruote, il timone, la cassetta, il sedile e così via. Quindi non puoi parlare di una particolare individualità del carro, ma devi renderti conto che “carro” è una parola vuota se pensi a qualcosa di diverso dalle sue parti, dalle sue componenti».
Il saggio Nagasena ricorre anche a un altro paragone per il re Milinda: «Guarda il mango che cresce sull’albero», gli dice «e tieni conto che da un altro frutto è stato preso un seme messo nella terra a marcire. Da lì è cresciuto l’albero e su di esso il mango. Puoi dire che il frutto sull’albero ha qualcosa in comune oltre al nome e alla forma esteriore con quel frutto che, preso come seme, era stato messo a marcire sotto terra?»
Nagasena intende dire che l’uomo ha tanto in comune con l’uomo della sua incarnazione precedente quanto il mango sull’albero ha in comune con il mango che è stato messo come seme nella terra. E chi crede che quello che ci sta di fronte come “uomo” e che viene portato via dalla morte sia qualcos’altro che nome e forma, si sbaglia esattamente come chi crede che il carro, la parola “carro”, contenga qualcosa di diverso dalle sue parti: ruote, timone e così via. Dall’incarnazione precedente non passa in quella nuova quel qualcosa che l’uomo chiama il proprio “Io”.
Questo è importante e va continuamente sottolineato: ciò che conta non è il modo in cui all’uno o all’altro viene in mente di interpretare questa o quella parola del Buddha, bensì il modo in cui il buddismo ha agito nella coscienza della popolazione, quello che ha dato alle anime.
E ciò che ha dato alle anime è espresso in maniera estremamente chiara e significativa in questo paragone fatto dal saggio Nagasena al re Milinda che ci è stato tramandato. Di quello che chiamiamo “Io” e del quale diciamo che viene in prima linea sentito e percepito dall’uomo quando riflette sulla propria interiorità, il buddista dice: in definitiva si tratta di qualcosa che fluisce e che appartiene alla maya, al mondo dell’illusione, proprio come tutto il resto che non passa da un’incarnazione all’altra.
Ho già accennato una volta al fatto che un saggio cristiano, che potrebbe essere paragonato al saggio buddista, avrebbe parlato in modo diverso al re Milinda.
Il saggio buddista ha detto al re: osserva il carro: le ruote, il timone e via dicendo sono le sue parti. E oltre queste parti il carro è solo nome e forma. Nel carro, nel nome carro, non hai niente di reale. Se vuoi qualcosa di reale devi prendere le sue parti.
Sullo stesso caso il saggio cristiano si sarebbe espresso così: o saggio re Milinda, tu sei venuto su un carro. Guardalo: puoi vederne le ruote, il timone, la cassetta e così via. Ma io ti chiedo: puoi venire fin qui con le sole ruote? O con il solo timone? Puoi venire fin qui con il solo sedile e via dicendo? Non puoi venire qui su nessuna delle parti! In quanto parti, costituiscono sì il carro, ma sulle singole parti non puoi viaggiare. Se dunque le parti soltanto insieme formano il carro, è necessario qualcos’altro oltre al fatto che siano parti. Per il carro si tratta del pensiero ben preciso che collega fra loro in una forma ruote, timone, cassetta e così via. L’idea del “carro” è quindi qualcosa di assolutamente necessario, qualcosa che tu non puoi vedere ma che devi comunque riconoscere come realtà.
E il saggio cristiano passerebbe poi all’uomo e direbbe: del singolo uomo puoi vedere solo il corpo esteriore, le azioni e le esperienze animiche esteriori. In lui vedi il suo “Io” altrettanto poco quanto vedi il “carro” nelle sue singole parti. Ma come nelle parti è presente qualcosa di completamente diverso, e cioè quello che ti fa arrivare qui, così anche in tutte le parti dell’uomo è presente qualcosa di completamente diverso, ciò che costituisce l’Io. L’Io è qualcosa di reale che passa di incarnazione in incarnazione come un elemento sovrasensibile.
Come dobbiamo immaginarci lo schema della dottrina buddista della reincarnazione, se dev’essere rappresentata in modo conforme alla semplice teoria?
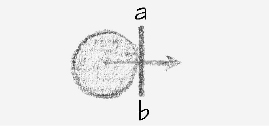
Con un cerchio rappresentiamo l’apparizione di un uomo fra nascita e morte. L’uomo muore. Indichiamo con la linea a b il momento della sua morte.
Che cosa resta ora di tutto quello che nell’attuale esistenza è compreso fra nascita e morte? Rimane una somma di cause, i risultati delle azioni, tutto ciò che l’uomo ha fatto di buono o di cattivo, di bello o di brutto, di intelligente o di stolto.
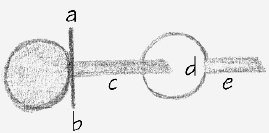
Ciò che rimane continua ad agire sotto forma di cause e crea un nucleo di cause c per la prossima incarnazione. Nel corso dell’incarnazione successiva d intorno a questo nucleo di cause si strutturano nuovi involucri corporei che sperimentano nuovi fatti e nuove esperienze secondo questo precedente nucleo di cause. Di queste esperienze e cose analoghe resta poi un nucleo di cause e per l’incarnazione successiva, che può racchiudere ciò che entra in essa dalle incarnazioni precedenti, e che con quello che si aggiunge durante questa incarnazione come qualcosa di completamente indipendente forma di nuovo il nucleo di cause per la prossima incarnazione, e così via.
Cioè, quello che passa attraverso le incarnazioni si esaurisce in cause ed effetti che agiscono da un’incarnazione all’altra senza essere tenuti insieme da un Io comune. Se quindi in questa incarnazione mi definisco “Io” non è per il fatto che lo stesso Io esisteva anche nell’incarnazione precedente. Dell’incarnazione precedente sono presenti solo i risultati karmici, e quello che chiamo il mio Io è solo un’illusione dell’incarnazione attuale.
Chi conosce veramente il buddismo lo deve presentare in questo modo, e deve rendersi conto che in tale dottrina non c’è posto per quello che chiamiamo “Io”.
Ma ora prendiamo in considerazione quello che sappiamo dalla conoscenza scientifico-spirituale.
In virtù di che cosa l’uomo è stato in grado di formare il proprio Io? Grazie all’evoluzione della Terra! Solo nel corso dell’evoluzione terrestre l’uomo è arrivato a formare il proprio Io. Sulla Terra al corpo fisico, a quello eterico e a quello astrale si è aggiunto l’Io.
Ora, se ricordiamo tutto quel che è stato detto sulle fasi evolutive dell’uomo in epoca saturnia, solare e lunare, sappiamo che durante il periodo lunare il corpo fisico umano non aveva ancora la sua forma ben precisa, forma che ha assunto solo sulla Terra.
Per questo parliamo dell’esistenza terrena come dell’epoca in cui sono intervenuti per la prima volta gli Spiriti della forma, trasformando il corpo fisico dell’uomo così da dargli la forma che ha adesso.
Ma questa forma del corpo fisico umano era necessaria perché l’Io potesse prender posto nell’uomo, affinché ciò che corrisponde alla Terra fisica come corpo fisico formato potesse offrire la base per la nascita dell’Io così come lo conosciamo. Se consideriamo questo, quanto segue non ci sembrerà più incomprensibile.
Riferendoci alla valutazione dell’Io presso i greci, abbiamo detto che esso trova la propria espressione nella forma umana esteriore.
Passiamo ora al buddismo e teniamo presente che esso con la sua conoscenza vuole gettar via, superare il più rapidamente possibile la forma esteriore del corpo fisico umano. Possiamo ancora stupirci di non trovarvi nessun apprezzamento di ciò che è connesso a questa forma del corpo fisico?
Così come viene poco apprezzata la forma esteriore del corpo fisico dalla più intima essenza del buddismo, altrettanto poco viene apprezzato l’Io, che ha bisogno della forma esteriore per giungere all’esistenza. Anzi, viene negato del tutto. Il buddismo ha quindi perso la forma dell’Io per via del modo in cui ha tenuto in poco conto la forma del corpo fisico.
Vediamo così come queste due correnti spirituali si contrappongano antiteticamente:
• l’ellenismo, di cui sentiamo che apprezza sommamente la forma del corpo fisico come forma esteriore dell’Io,
• il buddismo, che richiede che la forma esteriore del corpo fisico con tutta la brama di esistenza venga superata il più presto possibile, e che perciò nella sua teoria ha perso completamente l’Io.
Fra queste due concezioni del mondo fra loro opposte si colloca l’antico ebraismo.
Questa concezione è ben lungi dall’avere un’opinione dell’Io così scarsa come quella del buddismo. Vi basti ricordare che nel buddismo è un’eresia riconoscere l’esistenza di un Io che permane di incarnazione in incarnazione. Ma l’antichità ebraica si attiene con gran forza a questa eresia.
A nessun seguace dell’antichità ebraica sarebbe mai venuto in mente che quella che vive nell’uomo come effettiva scintilla divina, in relazione con il suo concetto di Io, andasse perduta nel momento in cui l’uomo attraversa la porta della morte.
Se ci vogliamo rendere conto di come si pone il seguace dell’antico ebraismo nei confronti di questa faccenda, dobbiamo dirci: nella sua interiorità si sente intimamente unito alla divinità, sa di essere in un certo senso attaccato all’essere di questa divinità con le fibre migliori della sua vita interiore.
Così, per quanto concerne il concetto dell’Io, il seguace dell’antichità ebraica è molto diverso dal buddista, ma d’altro canto lo è anche dal greco.
Se si osserva tutta l’antichità si nota che nell’ebraismo non c’è quella valutazione della personalità e quindi anche della forma umana esteriore tipica dei greci. Per il greco sarebbe stato semplicemente assurdo dire: «Non devi farti nessuna immagine del tuo dio». Non avrebbe capito se qualcuno gli avesse detto: non devi farti nessuna immagine del tuo Zeus, del tuo Apollo e così via.
Egli infatti aveva la sensazione che la forma esteriore fosse il sommo bene e che il massimo onore che l’uomo poteva tributare agli dei consistesse nel rivestirli della forma umana da lui sommamente amata. Niente gli sarebbe parso più assurdo del comandamento: «Non ti devi fare nessuna immagine di Dio». L’artista greco ha attribuito anche ai suoi dei la propria forma umana. Per diventare veramente ciò che pensava di essere, un’immagine della divinità, si dava ai combattimenti, alla ginnastica e ad altre attività analoghe.
Ma l’antichità ebraica aveva il comandamento: «Non devi farti nessuna immagine del tuo dio», poiché il suo seguace non apprezzava la forma esteriore come il greco, in quanto la riteneva indegna rispetto all’Entità divina.
Pur essendo da un lato lontano dal buddista, che avrebbe preferito abbandonare completamente la forma umana al momento della morte, dall’altro il seguace dell’antichità ebraica era altrettanto lontano anche dal greco.
Per lui era importante che quella forma esprimesse i comandamenti, le leggi dell’Entità divina. E si rendeva conto che chi è “giusto” tramanda alle generazioni successive quanto di giusto ha raccolto. Non l’annientamento della forma, ma la sua propagazione attraverso le generazioni era ciò cui mirava il seguace dell’antico ebraismo.
La concezione di un membro dell’antico popolo ebraico stava quindi come una terza a metà strada tra quella del buddista, che aveva perso l’apprezzamento dell’Io, e quella del greco, che vedeva la somma realtà nella forma corporea e provava tristezza per la sua scomparsa al momento della morte. Tale era il reciproco rapporto delle tre concezioni.
Per capire ancor meglio l’antichità ebraica dobbiamo renderci conto che per il suo seguace quello che apprezzava come il proprio Io era in un certo senso nel contempo l’Io divino. La divinità continuava a vivere nell’umanità, dentro gli uomini. E nel legame con l’essere divino l’antico ebreo sentiva allo stesso tempo il proprio Io.
Così l’Io che sentiva in sé coincideva con l’Io divino. L’Io divino lo portava in sé e agiva anche dentro di lui.
• Se il greco diceva: «Apprezzo talmente il mio Io da vedere con orrore quello che esso diventa dopo la morte»;
• se il buddista affermava: «La causa della forma esteriore dell’uomo deve staccarsi da lui il più presto possibile»;
• il seguace dell’antichità ebraica diceva: «Io sono in unione con Dio, questo è il mio destino. E finché sono unito a lui il mio destino mi trasporta. Non conosco nient’altro che l’identificazione del mio Io con l’Io divino».
In questo modo di pensare dell’antico ebraismo, poiché sta nel mezzo fra ellenismo e buddismo, non si trova fin dall’inizio come nell’ellenismo la tendenza alla tragicità rispetto al fenomeno della morte, ma questa tragicità è presente in maniera indiretta.
E se è tipicamente greco che l’eroe dica: «Meglio mendicante sulla Terra» – cioè con la forma corporea umana – «che re nel regno delle ombre», il seguace dell’antico ebraismo non avrebbe potuto fare una simile affermazione, poiché sapeva che anche se nella morte la sua forma corporea si stacca da lui, l’unione col suo dio non viene spezzata. Non poteva quindi cadere in uno stato d’animo tragico solo per via del fatto della morte.
E tuttavia, seppure indirettamente, nell’antico ebraismo c’è l’inclinazione alla tragicità, e la troviamo espressa nel più straordinario racconto drammatico che sia mai stato scritto nell’antichità, nel racconto di Giobbe.
In esso vediamo come l’Io di Giobbe si senta connesso al suo dio e come entri in conflitto con lui, ma in modo diverso rispetto all’Io greco.
In questo racconto ci viene descritto come Giobbe sia colpito da una disgrazia dietro l’altra, nonostante egli sia cosciente di essere un uomo “giusto”, che ha fatto cioè tutto il possibile per mantenere il legame fra il proprio Io e l’Io divino. E mentre sembrava che la sua esistenza fosse benedetta, dovesse essere tale, il destino tragico si abbatte su di lui.
Giobbe non è cosciente di nessun peccato. È cosciente di aver fatto quello che un uomo “giusto” deve fare nei confronti del proprio dio. Gli viene annunciato che i suoi averi sono stati distrutti e che tutta la sua famiglia è stata uccisa. Dopo di che anche lui, per quanto riguarda il suo corpo esteriore, questa forma divina, viene colpito da grave malattia e tribolazione. È lì, cosciente di questo: quello che in me è in relazione con il mio dio si è adoperato per essere giusto nei suoi confronti. Ed è il destino inflittomi da questo dio che mi ha inserito nel mondo. Queste azioni di Dio mi hanno colpito così duramente!
E accanto a lui c’è sua moglie, che lo esorta con parole strane a rinnegare il suo dio. Queste parole sono state tramandate correttamente. Le parole pronunciate da sua moglie corrispondono a quanto dice la cronaca dell’invisibile: «Rinnega il tuo dio» – poiché ti fa tanto soffrire, poiché egli ti ha imposto queste sofferenze – «e muori!».
Quanto di infinito c’è in queste parole! “Se perdi la coscienza del rapporto con il tuo dio cadi fuori dalla relazione divina, come una foglia cade dall’albero, e il tuo dio non ti può più punire.” La perdita della connessione con Dio è nello stesso tempo la morte, poiché fino a quando l’Io si sente in relazione con il dio la morte non lo può raggiungere. Deve strapparsi dalla connessione con il dio, solo allora la morte può arrivare, solo allora l’uomo finisce di essere.
In pratica l’esperienza esteriore parla in modo da far sembrare che tutto sia contro il giusto Giobbe. Sua moglie vede le sue sofferenze e gli consiglia di rinnegare Dio e morire. Vengono gli amici che gli dicono: “Devi aver fatto questo e quello di male, perché Dio non punisce i giusti.” Ma lui, per quanto concerne la sua coscienza personale, sa di non aver commesso ingiustizia alcuna.
Per via di quello che gli si presenta nel mondo esteriore, Giobbe è quindi di fronte a un’immensa tragedia, la tragedia di non poter capire tutta l’entità umana, di sentirsi unito a Dio senza poter comprendere come ciò che sperimenta possa venire da Dio stesso.
Immaginiamo quello che è stato depositato con tutta la forza sull’anima umana e le parole che ora prorompono da quest’anima, quelle tramandateci nel racconto di Giobbe: «Io so che il mio Redentore vive! So che un giorno riprenderò il mio corpo, la mia pelle, e vedrò il dio con cui sono unito!»
Nonostante tutti i dolori e le sofferenze, dall’anima di Giobbe erompe questa coscienza dell’indistruttibilità dell’individualità umana. Tanto intensa è la coscienza dell’Io all’interno della confessione ebraica antica.
Ma qualcosa di molto strano ci si fa incontro: «Io so che il mio Redentore vive!», esclama Giobbe. «So che un giorno sarò di nuovo avvolto dalla mia pelle e che coi miei occhi vedrò di nuovo la magnificenza del mio dio!». Giobbe mette il corpo esteriore in relazione con l’idea del Redentore: la pelle, le ossa, gli occhi che vedono fisicamente.
Strano: all’improvviso in questa coscienza ebraica antica, che sta a metà strada tra ellenismo e buddismo, ci si presenta la consapevolezza del significato della forma corporea fisica in relazione con l’idea del “Redentore”, che è diventato poi il terreno per l’idea del Cristo.
E se prendiamo la risposta della moglie, tutte le affermazioni di Giobbe appaiono in una luce più chiara. «Rinnega il tuo dio che così muori!» significa allora: chi non rinnega il proprio dio non muore. Ecco cosa dicono queste parole. Ma che cosa vuol dire “morire”?
Morire significa liberarsi del corpo fisico – questo sembra dire la maya, l’illusione esteriore. Il corpo fisico si tramuta negli elementi della Terra e sparisce. La risposta della moglie di Giobbe allora contiene anche questo: «Fa’ quel che è necessario affinché il tuo corpo fisico sparisca». Non potrebbe significare altro, poiché altrimenti le parole successive di Giobbe non avrebbero alcun senso. Si può capire una cosa del genere solo comprendendo lo strumento per mezzo del quale la divinità ci ha messi nel mondo, vale a dire il significato del corpo fisico.
Ma lo stesso Giobbe dice, poiché ciò sta nelle sue parole: oh, io so ben di non dover fare quello che fa sparire il mio corpo fisico, quello che solo l’apparenza esteriore offre. C’è una possibilità che, per il fatto che il mio Redentore vive, venga salvato quello che posso solo riassumere con le parole: un giorno avrò di nuovo la mia pelle e le mie ossa, ricreate, e con i miei occhi vedrò di nuovo la magnificenza del mio dio. Potrò riottenere le forze che reggono il mio corpo fisico, ma per questo devo avere coscienza che il mio Redentore vive!
Così nel racconto di Giobbe incontriamo per la prima volta una relazione fra la forma corporea fisica – che il buddista vorrebbe eliminare e il greco vede sciogliersi con amarezza – e la coscienza dell’Io.
Per la prima volta ci si presenta come una prospettiva di salvezza di quella che la schiera degli dei di Saturno, del Sole e della Luna ha prodotto fin sulla Terra come la forma corporea fisica e che per essere conservata, affinché ciò che ci è dato nelle ossa, nella pelle e negli organi di senso abbia una realtà, è necessario aggiungere queste parole: io so che il mio Redentore vive!
Dopo quanto è stato detto qualcuno potrebbe chiedere: Strano! Risulta forse dal racconto di Giobbe che il Cristo risveglia i morti e salva la forma corporea che i greci ritenevano andasse perduta? In esso si dice forse che per l’evoluzione complessiva dell’umanità non è vero nel pieno senso della parola che la forma corporea esterna svanisce del tutto, ma che viene invece intessuta nel processo evolutivo complessivo dell’umanità? Questo ha un ruolo nel futuro ed è in relazione con l’Entità cristica?
Questa domanda ci viene posta, e allora arriviamo ad ampliare in un certo modo quanto abbiamo finora sentito dire dalla scienza dello spirito.
Sentiamo dire che quando varchiamo la porta della morte conserviamo almeno in parte il corpo eterico, ma ci liberiamo del tutto da quello fisico, lo vediamo esteriormente consegnato agli elementi. Ma la sua forma, alla quale si è lavorato per milioni e milioni di anni, va perduta divenendo insussistente? O viene in qualche modo preservata?
Consideriamo questa domanda come il risultato della spiegazione odierna e domani ci occuperemo della domanda: in che rapporto sta l’impulso cristico per l’evoluzione dell’umanità con il significato del corpo fisico esteriore che nell’evoluzione terrena viene ceduto alla tomba, al fuoco o all’aria, e che nella conservazione della sua forma è necessario per il futuro dell’umanità?
Sesta conferenza
Il corpo fisico
Come corpo spirituale
Delle forze formanti
(fantoma)
Karlsruhe, 10 ottobre 1911
Partendo dalle cose di cui abbiamo parlato ieri potremo avvicinarci alle questioni nodali del cristianesimo, cercando di capirne la vera essenza.
Vedremo come solo in questo modo sia possibile intuire che cosa è diventato per l’evoluzione dell’umanità l’impulso cristico e cosa dovrà essere in futuro.
Quando gli uomini continuano a sottolineare che le risposte alle domande più elevate non devono essere così complesse, ma che in definitiva la verità deve poter essere portata a ognuno nel modo più semplice e diretto, e quando in una simile occasione viene detto che per esempio in tarda età l’apostolo Giovanni ha riassunto l’essenza del cristianesimo nelle parole: «Figlioli, amatevi!», nessuno è autorizzato a trarre la conclusione: io conosco la natura del cristianesimo, conosco l’essenza della verità per tutti gli uomini, dal momento che dico: figlioli, amatevi!
Per poter esprimere queste semplici parole l’apostolo Giovanni aveva dovuto procurarsi diversi prerequisiti. Prima di tutto sappiamo che è arrivato a quella massima solo alla fine di una lunga vita, a 95 anni, e che quindi soltanto in quell’incarnazione si era conquistato il diritto di pronunciare una simile frase. In tal modo rende testimonianza del fatto che le stesse parole dette da un uomo qualsiasi non hanno la medesima forza di cui dispongono nell’apostolo Giovanni.
Ma l’apostolo aveva conseguito anche qualcos’altro. Anche se la critica sostiene il contrario, è l’autore del Vangelo di Giovanni, dell’Apocalisse e delle Lettere di Giovanni. Quindi non ha sempre detto per tutta la vita solo: «Figlioli, amatevi!», ma ha per esempio scritto una delle opere più difficili dell’umanità – l’Apocalisse – e una di quelle che penetrano più intimamente e profondamente nell’anima umana, il Vangelo di Giovanni.
Si è guadagnato il diritto di pronunciare queste parole attraverso una lunga vita e ciò che ha compiuto. E se qualcuno vive secondo il modello di questa vita e fa ciò che ha fatto Giovanni, e poi dice come lui: «Figlioli, amatevi!», non si può obiettare nulla contro un simile modo di procedere. Ma dobbiamo renderci conto che le cose che possono essere riassunte in poche parole, che possono essere espresse con tali parole, possono significare molto, ma possono anche essere insignificanti.
E chi si limita a esprimere una massima che forse con le debite premesse può avere un significato molto profondo e crede così di aver detto moltissimo, richiama alla memoria il racconto di quel regnante che un giorno andò a visitare un carcere e a cui venne portato davanti un detenuto, un ladro. Allora il sovrano chiese al ladro come mai avesse rubato e quello gli rispose di averlo fatto perché aveva fame. Della questione su come rimediare alla fame si sono già occupati in molti, ma il regnante in questione disse al ladro di aver sempre sentito dire che quando si ha fame si mangia, non si ruba!
Dire che quando si ha fame si deve mangiare e non rubare è indubbiamente una risposta giusta, ma si tratta di vedere se è anche adeguata alla situazione. Il fatto che la risposta sia vera non garantisce che esprima anche qualcosa che ha importanza o valore per la relativa questione.
Perciò in età avanzata l’autore dell’Apocalisse e del Vangelo di Giovanni può anche dire: “Figlioli, amatevi!» e dirlo dal cuore del cristianesimo, ma la stessa frase pronunciata da un altro può sembrare un semplice luogo comune. Dobbiamo quindi sapere che le cose per la comprensione del cristianesimo vanno recuperate da lontano, proprio per poter essere applicate alle verità più semplici della vita quotidiana.
Ieri ci siamo dovuti occupare della domanda fatidica per il pensiero moderno su come stiano le cose con quello che nella quadruplice entità dell’uomo chiamiamo il “corpo fisico”. Vedremo come ciò a cui abbiamo accennato ieri riguardo alla triplice concezione – dell’ellenismo, dell’ebraismo e del buddismo – ci condurrà alla comprensione dell’essenza del cristianesimo.
Dapprima tuttavia, quando ci informiamo sulla questione del destino del corpo fisico, veniamo condotti a una domanda che sta veramente al centro di tutta la concezione cristiana del mondo. Veniamo guidati nientemeno che alla domanda: come stanno le cose con la risurrezione del Cristo?
Possiamo supporre che per la comprensione del cristianesimo sia importante capire la questione della risurrezione?
Per sapere che è importante ci basta ricordare quello che è scritto nella Prima Lettera ai Corinti di Paolo:
Or, se Cristo non è risorto, è vana dunque la nostra predicazione e vana è pure la vostra fede. Anzi, diventerebbe manifesto che noi siamo falsi testimoni di Dio, perché per Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non l’avrebbe risuscitato, se i morti non risorgono; perché se i morti non risorgono, neppure Cristo è risorto. Se Cristo poi non è risorto, la vostra fede è vana; voi siete ancora nei vostri peccati. E quindi anche quelli che si sono addormentati in Cristo sono perduti. Se noi riponiamo la nostra speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ma ecco che Cristo è risorto dai morti, primizia di quei che dormono. (1Cor. 15, 14-20)
Dobbiamo far notare che il cristianesimo così come si è diffuso inizialmente nel mondo ha avuto origine da Paolo. E se abbiamo la sensibilità necessaria per prendere sul serio le sue parole, non possiamo ignorare le sue affermazioni più importanti e dire qualcosa come: lasciamo pure irrisolta la questione della risurrezione.
Che cosa dice infatti Paolo? Dice che il cristianesimo nel suo insieme non avrebbe alcuna giustificazione e che l’intera fede cristiana non avrebbe alcun senso se la risurrezione non fosse una realtà! Questo dice Paolo, dal quale ha preso le mosse il cristianesimo quale fatto storico.
E con ciò in definitiva non si dice nientedimeno che stando a Paolo chi vuole rinunciare alla risurrezione deve abbandonare il cristianesimo.
Volgiamo ora lo sguardo a circa duemila anni dopo e chiediamoci quale atteggiamento devono assumere gli uomini del presente rispetto alla questione della risurrezione in base ai presupposti dell’attuale cultura.
Non voglio prendere in considerazione quelli che negano completamente Gesù; in questo caso è ben facile chiarirsi le idee sulla risurrezione! In fondo il modo “più facile” per rispondere consiste nel dire: Gesù non è affatto vissuto, ragion per cui non è necessario rompersi la testa sulla questione della risurrezione.
Se ci rivolgiamo a un uomo che si è conquistato una grande influenza sul modo di pensare di coloro che si ritengono sommamente illuminati, David Friedrich Strauss, e prendiamo il suo scritto su Reimarus, il pensatore del diciottesimo secolo, leggiamo quanto segue:
«La risurrezione di Gesù è davvero il distintivo su cui si scontrano non solo le varie concezioni del cristianesimo, ma anche varie ideologie e vari stadi evolutivi spirituali.»
E quasi nello stesso periodo leggiamo su una rivista svizzera: «Non appena riesco a convincermi della realtà della risurrezione del Cristo, di questo assoluto miracolo, devo fare a pezzi la concezione moderna del mondo. Questa spaccatura nell’ordine naturale, per me irrevocabile, sarebbe come una lacerazione fatale nel mio sistema, in tutto il mio mondo concettuale».
Chiediamoci quanti uomini del presente devono sottoscrivere queste parole in base all’odierno modo di pensare, come molti diranno: se fossi tenuto a riconoscere la risurrezione come fatto storico, farei a pezzi tutto il mio sistema filosofico o di qualsiasi altro genere.
Chiediamoci: come potrebbe mai calzare la risurrezione come fatto storico nella concezione del mondo dell’uomo moderno?
Ricordiamo che già nella prima conferenza pubblica abbiamo fatto notare come i vangeli vogliano in primo luogo essere considerati degli scritti iniziatici. Quelli che nei vangeli sono descritti come i fatti più grandi sono in definitiva fatti iniziatici, processi che dapprima si sono svolti nel segreto dei templi dei misteri, quando questo o quell’uomo, dopo esserne stato ritenuto degno, veniva iniziato dallo ierofante, dal sommo sacerdote.
Allora un uomo con questi prerequisiti, dopo essere stato preparato a lungo, attraversava una specie di “morte” e di “risurrezione”. Doveva anche sperimentare determinate condizioni di vita che ci riappaiono nei vangeli, per esempio nel racconto della tentazione, in quello sul Monte degli ulivi e altri.
È proprio per questo che anche le descrizioni degli antichi iniziati, che non intendono essere delle biografie nel senso comune del termine, risultano così simili agli eventi circa il Cristo Gesù narrati nei vangeli.
E se leggiamo la storia di Apollonio di Tiana e perfino quella del Buddha, di Zarathustra, di Osiride o di Orfeo – le biografie dei più grandi iniziati – ci capita spesso di trovarvi gli stessi importanti tratti di vita del Cristo Gesù descritti nei vangeli.
Ma pur dovendo ammettere che per i processi importanti che ci vengono descritti nei vangeli dobbiamo cercare i modelli nelle cerimonie iniziatiche dei misteri antichi, d’altro canto ci risulta evidente che nei vangeli i grandi insegnamenti e la vita del Cristo Gesù sono ovunque pervasi da singoli particolari che non vogliono essere una pura e semplice ripetizione delle cerimonie iniziatiche, ma che ci fanno notare che vengono descritti direttamente dei fatti storici.
O non dobbiamo dire che la seguente descrizione nel Vangelo di Giovanni produce in maniera singolare su di noi un’impressione del tutto realistica?
«Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena andò al sepolcro, di mattina presto, mentre era ancora buio, e vide che dal sepolcro era stata tolta la pietra. Allora di corsa si reca da Simon Pietro e da quell’altro discepolo prediletto di Gesù e dice loro: ‹Hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l’abbiano messo›. Uscì dunque Pietro con l’altro discepolo e andarono al sepolcro. Correvano tutt’e due insieme, ma quell’altro discepolo corse più svelto di Pietro e arrivò primo al sepolcro.
Chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò. Arrivò anche Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nella tomba e vide le bende per terra e il sudario, che era sul capo di Gesù, non per terra con le bende, ma ripiegato, in un angolo a parte. Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto prima al sepolcro, vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Poi i discepoli ritornarono a casa. Maria invece stava fuori, in lacrime, vicino al sepolcro. Piangendo s’affacciò al sepolcro e vide due Angeli vestiti di bianco, seduti l’uno al capo e l’altro ai piedi, dov’era stato posto il corpo di Gesù. Essi le domandarono: ‹Donna, perché piangi?›. Rispose loro: ‹Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l’abbiano messo›. Detto questo si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era lui. Gesù le domandò: ‹Donna, perché piangi? E chi cerchi?›. Ella, credendo che fosse l’ortolano, gli chiese: ‹Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai messo e io lo prenderò!›. Gesù le disse: ‹Maria!›. Ella, voltandosi, esclamò in ebraico: ‹Rabboni!›, che significa: Maestro! Gesù le disse: ‹Non trattenermi, perché non sono ancora asceso al Padre›…» (Gv 20,1-17)
Abbiamo lì una situazione descritta con una tale ricchezza di particolari che non ci manca quasi nulla se ce la vogliamo immaginare. Lo vediamo per esempio quando viene detto che un discepolo corre più veloce dell’altro, che il sudario con cui era stata coperta la testa è stato messo in un altro posto e così via. In tutti i particolari troviamo la descrizione di qualcosa che non avrebbe senso se non si riferisse a dei fatti reali.
Già in un’altra occasione ho fatto notare che ci viene raccontato che Maria non ha riconosciuto il Cristo Gesù. E ho anche richiamato l’attenzione su come sia impossibile non riconoscere a distanza di tre giorni qualcuno che prima si conosceva bene, se ci appare nelle stesse sembianze. Bisogna quindi tener conto del fatto che il Cristo è apparso a Maria sotto un’altra forma, altrimenti quelle parole non avrebbero senso.
Possiamo dunque dire due cose: dobbiamo intendere la risurrezione come effettiva evoluzione storica del risveglio che avveniva nei misteri sacri di ogni tempo, con la differenza però che nei misteri era lo ierofante a ridestare i singoli discepoli, mentre nei vangeli si indica che colui che ha risvegliato il Cristo è l’Entità a cui noi diamo il nome di “Padre”, che il Cristo è stato ridestato dal Padre stesso.
Con questo ci viene anche comunicato che quello che di solito accadeva in misura minore nelle profondità dei misteri è stato messo a disposizione dell’umanità dagli spiriti divini sul Golgota e che l’Entità stessa definita Padre è intervenuta come ierofante per risvegliare il Cristo Gesù. Troviamo quindi portato all’apice quello che di solito avveniva in misura più modesta nei misteri. E questa è una cosa.
L’altra è che alle vicende che si rifanno ai misteri sono state intessute descrizioni di particolari tali per cui ancor oggi siamo in grado di ricostruire fin nei minimi dettagli le situazioni contenute nei vangeli, come abbiamo visto nel quadro citato.
C’è ancora una cosa più importante che va considerata. Le seguenti parole devono avere un senso:
Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Poi i discepoli ritornarono a casa. (Gv 20,9-10)
Chiediamoci allora: di che cosa si erano potuti convincere fino a quel momento i discepoli?
Nel modo più chiaro possibile ci viene descritto che le bende sono lì, ma la salma no, non è più nel sepolcro. Di nient’altro si erano potuti “convincere” gli apostoli e nient’altro capivano mentre tornavano a casa. Altrimenti queste parole non avrebbero senso.
Più ci addentriamo nel testo e più dobbiamo dirci che i discepoli che erano presso il sepolcro si sono convinti che le bende erano lì e che la salma non era più nella tomba, e sono tornati a casa chiedendosi: dov’è finito il corpo? Chi l’ha portato via dal sepolcro?
E adesso i vangeli ci portano lentamente dalla convinzione che la salma non c’è più, stando agli elementi attraverso i quali i discepoli vengono convinti della “risurrezione”.
Cos’è che li convince? Il fatto che, come ci raccontano i vangeli, il Cristo è “apparso” loro gradualmente, così che hanno potuto dirsi: «Egli è qui!», al punto che Tommaso, chiamato “l’incredulo”, ha potuto toccare direttamente le sue ferite.
In breve, dai vangeli possiamo vedere che gli apostoli si sono convinti della risurrezione solo perché in seguito il Cristo è apparso loro come risorto. Il fatto che Egli fosse presente era per loro la dimostrazione della sua risurrezione.
E se interrogati sull’effettivo contenuto della loro fede, quegli apostoli che si erano a poco a poco procurati la convinzione che il Cristo era vivo nonostante fosse morto, avrebbero risposto: «Abbiamo le prove che il Cristo vive». Ma non avrebbero parlato affatto come ha fatto in seguito Paolo quando ha vissuto l’evento di Damasco.
Chi lascia agire su di sé il Vangelo e le Lettere di Paolo noterà la profonda differenza a proposito della risurrezione fra la nota fondamentale dei vangeli e quella della concezione paolina.
È vero che Paolo fa un parallelismo fra la sua convinzione a proposito della risurrezione e quella dei vangeli, poiché nel momento in cui dice che Cristo è “risorto” indica che il Cristo, dopo essere stato crocifisso, è apparso come se fosse vivo a Cefa, ai Dodici, poi a cinquecento fratelli in una volta e da ultimo anche a lui, nato prematuro, nel fulgore del fuoco dello spirito. Così è apparso anche ai discepoli, fa notare Paolo; le sue esperienze con il Risorto non sono state diverse da quelle dei discepoli, ma a esse collega subito ciò che è stato per lui l’evento di Damasco, la sua meravigliosa e facilmente comprensibile dottrina sull’Entità del Cristo. Che cosa diventa infatti per lui l’Entità del Cristo a partire dall’evento di Damasco? Diventa per lui il “secondo Adamo”.
Paolo distingue direttamente il primo dal secondo Adamo, il Cristo.
Definisce il primo Adamo il progenitore degli uomini sulla Terra, ma come? Non è necessario andare molto lontano per trovare la risposta a questa domanda. Lo chiama il capostipite degli uomini sulla Terra poiché vede in lui il primo uomo da cui discendono tutti gli altri. Questo per Paolo significa che Adamo è colui che ha trasmesso in eredità agli uomini il corpo fisico.
Così tutti gli uomini hanno ereditato il loro corpo fisico da “Adamo”. È il corpo che per primo ci si fa incontro nella maya, nell’illusione esteriore, e che è mortale. È il corpo ereditato da Adamo, il “corpo corruttibile”, il corpo fisico dell’uomo che è soggetto alla morte. Gli uomini “indossano” questo corpo, possiamo usare quest’espressione perché rende bene.
Al contrario del primo, il “secondo Adamo”, il Cristo, viene visto da Paolo come detentore del corpo “incorruttibile”, “immortale”. E Paolo premette che grazie all’evoluzione cristiana gli uomini diventano a poco a poco capaci di mettere il secondo Adamo al posto del primo, di indossare il corpo incorruttibile del secondo Adamo, del Cristo, al posto di quello corruttibile del primo Adamo.
Paolo dunque sembra pretendere da tutti quelli che si definiscono veri cristiani niente di meno che ciò che pare lacerare tutta la vecchia concezione del mondo: come il primo corpo corruttibile deriva da Adamo, così quello incorruttibile deve derivare dal secondo Adamo, dal Cristo.
Ogni cristiano dovrebbe pertanto dirsi: «Dato che discendo da Adamo ho come lui un corpo corruttibile. E nel momento in cui mi pongo nel giusto rapporto col Cristo ricevo da Lui, che è il secondo Adamo, un corpo incorruttibile». Questa visione emerge per Paolo in tutto il suo splendore direttamente dall’evento di Damasco.
In altre parole, che cosa vuol dire Paolo? Forse lo possiamo esprimere con un semplice disegno schematico.
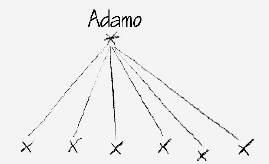
Se in un determinato momento abbiamo un numero di uomini x, in base all’albero genealogico Paolo li farà risalire tutti al primo Adamo, da cui tutti discendono e dal quale tutti hanno ricevuto il corpo corruttibile.
Secondo Paolo dev’essere altrettanto possibile anche un’altra cosa. Come per quanto riguarda la loro umanità gli uomini possono dirsi: «Siamo imparentati fra noi poiché discendiamo tutti dall’unico uomo originario, da Adamo», così secondo Paolo possono dirsi anche:
Come possiamo ricondurre ad Adamo queste linee senza il nostro intervento, attraverso i rapporti esistenti nella riproduzione fisica dell’umanità, dev’essere possibile far sorgere in noi qualcosa che ci consenta qualcos’altro. Come le linee naturali riconducono ad Adamo, così dev’essere possibile tracciare delle linee che non ci portino all’Adamo mortale con il corpo corruttibile, ma a quel corpo che è incorruttibile e che, in base alla concezione di Paolo, possiamo portare dentro di noi grazie al nostro rapporto con il Cristo, proprio come attraverso Adamo portiamo in noi il corpo corruttibile.
Per la coscienza moderna non c’è niente di più scomodo di questa idea! Che cosa ci richiede infatti, se esaminata obiettivamente? Ci richiede qualcosa che per il pensiero moderno è del tutto incredibile.
Il pensiero moderno ha discusso a lungo se tutti gli uomini discendano da un unico uomo originario. Ma per l’origine fisica si può ancora accettare che tutti gli uomini discendano da un unico uomo esistito una volta sulla Terra.
Paolo però esige quanto segue: Se vuoi diventare un cristiano nel senso giusto, devi immaginarti che dentro di te possa nascere e vivere qualcosa a proposito del quale devi dire che anche da esso è possibile tracciare delle linee spirituali verso un “secondo Adamo”, verso il Cristo – e precisamente verso quel Cristo che il terzo giorno si è sollevato dal sepolcro –, proprio come tutti gli uomini possono tracciare delle linee che vanno fino al corpo fisico del “primo Adamo”.
(V. Disegno, p. 147)
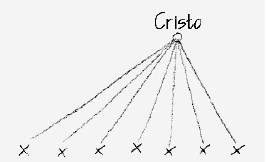
Così Paolo esige da tutti quelli che si definiscono cristiani che creino dentro di sé qualcosa che è davvero in loro e che, così come il corpo corruttibile riconduce ad Adamo, porta a quello che il terzo giorno si è sollevato dal sepolcro in cui era stato deposto il corpo del Cristo Gesù. Chi non lo ammette non ha nulla a che fare con Paolo, non può sostenere di capirlo.
Se rispetto al proprio corpo corruttibile si discende dal primo Adamo si può, immedesimandosi profondamente nell’Entità del Cristo, avere un secondo progenitore. Ma si tratta di Colui che il terzo giorno dopo la sepoltura in terra di Gesù si è levato dal sepolcro.
Dev’esser chiaro che questo è quanto Paolo sostiene, per quanto scomodo possa risultare al pensiero moderno. Da questa interpretazione paolina cercheremo poi l’aggancio al pensiero moderno, ma è chiaro che non si può vedere in altro modo quello che Paolo ci muove incontro così chiaramente. Non va cavillato su ciò che in Paolo viene espresso in modo così chiaro. È di sicuro comodo interpretarlo allegoricamente e dire che Paolo ha inteso dire questo e quello, ma tutte queste “interpretazioni” sono prive di senso.
Se vogliamo dargli un significato, non ci resta che affermare che secondo Paolo il Cristo è “risorto” dopo tre giorni, anche se per la coscienza moderna è un’aberrazione.
Ma andiamo avanti. A questo punto vorrei aggiungere che un’affermazione come quella fatta da Paolo dopo aver raggiunto il culmine della sua iniziazione grazie all’evento di Damasco – la dichiarazione sul secondo Adamo e sulla sua risurrezione dal sepolcro – poteva essere fatta solo da uno il cui modo di pensare proveniva in tutto e per tutto dall’ellenismo, da uno che aveva le proprie radici nell’ellenismo pur essendo un membro del popolo ebraico, uno che in un certo senso aveva sacrificato tutto il suo ebraismo alla concezione greca.
Che cosa sostiene in effetti Paolo, se esaminiamo più da vicino la questione? In base alla sua visione Paolo dice, riferendosi a ciò che i greci amavano e apprezzavano, cioè la forma esteriore del corpo umano di cui avevano la tragica sensazione che finisse nel momento in cui l’uomo varca la soglia della morte: con la risurrezione del Cristo questa forma esteriore si è sollevata trionfante dal sepolcro!
E il modo migliore per gettare un ponte fra queste due concezioni del mondo è il seguente: in base al suo sentire l’eroe greco diceva: «Meglio essere un mendicante sulla Terra che un re nel regno delle ombre!», e lo affermava perché secondo il suo sentimento in quanto greco era convinto che ciò che amava, vale a dire la forma esteriore del corpo fisico, andasse perduta per sempre una volta varcata la porta della morte.
Paolo, il divulgatore del Vangelo fra i greci, è comparso sul medesimo terreno sul quale era cresciuta quella tragica disposizione d’animo intrisa di bellezza.
E non ci scostiamo dalle sue parole traducendole nel seguente modo: «In futuro ciò che voi apprezzate più di ogni altra cosa, la forma del corpo umano, non morirà. Il ‘Cristo’ infatti è stato il primo a risorgere di quelli che verranno ‘ridestati’ dai morti! La forma corporea fisica non va perduta, ma viene restituita all’umanità mediante la risurrezione del Cristo!».
Con la “risurrezione” l’ebreo Paolo dalla formazione culturale greca ha reso ai greci ciò che essi maggiormente apprezzavano. Solo un greco poteva pensare e parlare in quel modo, ma solo uno che nello stesso tempo fosse diventato tale con tutte le premesse che gli venivano fornite dalla sua origine ebraica. Solo un ebreo divenuto greco poteva parlare in quel modo, nessun altro.
Ma come possiamo accostarci a queste cose dal punto di vista della scienza dello spirito?
Per il momento sappiamo che Paolo richiedeva qualcosa che capovolge il pensiero moderno. Ora vogliamo cercare di avvicinarci dall’ottica della scienza dello spirito a quanto viene richiesto da Paolo.
Mettiamo dapprima insieme le cose che conosciamo dalla scienza dello spirito, per farci un’idea delle affermazioni di Paolo partendo da quello che noi stessi diciamo. Se richiamiamo all’anima le più semplici verità scientifico-spirituali, sappiamo che l’uomo consiste in corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io.
Ora, se a qualcuno che si sia occupato un po’, ma non a fondo, di scienza dello spirito, chiedete se conosce il corpo fisico dell’uomo, vi risponderà senz’altro: lo conosco molto bene, poiché lo vedo quando un uomo mi compare davanti agli occhi. Le altre parti sono sovrasensibili, invisibili, non le si può vedere, ma il corpo fisico dell’uomo lo conosco bene».
Ma il corpo fisico umano appare davvero ai nostri occhi quando andiamo incontro a un uomo con il nostro solito modo di vedere fisico e il nostro intelletto fisico?
Vi chiedo: chi ha mai visto senza chiaroveggenza un corpo fisico umano? Che cos’hanno gli uomini davanti agli occhi quando guardano solo con gli occhi fisici e comprendono solo con l’intelletto fisico? Un essere umano, ma composto da corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io. E quando abbiamo di fronte un uomo, abbiamo davanti un’unità organizzata costituita da corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io.
Dire che ci troviamo di fronte un corpo fisico ha esattamente poco senso come dire, presentando a qualcuno un bicchiere d’acqua, che contiene idrogeno!
L’acqua è composta da idrogeno e ossigeno, come l’uomo è formato da corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io. La combinazione di queste quattro parti è visibile esteriormente nel mondo fisico, come l’acqua nel bicchiere. L’idrogeno e l’ossigeno invece non si vedono, e si sbaglierebbe di grosso chi sostenesse di vedere l’uno o l’altro nell’acqua.
Così sbaglia anche chi afferma di vedere il corpo fisico quando vede un uomo nel mondo esteriore. L’osservatore dotato di sensi fisici e di intelletto fisico non vede un corpo fisico umano, bensì un essere composto da quattro parti, e il corpo fisico solo nella misura in cui è pervaso dalle altre componenti. In quella situazione però esso è trasformato proprio come l’idrogeno nell’acqua quando è unito all’ossigeno. L’idrogeno è infatti un gas, come pure l’ossigeno. Abbiamo quindi due gas dalla cui combinazione risulta un liquido.
Perché allora non dovremmo capire che l’uomo che ci appare nel mondo fisico è molto diverso dalle sue singole parti – dal corpo fisico, dal corpo eterico, dal corpo astrale e dall’Io – se anche l’acqua è molto differente dall’idrogeno e dall’ossigeno? Anche per l’uomo non dev’essere una cosa inconcepibile.
Per questo dobbiamo dire che l’uomo non può fare affidamento su quella maya, su quella parvenza illusoria che gli fornisce la percezione del corpo fisico. Se vogliamo avvicinarci all’essenza del corpo fisico umano lo dobbiamo pensare in maniera del tutto diversa.
Il fatto è che l’osservazione del corpo fisico umano fa parte dei più difficili problemi di chiaroveggenza!
Supponiamo infatti di compiere con l’uomo nel mondo esteriore quell’esperimento simile alla scomposizione dell’acqua in idrogeno e in ossigeno. Orbene, nella morte questo esperimento viene compiuto dalla natura. Lì vediamo come l’uomo depone il proprio corpo fisico.
Ma è davvero il suo “corpo fisico” che depone? La domanda sembra ridicola: che cosa ci appare infatti più chiaro del fatto che con la morte l’uomo depone il proprio corpo fisico?
Cos’è che viene deposto dall’uomo con la morte? Qualcosa di cui perlomeno bisogna dirsi che non possiede più la cosa fondamentale che il corpo fisico ha nella vita, vale a dire la forma, che dal momento della morte comincia a essere distrutta in ciò che è stato scartato. Abbiamo di fronte sostanze in decomposizione, ormai prive di forma.
Quelli che vengono deposti sono in fin dei conti le sostanze e gli elementi che di solito troviamo anche in natura. Non è qualcosa naturalmente in grado di darsi una forma umana, però questa forma è parte assolutamente essenziale del corpo fisico umano.
Per lo sguardo chiaroveggente del principiante è come se l’uomo deponesse semplicemente queste sostanze che poi vengono portate a decomporsi o a bruciare, e come se del suo corpo fisico non restasse nulla. Dopo la morte, la chiaroveggenza comune guarda a quel composto formato da Io, corpo astrale e corpo eterico per tutto il tempo in cui l’uomo rivede la sua vita passata. E così in effetti sembra che un paio di giorni dopo la morte l’uomo abbia deposto il corpo fisico con le sue sostanze e le sue forze fisiche.
Poi, andando avanti, il chiaroveggente vede staccarsi anche il corpo eterico, vede un estratto del corpo eterico andare con il defunto e il resto dissolversi in un modo o nell’altro nell’etere cosmico universale. E, seguendo più oltre l’uomo nel periodo del kamaloka, del purgatorio, il chiaroveggente vede come di nuovo egli porti con sé un estratto del corpo astrale attraverso la vita ulteriore fra la morte e la nuova nascita, e come la parte residua del corpo astrale venga ceduta all’astralità universale.
Vediamo quindi che il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale vengono deposti e che il corpo fisico sembra esaurito in quello che abbiamo davanti nelle sostanze e nelle forze che vanno incontro alla decomposizione o alla cremazione o a un altro tipo di dissolvimento negli elementi.
Ma quanto più nel nostro tempo l’uomo svilupperà la chiaroveggenza, tanto più si renderà conto di una cosa: che ciò che viene deposto con il corpo fisico in quanto sostanze e forze fisiche non è l’intero corpo fisico, che questo non può affatto dare tutta la conformazione del corpo fisico, ma che oltre a queste sostanze e forze c’è qualcos’altro che, per usare un termine adeguato, dobbiamo chiamare “il fantoma” dell’uomo.
Questo fantoma è la figura, la forma dell’uomo, è un tessuto spirituale che elabora le sostanze e le forze fisiche, in modo che si dispongano secondo quella forma che nel mondo fisico ci muove incontro come “l’uomo”.
Come lo scultore non realizza una statua prendendo del marmo o qualcos’altro e picchiandogli sopra selvaggiamente facendone saltar via delle singole schegge, come le farebbe saltar via da sola la materia, ma deve invece avere un’idea da imprimere alla materia, così anche per il corpo umano esiste il pensiero della forma, ma non come quello dell’artista, giacché il materiale del corpo umano non è né il marmo né il gesso, ma è presente come pensiero reale nel mondo esteriore – come fantoma. Quello che lo scultore imprime alla materia, è impresso come fantoma del corpo fisico nelle sostanze che dopo la morte cediamo alla tomba o al fuoco.
Il fantoma è parte integrale del corpo fisico, è quel che rimane del corpo fisico ed è ben più importante delle sostanze esteriori, poiché queste non sono altro che qualcosa che viene “inserito” nella struttura della forma umana, allo stesso modo in cui delle mele si caricano su un carro e ne prendono la forma.
Il fantoma è qualcosa di importante! Le sostanze che vanno in decomposizione dopo la morte sono in fondo ciò che troviamo anche là fuori nella natura, solo che vengono afferrate dalla forma dell’uomo.
Riflettendo più profondamente, possiamo immaginarci che tutto il lavoro svolto dai grandi spiriti divini nel corso delle ere di Saturno, del Sole e della Luna abbia creato soltanto ciò che con la morte viene ceduto agli elementi della Terra? No, non è affatto così! Ciò che è stato sviluppato attraverso le ere di Saturno, del Sole e della Luna è il fantoma, è la forma di pensiero del corpo fisico.
Questo ci dev’essere ben chiaro: che la comprensione del corpo fisico non è così facile. Soprattutto tale comprensione non può essere cercata nel mondo della maya, nel mondo dell’illusione esteriore.
Sappiamo che i Troni hanno posto la base, il seme per così dire, per questo fantoma del corpo fisico durante l’era saturnia; che poi gli Spiriti della saggezza vi hanno ulteriormente lavorato nel corso dell’era solare, gli Spiriti del movimento nell’epoca lunare e gli Spiriti della forma nell’epoca terrestre. E solo così il corpo fisico è diventato il fantoma.
Per questo li chiamiamo Spiriti della forma, poiché vivono in quello a cui diamo il nome di fantoma del corpo fisico. Per capire il corpo fisico dobbiamo quindi risalire al suo fantoma.
Se quindi ci spostassimo al principio della nostra esistenza terrestre potremmo dire che le schiere provenienti dalle Gerarchie superiori, che nel corso delle ere di Saturno, del Sole e della Luna fino all’epoca terrestre hanno preparato il corpo fisico umano nella sua forma, hanno inserito prima di tutto questo fantoma nell’evoluzione della Terra.
In realtà il fantoma è stato la prima realtà del corpo fisico, impossibile a vedersi con gli occhi fisici. È un corpo, una struttura energetica del tutto trasparente. L’occhio fisico vede le sostanze fisiche mangiate e assimilate dall’uomo che riempiono questo contenitore invisibile. Quando l’occhio fisico osserva un corpo fisico vede in realtà le sostanze minerali che lo riempiono, ma non il corpo fisico vero e proprio.
Ma in che modo le sostanze minerali si sono inserite in questo fantoma del corpo fisico umano? Per rispondere a questa domanda richiamiamo ancora una volta alla memoria l’origine dell’uomo, il suo primo divenire sulla nostra Terra.
Da Saturno, dal Sole e dalla Luna è passata a noi quella connessione di forze che ci si presenta nella sua vera forma nel fantoma invisibile del corpo fisico e che proprio a una chiaroveggenza esperta appare come fantoma, prescindendo dalle sostanze esteriori da cui esso è riempito. Questo fantoma è quindi ciò che si trova al punto di partenza. All’inizio del suo divenire terrestre l’uomo era invisibile anche come corpo fisico.
Adesso supponiamo che a questo fantoma del corpo fisico venga aggiunto anche il corpo eterico. In tal modo il corpo fisico diverrebbe ora visibile come fantoma? Certo che no, poiché il corpo eterico è altrettanto invisibile per lo sguardo ordinario. Il corpo fisico e il corpo eterico continuano a essere invisibili nel senso fisico esteriore. Lo stesso vale per il corpo astrale, di modo che il corpo fisico come fantoma insieme al corpo eterico e a quello astrale rimane invisibile. E l’Io aggiunto a essi sarebbe percepibile a livello interiore ma esso pure invisibile esteriormente.
L’uomo giunto a noi dalle epoche di Saturno, del Sole e della Luna resterebbe dunque qualcosa di invisibile, potrebbe essere visto solo da un chiaroveggente. In virtù di che cosa è diventato visibile?
Non sarebbe divenuto visibile se non si fosse verificato quello che ci viene descritto simbolicamente dalla Bibbia e realmente dalla scienza dello spirito: l’influsso luciferico (il peccato originale). Che cosa è accaduto con esso?
Lo si può leggere nella mia Scienza occulta: dalla traiettoria evolutiva su cui l’uomo si trovava per il fatto che il suo corpo fisico, quello eterico e quello astrale erano rimasti invisibili, è stato gettato nella materia più densa, assimilandola come la doveva assimilare sotto l’influsso di Lucifero.
Se quindi nel nostro corpo astrale e nel nostro Io non ci fosse quella che chiamiamo forza luciferica, la materialità densa non sarebbe diventata così visibile com’è diventata.
Per questo dobbiamo dire che l’uomo va considerato invisibile. Solo con gli influssi di Lucifero sono entrate in lui delle forze che lo rendono visibile attraverso la materia. Per mezzo degli influssi luciferici, le sostanze e le forze esteriori entrano nella compagine del fantoma e lo compenetrano.
Come quando versiamo un liquido colorato in un bicchiere trasparente, facendo apparire colorato anche il bicchiere che di solito per il nostro occhio è trasparente, così dobbiamo immaginarci che l’influsso luciferico abbia riversato nella forma del fantoma umano delle forze che hanno reso l’uomo adatto ad assimilare quelle sostanze e forze della Terra che permettono di vedere la sua forma, altrimenti invisibile.
Cos’è dunque che rende visibile l’uomo? Le forze luciferiche nella sua interiorità lo rendono visibile così come ci appare nel mondo fisico. Diversamente il suo corpo fisico sarebbe rimasto sempre invisibile. Per questo gli alchimisti hanno sempre sottolineato che in verità il corpo fisico è fatto della stessa sostanza di cui è costituita la “pietra filosofale”, completamente trasparente e cristallina.
Il corpo fisico consiste davvero di trasparenza assoluta, e sono le forze luciferiche nell’uomo ad averlo reso non trasparente, facendo sì che esso ci risulti opaco e tangibile. Da questo vediamo che l’uomo è diventato un essere che assorbe sostanze e forze esteriori della Terra, che con la morte vengono di nuovo abbandonate, solo perché è stato sedotto da Lucifero e perché nel suo corpo astrale sono state riversate determinate forze.
Che cosa ne consegue necessariamente? Che l’uomo è diventato ciò che è sulla Terra solo quando sul nostro pianeta, sotto l’influsso di Lucifero, l’Io si è inserito nella struttura formata da corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale. Per via di questo è diventato il portatore della figura terrestre, altrimenti non lo sarebbe.
E adesso supponiamo che a un certo punto della vita l’Io abbandoni un’unità umana costituita da corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale, e che quindi ci restino davanti soltanto le prime tre parti senza l’Io. Ammettiamo che si verifichi ciò che è successo a Gesù di Nazareth nel suo trentesimo anno di vita, quando l’Io umano ha abbandonato l’insieme di corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale.
E con il battesimo nel Giordano da parte di Giovanni, l’Entità cristica entra in ciò che è rimasto, vale a dire nell’insieme di corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale. Ora al posto dell’Io in un complesso umano c’è “l’Entità cristica”.
Che cos’è allora che distingue questo “Cristo Gesù” da tutti gli altri uomini della Terra? Il fatto che tutti gli altri uomini portano in sé quell’Io che una volta ha subito la tentazione di Lucifero, mentre il Cristo Gesù non porta dentro di sé quell’Io, ma l’Entità cristica.
Così che, a partire dal battesimo di Giovanni nel Giordano, Egli porta in sé il residuo di quel che proviene da Lucifero, senza che un Io umano possa più lasciar entrare gli influssi luciferici in quel corpo. Un corpo fisico, un corpo eterico e un corpo astrale nei quali sono contenuti i residui degli influssi luciferici del passato, ma in cui nei tre anni successivi non può penetrare alcun influsso nuovo, e l’Entità cristica: ecco da che cosa è formato il Cristo Gesù.
Rendiamoci ben conto di che cosa è il Cristo dal momento del battesimo nel Giordano fino al mistero del Golgota: un corpo fisico, un corpo eterico e un corpo astrale che rende visibili i primi due, dato che contiene ancora i residui dell’influsso luciferico. Il corpo fisico è visibile infatti come portatore del Cristo poiché l’Entità cristica ha ancora i residui del corpo astrale posseduto da Gesù di Nazareth dalla nascita fino al trentesimo anno.
Dal battesimo nel Giordano da parte di Giovanni abbiamo quindi davanti a noi
• un corpo fisico che in quanto tale non sarebbe visibile nel mondo fisico,
• un corpo eterico, che come tale sarebbe altrettanto impossibile percepire,
• i residui del corpo astrale che rende visibili gli altri due, e che rende visibile il corpo di Gesù di Nazareth dal battesimo nel Giordano fino al mistero del Golgota
• e al loro interno l’entità del Cristo.
Vediamo di imprimerci bene nell’anima questa quadruplice natura del Cristo Gesù e diciamoci: ogni uomo che ci sta di fronte nel mondo fisico è costituito da corpo fisico, corpo eterico, corpo astrale e Io. Ma questo Io è tale per cui agisce nel corpo astrale fino alla morte.
L’Entità del Cristo Gesù ci sta però davanti come un’entità composta anch’essa da corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale, ma priva di un Io umano. Ecco allora che nei tre anni fino alla morte non agisce quello che agisce di solito nell’entità umana, ma è all’opera l’Entità cristica.
Vogliamo scrivere tutto ciò a chiare lettere nella nostra anima e domani osserveremo ulteriormente la cosa partendo da questo punto.
Settima conferenza
Distruzione e ripristino
del corpo del fantoma
Karlsruhe, 11 ottobre 1911
Nelle nostre riflessioni di ieri abbiamo visto che sotto un certo aspetto la questione del cristianesimo è quella della risurrezione del Cristo Gesù.
Soprattutto ci è risultato chiaro che a Paolo – quell’annunciatore del Vangelo che dopo aver riconosciuto la natura dell’impulso cristico ha subito riconosciuto anche il fatto che il Cristo dopo l’evento del Golgota continua a vivere – si è schiusa un’immagine storica imponente e grandiosa dell’evoluzione dell’umanità.
E, partendo da questo punto, ieri abbiamo spinto le nostre osservazioni fino a farci un’idea di quello che era il Cristo Gesù subito dopo il battesimo impartitogli da Giovanni nel Giordano.
Il nostro prossimo compito consisterà nell’esaminare quanto è accaduto dal momento del battesimo nel Giordano fino al mistero del Golgota.
Ma per poterci elevare dal punto di partenza di ieri fino alla comprensione di questo mistero del Golgota, sarà necessario far notare alcune cose al fine di eliminare dal cammino certi ostacoli che si presentano quando si vuol comprendere in modo serio e approfondito questo mistero.
Da tutto ciò che nel corso degli anni è stato detto sui vangeli e anche da ciò di cui si è parlato già nelle poche conferenze di questi giorni potete dedurre che in realtà certe idee scientifico-spirituali qui o là ritenute sufficienti non bastano per rispondere alla domanda di cui ci stiamo occupando.
Dobbiamo soprattutto prendere molto sul serio quanto è stato detto sulle tre correnti dell’umanità:
• la corrente emersa attraverso l’ellenismo,
• una seconda corrente che pervade l’antichità ebraica, e infine
• la corrente che ha trovato espressione nel Buddha Gautama cinquecento anni prima della nostra era.
Abbiamo visto che la corrente del Buddha, soprattutto per la piega assunta presso i suoi seguaci, è la meno indicata a trasmettere una comprensione del mistero del Golgota.
Per l’uomo moderno, pervaso dalla coscienza della cultura attuale, proprio la corrente che si esprime nella dottrina del Buddha ha sicuramente qualcosa di “comodo”. Non esiste forse un’altra corrente che venga incontro come questa ai concetti del presente, nella misura in cui tali concetti vogliono arrestarsi proprio davanti alla cosa più grande che l’umanità deve capire: la questione della risurrezione. Tutta la storia dell’umanità è infatti in relazione con la questione della risurrezione.
Come abbiamo visto, nella dottrina del Buddha è andata perduta quella che in senso proprio chiamiamo la quarta parte della natura umana, la reale essenza dell’Io.
Certo, anche a queste cose si può applicare ogni genere di cavillo e di arte interpretativa, e saranno non pochi quelli che in un certo modo criticheranno quanto è stato detto qui sulla corrente del Buddha. Ma non è questo che conta.
Infatti un esempio come il dialogo fra il re Milinda e il saggio buddista Nagasena che ho citato, e che proviene dal cuore di un buddista, indica chiaramente che nel buddismo non si può parlare della natura dell’Io umano come dobbiamo fare noi. Dobbiamo renderci conto che per un autentico seguace del buddismo il nostro modo di parlare della natura dell’Io è addirittura un’eresia. Per questo è necessario che ci intendiamo sulla natura dell’Io.
In Gesù di Nazareth possiamo parlare solo dalla nascita fino al battesimo nel Giordano di quello che chiamiamo Io umano e che riteniamo che in ogni uomo, sia pure l’adepto più elevato, passi di incarnazione in incarnazione – come abbiamo detto ieri a conclusione della conferenza.
Dopo il battesimo, nell’Entità del Cristo Gesù abbiamo ancora il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale di Gesù di Nazareth, ma in quegli involucri umani non alberga più un Io umano, bensì un essere cosmico, quello che da anni cerchiamo con le nostre parole di far comprendere come “l’Essere cristico”.
Non appena si capisce l’intera Entità del Cristo Gesù è del tutto ovvio che per Lui si debba scartare qualsiasi tipo di reincarnazione fisica, corporea, e che l’espressione usata nel mio dramma misteriosofico La prova dell’anima secondo la quale il Cristo è stato presente un’unica volta in un corpo di carne sia da prendere alla lettera e sul serio.
Dobbiamo quindi per prima cosa occuparci dell’essenza, della natura dell’Io umano, di quello che l’Entità del Cristo Gesù dal momento del battesimo nel Giordano fino al mistero del Golgota supera di gran lunga.
Dalle conferenze precedenti, nelle quali si è mostrato che prima dell’evoluzione della Terra c’è stata un’esistenza saturnia, una solare e una lunare e che queste tre incarnazioni planetarie sono state seguite da una quarta, la nostra attuale incarnazione terrestre, sappiamo che solo sulla nostra “Terra”, nel quarto degli stati planetari necessari per realizzarla con tutti i suoi esseri, quello che chiamiamo Io umano ha potuto unirsi con la natura umana. Come
• per l’antica epoca saturnia parliamo dell’inizio del corpo fisico, così
• per l’antica epoca solare parliamo del primo sviluppo del corpo eterico,
• per l’esistenza lunare del primo sviluppo del corpo astrale
• e solo nell’evoluzione terrestre parliamo dello sviluppo dell’Io.
Così starebbero le cose da un punto di vista storico, storico-cosmico. E se invece prendiamo in considerazione “l’uomo”?
In questo caso dalle considerazioni fatte finora sappiamo che, nonostante già in epoca lemurica il germe dell’Io sia stato posto nell’entità umana, solo verso la fine dell’epoca atlantidea per l’uomo si è manifestata una possibilità di giungere alla coscienza dell’Io e che comunque anche allora tale coscienza era dapprima molto crepuscolare e oscura. Anche in epoca postatlantidea, attraverso i vari periodi culturali che hanno preceduto il mistero del Golgota, la coscienza dell’Io è rimasta ancora relativamente a lungo crepuscolare, quasi sognante.
E se prendiamo in esame l’evoluzione del popolo ebraico ci renderemo conto che proprio presso questo popolo la coscienza dell’Io si è espressa in un modo particolare. Quello che è vissuto in ogni singolo membro dell’antico popolo ebraico era una sorta di “Io di popolo”. Ciascun appartenente a questo popolo faceva risalire il proprio Io al progenitore carnale, ad Abramo.
Per questo possiamo dire che l’Io dell’antico popolo ebraico è ancora tale da essere definito un Io di gruppo, un Io di gruppo etnico. La coscienza dell’Io non era ancora penetrata fino al singolo essere umano individuale. Per quale motivo?
Perché quella struttura dell’entità umana composta da quattro parti, per noi oggi normale, si è formata solo a poco a poco nel corso dell’evoluzione terrestre e perché in fondo la parte di corpo eterico che sul finire dell’epoca atlantidea si trovava ancora molto al di fuori del corpo fisico si è andata via via ritirandosi in esso.
E solo quando si è formata questa particolare organizzazione che ora con la coscienza chiaroveggente riconosciamo come normale – il fatto che corpo fisico e corpo eterico coincidano approssimativamente –, l’uomo ha avuto la possibilità di sviluppare la coscienza dell’Io.
Ma questa coscienza dell’Io ci muove incontro in maniera molto particolare. Vediamo di farci a poco a poco un’idea di come questa coscienza dell’Io si manifesta nell’uomo.
Ieri vi ho fatto notare come si sono espressi degli uomini che con tutta l’intellettualità del presente, con tutto l’acume della nostra epoca, sono stati messi davanti alla questione della risurrezione. Costoro dicono: «Se devo ammettere quello che è l’autentico insegnamento paolino sulla risurrezione, allora devo fare uno strappo in tutta la mia concezione del mondo». Questo dicono gli uomini del presente, uomini che quindi dovrebbero espellere dalla propria anima ciò che appartiene al nostro intelletto presente.
Per questi uomini che si esprimono così, ciò che va detto ora risulterà di certo come qualcosa di assolutamente estraneo.
Ma non sarebbe possibile che simili uomini facessero una volta la seguente riflessione e si chiedessero: bene, se devo accettare la risurrezione devo fare uno strappo in tutta la mia concezione intellettuale, in tutto ciò che posso pensare intellettualmente. Ma questo è un motivo per rifiutarla?
L’unica possibilità di risolvere questo conflitto consiste nel rifiutare la risurrezione per il fatto che il nostro intelletto non la capisce e la deve considerare un miracolo? Non ce ne potrebbe essere un’altra?
L’altra possibilità risulta tutt’altro che facile all’uomo moderno! Si esprimerebbe infatti in questa affermazione: forse il fatto che io non la capisca non dipende dalla risurrezione, ma dal mio intelletto. Forse il mio intelletto attuale non è adatto a comprendere la risurrezione!
Per quanto poco sul serio venga presa questa questione ai nostri giorni, si può tuttavia dire che l’uomo moderno è ostacolato dalla sua presunzione, proprio perché non pensa affatto che non c’entra con l’orgoglio il dichiarare il proprio intelletto incompetente in merito. Che cosa infatti potrebbe essere più sensato? Dire: «Rifiuto ciò che fa a pezzi la mia concezione intellettuale» o dirsi, come abbiamo appena accennato, che forse l’intelletto non è competente? Ma la presunzione non permette quest’ultima affermazione.
Naturalmente lo scienziato spirituale deve autoeducarsi per superare questa presunzione, e al vero e autentico cuore scientifico-spirituale non dovrebbe risultare estranea una frase come questa: forse il mio intelletto non ha la competenza necessaria per decidere sulla risurrezione.
Ma allora allo scienziato dello spirito si presenta un’altra difficoltà, quella di dover comprendere perché mai l’intelletto dell’uomo non può essere adatto a capire il più grande fatto dell’evoluzione umana.
Possiamo rispondere a questa domanda occupandoci dapprima in modo un po’ più preciso dell’effettiva natura dell’intelletto umano.
In proposito vorrei richiamare all’attenzione le mie conferenze di Monaco su Meraviglie del creato; prove dell’anima; manifestazioni spirituali, delle quali ora fornirò un breve riassunto riguardo ai punti che ci interessano.
Il contenuto di ciò che elaboriamo a livello interiore non è nel nostro attuale corpo fisico, ma arriva all’interno della nostra organizzazione solo fino al corpo eterico dell’uomo. Per quanto riguarda il contenuto, i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni hanno gioco solo fino al nostro corpo eterico.
Per spiegarcelo immaginiamoci la nostra entità umana composta da Io, corpo astrale e corpo eterico, simboleggiata da una superficie ellittica. È la schematizzazione grafica di quella che in questo contesto chiamiamo la nostra interiorità, di quanto possiamo sperimentare animicamente e che arriva ad esprimersi fin nelle correnti e nelle forze del corpo eterico.

Quando concepiamo un pensiero, quando proviamo una sensazione, un impulso della volontà, nella nostra anima avviene come in tre parti, che presentiamo nella figura seguente. Nella nostra vita animica non vi è assolutamente nulla che non sia in noi proprio in questo modo.
Se ora l’uomo con la sua coscienza ordinaria terrena avesse le proprie esperienze animiche solo così come le ho descritte, di certo le vivrebbe, ma non potrebbe averne coscienza, esse resterebbero inconscie. (V. Disegno I, p. 168) Prendiamo coscienza delle nostre esperienze animiche solo attraverso un processo che possiamo comprendere servendoci della seguente metafora.
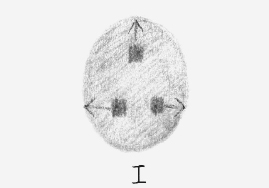
Immaginiamo di andare in una certa direzione e di guardare in avanti. Pensiamo di chiamarci “Müller”: mentre procediamo non vediamo il “Müller”, eppure lo siamo, lo sperimentiamo, siamo l’entità “Müller”. Immaginiamo poi che mentre camminiamo così qualcuno ci metta davanti uno specchio. Ora abbiamo di fronte a noi il “Müller”. Quello che prima abbiamo sperimentato, adesso lo vediamo, ci si fa incontro nello specchio.
Lo stesso avviene con tutta la vita animica umana: l’uomo la vive, ma non ne è cosciente se non gli viene tenuto di fronte uno specchio. E per la vita interiore lo “specchio” non è nient’altro che il corpo fisico.
Perciò ora possiamo disegnare schematicamente il corpo fisico come l’involucro più esterno. Le sensazioni o i pensieri vengono riflessi dall’involucro del corpo fisico. In questo modo diventiamo coscienti dei processi. Così per noi in quanto uomini terrestri il corpo fisico umano è in verità un apparato riflettente. (V. Disegno II, p. 169)
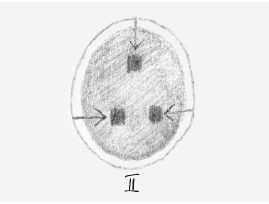
Se in questo modo ci inoltriamo sempre più a fondo nell’essenza della vita interiore e della coscienza umane, ci sarà impossibile trovare una qualsiasi giustificazione o un qualunque significato a tutte quelle cose che il materialismo continua a opporre alla concezione spirituale del mondo.
È infatti completamente assurdo, per esempio, trarre la conclusione che l’esperienza animica dipenda dall’apparecchio riflettente solo per il fatto che quando questo ha subito un danno qualsiasi la coscienza smette di percepire l’esperienza animica.
Se infatti qualcuno rompe lo specchio che abbiamo di fronte e attraverso il quale percepiamo, non per questo manda in frantumi anche noi, che ci limitiamo invece a scomparire al nostro sguardo. Così è quando l’apparecchio riflettente della vita animica, il cervello, viene distrutto. La percezione cessa, ma la vita animica in sé, nella misura in cui si svolge nel corpo eterico e in quello astrale, non ne viene affatto toccata.
Chiediamoci ora: adesso che ci rendiamo conto di questo, non siamo forse in grado di capire l’essenza e la natura del corpo fisico?
Una semplice riflessione può mostrarci che senza coscienza non possiamo arrivare all’Io, vale a dire a nessuna coscienza dell’Io. Se non sviluppiamo una coscienza non possiamo giungere all’Io.
Per procurarci sulla Terra la coscienza dell’Io, il nostro corpo fisico con l’organizzazione del cervello deve fungere da apparato riflettente. Tramite la nostra immagine riflessa dobbiamo imparare a diventare coscienti di noi stessi. Se non avessimo un apparato riflettente non potremmo prendere coscienza di noi stessi. Ma com’è fatto questo specchio?
Se ci occupiamo delle ricerche occulte, che mediante la lettura della cronaca dell’akasha risalgono fino all’origine della nostra esistenza terrestre, vediamo che in effetti proprio all’inizio dell’esistenza sulla Terra, per via dell’influsso luciferico, questo apparato riflettente, il corpo fisico esteriore, è diventato diverso da come sarebbe diventato se non ci fosse stato tale influsso. Ieri abbiamo chiarito che cosa è diventato per l’uomo terrestre questo corpo fisico. È qualcosa che si decompone quando l’uomo varca la soglia della morte.
Ma abbiamo anche detto che ciò che si decompone non è quello che gli Spiriti divini hanno “preparato” nel corso di quattro stati planetari affinché sulla Terra diventasse il corpo fisico. Quello che ieri abbiamo definito fantoma appartiene al corpo fisico come qualcosa che, come corpo formante, compenetra e nel contempo tiene insieme le parti materiali intessute nel nostro corpo fisico. Se non ci fosse stato l’influsso luciferico, all’inizio dell’esistenza terrestre l’uomo avrebbe ricevuto con il suo corpo fisico questo fantoma in piena forza.
Ma nell’organizzazione umana, nella misura in cui è formata da corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale, penetrarono gli influssi luciferici, e la conseguenza fu la rovina del fantoma del corpo fisico. Si tratta, come vedremo, di quello che nella Bibbia viene espresso simbolicamente con il “peccato originale” e con il fatto, come viene detto nell’Antico Testamento, che al peccato originale segue la “morte”.
La morte è appunto la conseguenza della distruzione del fantoma del corpo fisico. Ne deriva che l’uomo deve assistere alla decomposizione del proprio corpo fisico quando attraversa la soglia della morte.
L’uomo porta praticamente con sé per tutta la vita terrena, dalla nascita alla morte, questo corpo fisico in decomposizione a cui manca la forza del fantoma. La decomposizione è costantemente in corso e il dissolvimento totale, la morte del corpo fisico, è solo l’epilogo, il culmine di una continua evoluzione sempre in atto. Se infatti non ci si opponesse a questa decomposizione con processi di ricostruzione nello stesso modo in cui si verifica la distruzione del fantoma, si finisce per giungere a quella che chiamiamo morte.
Se non ci fosse stato un influsso luciferico, nel corpo fisico esisterebbe un equilibrio fra le forze distruttrici e quelle costruttrici. Ma allora nell’esistenza terrena tutto sarebbe stato diverso nella natura umana, allora per esempio non esisterebbe un intelletto incapace di comprendere la risurrezione.
Che tipo di intelletto è infatti quello che non è in grado di capire la risurrezione?
È l’intelletto legato al corpo fisico in decomposizione. Ed è fatto così perché con l’influsso luciferico l’uomo ha accolto in sé la distruzione del fantoma del corpo fisico. Per questo l’intelletto umano, la ragione umana, è diventato così fatuo e debole da non poter recepire i grandi processi dell’evoluzione cosmica. Li considera dei miracoli, oppure dice di non poterli capire.
Senza l’influsso luciferico l’intelletto umano, attraverso tutto ciò che gli era destinato a causa delle forze costruttrici presenti nel corpo umano che avrebbero bilanciato quelle distruttrici, sarebbe diventato tale da permettere all’uomo di capire il processo costruttivo, come si capisce un esperimento fatto in laboratorio. Invece il nostro intelletto è diventato tale per cui rimane solo alla superficie delle cose e non le vede in profondità.
Chi allora volesse descrivere correttamente questi fatti dovrebbe dire: all’inizio della nostra esistenza terrena, a causa dell’influsso luciferico, il nostro corpo non è diventato quello che sarebbe dovuto divenire in base alla volontà delle potenze che hanno agito attraverso Saturno, Sole e Luna, ma in esso si è inserito un processo di distruzione. E da quel momento, dall’inizio dell’esistenza terrena, l’uomo vive in un corpo fisico soggetto alla distruzione, un corpo che non è in grado di contrapporre adeguate forze costruttrici a quelle distruttrici.
È quindi vero ciò che all’uomo moderno sembra così strambo: che vi sia una relazione segreta fra quanto è accaduto per via dell’azione di Lucifero e la morte. Osserviamo quell’azione: qual è stato l’effetto di quella distruzione del corpo fisico?
Se avessimo il corpo fisico nella sua completezza che ci era destinata all’inizio dell’esistenza terrena, le nostre forze animiche si rifletterebbero in modo completamente diverso e noi sapremmo veramente chi siamo. Non sappiamo che cosa siamo perché il corpo fisico non ci è dato nella sua completezza.
Parliamo della natura e dell’entità dell’Io dell’uomo, ma chiediamoci: fino a che punto l’uomo conosce l’Io?
L’Io è talmente dubbio, talmente incerto, che il buddismo nega addirittura che passi da un’incarnazione all’altra. È talmente controverso che l’ellenismo poteva esser preda di uno stato d’animo tragico, come espresso nelle parole dell’eroe greco: «Meglio essere un mendicante sulla Terra che un re nel regno delle ombre».
Con questo viene detto nientedimeno che, a causa del valore che dava al corpo fisico, vale a dire a quello che riempie il fantoma, e a causa della distruzione di quel corpo, il greco provava struggimento nel momento in cui l’Io svaniva e si offuscava, poiché sentiva che l’Io può esistere solo se se ne ha coscienza. E mentre assisteva alla disgregazione della forma del corpo fisico, provava angoscia al pensiero che il suo Io si ottenebrasse, quell’Io che risulta soltanto dal suo specchiarsi nella forma del corpo fisico.
E se esaminiamo l’evoluzione umana dai primordi della Terra fino al mistero del Golgota, troviamo che il processo a cui abbiamo appena accennato si manifesta in misura sempre maggiore. Lo possiamo già vedere nel fatto che per esempio nei tempi più antichi non si sarebbe trovato nessuno che annunciasse l’annientamento del corpo fisico in maniera così radicale come ha fatto il Buddha.
Tale annuncio presuppone che il disfacimento del corpo umano, il totale annientamento della sua forma, si compisse sempre più in modo da far svanire ogni speranza che ciò che diviene cosciente mediante il corpo fisico, mediante la sua forma, possa veramente passare da un’incarnazione all’altra.
In realtà l’uomo ha perduto nel corso dell’evoluzione terrena la forma del corpo fisico, gli manca ciò che gli esseri divini gli avevano destinato fin dall’inizio della Terra. Doveva perciò riottenerlo, doveva essergli di nuovo trasmesso.
È impossibile comprendere il cristianesimo se non ci si rende conto che, ai tempi in cui si sono svolti gli eventi della Palestina, il genere umano sulla Terra era giunto al culmine della distruzione del corpo fisico e che l’intera evoluzione dell’umanità correva il rischio di perdere la coscienza dell’Io, la vera conquista dell’evoluzione terrena.
Se a ciò che era esistito prima degli eventi della Palestina non si fosse aggiunto nient’altro, tale processo sarebbe progredito oltre, nella corporeità fisica umana sarebbe entrato sempre più l’elemento distruttivo. Gli uomini nati dopo gli eventi della Palestina avrebbero dovuto vivere con un senso dell’Io sempre più vago. Quello che dipende dalla perfezione del rispecchiamento dovuto al corpo fisico sarebbe divenuto sempre più opaco.
Allora subentrò il mistero del Golgota così come lo abbiamo descritto.
E grazie al mistero del Golgota si è effettivamente verificato quello che risulta così difficile da capire all’intelletto che è prevalentemente legato al corpo fisico colmo di forze distruttrici.
È successo che quell’uomo che era il portatore del Cristo ha attraversato una morte tale per cui dopo tre giorni la parte mortale del corpo fisico umano ha dovuto sparire.
E dal sepolcro è emerso quel corpo che porta in sé le forze delle parti fisico-materiali. Ciò che era stato destinato all’uomo dai reggenti di Saturno, del Sole e della Luna si è sollevato dalla tomba: il puro fantoma del corpo fisico, con tutte le caratteristiche del corpo fisico.
Così è sorta la possibilità di quell’albero genealogico spirituale di cui abbiamo parlato.
Se pensiamo al corpo del Cristo risorto dalla tomba, possiamo immaginarci che, come i corpi degli uomini terrestri discendono dal corpo di Adamo nella misura in cui hanno un corpo corruttibile, così da Colui che è risuscitato dal sepolcro discendono i corpi spirituali, i fantomi per tutti gli uomini.
Ed è possibile instaurare un tipo di rapporto con il Cristo attraverso il quale l’uomo terrestre inserisce nel suo corpo fisico, altrimenti corruttibile, questo fantoma risorto dal sepolcro del Golgota. È possibile che l’uomo riceva nella propria organizzazione le forze allora risorte nello stesso modo in cui all’inizio della Terra, attraverso la sua organizzazione fisica, ha ricevuto l’organizzazione di Adamo a causa delle forze luciferiche.
È questo che vuol dire Paolo: come l’uomo, in quanto membro della corrente evolutiva fisica, ha ereditato il corpo fisico in cui si è andata sempre più compiendo la distruzione del fantoma, del portatore di forze, così da ciò che è risorto dalla tomba può “ereditare” quello che aveva perduto.
Lo può ereditare, se ne può rivestire, come ha fatto con il primo Adamo. Può diventare un tutt’uno con esso e attraversare quindi un’evoluzione mediante la quale risalire di nuovo, proprio come nell’evoluzione antecedente al mistero del Golgota era disceso.
Ciò significa che quanto gli è stato sottratto allora dall’influsso luciferico gli può essere restituito per il fatto che ora esiste come corpo risorto del Cristo.
Come è un gioco da ragazzi confutare dal punto di vista dell’anatomia o della fisiologia moderne tutto ciò che è stato detto in quest’ora – confutarlo apparentemente –, così è anche molto facile sollevare ora un’altra obiezione. Si potrebbe dire: se Paolo ha davvero creduto che sia risorto un corpo spirituale, che cos’ha a che fare con ciò che ogni uomo porta dentro di sé quel corpo spirituale che allora si è sollevato dal sepolcro?
Lo si può capire, basta pensare per analogia a ciò per cui ogni essere umano esiste come uomo fisico.
Si potrebbe chiedere: da dove proviene il singolo uomo? In quanto uomo fisico proviene dalla singola cellula uovo. Un corpo fisico è composto da singole cellule, che sono tutte figlie della cellula uovo originaria. Tutte le cellule che formano un corpo umano risalgono alla cellula uovo originaria.
Immaginiamo che, attraverso quello che ci si può raffigurare come processo mistico-cristologico, l’uomo ottenga un corpo completamente diverso da quello che ha ricevuto a poco a poco nella linea discendente. E immaginiamo che ognuno di questi corpi ricevuti dagli uomini sia in relazione con ciò che è risorto dalla tomba, così come le cellule umane del corpo fisico sono connesse alla cellula uovo originaria.
Ciò vuol dire che dobbiamo immaginarci che quanto è risorto si moltiplichi numericamente alla stessa velocità della cellula uovo che sta alla base del corpo fisico.
Così nell’evoluzione successiva all’evento del Golgota ogni uomo può acquisire qualcosa che agisce in lui e che, per usare le parole di Paolo, discende spiritualmente da ciò che è risorto dal sepolcro, come il normale corpo corruttibile discende da Adamo.
Ovviamente per l’intelletto umano, con l’alterigia che ha oggigiorno, è una beffa dire che a livello invisibile si verifica un processo analogo a quello della moltiplicazione della cellula uovo, che può almeno essere osservato.
Quello che è accaduto con il mistero del Golgota è un fatto spirituale. E per chi osserva l’evoluzione con occhio chiaroveggente, avviene che quel germe spirituale, cioè il corpo che ha sconfitto la morte, il corpo del Cristo Gesù risorto dal sepolcro, si trasmette a chiunque nel corso del tempo acquisisca l’adeguato rapporto con il Cristo.
Per chi vuole negare i processi sovrasensibili questo risulterà naturalmente assurdo. Ma per chi li ammette, questo processo sovrasensibile potrà essere immaginato in modo tale che ciò che si solleva dalla tomba si trasmetta agli uomini che si rendono idonei ad accoglierlo. La cosa diventa comprensibile per chi ammette il sovrasensibile.
Se scriviamo nell’anima questo che è il vero insegnamento di Paolo, arriviamo a considerare il mistero del Golgota qualcosa di reale, che si è verificato nell’evoluzione terrestre e che doveva accadere poiché è davvero la salvezza dell’Io umano.
Abbiamo visto che se il processo evolutivo fosse andato avanti come aveva fatto fino agli eventi della Palestina, la coscienza dell’Io non avrebbe potuto svilupparsi ulteriormente, dall’epoca del Cristo Gesù non sarebbe progredita, ma sarebbe invece discesa sempre più nell’oscurità.
Così invece si è avviata verso l’alto e salirà nella misura in cui gli uomini troveranno il loro rapporto con l’Entità cristica.
Ora possiamo capire bene anche il buddismo. Pensiamo a un uomo, mezzo millennio prima degli eventi della Palestina, che proclama la verità, ma che per via della sua direzione evolutiva non può tener conto dell’evento del Golgota: «Tutto ciò che avvolge l’uomo come corpo fisico, che fa di lui un essere in un’incarnazione corporea, dev’essere considerato privo di valore, fondamentalmente qualcosa di poco importante che va abbandonato». Fino a quel momento, se non fosse giunto qualcosa di diverso, l’umanità si sarebbe dovuta dirigere verso una simile concezione del mondo.
Ma si è appunto verificato l’evento del Golgota che ha prodotto un completo ripristino dei principi evolutivi dell’uomo che erano andati perduti.
Accogliendo quello che già ieri abbiamo chiamato “corpo incorruttibile” e che oggi abbiamo descritto in modo più preciso, appropriandosi di questo corpo incorruttibile, l’uomo riuscirà a rendere sempre più chiara la propria coscienza dell’Io, riconoscerà sempre più nella sua natura ciò che passa di incarnazione in incarnazione.
Così quello che è venuto nel mondo con il cristianesimo non dev’essere visto semplicemente come una nuova dottrina – e questo va ribadito con forza –, non come una nuova teoria, ma come qualcosa di reale ed effettivo.
Se quindi gli uomini sostenessero che tutto ciò che il Cristo ha insegnato c’era già anche prima, questo non significherebbe nulla per la vera comprensione del cristianesimo, poiché non è l’essenziale. L’essenziale non è quello che il Cristo ha insegnato, ma quello che ha dato: il suo corpo.
Fino ad allora infatti con nessun uomo che fosse morto era entrato nell’evoluzione terrestre quello che è risorto dal sepolcro del Golgota. Dall’inizio dell’evoluzione dell’umanità non c’era mai stato sulla Terra, tramite un uomo passato attraverso la morte, quello che c’è stato con il corpo risorto del Cristo Gesù.
Di tutto ciò che c’era in modo simile si può dire: era lì perché gli uomini, dopo aver attraversato la porta della morte e il periodo fra la morte e una nuova nascita, sono tornati a esistere grazie a una nuova nascita. Si portavano però appresso il fantoma degenere, votato al decadimento, non hanno fatto risorgere un fantoma completo.
Possiamo citare anche i casi degli iniziati o degli adepti. A loro succedeva sempre di dover ricevere l’iniziazione al di fuori del corpo fisico, superando il corpo fisico, iniziazione che non si estendeva fino al risveglio del fantoma fisico. Tutte le iniziazioni dell’era precristiana erano tali da giungere solo fino al limite estremo del corpo fisico. Non toccavano le forze del corpo fisico se non in modo generale, come l’organizzazione interiore sfiora quella esteriore.
In nessun caso era mai capitato che ciò che aveva attraversato la morte umana l’avesse superata come fantoma umano. Erano successe cose analoghe, ma mai quella per cui, dopo aver attraversato una morte umana completa, il fantoma completo avesse riportato la vittoria sulla morte.
Come è vero che solo quel fantoma ci può dare la piena umanità terrestre nel corso dell’evoluzione della Terra, così è vero anche che quel fantoma ha preso le mosse dal sepolcro del Golgota. Questa è la cosa importante nell’evoluzione cristiana.
Per questo non è un biasimo il fatto che i benpensanti continuino a ripetere che l’insegnamento del Cristo Gesù si è trasformato in un insegnamento sul Cristo Gesù. Doveva essere così, poiché ciò che conta non è quello che il Cristo Gesù ha insegnato, ma ciò che ha dato all’umanità.
La sua risurrezione è la nascita di una nuova componente della natura umana, di un corpo incorruttibile. Ma che questo potesse accadere, che questo fantoma umano potesse essere salvato attraverso la morte, dipende da due fattori:
• da un lato dal fatto che l’entità del Cristo Gesù era quella che abbiamo illustrato ieri: corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale, così come li abbiamo descritti, e non un Io umano, ma l’entità cristica;
• e dall’altro dal fatto che l’entità cristica ha deciso di calarsi in un corpo umano, di incarnarsi in un corpo umano di carne.
Infatti, se vogliamo osservare sotto la giusta luce questa Entità cristica, la dobbiamo cercare come Entità nell’epoca che precede la comparsa dell’uomo sulla Terra. L’Entità cristica esisteva già allora. Non entra nel ciclo dell’evoluzione umana, ma continua a vivere nel mondo spirituale.
L’uomo va sempre più in basso e, nel momento in cui era giunta la grande crisi per l’evoluzione umana, l’Entità cristica si è incarnata nel corpo di carne di un uomo.
Altro non è che il più grande sacrificio che ha potuto essere portato all’evoluzione terrestre dall’Entità cristica. Questa è la seconda cosa che dobbiamo capire: in che cosa consista il sacrificio fatto dall’Entità cristica all’evoluzione umana sulla Terra.
Per questo ieri abbiamo posto una parte della domanda relativa alla natura del Cristo dopo il battesimo nel Giordano da parte di Giovanni. Oggi abbiamo posto l’altra domanda: che cosa significa che con il battesimo nel Giordano l’Entità cristica è entrata in un corpo di carne?
E come si è svolta la morte nel mistero del Golgota? Di questo ci occuperemo nei prossimi giorni.
Ottava conferenza
L’uomo celeste e l’uomo terreno
In Gesù di nazareth
Karlsruhe, 12 ottobre 1911
Ieri abbiamo accennato al fatto che adesso diventa importante rispondere alla domanda: che cosa è successo a quell’Entità a cui diamo il nome di Cristo Gesù dal battesimo nel Giordano da parte di Giovanni fino al mistero del Golgota?
Per rispondere a questa domanda per quanto è possibile in un primo momento, richiamiamo brevemente alla memoria ciò che sappiamo dalle precedenti conferenze sulla vita di Gesù di Nazareth, che nel suo trentesimo anno è diventato il portatore del Cristo. Ho accennato all’essenziale anche nel mio scritto pubblicato di recente, La guida spirituale dell’uomo e dell’umanità.
Sappiamo che nella Palestina di quei tempi sono venuti al mondo non uno, ma due bambini chiamati Gesù. La strana contraddizione fra l’inizio del Vangelo di Matteo e quello di Luca deriva dal fatto che le informazioni dello scrittore del Vangelo di Matteo si riferiscono a un bambino Gesù, quello della linea salomonica della casa di Davide. Un bambino è nato dalla linea salomonica della casa di Davide ed è il bambino Gesù di cui narra il Vangelo di Matteo. Poi, non del tutto contemporaneamente, è nato un altro bambino Gesù dalla linea natanica della casa di Davide, quello di cui parla il Vangelo di Luca.
Ora l’importante è rendersi conto di che entità fossero. La ricerca spirituale mostra che l’individualità presente nel fanciullo Gesù salomonico era quella di Zarathustra che, dopo la sua principale missione di cui abbiamo parlato, svolta nella cultura paleopersiana, aveva continuato a incarnarsi, da ultimo anche nella cultura babilonese-caldea e poi appunto in questo bambino Gesù salomonico.
Era necessario che, con tutte le grandi, poderose forze interiori che portava naturalmente con sé dalle precedenti incarnazioni, questa individualità di Zarathustra si incarnasse dapprima in un corpo che discendesse dalla linea salomonica della casa di Davide e che fosse idoneo a elaborare le grandi facoltà di Zarathustra e a svilupparle nel modo in cui è possibile far evolvere le facoltà umane che si trovano già a uno stadio molto elevato, nella misura in cui appartengono a una entità che passa di incarnazione in incarnazione.
Si tratta quindi di un corpo umano che può elaborare queste facoltà non solo in età più adulta, ma già in un’organizzazione adolescente, dalle forze infantili. Vediamo perciò l’individualità di Zarathustra crescere in modo che le facoltà del ragazzo si sviluppino relativamente presto. Quel fanciullo mostrava precocemente perfino determinate conoscenze che in genere è impossibile avere a quell’età.
Ma una cosa dobbiamo tenere a mente: che questo bambino Gesù salomonico, pur essendo l’incarnazione di un’individualità così elevata, era appunto un essere umano evoluto, vale a dire che, pur essendo l’uomo più evoluto, era in un certo modo soggetto a errore, era passibile di debolezze morali, anche se non direttamente di vizi o di peccati.
Poi sappiamo che l’individualità di Zarathustra, secondo un processo spirituale noto a chiunque si sia impratichito di tali fatti, nel dodicesimo anno ha abbandonato il corpo del fanciullo Gesù salomonico per trasferirsi in quello del Gesù natanico.
Il corpo di quel fanciullo Gesù natanico – o meglio, la triplice corporeità di quel ragazzo: corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale – era molto particolare, poiché quel corpo era tale per cui il ragazzo che lo possedeva mostrava di avere proprio le facoltà opposte a quelle del Gesù salomonico.
Mentre quest’ultimo si faceva notare per il suo grande talento per le cose esteriori, che si possono appunto imparare esteriormente, per quanto riguarda le doti esteriori il bambino Gesù natanico poteva quasi essere definito “negato”. Ci è subito chiaro che questo non può essere affatto detto in senso negativo. Non era semplicemente in grado di familiarizzare con le cose create dalla civiltà umana sulla Terra.
E proprio per questo si era manifestata in lui una cosa singolare: fin dalla nascita sapeva parlare. Le doti di natura legate di più al corpo si sono rivelate come facoltà già dalla nascita. È assolutamente giusta la tradizione in base alla quale ha parlato in una lingua incomprensibile per tutti gli altri uomini. Ma riguardo al contenuto di quella lingua acquisita fin dalla nascita si racconta – e si tratta di una buona tradizione, che può essere confermata anche dall’indagine nel mondo spirituale – che la madre era in grado di capire quanto veniva detto dal bambino.
In quel bambino spiccavano proprio quelle caratteristiche che possiamo definire le qualità del cuore; era contraddistinto da un’immensa capacità di amore e da un’indole capace di straordinaria dedizione. E la cosa singolare era che, fin dal primo giorno di vita, la sua semplice presenza o anche solo il suo sfiorare le cose o le persone produceva degli effetti benefici, che oggi potremmo definire “magnetici”. In quel bimbo si manifestavano tutte le qualità del cuore, amplificate al punto da potersi esplicare in azioni benefiche per il suo ambiente.
Sappiamo anche che nel corpo astrale di quel bambino agivano le forze acquisite una volta da quel bodhisattva che è poi diventato il Buddha. Sappiamo – e a questo proposito la tradizione orientale è assolutamente esatta, poiché può essere verificata dalla scienza dello spirito – che il bodhisattva diventato Buddha cinquecento anni prima della nostra era non doveva più incarnarsi in corpi fisici sulla Terra. Da allora in poi aveva cominciato ad agire su tutti quelli che seguivano la sua dottrina, ma dal mondo spirituale.
Questa è la peculiarità di una simile individualità, che ascende fino a un punto per cui non ha più bisogno di incarnarsi in un corpo fisico, e prende poi parte alle vicende e alle sorti della nostra esistenza terrena dall’alto dei mondi spirituali. Questo può avvenire nei modi più svariati. In effetti il bodhisattva che si è incarnato per l’ultima volta sulla Terra come Buddha ha preso parte in modo essenziale all’ulteriore evoluzione dell’umanità.
Ci dobbiamo rendere conto che il nostro mondo spirituale umano è in connessione costante con tutto il rimanente mondo spirituale. Ci sia ben chiaro che l’uomo non si limita a mangiare e a bere, assimilando così le sostanze della Terra fisica, ma riceve in continuazione nutrimento animico-spirituale dal mondo spirituale, che nell’esistenza fisico-terrena affluiscono perennemente forze dai mondi spirituali, nei modi più disparati.
Un simile affluire nell’ulteriore andamento dell’umanità delle forze conquistatesi dal Buddha si è verificato grazie al fatto che quelle forze hanno pervaso il corpo astrale del bambino Gesù natanico, così che nel corpo astrale del fanciullo agiva ciò che il Buddha doveva dare all’umanità nella forma che si confaceva a quei tempi.
Sappiamo anche dalle conferenze precedenti che in sostanza le parole da noi usate ancor oggi come massima natalizia: «La rivelazione si manifesta dalle altezze dei mondi e la pace si diffonderà sulla Terra nei cuori di coloro che sono di buona volontà» derivano da ciò che è confluito nell’evoluzione dell’umanità per il fatto che le forze del Buddha si sono immerse nel corpo astrale del bambino Gesù natanico.
Vediamo così le forze del Buddha continuare ad agire nella corrente dell’esistenza terrena che ha avuto come punto di partenza gli eventi della Palestina. Quelle forze del Buddha hanno poi continuato ad agire, ed è comunque molto interessante che proprio le più recenti ricerche spirituali svolte negli ultimi anni nell’occultismo occidentale abbiano portato a riconoscere l’esistenza di un importantissimo legame fra quelle forze e la cultura europea.
Da molto tempo quelle forze del Buddha agiscono dai mondi spirituali, in particolar modo su tutto ciò che nella cultura occidentale sarebbe impensabile senza l’influsso specificamente cristiano. Le correnti ideologiche che vediamo svilupparsi negli ultimi secoli fino al diciannovesimo sono tutte pervase dall’impulso cristico, nella misura in cui sono correnti spirituali occidentali, ma in esse ha sempre operato il Buddha dal mondo spirituale.
Possiamo allora dire che la cosa più importante che l’umanità europea odierna può ricevere dal Buddha non deve provenire dalla tradizione di ciò che il Buddha ha dato agli uomini mezzo millennio prima dell’era cristiana, ma da quello che da allora è diventato. Egli infatti non si è fermato, ma ha continuato a evolvere. E proprio grazie a questo progresso come essere spirituale nei mondi spirituali ha potuto prender parte nel senso più alto all’ulteriore evoluzione della cultura occidentale.
Questo è senz’altro un risultato all’interno della nostra ricerca occulta che coincide in maniera straordinaria con molti elementi con cui siamo già entrati in contatto prima che questo importante influsso venisse nuovamente studiato a fondo.
Sappiamo infatti che la stessa individualità comparsa in Oriente come Buddha aveva già operato in precedenza in Occidente e che certe leggende e tradizioni collegate al nome Bodha o Wotan hanno a che fare con la medesima individualità presentatasi più tardi come Buddha Gautama nel buddismo orientale. Ecco allora che in un certo senso viene occupato nuovamente lo stesso luogo d’azione che già prima era stato preparato dalla medesima individualità rispetto all’evoluzione dell’umanità.
Così concatenate fra loro sono le vie percorse dalle correnti spirituali dell’evoluzione dell’umanità!
Oggi la cosa fondamentale per noi è che nel corpo astrale del bambino Gesù natanico sono attive le forze del Buddha. Quando quel bambino ebbe dodici anni, l’individualità di Zarathustra entrò nella sua triplice corporeità.
Per quale motivo quel fanciullo Gesù possedeva le singolari qualità che abbiamo or ora descritto? Perché non era un’individualità umana come le altre, ma in un certo modo era completamente diversa da ogni altra.
Per capirla dobbiamo risalire all’antica epoca lemurica, l’era in cui sostanzialmente l’evoluzione terrestre degli uomini ha avuto il suo vero e proprio inizio.
Dobbiamo renderci conto che tutto ciò che esisteva prima dell’era lemurica era in effetti solo una ripetizione dell’esistenza di Saturno, del Sole e della Luna e che solo allora l’Io è stato dato nell’uomo come primo germe, come possibilità di accogliere nell’evoluzione terrena la quarta componente della sua entità, l’Io.
Se consideriamo tutta la corrente dell’evoluzione del genere umano, dobbiamo dirci che, così come si è diffusa sulla Terra in epoca lemurica (e di questo fenomeno trovate una descrizione più dettagliata nella mia Scienza occulta), l’umanità va fatta risalire a determinati antenati umani di quel periodo iniziale della nostra Terra odierna.
E nell’era lemurica dobbiamo stabilire un momento a partire dal quale possiamo parlare di “genere umano” nel senso attuale del termine. Rispetto a quello che c’era prima non si può dire che negli uomini terrestri fosse già presente l’Io che poi avrebbe continuato a reincarnarsi. Le cose non stavano così.
Prima l’Io dell’uomo non era ancora in nessun modo separato dalla sostanza di quella Gerarchia che all’inizio diede la predisposizione a esso, la Gerarchia degli Spiriti della forma. Possiamo ora immaginarci, e la ricerca spirituale ce lo conferma, che una parte della sostanza degli Spiriti della forma sia penetrata per così dire nelle incarnazioni umane per la formazione dell’Io umano.
Ma quando l’uomo è stato consegnato alle sue incarnazioni corporee sulla Terra, di quello che doveva diventare “uomo” è stato trattenuto qualcosa. È stata per così dire trattenuta una sostanza dell’Io che non è stata inserita nel flusso delle incarnazioni corporee.
Se vogliamo immaginarci questo flusso delle incarnazioni corporee dell’uomo, che ha inizio con quello a cui la Bibbia dà il nome di “Adamo”, il progenitore del genere umano, dobbiamo disegnare un albero genealogico dalle numerose ramificazioni. Ma possiamo semplicemente immaginare che quello che si è riversato dagli Spiriti della forma continui a fluire.
Qualcosa però è stato trattenuto nel mondo spirituale, in un certo senso preservato dall’ingresso nelle incarnazioni corporee – un “Io” che non continuava ad apparire come uomo, ma che conservava quella forma, quella sostanzialità propria dell’uomo prima della sua prima incarnazione terrestre.
Un Io dunque che continuava a vivere accanto al resto dell’umanità e che ai tempi di cui stiamo parlando, in cui dovevano verificarsi gli eventi della Palestina, non si era mai incarnato in un corpo fisico umano, un Io che, se vogliamo esprimerci in termini biblici, era ancora nella stessa situazione dell’Io di Adamo antecedente alla sua prima incarnazione corporea terrestre. Un tale Io era sempre esistito.
Se ora ci accostiamo un po’ alle conoscenze di scienza spirituale relative a quell’Io, che naturalmente per l’uomo d’oggi sono del tutto assurde, vediamo che l’Io tenuto per così dire “di riserva” non è stato condotto in un corpo umano, ma in effetti è stato affidato solo ai misteri sacri, esistiti attraverso l’era atlantidea e postatlantidea. In un importante centro misterico veniva conservato come in un tabernacolo, perciò quell’Io aveva delle caratteristiche molto particolari.
Aveva la particolarità di non essere sfiorato da tutto ciò che un Io umano poteva sperimentare sulla Terra. Non era stato sfiorato neppure da tutti gli influssi luciferici e arimanici. Era praticamente qualcosa che, rispetto a tutti gli altri Io umani, possiamo immaginarci come una sfera vuota, qualcosa di ancora completamente vergine rispetto a tutte le esperienze terrene, un nulla, qualcosa di negativo rispetto a tutte le esperienze terrene.
Per questo sembrava che il bambino Gesù natanico descritto nel Vangelo di Luca fosse privo di Io umano, come se fosse costituito solo da corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale. E per il momento ci basta dire che nel bambino Gesù di Luca non c’è un Io evoluto come quello sviluppatosi attraverso l’epoca atlantidea e postatlantidea.
Ci esprimiamo nel senso giusto dicendo che nel bambino Gesù di Matteo abbiamo a che fare con un essere umano dotato di Io pienamente formato, mentre nel bambino Gesù del Vangelo di Luca abbiamo a che fare con un corpo fisico, un corpo eterico e un corpo astrale disposti in modo da rappresentare l’uomo armonico quale è giunto a noi come risultato dell’evoluzione saturnia, solare e lunare.
Per questo quel fanciullo Gesù, come ci insegna la cronaca dell’akasha, non aveva alcuna predisposizione per tutto ciò che la civiltà umana aveva sviluppato. Non lo poteva accogliere, poiché non vi aveva mai preso parte. Noi manifestiamo di avere delle abilità e delle capacità esteriori per affrontare l’esistenza, per il fatto che in incarnazioni precedenti abbiamo già preso parte a determinate attività. Ma chi non le ha mai svolte si rivela inadeguato per tutto ciò che gli uomini hanno realizzato nel corso dell’evoluzione terrestre.
Se il bambino Gesù natanico fosse nato nella nostra epoca, avrebbe mostrato uno scarsissimo talento nell’imparare a scrivere, poiché ai tempi di Adamo gli uomini non scrivevano e prima ancora men che meno.
Il bambino Gesù di Luca risultava assolutamente privo di talento per tutto ciò che si è acquisito nel corso dell’evoluzione dell’umanità. Invece le qualità interiori che aveva portato con sé e che non si erano degenerate per via degli influssi luciferici si manifestavano in lui a un grado elevato.
Ancor più interessante è il fatto che questo bambino Gesù parlasse una lingua singolare. A questo proposito dobbiamo prendere in considerazione quanto ho scritto nel mio libro La guida spirituale dell’uomo e dell’umanità: le lingue oggi diffuse sulla Terra che compaiono presso le varie etnie sono sorte relativamente tardi nell’evoluzione dell’umanità e sono state realmente precedute da quella che si potrebbe definire una “protolingua umana”.
Sono stati gli Spiriti separatori del mondo luciferico e arimanico a portare sulla Terra le varie lingue a partire da quella originaria. La protolingua è andata perduta e al giorno d’oggi non può essere parlata da nessun uomo il cui Io sia passato di incarnazione in incarnazione nel corso dell’evoluzione terrestre.
Quel Gesù bambino che non aveva attraversato le incarnazioni umane era stato dotato fin dall’inizio dell’evoluzione dell’umanità della facoltà di parlare non una lingua qualsiasi, ma quella di cui a ragione si sosteneva che non fosse comprensibile per l’ambiente circostante, ma che per l’intensità di cuore che viveva in essa poteva essere capita dal cuore di sua madre. In questo modo si richiama l’attenzione su un fenomeno di enorme importanza che riguarda il bambino Gesù di Luca.
Quando è nato, quel bambino Gesù era quindi dotato di tutto ciò che non aveva subito l’influsso delle forze luciferico-arimaniche. Non aveva un Io incarnatosi ripetutamente, per questo non è stato necessario espellere nulla quando nel suo dodicesimo anno l’individualità di Zarathustra ha abbandonato il bambino Gesù salomonico del Vangelo di Matteo per entrare nel bambino Gesù natanico.
Prima ho detto che questa parte umana rimasta indietro, che fino ad allora si era sviluppata nei misteri accanto al resto dell’umanità, è nata per la prima volta come bambino Gesù natanico ai tempi degli eventi della Palestina. Si trattava del trasferimento da un centro misterico dell’Asia anteriore, in cui quel germe umano era stato conservato, nel corpo del bambino Gesù natanico.
Quel bambino crebbe e quando ebbe dodici anni si trasferì in lui l’individualità di Zarathustra. Sappiamo anche che questo passaggio ci viene indicato con la scena di Gesù dodicenne nel tempio. È comprensibile che i genitori del bambino Gesù natanico, abituati a considerare il figlio nel modo in cui lo abbiamo appena descritto, debbano aver rilevato uno strano cambiamento in lui quando, dopo averlo perduto, l’hanno ritrovato nel tempio.
Quello è stato infatti il momento in cui nel fanciullo dodicenne è entrata l’individualità di Zarathustra, così che dai dodici ai trent’anni nel Gesù di Luca abbiamo l’individualità di Zarathustra.
Nel Vangelo di Luca troviamo un singolare commento, con il quale si fa riferimento a qualcosa che può essere chiarito solo dalla ricerca scientifico-spirituale.
Sappiamo che nel Vangelo di Luca, dopo la descrizione della scena con Gesù dodicenne nel tempio, si trova questo passo:
«Intanto Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini.» (Lc 2, 52).
Così leggiamo nella Bibbia delle edizioni correnti (Ed. Paoline, [NdT]); anche Lutero lo traduce in questo modo. La frase non ha però molto senso.
Leggendo infatti: «Gesù cresceva in statura», vorrei sapere che cosa significa una frase simile riferita a un ragazzo di dodici anni. Per questo bastava il trascorrere del tempo! Ma in verità in quel brano, se riproduciamo il testo dei vangeli dalla cronaca dell’invisibile, si dice che:
• cresceva in tutto quello in cui può crescere un corpo astrale, vale a dire in saggezza;
• cresceva in tutto quello in cui può crescere un corpo eterico, vale a dire in tutte le qualità della bontà, della benevolenza e così via;
• e cresceva in tutto quello in cui può crescere un corpo fisico, il che si manifesta esteriormente nella bella corporatura.
Con ciò dev’essere accennato particolarmente al fatto che il fanciullo Gesù, per via delle caratteristiche da lui possedute fino ai dodici anni, era rimasto incontaminato, non era stato affatto toccato nella sua individualità dalle forze luciferiche e arimaniche, dal momento che non era un’individualità passata di incarnazione in incarnazione.
Il Vangelo di Luca lo indica ancora in modo molto particolare seguendo la serie delle generazioni, passando da Adamo per salire fino a “Dio”, per dire che è la sostanza che non ha subito l’influsso di tutto ciò che è passato attraverso l’evoluzione umana.
Dunque questo fanciullo Gesù cresce in tutto quello che è possibile nello sviluppo di una triplice corporeità che non è stata toccata da quello che ha influenzato le triplici corporeità degli altri uomini.
E a quel punto l’individualità di Zarathustra aveva la possibilità di collegare l’eccellenza raggiunta fino ad allora con tutto ciò che di meraviglioso era contenuto in quella triplice corporeità, poiché essa non era stata corrotta da nulla, ma anzi aveva potuto sviluppare tutto quello che può essere sviluppato esteriormente solo da un corpo fisico, da un corpo eterico e da un corpo astrale ideali. Questo indica la frase del Vangelo di Luca che abbiamo appena citato.
Così fu possibile che fino al trentesimo anno nello sviluppo di quel giovane entrasse qualcosa di cui possiamo dire: fino al trentesimo anno quell’individualità di Zarathustra era in grado di effondere in quella triplice corporeità umana tutto ciò che può provenire da un’individualità così eccelsa.
Ci facciamo un’idea giusta di Gesù di Nazareth fino al suo trentesimo anno immaginandolo come un’elevata individualità umana, un’individualità appunto per la cui realizzazione erano stati fatti, come abbiamo visto, i più grandi preparativi possibili.
Ma, se vogliamo intenderci, ci dobbiamo rendere conto di una cosa: i frutti dello sviluppo che viviamo nei nostri corpi vanno a beneficio dell’individualità. I nostri corpi ci forniscono l’occasione affinché la nostra individualità tragga da essi i frutti per la sua ulteriore evoluzione.
Quando al momento della morte, la morte di un uomo normale, abbandoniamo i nostri corpi, non lasciamo in essi ciò che abbiamo acquisito ed elaborato come individualità. Vedremo in seguito a quali particolari condizioni può rimanere qualcosa nei corpi. Ma la regola, la norma, è che l’individualità non abbandona nei corpi ciò che ha conseguito.
Quindi, mentre abbandona la triplice corporeità di Gesù di Nazareth nel suo trentesimo anno, Zarathustra si lascia alle spalle i tre corpi, quello fisico, quello astrale e quello eterico. Ma tutto quello che Zarathustra ha potuto procurarsi come individualità grazie a questi tre strumenti entra nella sua stessa individualità, continua a vivere con essa anche dopo aver abbandonato la triplice corporeità. Ciò va a beneficio di questa individualità.
Una cosa è sicuramente stata raggiunta nella triplice corporeità di Gesù di Nazareth: l’unione fra la natura umana, così com’era prima degli influssi luciferici e arimanici, e quell’individualità che nel modo più significativo aveva guardato dentro la spiritualità del macrocosmo.
Pensate solo a tutto quello che aveva attraversato questa individualità di Zarathustra. Un tempo, quando lavorava alla fondazione della civiltà paleopersiana sollevando lo sguardo verso il grande spirito solare, i suoi occhi penetravano nelle vastità cosmiche dello spirito. E proprio questa individualità continuava a evolvere attraverso le incarnazioni successive.
Se il profondo della natura umana con le forze più intense dell’amore e della compassione si era realizzato per il fatto che una sostanza umana pura era rimasta conservata fino alla nascita del Gesù natanico, e per il fatto che il corpo astrale si era poi compenetrato delle forze del Buddha – se quindi nel Gesù natanico vi era quella che possiamo chiamare la più profonda interiorità dell’uomo –, allora nel dodicesimo anno a questa corporeità si è unita quell’individualità umana che più di ogni altra aveva guardato con chiarezza e profondità nella spiritualità del macrocosmo.
In tal modo però gli strumenti del Gesù natanico sono stati trasformati al punto da diventare idonei ad accogliere in sé l’essenza cristica del macrocosmo.
Se quella corporeità non fosse stata pervasa fino ai trent’anni dall’individualità di Zarathustra, i suoi occhi non sarebbero stati in grado, dal trentesimo anno al mistero del Golgota, di sopportare la sostanza del Cristo, al trentesimo anno le sue mani non sarebbero state capaci di compenetrarsi della sostanza del Cristo. Per poter accogliere il Cristo quella corporeità ha dovuto essere preparata, per così dire dilatata, dall’individualità di Zarathustra.
Così in Gesù di Nazareth, nel momento in cui Zarathustra lo abbandona ed entra in lui l’individualità del Cristo, non abbiamo né un adepto né un uomo superiore. Un adepto è infatti tale perché ha un’individualità altamente evoluta. Ma proprio questa individualità ha abbandonato la triplice corporeità di Gesù di Nazareth.
La presenza di Zarathustra è servita a preparare la triplice corporeità ad accogliere l’individualità del Cristo. Ma a quel punto, per via dell’unione dell’individualità del Cristo con quel corpo che abbiamo appena descritto, si è reso necessario quanto segue.
Durante i tre anni dal battesimo nel Giordano fino al vero e proprio mistero del Golgota, lo sviluppo del corpo fisico, del corpo eterico e del corpo astrale è stato completamente diverso da quello degli altri uomini.
Dato che le forze luciferiche e arimaniche non avevano esercitato alcun influsso sul Gesù natanico nel corso di incarnazioni precedenti, dato che ora in quel Gesù di Nazareth non c’era un Io individuale umano, ma l’individualità del Cristo, è stato possibile che dal battesimo nel Giordano in poi non venisse formato tutto ciò che di solito deve agire nella corporeità dell’uomo.
Ieri abbiamo parlato di come quello che chiamiamo il fantoma umano, la vera forma originaria che assorbe gli elementi materiali, li assimila e poi li abbandona con la morte, sia degenerato nel corso dell’evoluzione umana fino al mistero del Golgota.
In un certo modo possiamo intendere questa degenerazione come se quel fantoma fosse destinato fin dall’inizio dell’evoluzione umana a non essere affetto dalle parti materiali che l’uomo assorbe sotto forma di cibo dal regno minerale, vegetale e animale. Il fantoma non avrebbe dovuto esserne toccato, ma così non è stato.
A causa dell’influsso luciferico sorse uno stretto legame fra il fantoma e le forze assorbite dall’uomo attraverso il nutrimento terreno, soprattutto con l’elemento della cenere. La conseguenza dell’influsso luciferico fu dunque che, nel corso dell’ulteriore evoluzione dell’umanità, il fantoma sviluppò una forte attrazione per le componenti della cenere e, invece di seguire il corpo eterico dell’uomo, si aggregò ai prodotti di disintegrazione. Tutto ciò avvenne come conseguenza dell’influsso luciferico.
E laddove questi influssi luciferici erano stati tenuti lontani come nel caso del Gesù natanico, nel quale non c’era un Io umano ma dal battesimo nel Giordano in poi era presente l’Entità cosmica del Cristo, risultò l’assenza di ogni genere di forza di attrazione fra il fantoma umano e quello che veniva assimilato sotto forma di parti materiali.
Per tutti e tre gli anni il fantoma rimase incontaminato dalle parti materiali.
A livello occulto lo si esprime dicendo che il fantoma umano, in base a come si era andato formando attraverso le epoche di Saturno, del Sole e della Luna, non avrebbe dovuto esercitare nessuna forza di attrazione verso le componenti della cenere, ma solo per le componenti solubili del sale, così da evaporare nella misura in cui le componenti del sale si dissolvono. In senso scientifico-spirituale si direbbe che “si dissolve” e finisce non nella terra, ma negli elementi volatili.
Ma proprio questo era il fatto, che cioè con il battesimo nel Giordano da parte di Giovanni, con il passaggio dell’individualità del Cristo nel corpo del Gesù natanico, ogni relazione fra il fantoma e le componenti della cenere venne annullata, eliminata, e rimase solo la connessione con le componenti del sale.
Lo vediamo anche quando il Cristo Gesù vuole spiegare ai suoi discepoli che attraverso il modo in cui essi si sentono uniti all’Entità cristica dev’essere creata la possibilità di ulteriore evoluzione umana, grazie al fatto che quel corpo risorto dal sepolcro – il corpo spirituale – possa trasferirsi agli uomini. È questo che il Cristo intende dire con la frase: «Voi siete il sale della Terra». (Mt 5,13)
Tutte queste parole, di nuovo ricordate nella terminologia e nelle espressioni artistiche degli alchimisti e dell’occultismo successivi, tutte queste parole che troviamo nei vangeli hanno il significato più profondo che si possa immaginare. Tale significato era ben noto ai veri alchimisti del medioevo e delle epoche postmedievali, non ai ciarlatani di cui parla la letteratura. E nessuno esprimeva queste relazioni senza sentirsi nel suo cuore in rapporto con il Cristo.
È quindi emerso che quando il Cristo Gesù è stato crocifisso, quando il suo corpo è stato inchiodato alla croce – notate che sto usando le stesse parole del Vangelo per il semplice motivo che le vere ricerche scientifico-spirituali le confermano in maniera assoluta –, quando il corpo di Gesù di Nazareth è stato conficcato sulla croce, il fantoma era perfettamente intatto. Esisteva come forma corporea spirituale, visibile solo a livello sovrasensibile, e la connessione che aveva con il contenuto materiale degli elementi terreni era molto più esile che in chiunque altro, per il semplice motivo che in ogni altro uomo è subentrata una tale unione del fantoma con gli elementi che tiene insieme questi elementi.
Per il Cristo Gesù le cose stavano in tutt’altro modo. Era come se, in base alla legge della forza d’inerzia, determinate parti materiali restassero ancora insieme nella forma data loro, per disgregarsi dopo un po’ così che di esse non resta visibile quasi nulla. Questo accadde alle parti materiali del corpo del Cristo Gesù.
Quando fu deposto dalla croce, le parti erano per così dire ancora insieme, ma non avevano alcun rapporto col fantoma, perché esso ne era completamente libero.
Quando poi al corpo vennero somministrate certe spezie, che su di esso avevano un effetto del tutto diverso da quello che avevano su un altro corpo che veniva imbalsamato, dopo la sepoltura le sostanze materiali si volatilizzarono, si trasformarono rapidamente negli elementi volatili. Per questo i discepoli che andarono a vedere trovarono solo le bende con cui era stato coperto.
Dal sepolcro era “risorto” il fantoma da cui dipende l’evoluzione dell’Io.
Non c’è da stupirsi che Maria di Magdala, che conosceva solo il fantoma di prima, intriso degli elementi della Terra, non abbia potuto riconoscere nel fantoma liberato da tutta la pesantezza della Terra la stessa figura che adesso vedeva spiritualmente. Ora essa le appariva diversa. In particolare dobbiamo renderci conto che i discepoli e tutti quelli di cui ci viene raccontato, hanno potuto vedere il Risorto solo per virtù dell’essere stati insieme al Cristo.
Egli infatti apparve nel corpo spirituale, nel corpo di cui Paolo dice che si moltiplica come il seme comunicandosi a tutti gli uomini. In questo brano Paolo si dice convinto che agli altri discepoli sia apparso non il corpo permeato dagli elementi terreni, ma il medesimo corpo che è apparso a lui:
Infatti, vi ho trasmesso, prima di tutto, quanto anch’io ho ricevuto, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa e poi ai Dodici. Apparve pure a più di cinquecento fratelli in una sola volta, dei quali i più vivono tuttora, mentre alcuni sono morti. Apparve quindi a Giacomo, poi a tutti gli Apostoli. Infine, dopo tutti, è apparso anche a me, come all’aborto. (1Cor 15,3-8)
Il Cristo è apparso a Paolo attraverso l’evento di Damasco. E il fatto che il modo in cui gli è apparso venga messo sullo stesso piano delle apparizioni agli altri discepoli dimostra che il Cristo si è manifestato anche a Paolo nella medesima forma con cui è apparso agli altri. Ma che cos’è che ha convinto Paolo?
Già prima dell’evento di Damasco Paolo era in un certo senso un iniziato, ma si trattava di un’iniziazione secondo l’antico principio ebraico e quello greco. Paolo era un iniziato che, fino a quel momento, sapeva soltanto che coloro che per mezzo dell’iniziazione sono entrati in unione con il mondo spirituale nel corpo eterico si sono resi indipendenti dal corpo fisico e che in un certo modo possono apparire nella forma più pura del loro corpo eterico a chi è in grado di vederli.
Se a Paolo si fosse manifestato solo un corpo eterico puro e indipendente dal corpo fisico, avrebbe parlato diversamente. Avrebbe detto di aver visto un iniziato che continuava a vivere con l’evoluzione terrestre indipendentemente dal corpo fisico. Non sarebbe stato niente di particolarmente sorprendente per lui. Quindi non può essere questa l’esperienza che ha vissuto a Damasco.
Ciò che ha sperimentato e di cui sapeva che può essere vissuto solo quando le «Scritture si sono compiute» era che nell’atmosfera spirituale della Terra una volta ci sarebbe stato un fantoma umano completo, un corpo umano risorto dalla tomba come figura sovrasensibile.
E questo aveva visto! Questo gli era apparso a Damasco e l’aveva convinto: «Egli è qui! È risorto! È presente ciò che solo da Lui può provenire, il fantoma che può essere visto da tutte le individualità umane che cercano un rapporto con il Cristo».
Ecco che cosa l’ha convinto: che il Cristo è già presente, che non deve ancora venire; il fatto che Egli è veramente vissuto in un corpo fisico e che quel corpo fisico ha redento la vera forma originaria del corpo fisico per la salvezza di tutti gli uomini.
Domani parleremo di come quest’azione sia potuta avvenire solo grazie alla massima espressione dell’amore divino e spiegheremo in che senso si è trattato di un’azione di amore e in che senso va intesa la parola “redenzione” nell’ulteriore evoluzione dell’umanità.
Nona conferenza
La redenzione come evento
nel cosmo e nell’uomo
Karlsruhe, 13 ottobre 1911
Le conferenze tenute finora ci hanno in sostanza condotti a due questioni:
• la prima si riferisce all’evento oggettivo legato al nome del Cristo Gesù, alla natura di quell’impulso che è intervenuto nell’evoluzione umana come elemento cristico.
• la seconda si riferisce al modo in cui il singolo uomo può stabilire il proprio rapporto soggettivo con l’impulso cristico, al modo in cui questo impulso cristico agisce per il singolo individuo.
Naturalmente le risposte a queste due domande sono collegate fra loro. Abbiamo visto infatti che l’evento cristico è un fatto oggettivo dell’evoluzione umana terrestre e che da quello che ci si presenta nella “risurrezione” promana qualcosa di reale, di effettivo.
In un certo senso, con il Cristo è risorto dalla tomba una specie di seme per il ripristino dello stato del nostro fantoma umano. E quello che sotto forma di germe si è sollevato dal sepolcro con il Cristo ha la possibilità di essere incorporato negli uomini che entrano in relazione con l’impulso cristico. Questo è l’aspetto oggettivo del rapporto che il singolo individuo ha con l’impulso cristico.
Oggi vogliamo inserire nelle considerazioni dei giorni scorsi il lato soggettivo, vogliamo cioè cercare di trovare una risposta alla domanda che potremmo formulare più o meno così: come fa il singolo individuo ad accogliere a poco a poco dentro di sé ciò che si è irradiato dal Cristo per mezzo della risurrezione?
Se vogliamo rispondere a questa domanda dobbiamo prima distinguere fra due cose.
Quando il cristianesimo ha fatto il suo ingresso nel mondo come religione, non era semplicemente una religione per uomini che aspiravano all’occultismo, vale a dire per uomini che volevano accostarsi al Cristo passando per una qualche via spirituale, ma il cristianesimo era una religione che doveva valere per tutti gli uomini, che doveva poter essere accolta da tutti. Per questo non si deve credere che per trovare la via che porta al Cristo occorra una speciale evoluzione occulta o esoterica.
Dobbiamo allora innanzitutto prendere in considerazione la via verso il Cristo aperta a tutti, quella che ogni anima, ogni cuore ha potuto trovare nel corso del tempo.
Da questa via dobbiamo poi distinguere l’altra, quella che fino ai nostri giorni si apriva a un’anima che volesse seguire un percorso scientifico-spirituale, che quindi volesse cercare il Cristo non solo sul sentiero esteriore, ma attraverso l’esplicazione di forze occulte.
Dobbiamo allora distinguere fra
• la via del mondo esteriore e
• la via dei mondi sovrasensibili.
Non c’è secolo fra quelli passati che abbia avuto idee così confuse come il diciannovesimo riguardo alla via esteriore, universale, per giungere al Cristo. E il corso di questo secolo è stato tale per cui nella sua prima metà il modo di vedere era più chiaro che nella seconda. Si può dire che gli uomini si sono allontanati sempre di più dalla conoscenza della via che porta al Cristo.
Sotto questo aspetto, coloro che prendono parte al pensiero odierno non si fanno più le idee giuste, mentre per esempio ancora nel diciottesimo secolo le anime trovavano la via verso l’impulso cristico e nella prima metà del diciannovesimo secolo c’era ancora una certa possibilità di considerare l’impulso cristico qualcosa di reale. È soprattutto nel diciannovesimo secolo che questa via dell’uomo verso il Cristo è andata perduta.
Ce ne rendiamo conto se prendiamo in considerazione il fatto che ci troviamo al punto di partenza di una nuova strada che conduce al Cristo. Abbiamo parlato spesso della nuova via che si schiude alle anime come una sorta di rinnovamento dell’evento cristico.
È tipico dell’evoluzione dell’umanità che si debba arrivare a toccare il fondo riguardo a una cosa prima che possa accendersi una nuova luce. Così anche l’allontanamento dai mondi spirituali verificatosi nel diciannovesimo secolo è comprensibile se paragonato al fatto che nel ventesimo dovrà iniziare, proprio nel modo particolare più volte accennato, una nuova epoca per la vita spirituale dell’uomo.
Talvolta il nostro movimento scientifico-spirituale appare come qualcosa di assolutamente nuovo perfino a coloro che hanno già familiarizzato un po’ con la scienza dello spirito.
Se prescindiamo dal fatto che negli ultimi tempi in Occidente l’anelito scientifico-spirituale ha vissuto un arricchimento per via delle idee della reincarnazione e del karma che vi sono confluite, se prescindiamo dalla dottrina delle ripetute vite terrene e dal suo significato per l’evoluzione umana nel suo complesso, dobbiamo dire che per il resto le vie che portano al mondo spirituale, molto simili al nostro sentiero scientifico-spirituale, non rappresentano nulla di nuovo per l’evoluzione dell’umanità occidentale.
Ora, l’uomo che cerca di spingersi nei mondi spirituali sulla via odierna della scienza dello spirito trova un po’ strano il modo in cui la “teosofia” è stata coltivata per esempio nel diciottesimo secolo. Proprio in questa regione (Baden), e soprattutto nel Württemberg, nel diciottesimo secolo si è praticata moltissimo la teosofia. Solo che dappertutto mancava una visuale chiara sulla dottrina delle ripetute vite terrene, ragion per cui tutto il campo del lavoro scientifico-spirituale era in un certo modo offuscato. La mancanza di un giusto insegnamento sulle ripetute vite terrene ha fatto sì che questa visione risultasse offuscata anche per chi era in grado di guardare a fondo nei nessi spirituali, e soprattutto anche nel collegamento fra l’impulso cristico e il mondo.
Ma da tutta la cerchia della concezione cristiana del mondo e della vita cristiana è sempre sorta una specie di aspirazione scientifico-spirituale. E tale aspirazione ha agito ovunque, anche nelle vie esteriori e generali degli uomini che non potevano andare oltre una condivisione esteriore della vita comunitaria cristiana o di altre simili.
Possiamo vedere in che misura la “teosofia” ha pervaso l’aspirazione cristiana citando per esempio nomi come Bengel e Oetinger, personaggi che hanno lavorato nel Württemberg e che in tutto il loro modo di agire, se teniamo conto che non avevano l’idea delle ripetute vite terrene, sono giunti assolutamente a quello che si può raggiungere anche rispetto a concezioni superiori sull’evoluzione dell’umanità, nella misura in cui è dotata dell’impulso cristico.
Se consideriamo questo, dobbiamo dire che il punto nevralgico della vita scientifico-spirituale è sempre esistito. Per questo ci sono molte cose giuste in quello che ha scritto Rothe, che ha insegnato all’università di Heidelberg, qui nelle immediate vicinanze di Karlsruhe, nella prefazione di un libro uscito nel 1847 su alcuni argomenti teosofici del diciottesimo secolo. Dice:
«Quello che la teosofia vuole effettivamente è spesso difficile da riconoscere presso gli antichi teosofi… Ma non è meno chiaro anche che sulla via seguita finora non può condurre a nessuna esistenza scientifica e di conseguenza a nessuna azione di vasta portata. Sarebbe però molto affrettato dedurne che sia un fenomeno ingiustificato ed effimero dal punto di vista scientifico. La storia ne fornisce la prova contraria con sufficiente determinazione. Ci racconta come questo fenomeno enigmatico non abbia mai potuto farsi largo e come malgrado ciò sia sempre ricomparso di nuovo, tenuto insieme nelle sue forme più diverse dalla catena di una tradizione perenne.»
Bisogna pensare che chi ha scritto queste parole negli anni quaranta del diciannovesimo secolo poteva conoscere la scienza dello spirito solo così come gli era stata trasmessa da qualche teosofo del diciottesimo secolo. Occorre quindi dire che quello che veniva trasmesso non poteva essere di certo rivestito delle forme della nostra scienza dello spirito. Perciò era anche difficile credere che la teosofia di allora potesse conquistare cerchie più vaste. Se prescindiamo da tutto questo, dovremo considerare importante una simile voce, che dagli anni quaranta del diciannovesimo secolo ci dice:
«E la cosa principale è che, quando sarà diventata una vera e propria scienza e avrà anche prodotto risultati nettamente precisi, questi si trasformeranno a poco a poco in una convinzione generale o divente-
ranno popolari, passando in eredità come verità generalmente accettate a coloro che non si trovano a proprio agio sulle vie lungo le quali sono state scoperte e che sono le uniche strade lungo le quali potevano esserlo». (p. 26)
Ma poi il testo ha una nota pessimistica, che oggi non possiamo più condividere, nei confronti della scienza dello spirito. Chi infatti familiarizza con la forma attuale dell’aspirazione scientifico-spirituale si convincerà che questa scienza dello spirito possa diventare popolare nelle più vaste cerchie nel suo modo di agire. Perciò una simile nota può solo esserci di sprone, là dove continua dicendo:
«Questo tuttavia riposa in grembo al futuro, che non vogliamo anticipare; per il momento rallegriamoci con gratitudine della bella esposizione di Oetinger, che può senz’altro contare sull’adesione di una vasta cerchia». (p.26)
Così vediamo come la scienza dello spirito fosse per così dire una pia speranza degli uomini che dal diciottesimo secolo in avanti sapevano ancora qualcosa dell’antica teosofia. La corrente della vita scientifico-spirituale è stata poi travolta dalle aspirazioni materialistiche del diciannovesimo secolo.
Per mezzo di quella che possiamo accogliere in noi come l’alba di una nuova era ci riaccostiamo alla vera vita spirituale, ma ora in una forma così scientifica da poter essere capita sostanzialmente da ogni cuore e da ogni anima.
Nel diciannovesimo secolo è andata del tutto perduta la comprensione per qualcosa che per esempio i teosofi del secolo precedente possedevano ancora in pieno, quello che a quei tempi veniva chiamato il “senso centrale”. Di Oetinger per esempio, che è vissuto qui nelle vicinanze, a Murrhardt, sappiamo che per un certo periodo è stato allievo di un uomo molto semplice della Turingia, i cui discepoli dicevano che possedesse il cosiddetto senso centrale.
Che cos’era per quei tempi questo senso centrale? Nient’altro che ciò che adesso sorge in ogni uomo quando si attiene con serietà e ferrea energia a quanto potete trovare nel mio libro L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? In pratica non era nient’altro che questo ciò che quell’uomo semplice della Turingia, di nome Völker, possedeva e che in seguito ha attuato in una teosofia molto interessante per quell’epoca e che ha esercitato il suo influsso su Oetinger.
Come per gli uomini del presente è difficile riconoscere che un approfondimento scientifico-spirituale ci è in effetti così vicino e dispone di una ricca letteratura, benché sepolta nelle biblioteche e presso gli antiquari, altrettanto difficile riesce loro considerare l’evento cristico come un fatto oggettivo.
Quanto si è discusso in questo senso nel diciannovesimo secolo! In poco tempo non è neppure possibile accennare a quante diverse opinioni sul Cristo Gesù si debbano elencare nel diciannovesimo secolo.
E se ci si dà la pena di esaminare diverse opinioni sul Cristo Gesù, sia laiche che teologiche, si incontreranno di sicuro delle difficoltà volendo accostare la produzione del diciannovesimo secolo relativa a questa questione ai tempi in cui regnavano tradizioni ancora migliori. Nel diciannovesimo secolo è addirittura diventato possibile considerare grandi teologi cristiani certi individui che sono ben lontani perfino dall’ipotesi di un Cristo oggettivo, che abbia fatto il proprio ingresso nella storia del mondo e vi abbia agito.
Ci poniamo allora la domanda: che rapporto con il Cristo può trovare chi non percorre una via esoterica ma si attiene a ciò che è accessibile a tutti?
Finché ci si basa sulle convinzioni dei teologi del diciannovesimo secolo, secondo cui l’evoluzione umana è qualcosa che può svolgersi unicamente nell’interiorità dell’uomo e che per così dire “non ha niente a che vedere” con il mondo esteriore, è del tutto impossibile giungere a un riconoscimento obiettivo del Cristo Gesù. Si arriva a idee grottesche di ogni sorta, mai però a un rapporto con l’evento cristico in quanto tale.
Se l’uomo crede di poter raggiungere il sommo ideale umano previsto per l’evoluzione terrestre seguendo una via puramente interiore, tramite una specie di “autoredenzione”, allora non c’è possibilità di rapporto con il Cristo oggettivo. Si potrebbe anche dire: fino a quando il pensiero della redenzione sarà per l’uomo qualcosa a cui si può dare una risposta soltanto a livello psicologico, non verrà instaurato alcun rapporto con il Cristo.
Chi penetra più profondamente nei segreti del mondo troverà ben presto che se l’uomo crede di poter raggiungere il sommo ideale dell’esistenza terrena solo attraverso se stesso, per mezzo della sua evoluzione interiore, finisce per recidere il proprio legame con l’universo, che gli starà davanti come una specie di “natura”, e accanto al mondo oggettivo avrà l’evoluzione interiore, che scorre parallela a esso. E non potrà trovare una connessione fra i due.
Proprio questo è l’elemento terribilmente grottesco dell’evoluzione nel diciannovesimo secolo: che il microcosmo e il macrocosmo, uomo e mondo, che hanno bisogno di essere uniti, sono stati separati, divisi con violenza. Se non fosse successo, non sarebbero potuti sorgere tutti gli equivoci legati alle espressioni “materialismo teorico” da un lato e “idealismo astratto” dall’altro.
La separazione di microcosmo e macrocosmo ha fatto sì che gli uomini che prestavano poca attenzione alla vita interiore arrivassero ad attribuirla al macrocosmo, proprio come facevano con la corporeità esteriore, per poi far dissolvere tutto in processi materiali. Gli altri, accortisi dell’esistenza di una vita interiore, sono gradualmente caduti in astrazioni riguardo a tutto quello che in definitiva ha importanza solo per l’anima umana.
Per chiarirsi le idee su questa difficile questione occorre forse ricordare qualcosa di molto importante che gli uomini hanno appreso nelle scuole misteriche.
Proviamo a chiederci quanti uomini credano oggi nell’intimo della loro coscienza: quando penso qualcosa, per esempio quando ho un pensiero cattivo su un mio simile, questo non ha in fondo nessuna importanza per il mondo esteriore, quel pensiero è solo dentro di me. La cosa cambia se gli dò uno schiaffo, perché quello è un evento nel mondo fisico. L’altro è un mero sentimento o un semplice pensiero.
Chiediamoci ancora: quanti sono gli uomini che, quando commettono una malefatta o un errore o dicono una bugia, dichiarano: «È qualcosa che si verifica nell’anima» e di contro, quando per esempio cade una tegola dal tetto, dicono: «È qualcosa che si verifica nel mondo esterno».
È possibile spiegare in base a concetti ovvi che quando una tegola cade dal tetto o magari piomba nell’acqua, lì nell’acqua si generano delle onde che continuano a propagarsi, così che ogni cosa ha degli effetti che si diffondono in modi sottili. Invece quello che si svolge nell’anima di un uomo è visto separato da tutte le altre cose.
Per questo gli uomini hanno potuto credere che peccare, sbagliare e porre rimedio ai propri errori sia una questione che riguarda esclusivamente l’anima.
Su una tale coscienza ciò che almeno gran parte di noi ha incontrato negli ultimi due anni dovrebbe avere un effetto grottesco. Desidero rammentarvi la scena nel dramma rosacrociano La porta dell’iniziazione, in cui Capesius e Strader giungono nel mondo astrale e viene mostrato come i loro pensieri, discorsi e sentimenti non siano privi di importanza per il mondo oggettivo, il macrocosmo, ma come scatenino addirittura delle tempeste nel mondo degli elementi.
Per l’uomo d’oggi è veramente “pazzesco” pensare che nel mondo agiscano forze distruttrici per via di un pensiero sbagliato pensato da qualcuno. Ma nei misteri veniva spiegato che quando per esempio una persona mente o commette errori, si tratta di un processo reale che non ha che fare soltanto con noi. È nato perfino il proverbio che dice: «I pensieri non pagano dazio», perché la barriera doganale non si vede quando sorgono i pensieri. Essi però appartengono al mondo oggettivo, non sono solo eventi dell’anima.
Allora al discepolo dei misteri si diceva: «Quando dici una bugia, questo equivale nel mondo sovrasensibile all’oscuramento di una certa luce; quando compi un’azione fredda e insensibile, nel mondo spirituale viene bruciato qualcosa dal fuoco della mancanza di amore. Con i tuoi errori spegni delle luci nel mondo».
Queste erano le conseguenze mostrate al discepolo per mezzo dell’evento oggettivo: come attraverso l’errore venga spento qualcosa nel mondo astrale e subentri l’oscurità, o come un’azione priva di amore abbia l’effetto di un fuoco che distrugge e incenerisce.
Nella vita ordinaria l’uomo non sa che cosa succede intorno a lui. È davvero come lo struzzo, nasconde la testa nella sabbia e non vede gli effetti che però esistono. Gli effetti dei sentimenti esistono e diventavano visibili agli occhi sovrasensibili quando l’uomo veniva introdotto ai misteri.
Solo nel diciannovesimo secolo è stato possibile dirsi: tutti i peccati commessi dall’uomo, tutte le sue debolezze, sono una questione esclusivamente personale. La redenzione deve aver luogo per mezzo di un evento nell’anima. Per questo anche il Cristo può essere solo una faccenda interiore dell’anima.
Per trovare la propria via verso il Cristo senza nel contempo spezzare il proprio legame con il mondo oggettivo, l’uomo deve riconoscere questo: quando commetti un errore o un peccato, si tratta di eventi oggettivi e non puramente soggettivi, nel mondo esterno avviene qualcosa.
Nell’istante in cui l’uomo prende coscienza del fatto che con le sue mancanze e con il suo errore si verifica qualcosa di oggettivo, sa che ciò che ha fatto ed emanato continua ad agire, diventando qualcosa che è in relazione non più solo con lui, ma con tutto l’andamento oggettivo dell’evoluzione cosmica.
Quando l’uomo abbraccia con lo sguardo l’intero corso dell’evoluzione cosmica non può più dirsi che il porre rimedio a ciò che ha provocato sia una faccenda puramente interiore.
• C’è una possibilità, che ha anche il suo buon significato, di considerare gli errori e le debolezze prodotti dall’uomo attraverso le successive vite terrene come una questione interiore, anche se non di una singola esistenza, ma del karma;
• ma non c’è possibilità di eliminare dal mondo per mezzo dell’operare umano un evento che non è storico e non è stato causato dagli uomini, come l’influsso luciferico nell’antica epoca lemurica.
Da una parte l’evento luciferico, la cosiddetta caduta, si è rivelata una grande benedizione per l’uomo, poiché egli è diventato libero. Ma dall’altra l’uomo ha dovuto mettere in conto la possibilità di deviare dalla via del bene e del giusto, e anche da quella del vero.
Quello che si è verificato nel corso delle incarnazioni è una questione del karma, ma tutto ciò che dal mondo si insedia nell’uomo, ciò che è stato dato all’uomo dalle forze luciferiche, è qualcosa che l’uomo non riesce a pareggiare da solo. Per pareggiarlo è necessario un fatto oggettivo.
In breve, poiché gli errori o i peccati commessi non sono solo soggettivi, l’uomo deve sentire che per conseguire la redenzione non basta un’attività puramente soggettiva nell’anima.
Così chi è convinto dell’oggettività dell’errore e del peccato si renderà immediatamente conto anche dell’oggettività dell’atto di redenzione. Non si può affatto presentare l’influsso luciferico come atto oggettivo senza fare altrettanto anche con l’atto che l’ha pareggiato, cioè l’evento del Golgota.
In fin dei conti come scienziato spirituale si ha solo la scelta fra due cose. Si può mettere tutto sulla base del karma, e questo è ovviamente valido per tutto ciò che è stato causato dall’uomo stesso; ma allora bisognerebbe prolungare arbitrariamente le vite ripetute in avanti e all’indietro, senza giungere a una fine né prima né dopo. È come una ruota che continua a girare.
L’idea concreta dell’evoluzione che dovremmo afferrare è l’altra, vale a dire che ci sono state un’esistenza saturnia, una solare e una lunare, completamente diverse da quella terrestre, che in quest’ultima si verifica il tipo di ripetizione delle vite terrene che conosciamo e che poi l’evento luciferico si è verificato un’unica volta. Tutto questo fornisce un vero contenuto a quella che definiamo concezione scientifico-spirituale, ma è impensabile senza l’oggettività dell’evento del Golgota.
Se prendiamo in esame l’epoca precristiana – di questo è già stato parlato da un’altra angolazione – vediamo che sotto un certo aspetto gli uomini erano allora diversi. Quando scendevano dai mondi spirituali nelle incarnazioni terrestri, gli uomini portavano con sé una certa quantità di realtà divina, che è andata via via esaurendosi quanto più l’uomo procedeva nelle incarnazioni terrene ed era venuto meno all’epoca degli eventi della Palestina.
Perciò in era precristiana, riflettendo per così dire sulla propria debolezza, gli uomini hanno sempre avuto la sensazione che quanto di meglio avevano derivasse pur sempre dalla sfera divina da cui erano discesi. Sentivano ancora gli ultimi riflessi dell’elemento divino.
Ma questo si era esaurito ai tempi in cui Giovanni il Battista proclamava: «Cambiate la vostra concezione del mondo, poiché i tempi sono cambiati. Ora non potrete più ascendere allo spirito come avete fatto finora, poiché non è più possibile gettare lo sguardo nell’antica spiritualità. Cambiate il vostro modo di pensare e accogliete quell’Entità divina che deve dare agli uomini in modo nuovo quello che hanno dovuto perdere con la loro discesa».
Per questo motivo – lo si può negare se si vuole pensare in astratto, ma non lo si può negare se si vuole osservare in concreto la storia esteriore – tutto il modo di sentire dell’uomo è cambiato nel periodo a cavallo tra l’era antica e quella nuova, segnato dagli eventi della Palestina.
Dopo quegli eventi gli uomini hanno cominciato a sentirsi abbandonati. Si sentivano abbandonati quando si accostavano alle difficili domande relative all’aspetto più intimo e concreto dell’anima, quando per esempio si chiedevano: cosa ne sarà di me nell’ambito complessivo dell’universo se varco la soglia della morte con una quantità di azioni non pareggiate?
Allora quegli uomini venivano sfiorati da un pensiero che in un primo tempo poteva nascere dalla nostalgia dell’anima, ma che poteva venir soddisfatto solo se l’anima umana riusciva a pensare: sì, è vissuto un essere, penetrato nell’evoluzione dell’umanità, sul quale puoi fare affidamento e che opera nel mondo esteriore, sul quale tu non puoi agire, per compensare le tue azioni e che ti aiuta a porre rimedio a ciò che è stato danneggiato dagli influssi luciferici.
Nell’umanità è entrato il sentirsi abbandonati e il sentirsi protetti da una potenza oggettiva: la sensazione che il peccato sia una forza reale, un fatto oggettivo, e che la sua controparte, la “redenzione”, sia anch’essa un fatto oggettivo, qualcosa che non può essere effettuato dal singolo, poiché non è lui ad avere evocato l’influsso luciferico, ma che può essere realizzato solo da chi agisce consapevolmente nei mondi in cui opera anche Lucifero.
Tutte queste cose che vi descrivo con parole prese dalla scienza dello spirito non esistevano come concetti, come conoscenza cosciente, ma erano presenti nei sentimenti e nelle sensazioni. E a livello di sentimenti e sensazioni c’era l’esigenza di rivolgersi al Cristo. Come conseguenza c’era per quegli uomini la possibilità di trovare nelle comunità cristiane le vie per approfondire tutte quelle sensazioni e quei sentimenti.
Che cosa trovava in definitiva l’uomo quando vedeva là fuori il mondo della materia, avendo perduto la propria connessione originaria con gli esseri divini?
Con la discesa dell’uomo nella materia si è perso sempre più di vista l’elemento spirituale e divino nel mondo fisico. Gli ultimi residui dell’antica chiaroveggenza sono svaniti a poco a poco e la natura è stata in un certo senso privata del suo carattere divino. Davanti all’uomo si estendeva ormai un mondo puramente materiale.
Di fronte a quel mondo materiale l’uomo non poteva più continuare a credere che in esso agisse in maniera oggettiva un principio cristico. È assurdo pensare che il Cristo possa far parte integrante della concezione del mondo dello studioso materialista della natura, dell’idea che si è sviluppata per esempio nel diciannovesimo secolo, secondo la quale l’universo che sta alla base della nostra Terra si è addensato dalla nebulosa protoplanetaria di Kant-Laplace e che poi la vita è sorta sui singoli pianeti – il che ha finito per far sì che l’intero universo sia considerato un’interazione di atomi.
Di fronte a una simile concezione del mondo non è possibile sostenere l’esistenza dell’Entità cristica, e nemmeno alcunché di spirituale.
Ma dobbiamo renderci conto che c’è ben qualcuno che sostiene quello che vi ho letto, vale a dire che dovrebbe fare a pezzi la propria concezione del mondo se dovesse credere alla risurrezione. Tutta questa concezione del mondo, formatasi gradualmente, mostra solo che per l’osservazione esteriore della natura è scomparsa per il pensiero sulla natura la possibilità di immedesimarsi nell’essenza vivente dei fatti naturali.
Il fatto che vi parli in questo modo non è una critica negativa. Era necessario che la natura venisse privata del suo carattere divino e spirituale, affinché l’uomo potesse concepire il complesso di pensieri astratti per comprendere la natura esteriore in base alla concezione copernicana, kepleriana e galileiana. L’umanità doveva essere afferrata dalla rete di pensieri che ci ha portati alla nostra era delle macchine.
D’altra parte era anche necessario che quest’epoca venisse contraccambiata per il fatto che era diventato impossibile trovare la via verso lo spirito direttamente dalla Terra. Se infatti si fosse trovata la via per lo spirito si sarebbe dovuta trovare anche la via verso il Cristo, come la si troverà nei prossimi secoli. Ci doveva essere una compensazione.
A questo punto la domanda è: che cosa è stato necessario per una via generale dell’uomo verso il Cristo, nel corso dei secoli in cui si preparava a poco a poco una visione atomistica del mondo che doveva privare sempre più la natura della sua divinità e che è sfociata nel diciannovesimo secolo in una considerazione della natura a cui è stato tolto del tutto il carattere divino?
Due erano le cose necessarie, lungo una duplice via si poteva giungere in generale alla visione spirituale del Cristo.
Da un lato questo poteva accadere dando all’uomo la possibilità di vedere che non è vero che tutta la materia è totalmente estranea all’interiorità umana, allo spirito nella propria interiorità. Andava mostrato che non è giusto dire che ovunque la materia appare nello spazio vi sia solo materia. In che modo poteva succedere?
Non poteva che accadere per una sola via: presentando all’uomo qualcosa che fosse nello stesso tempo spirito e materia, di cui egli sapesse che è spirito e di cui vedesse che è materia. Era quindi la “transustanziazione” che doveva rimanere viva, la trasformazione sempre in corso dello spirito in materia e della materia in spirito.
E questo è avvenuto grazie all’eucarestia, che si è instaurata ed è stata coltivata nei secoli come istituzione cristiana. E più torniamo indietro nei secoli dal momento dell’introduzione dell’eucarestia, più ci accorgiamo che le epoche più antiche e meno materialistiche l’hanno capita meglio.
Di solito la prova che non si capiscono più le cose elevate consiste nel cominciare a discuterne. Ci sono appunto delle cose sulle quali si discute poco finché le si comprende e sulle quali si comincia a dissertare quando non le si capisce più. Le discussioni sono una prova del fatto che la maggior parte di quelli che discutono di una cosa non la capiscono.
Lo stesso si è verificato anche con l’eucarestia: finché si è saputo che era una prova vivente che la materia non è semplicemente materia, ma che ci sono degli atti rituali attraverso i quali alla materia può venir aggiunto lo spirito, finché l’uomo ha saputo che quella compenetrazione della materia con lo spirito era la sua “cristianizzazione” quale viene espressa nell’eucarestia, fino ad allora la si è accettata senza discutere.
Ma poi è arrivato il tempo in cui cominciava già a sorgere il materialismo, in cui non si capiva più che cosa c’è alla base dell’eucarestia, in cui si discuteva se il pane e il vino fossero semplici simboli del divino o se in essi si riversasse davvero la forza divina. Hanno avuto allora inizio tutte le dispute sorte all’alba dell’era moderna, ma che per chi vede più in profondità significano che la comprensione originaria della questione era andata perduta.
Per gli uomini che volevano giungere al Cristo, l’eucarestia sostituiva adeguatamente la via esoterica per chi non la poteva percorrere. Costui poteva trovare nell’eucarestia una vera unione con il Cristo.
Ma ogni cosa ha il suo tempo. Come è vero che per quanto riguarda la vita spirituale sta iniziando un’era del tutto nuova, è anche vero che la via verso il Cristo che è stata giusta per molti secoli continuerà a esserlo per molti ancora. Le cose cambiano lentamente, ma ciò che era giusto un tempo si trasformerà gradualmente in qualcosa di diverso quando gli uomini saranno maturi.
E la scienza dello spirito deve portar l’uomo a vivere nello spirito qualcosa di concreto e reale. Per esempio, se attraverso la meditazione, la concentrazione e tutto quello che si impara in L’iniziazione: come si consegue la conoscenza dei mondi superiori? gli uomini diventano maturi non solo per sperimentare nella loro interiorità i mondi dei pensieri, i mondi astratti dei sentimenti e delle sensazioni, ma per pervadersi nell’intimo dell’elemento dello spirito, allora vivranno la comunione in spirito.
Allora nell’uomo possono vivere dei pensieri, sotto forma di pensieri meditativi, che rappresentano la stessa realtà, ma dall’interno, presentata nel segno esterno dell’eucarestia, nel pane consacrato.
E come il cristiano credente trovava nell’eucarestia la via verso il Cristo, così il cristiano più progredito, che grazie all’innovatrice scienza dello spirito impara a conoscere la realtà del Cristo, può elevarsi nello spirito a quella che in futuro dovrà diventare anche una via universale per gli uomini e fluirà come la forza destinata a portar loro un ampliamento dell’impulso cristico.
Ma allora cambieranno anche tutte le cerimonie religiose. Quello che prima avveniva sotto le speci del pane e del vino avverrà in futuro per mezzo di un’eucarestia spirituale. Però l’idea, l’essenza dell’eucarestia resterà.
È importante far sì che determinate idee che ci vengono dalle comunicazioni del movimento scientifico-spirituale, che determinati sentimenti pervadano e spiritualizzino la nostra interiorità con la stessa dedizione con cui nell’evoluzione cristiana l’eucarestia ha pervaso e spiritualizzato l’anima umana.
Quando questo sarà possibile – e lo sarà – avremo fatto un ulteriore passo avanti nell’evoluzione. In tal modo verrà di nuovo fornita la prova reale che il cristianesimo è più grande di tutte le sue forme esteriori.
Ha infatti una scarsa opinione del cristianesimo chi crede che esso verrebbe spazzato via se ne venisse eliminata la forma esteriore che era stata valida in un determinato periodo. Ha invece un’idea giusta del cristianesimo solo chi è convinto che tutte le chiese che hanno coltivato l’idea del Cristo, tutte le idee e le forme esteriori sono temporali e per questo transitorie, e che in futuro il pensiero del Cristo si introdurrà nei cuori e nelle anime degli uomini in forme sempre nuove, per quanto poco le si colgano al giorno d’oggi.
Così la scienza dello spirito ci insegna
• come su una via generale l’eucarestia avesse il proprio significato nei tempi passati e
• come l’altra via aperta a tutti fosse quella trasmessa dai vangeli.
Occorre rendersi conto anche di che cosa fossero i vangeli per gli uomini del passato.
Non è trascorso molto tempo da quando i vangeli venivano letti non come nel diciannovesimo secolo, ma considerandoli una fonte vivente dalla quale si trasmetteva alle anime un elemento sostanziale. Non li si leggeva neppure come vi ho illustrato nella prima ora di questo ciclo di conferenze descrivendo la via sbagliata, ma li si leggeva in modo che si vedesse giungere dall’esterno quello di cui l’anima aveva sete, che vi si trovasse descritto il vero Redentore, della cui esistenza nell’universo l’anima era assolutamente certa.
Per gli uomini che sapevano leggere i vangeli in questo modo si risolvevano già infinite questioni che sono diventate problematiche solo per le persone saccenti e presuntuose del diciannovesimo secolo.
Basta far notare quante volte, trattando la questione del Cristo Gesù, quelle persone così intelligenti, che hanno scientificità ed erudizione fin sopra i capelli, hanno ripetuto che il pensiero sul Cristo Gesù e sugli eventi della Palestina è del tutto inconciliabile con la moderna concezione del mondo.
In modo apparentemente chiaro viene detto che quando l’uomo non sapeva ancora che la Terra è un minuscolo corpo nel cosmo, poteva credere che con la croce del Golgota sulla Terra si fosse verificato un nuovo avvenimento importante. Ma dopo che Copernico ha insegnato che la Terra è un pianeta come gli altri è ancora possibile supporre che il Cristo sia venuto a noi da un altro pianeta? Perché mai si dovrebbe presumere che la Terra goda di una posizione eccezionale come una volta si credeva?
E poi ci si è serviti di questa immagine: da quando la visione del mondo si è “ampliata” in questo modo, è come se una delle più importanti esecuzioni o rappresentazioni artistiche non abbia luogo sul grande palcoscenico di una capitale, ma in un piccolo teatro di provincia! Così apparivano alla gente gli eventi della Palestina, come la messinscena di un dramma di grande portata storica sul palcoscenico di un teatrino di provincia, dal momento che la Terra è un corpo cosmico così piccolo. Non lo si può più pensare, se si vede la Terra così piccola rispetto all’universo!
Una simile affermazione sembra molto intelligente, ma in realtà non lo è per niente, perché il cristianesimo non ha mai sostenuto quello che qui viene apparentemente confutato. Il cristianesimo non ha fatto sorgere l’impulso cristico neanche nei luoghi più splendidi della Terra, ma si è sempre preso sul serio il fatto di veder nascere il portatore del Cristo in una stalla presso poveri pastori.
Nella tradizione cristiana non solo si è scelta la piccola Terra, ma per di più un luogo nascosto in cui collocare il Cristo.
Alle domande delle persone tanto intelligenti il cristianesimo ha già risposto fin dall’inizio! Solo che le risposte date dal cristianesimo stesso non sono state capite, poiché non si era più in grado di far agire sull’anima la forza vivente di quelle grandi e maestose immagini.
Però non sarebbe stato possibile trovare la via generale degli uomini verso il Cristo nelle sole immagini dei vangeli, senza l’eucarestia e ciò che è in relazione con essa, eucarestia che è al centro di tutti gli altri culti cristiani. I vangeli infatti non avrebbero potuto raggiungere quel grado di popolarità se la via verso il Cristo avesse dovuto diventare popolare solo tramite loro.
Quando i vangeli sono diventati popolari, si è visto che questo non costituiva una gran benedizione interiore, poiché in contemporanea con la loro divulgazione è sorto anche il grande malinteso: la loro banalizzazione e poi tutto quello che il diciannovesimo secolo ha fatto dei vangeli il che, detto obiettivamente, è già abbastanza grave.
Credo che gli scienziati spirituali possano capire che con “abbastanza grave” non si intende esprimere una critica e neppure si misconosce l’impegno messo dalla ricerca del diciannovesimo secolo in tutti i lavori scientifici, compresi quelli nel campo delle scienze naturali. Ma proprio questo è tragico, che questa scienza – e chi la conosce lo confermerà –, proprio per via della sua profonda serietà e del suo impegno contrassegnato da un enorme spirito di abnegazione, qualità peraltro ammirevoli, abbia portato a una totale disgregazione e distruzione di quello che voleva insegnare.
E la futura evoluzione dell’umanità vedrà come un evento culturale particolarmente tragico della nostra epoca l’aver voluto conquistare scientificamente la Bibbia per mezzo di una scienza senz’altro degna di ammirazione, che però ha finito col perdere la Bibbia.
Vediamo così che con queste due vie aperte a tutti viviamo in un’epoca di transizione e che, nella misura in cui abbiamo compreso il significato della scienza dello spirito, dobbiamo trasformare queste vie vecchie.
Dopo aver osservato le vie del passato comuni a tutti verso l’impulso cristico, vedremo domani quale forma assume il rapporto con il Cristo in campo scientifico-spirituale e porteremo così a conclusione le nostre considerazioni. Ciò ci porrà in grado di comprendere ciò che è l’evento cristico non solo per ogni singolo individuo, ma per l’intera evoluzione dell’umanità. Con tali considerazioni concluderemo il percorso che ci siamo prefissi in questo ciclo di conferenze.
Della via esoterica ci occuperemo più brevemente, poiché per questo abbiamo già posto le fondamenta negli anni passati. Arriveremo al culmine del nostro edificio prendendo in esame il rapporto fra l’impulso cristico e ogni singola anima umana.
Decima conferenza
L’umanitÀ diventa
un organismo spirituale
Attraverso un atto
d’amore divino
Karlsruhe, 14 ottobre 1911
Ieri abbiamo cercato di delineare la via che può ancora oggi essere percorsa e che soprattutto nei tempi andati poteva essere seguita dalla coscienza generale dell’uomo per arrivare al Cristo.
Ora vogliamo anche dedicare qualche parola alla via esoterica, vale a dire alla via che può condurre al Cristo in modo da trovarlo nei mondi sovrasensibili.
Prima di tutto va detto che questa via esoterica verso il Cristo Gesù era in fondo la stessa degli evangelisti, di coloro che hanno scritto i vangeli.
Infatti, sebbene l’autore del Vangelo di Giovanni abbia visto con i propri occhi gran parte di ciò che descrive nel suo Vangelo, come potete dedurre dall’interpretazione presentata nei cicli di conferenze sul Vangelo di Giovanni, dobbiamo anche dire che per lui la cosa fondamentale non era la descrizione di ciò di cui si ricordava. Questo dava in effetti solo quei piccoli tratti minuziosi da cui siamo sorpresi, come abbiamo visto nel Vangelo di Giovanni. Ma le prospettive di fondo, gli straordinari elementi all’opera nella redenzione e nel mistero del Golgota, anche questo evangelista li ha tratti dalla sua coscienza chiaroveggente.
Possiamo allora dire che i vangeli sono rituali di iniziazione rinnovati – come risulta anche dal libro Il cristianesimo come fatto mistico –, e lo sono diventati proprio perché sulla loro via esoterica gli evangelisti potevano procurarsi dal mondo sovrasensibile un’immagine di quanto era avvenuto in Palestina e aveva portato al mistero del Golgota.
Chi dal mistero del Golgota fino ai giorni nostri voleva giungere a un’esperienza sovrasensibile dell’evento cristico doveva lasciar agire su di sé quello che trovate descritto come i sette stadi dell’iniziazione cristiana nei cicli di conferenze che ormai costituiscono il fondamento del nostro lavoro scientifico-spirituale:
• la lavanda dei piedi
• la flagellazione
• l’incoronazione di spine
• la morte mistica
• la sepoltura
• la risurrezione e
• l’ascensione.
Oggi vogliamo renderci conto di che cosa può raggiungere il discepolo quando lascia agire su di sé questa iniziazione cristiana. Per capire bene il cammino dell’iniziazione cristiana, vediamo innanzitutto di che cosa si tratta.
Non si svolge, come potrete convincervi esaminando i rispettivi cicli di conferenze, nel modo inteso da quell’iniziazione non corretta di cui abbiamo parlato nella prima conferenza di questo ciclo, ma in modo tale per cui all’inizio debbano agire sentimenti universalmente umani che portano poi all’immaginazione della “lavanda dei piedi” e così via.
Non si comincia rappresentandosi una scena descritta nel Vangelo di Giovanni, ma colui che aspira all’iniziazione cristiana cerca dapprima di vivere per un lungo periodo con determinati sentimenti e sensazioni.
L’ho spesso descritto dicendo che il soggetto in questione doveva guardare la pianta che emerge dal terreno minerale, assorbe le sostanze del regno minerale e tuttavia si eleva al di sopra di esso in quanto essere superiore.
Se questa pianta potesse parlare e sentire, dovrebbe inchinarsi al regno minerale e dire: è vero che le leggi cosmiche mi hanno destinata a un livello superiore al tuo, minerale, ma tu mi dai la possibilità di esistere. Nella gerarchia degli esseri tu sei inferiore rispetto a me, ma è a te che devo la mia esistenza, e a te mi inchino umilmente.
Parimenti l’animale dovrebbe inchinarsi alla pianta, sebbene questa sia un essere inferiore a lui, e dirle: a te devo la mia esistenza, lo riconosco con umiltà e mi inchino davanti a te.
E così dovrebbe fare ogni essere che ascende: inchinarsi a quello che sta al di sotto di lui. E anche chi sulla scala spirituale è asceso a un gradino più alto dovrebbe inchinarsi agli esseri che gliel’hanno reso possibile.
Chi si fa compenetrare dal sentimento di umiltà nei confronti di chi gli è inferiore, chi diventa una cosa sola con questo sentimento facendolo agire dentro di sé per mesi, magari per anni, vedrà che esso permeerà il suo organismo fino a fargli sperimentare la trasformazione di questo sentimento in un’immaginazione, in una visione.
E questa immaginazione contiene esattamente la scena descritta nel Vangelo di Giovanni come la lavanda dei piedi, poiché il Cristo Gesù, il maestro dei Dodici, si inchina a quelli che gli sono inferiori nell’ordine del mondo fisico, e riconosce umilmente di dovere la possibilità di ascendere a coloro che sono al di sotto di lui.
Riconosce davanti ai Dodici: come l’animale con la pianta, così io devo a voi quel che sono potuto diventare nel mondo fisico.
Chi si lascia pervadere da questa sensazione giunge non solo alla visione della lavanda dei piedi, ma anche a una sensazione ben precisa, alla sensazione che i suoi piedi siano lambiti dall’acqua. L’interessato può provare per settimane questa sensazione, che rappresenterebbe un segno esteriore di quanto a fondo si imprime nel nostro essere un tale mondo che, pur essendo fatto di sensazioni universalmente umane, innalza l’uomo al di sopra di se stesso.
Abbiamo inoltre visto che si può vivere ciò che porta all’immaginazione della “flagellazione” rappresentandosi in maniera vivida la seguente idea: nel mondo sarò colpito da molti dolori e sofferenze, che potranno arrivarmi da tutte le parti e che in fin dei conti non risparmiano nessuno. Ma io voglio temprare la mia volontà in modo che, pur essendo colpito su ogni lato dai dolori e dalle sofferenze, dai flagelli inferti dal mondo, possa mantenermi saldo e sopportare il mio destino, qualunque esso sia. Se infatti le cose non fossero andate nel modo che ho vissuto non mi sarei potuto evolvere fino al grado che ho raggiunto.
Se l’interessato si appropria di questa sensazione e vive con essa, prova veramente qualcosa di simile a pugnalate e ferite, come colpi di frusta sulla pelle. E in lui sorge la visione che gli fa sembrare di essere al di fuori di sé e di vedersi flagellato come il Cristo Gesù.
Secondo questo modello è possibile sperimentare l’incoronazione di spine, la morte mistica e così via, come è stato spesso descritto.
Che cosa consegue colui che cerca di fare l’esperienza interiore dei primi quattro stadi e, se il karma glielo consente, anche dei rimanenti tre dell’evoluzione cristiana?
Dalle relative descrizioni vediamo che l’intera sequenza delle sensazioni che attraversiamo deve fortificarci e temprarci, trasformando completamente la nostra natura, così che ci sentiamo forti, vigorosi e liberi nel mondo, ma deve anche renderci capaci di ogni atto d’amore compiuto con dedizione.
Nell’iniziazione cristiana tutto questo deve assumere il carattere di una seconda natura in un senso più profondo. In che modo?
Forse non tutti quelli che fra voi hanno letto i primi cicli elementari di conferenze, entrando in contatto con i sette stadi dell’iniziazione cristiana, si sono resi conto che per mezzo dell’intensità dei sentimenti che devono essere provati in quelle situazioni si esercita veramente un’azione fin nel corpo fisico.
Grazie alla forza con cui viviamo queste sensazioni, ci sentiamo come se l’acqua ci lambisse i piedi, come se ci venissero procurate delle ferite, come se ci venissero conficcate delle spine nel capo, sentiamo davvero tutti i dolori e le sofferenze della crocifissione. Dobbiamo provare queste sensazioni prima di fare le esperienze della morte mistica, della sepoltura e della risurrezione così come sono state descritte.
Se queste sensazioni non vengono vissute con sufficiente intensità, hanno comunque l’effetto di renderci forti e amorevoli nel vero senso della parola, ma ciò che viviamo non andrà al di là del corpo eterico. Quando però cominciamo a percepirle fin nel corpo fisico – quando sentiamo i piedi lambiti dall’acqua e il corpo coperto di ferite – vuol dire che abbiamo spinto queste sensazioni più intensamente nella nostra natura, facendole giungere fino al corpo fisico. E davvero arrivano fino al corpo fisico, in quanto appaiono le stigmate nei punti corrispondenti alle piaghe di sangue del Cristo Gesù.
Questo significa che spingiamo le sensazioni fin nel corpo fisico e sappiamo che danno prova della loro forza fino a quel livello; sappiamo che ci sentiamo toccati dalla nostra essenza oltre al corpo eterico e al corpo astrale. In sostanza possiamo dire che mediante un simile processo di sensazioni mistiche esercitiamo un’azione fin nel nostro corpo fisico.
E in tal modo non facciamo altro che prepararci ad accogliere a poco a poco nel nostro corpo fisico il fantoma che fuoriesce dal sepolcro sul Golgota. Interveniamo sul nostro corpo fisico per renderlo così vivo da permettergli di provare attrazione per il fantoma levatosi dal sepolcro sul Golgota.
A questo proposito desidero aprire una parentesi. Nella scienza dello spirito ci si deve abituare a conoscere a poco a poco i segreti e le verità universali. E chi non vuole prendersi tutto il tempo necessario nel senso indicato in queste conferenze, in base a cui dobbiamo “aspettare” le rispettive verità, non potrà progredire in modo giusto.
Certo, la gente vorrebbe avere tutta la scienza dello spirito in un colpo solo, meglio ancora in un libro o in un solo ciclo di conferenze. Ma così non va, e qui ne avete un esempio. È trascorso molto tempo da quando, in uno dei precedenti cicli di conferenze, si è descritta per la prima volta l’iniziazione cristiana dicendo: essa si svolge in questo modo, e mediante le sensazioni che agiscono nella sua anima, l’uomo giunge davvero a lavorare sul suo corpo fisico.
Solo oggi tuttavia ci è possibile parlare per la prima volta di come l’uomo, grazie alle rispettive esperienze d’animo dell’iniziazione cristiana, diviene maturo per accogliere il fantoma risorto dal sepolcro sul Golgota. Questo perché tutto quanto è stato detto in conferenze precedenti forniva gli elementi per comprendere il mistero del Golgota. È stato necessario attendere così a lungo, finché non si fosse trovato il collegamento fra soggettivo e oggettivo, per il quale sono state necessarie molte conferenze. Così ancora oggi vi sono cose che è solo possibile accennare a metà.
Chi avrà la pazienza di camminare insieme a noi – nell’attuale incarnazione o in un’altra, a seconda del suo karma –, chi ha visto come dalla descrizione della via mistica in senso cristiano sia stato possibile salire a quella del fatto oggettivo di quello che è il vero senso di questa iniziazione cristiana, vedrà anche che nel corso dei prossimi anni o della prossima era planetaria dalla scienza dello spirito verranno fatte emergere verità ancora più elevate. Questo è per noi lo scopo dell’iniziazione cristiana.
Quella che è stata descritta come via rosicruciana e l’iniziazione possibile oggi per l’uomo permettono, solo con strumenti un po’ diversi, di ottenere in un certo senso la stessa cosa: la creazione di un legame di attrazione fra l’uomo, nella misura in cui è incarnato in un corpo fisico, e il vero archetipo del corpo fisico risorto dal sepolcro sul Golgota.
Dall’inizio di questa serie di conferenze sappiamo di trovarci al punto di partenza di un’epoca in cui ci si deve aspettare un evento che non si svolgerà nel mondo fisico come quello del Golgota, bensì nel mondo superiore, sovrasensibile, pur essendo in relazione con l’evento del Golgota in maniera precisa e importante.
Mentre quest’ultimo era destinato a restituire all’uomo il fantoma, il vero corpo fisico delle forze che è andato degenerando dall’inizio dell’evoluzione terrestre, per cui all’inizio della nostra era si è resa necessaria una serie di avvenimenti che si sono realmente svolti nel mondo fisico, quello che deve accadere ai nostri giorni non ha bisogno di un evento nel mondo fisico. Un’incarnazione dell’Entità cristica in un corpo umano di carne poteva verificarsi una sola volta nel corso dell’evoluzione, e sostenere una ripetizione dell’incarnazione di questa Entità equivale a non comprenderne il senso.
Quello che invece si verificherà adesso fa parte di un mondo sovrasensibile e soltanto lì potrà essere osservato, ed è stato descritto con queste parole: il Cristo diventa per gli uomini il signore del karma.
Vuol dire che in futuro l’ordine delle questioni karmiche sarà di competenza del Cristo e un numero sempre più grande di uomini sentirà: varco la soglia della morte con il mio conto karmico. Da una parte ci sono le mie azioni buone, sagge e belle e i miei pensieri buoni, saggi e assennati; dall’altra ci sono tutte le cose cattive, malvagie, stupide, assurde e brutte. Ma chi in avvenire ricoprirà la carica di giudice riguardo alle incarnazioni successive nell’evoluzione umana per mettere ordine in questo conto karmico dell’uomo è il Cristo!
Dobbiamo immaginarci questo nel seguente modo: dopo aver attraversato la porta della morte, ci incarneremo di nuovo. Dovranno allora verificarsi per noi degli avvenimenti che ci consentano di compensare il karma, poiché ogni uomo deve raccogliere ciò che ha seminato. Il karma resta una legge equa.
Ma ciò che la legge karmica deve compiere non esiste solo per il singolo individuo. Il karma non pareggia solo gli egoismi, ma la compensazione deve avvenire in modo da inserirsi al meglio nelle vicende del mondo. Dobbiamo pareggiare il nostro karma così da favorire nel migliore dei modi anche
il progresso di tutto il genere umano sulla Terra.
E per questo abbiamo bisogno di un’illuminazione! Non basta sapere in generale che per le nostre azioni dovrà verificarsi il compenso karmico, poiché per ogni azione potrebbero verificarsi diversi adempimenti karmici. Ma poiché un adempimento potrebbe risultare più utile e un altro meno utile per il progresso generale dell’umanità, occorre scegliere quei pensieri, quei sentimenti o quelle volizioni che pareggiano il nostro karma e nello stesso tempo favoriscono il progresso generale dell’umanità.
In futuro spetterà al Cristo integrare il nostro pareggio karmico con il karma globale della Terra, con il progresso generale dell’umanità. Questo avviene essenzialmente nel periodo che trascorriamo fra la morte e una nuova nascita.
Ma anche nell’epoca a cui andiamo incontro, alle cui porte ci troviamo, questo si preparerà in modo che gli uomini possano acquisire sempre più la capacità di fare una determinata esperienza. Oggi sono in pochissimi, ma d’ora in avanti, dalla metà di questo secolo e nei prossimi millenni sempre più uomini faranno la seguente esperienza:
L’uomo avrà fatto questa o quella azione. Sentirà il bisogno di rifletterci, dovrà sollevare lo sguardo dall’azione compiuta e davanti a lui si formerà una sorta di immagine di sogno. Questo eserciterà su di lui un’impressione molto strana.
Si dirà: «Non mi sembra che si tratti di un ricordo di qualcosa che ho fatto, eppure è come se fosse un’esperienza mia». Si porrà di fronte all’uomo come un’immagine sognante che riguarda proprio lui, ma lui non sarà in grado di ricordare di averla vissuta o compiuta in passato.
Allora quell’uomo o sarà uno scienziato spirituale in grado di capire la cosa, oppure dovrà aspettare di arrivare alla scienza dello spirito per imparare a comprenderla. Lo scienziato spirituale saprà: ciò che vedi come conseguenza della tua azione è un’immagine che in futuro diventerà realtà nel tuo agire. Ciò che ti appare in anticipo è la compensazione della tua azione.
Ha inizio l’epoca in cui gli uomini, nell’istante in cui compiono un’azione, avranno come un presagio, una sensazione, magari addirittura un’immagine nitida di quello che sarà il pareggio karmico di quell’azione.
Così nella prossima era dell’umanità emergeranno facoltà più elevate, in stretta relazione con le esperienze umane. Saranno forti stimoli alla moralità dell’uomo.
Questi stimoli significheranno qualcosa di completamente diverso da ciò che ne è stata la preparazione, quale la voce della coscienza. L’uomo smetterà di credere: «Quello che hai fatto è qualcosa che muore con te», ma saprà con esattezza: «La tua azione non morirà con te, ma in quanto azione avrà una conseguenza che continuerà a vivere con te». E saprà anche diverse altre cose.
Il tempo in cui per gli uomini erano chiuse le porte del mondo spirituale sta per finire. Gli uomini devono ascendere di nuovo al mondo spirituale. Si ridesteranno le facoltà atte a far sì che gli uomini si rendano partecipi del mondo spirituale.
La “chiaroveggenza” sarà sempre qualcosa di diverso da questa partecipazione. Ma, come è esistita un’antica chiaroveggenza di tipo sognante, ci sarà una futura chiaroveggenza in cui non ci sarà posto per il sogno, ma dove gli uomini saranno coscienti delle azioni compiute e del loro significato.
E succederà anche qualcos’altro. L’uomo saprà: «Non sono solo. Dappertutto vivono esseri spirituali che hanno a che fare con me». L’uomo imparerà inoltre a conversare e a vivere con questi esseri.
Nei prossimi tre millenni ci sarà una quantità sufficiente di individui per i quali quella che possiamo chiamare “la mansione di giudice karmico da parte del Cristo” apparirà come una verità. Gli uomini sperimenteranno il Cristo stesso come figura eterica, in modo che poi, come Paolo alle porte di Damasco, sapranno con certezza che Egli vive ed è la fonte per il ripristino dell’archetipo fisico che abbiamo ricevuto all’inizio della nostra evoluzione terrestre e di cui abbiamo bisogno affinché l’Io possa svilupparsi pienamente.
Se da una parte con il mistero del Golgota si è verificato qualcosa che ha dato all’evoluzione umana sulla Terra l’impulso più grande, dall’altra esso si verifica proprio in quel periodo dell’evoluzione dell’umanità in cui l’anima umana aveva per così dire raggiunto il massimo grado di oscuramento.
Ci sono state epoche antiche nell’evoluzione dell’umanità in cui gli uomini con la loro memoria sapevano con certezza che l’individualità umana attraversa ripetute esistenze terrene. Nel Vangelo la dottrina delle ripetute vite terrene la troviamo solo se ne abbiamo già conoscenza, se ne siamo convinti, poiché quelli erano i tempi in cui gli uomini erano meno che mai in grado di comprendere questo insegnamento. Dopo di che si sono succedute le epoche fino a quella presente.
Ai tempi in cui gli uomini cercavano il Cristo innanzitutto sulla via a cui abbiamo accennato ieri, tutto doveva accadere come in una preparazione a livello infantile. Per questo l’umanità non poteva venir confrontata con l’esperienza delle ripetute vite terrene, cosa che l’avrebbe solo potuta confondere, non essendone ancora matura. Vediamo allora il cristianesimo svilupparsi per quasi due millenni senza che si sia potuto richiamare l’attenzione sulla dottrina della reincarnazione.
In queste conferenze abbiamo mostrato come, a differenza di quanto avviene nel buddismo, dalla coscienza occidentale emerga in maniera naturale l’idea delle ripetute vite sulla Terra. Certo, emerge in modo tale per cui regnano ancora molti malintesi, ma anche esaminando questa idea in Lessing o nello psicologo Drossbach, ci accorgiamo che per la coscienza europea la dottrina delle ripetute vite terrene è una questione che riguarda l’umanità intera, mentre nel buddismo l’uomo considera il passare di vita in vita una faccenda interiore della propria esistenza personale, allo scopo di liberarsi dalla sete di esistenza.
Mentre l’orientale trasforma la dottrina delle ripetute vite terrene in una verità che riguarda la redenzione individuale, per Lessing era per esempio fondamentale chiedersi: come può progredire l’umanità intera? E la risposta che si dava era: all’interno dell’evoluzione dell’umanità nel tempo dobbiamo distinguere dei periodi che si sono l’un l’altro succeduti. In ogni singola epoca all’umanità viene dato qualcosa di nuovo. Osservando la storia vediamo come nel corso dell’evoluzione dell’umanità continuino a subentrare nuove azioni culturali.
Come potremmo parlare di evoluzione dell’umanità intera, dice Lessing, se a un’anima fosse dato di vivere solo in una di queste epoche? Da dove potrebbero giungere i frutti della civiltà se gli uomini non si reincarnassero, portando in un’epoca successiva quanto hanno appreso nella precedente, e così di seguito?
Così per Lessing l’idea delle ripetute vite terrene diventa una questione che riguarda tutta l’umanità; la fa diventare una questione relativa non solo alla singola anima ma più ancora all’intera evoluzione culturale della Terra. Affinché possa nascere una civiltà più avanzata, l’anima che vive nel diciannovesimo secolo deve trasporre nella sua esistenza attuale ciò che si è conquistata in tempi andati. L’idea di Lessing è che gli uomini debbano reincarnarsi per amore della Terra e della sua civiltà.
L’idea della reincarnazione affiora così come una questione che riguarda l’umanità; lì l’impulso cristico ha già agito, è già stato introdotto, poiché rende tutto ciò che l’uomo fa o può fare una questione che riguarda tutta l’umanità, e non una faccenda unicamente individuale.
Può essere discepolo del Cristo solo colui che dice: «Lo faccio al più piccolo dei tuoi fratelli, poiché so che tu lo vivi come se lo avessi fatto direttamente a te». Siccome tutta l’umanità è unita al Cristo, chi professa la propria fede in Lui sente di far parte dell’umanità intera.
Questa idea ha avuto effetto sul pensare e sul sentire di tutta l’umanità e quando nel diciottesimo secolo è ricomparsa l’idea della reincarnazione, si è manifestata come idea cristiana.
E vedendo come per esempio Widenmann parla della reincarnazione, seppur in modo rudimentale e dilettantesco, dobbiamo comunque dire che nel suo scritto premiato del 1851 la sua idea di reincarnazione è pervasa dall’impulso cristico. In quello scritto c’è un capitolo a parte in cui avviene un confronto fra cristianesimo e dottrina della reincarnazione.
Nell’evoluzione dell’umanità era però necessario che le anime accogliessero prima gli altri impulsi cristiani affinché l’idea della reincarnazione potesse entrare nella nostra coscienza in una forma matura. E questa idea della reincarnazione si collegherà effettivamente al cristianesimo in modo da sentirlo come qualcosa che passa attraverso le singole incarnazioni, in modo che si capisca come l’individualità, che per la concezione buddista va perduta del tutto, come abbiamo visto nel dialogo fra il re Milinda e il saggio Nagasena, riceve il suo giusto contenuto solo “cristianizzandosi”.
Ora possiamo comprendere il motivo per cui mezzo millennio prima della venuta del Cristo la concezione buddista, pur mantenendo le incarnazioni successive, perde l’Io umano: perché non c’era ancora stato l’impulso cristico, il primo a far sorgere ciò che può passare da un’incarnazione all’altra in maniera sempre più cosciente.
Ma ora è giunto il tempo in cui per l’essere umano subentra la necessità di accogliere l’idea della reincarnazione, capirla e farsene compenetrare. Il progresso dell’evoluzione umana non dipende infatti da quali insegnamenti vengono diffusi, da quali nuove dottrine prendono piede, ma da altre leggi ancora sulle quali noi non esercitiamo alcun controllo.
In futuro nella natura umana verranno sviluppate certe forze che faranno in modo che l’uomo, non appena avrà raggiunto una determinata età e avrà preso coscienza di sé, proverà questa sensazione: «C’è qualcosa in me che devo capire». Gli uomini saranno sempre più colti da questa sensazione.
Nei tempi passati, per quanto coscienti fossero diventati gli uomini, questa coscienza non esisteva ancora. Si esprimerà più o meno così: «Sento qualcosa in me che è in relazione con il mio Io. È strano perché non calza con tutto ciò che posso sapere a partire dalla mia nascita attuale». Allora si potrà o non si potrà capire che cosa sta succedendo.
Lo potrà comprendere chi avrà fatto diventare gli insegnamenti della scienza dello spirito un contenuto della propria vita. Costui saprà: quello che sento adesso mi risulta estraneo perché si tratta dell’Io proveniente da vite precedenti.
Questa sensazione sarà invece opprimente e angosciante per quelli che non se la sapranno spiegare partendo dalle ripetute vite terrene. Queste emozioni, che ora non saranno solo dubbi teorici, ma angoscie e nodi esistenziali, si scioglieranno invece grazie ai sentimenti provenienti dalla scienza dello spirito, che dicono: devi considerare il tuo divenire come qualcosa che si estende su svariate vite terrene.
Allora gli uomini vedranno che cosa significa per loro sentire il rapporto con l’impulso cristico, poiché sarà proprio questo impulso a ravvivare lo sguardo e la prospettiva verso il passato. Si sentirà che lì c’è stata un’incarnazione e là un’altra, poi verrà un tempo oltre cui non si potrà andare a ritroso se non ci si sarà resi conto che sulla Terra c’è stato l’impulso cristico. E poi si andrà più indietro ancora, fino alle incarnazioni in cui l’evento cristico non si era ancora verificato.
Gli uomini avranno bisogno di questa chiarificazione dello sguardo a ritroso per mezzo dell’impulso cristico per acquistare fiducia nel futuro, essa sarà una necessità e un aiuto che si potranno riversare nelle incarnazioni successive.
Questa trasformazione dell’organizzazione animica umana avrà luogo, e prenderà le mosse dall’evento che avrà inizio nel ventesimo secolo e che possiamo definire una sorta di secondo evento cristico, così che gli uomini le cui facoltà superiori si saranno destate vedranno il “Signore del karma”.
Ma coloro che lo sperimenteranno non lo vivranno solo stando nel mondo fisico. Alcuni di voi potrebbero dire che, se la cosa fondamentale avrà luogo nell’evento cristico del ventesimo secolo, molti di quelli che oggi sono vivi faranno allora parte dei defunti, vivranno fra la morte e una nuova nascita. Ma un’anima che si sia preparata all’evento cristico ne farà l’esperienza, sia che si trovi in corpo fisico, sia che viva nel periodo compreso fra la morte e una nuova nascita.
La capacità di vedere l’evento cristico non dipende dal nostro essere incarnati in un corpo fisico, ma dalla nostra preparazione. Proprio come è stato necessario che il primo evento cristico si svolgesse nel mondo fisico per contribuire alla salvezza dell’uomo, così la preparazione indispensabile per vedere in piena luce e comprensione l’evento cristico del ventesimo secolo dovrà essere svolta qui nel mondo fisico.
L’uomo le cui forze si sono ridestate ma che lo vede senza l’adeguata preparazione non lo comprenderà. Allora il Signore del karma gli apparirà come una terribile punizione. Per capire questo evento con chiarezza occorre che l’uomo sia preparato.
Per questo viene fatta nel nostro tempo la preparazione grazie alla concezione scientifico-spirituale del mondo, così che l’uomo possa essere pronto a percepire l’evento cristico nel mondo fisico o nei mondi superiori. Gli uomini che non si sono preparati a sufficienza nel mondo fisico, che vivono impreparati fra la morte e una nuova nascita, dovranno aspettare ancora finché in una successiva incarnazione non saranno stati preparati dalla concezione scientifico-spirituale alla comprensione del Cristo.
I prossimi tre millenni offriranno però agli uomini l’opportunità di compiere questa preparazione, e tutta l’evoluzione scientifico-spirituale tenderà a consentire sempre più agli esseri umani di prendere dimestichezza con ciò che dovrà accadere.
Così capiamo come il passato fluisce nel futuro. E se ricordiamo in che modo ha agito il Buddha nel corpo astrale del bambino Gesù natanico, non potendosi più reincarnare sulla Terra, vediamo che anche le forze del Buddha continuano a esercitare la loro azione. E se ricordiamo come ciò che è in diretto rapporto con il Buddha abbia agito proprio in Occidente, allora vediamo in esso l’intervento del mondo spirituale nel mondo fisico.
Ma tutto quello che è dovuto accadere per la preparazione è in un certo modo connesso con il fatto che gli uomini si avvicinano sempre più a un ideale, che in fin dei conti era già sorto nell’antica Grecia, quell’ideale che Socrate formulava dicendo che l’uomo, quando comprende l’idea del buono, del morale, dell’etico, lo sente come un impulso così magico da renderlo capace di vivere in base a quell’idea.
Oggi non siamo ancora abbastanza evoluti da far sì che questo ideale possa essere realizzato; siamo solo in una situazione per cui l’uomo è senz’altro in grado di pensare il bene, di essere intelligente e assennato, senza tuttavia dover essere moralmente buono.
Ma il senso dell’evoluzione interiore sarà che le nostre idee del bene diventino direttamente anche stimoli morali. Questo farà parte dell’evoluzione che sperimenteremo prossimamente.
E gli insegnamenti sulla Terra diventeranno sempre più tali per cui nei secoli e nei millenni successivi il linguaggio umano avrà un effetto inaspettato e molto più forte di quello avuto in passato o ai giorni nostri.
Oggi qualcuno potrebbe vedere chiaramente nei mondi superiori in quale rapporto stanno fra loro l’intelletto e la moralità. Ma oggi non esiste ancora un linguaggio umano dall’effetto così magico da far sì che, quando si esprime un principio morale, esso entri nell’altro uomo in modo che questi lo percepisca immediatamente come morale e non possa far altro che realizzarlo in qualità di impulso morale.
Allo scadere dei prossimi tre millenni sarà possibile parlare agli uomini in una lingua simile, che oggi non può ancora essere affidata alla nostra laringe, così che tutto ciò che è intellettuale sarà nel contempo morale e entrerà nei cuori degli uomini.
Nei prossimi tre millenni l’uomo dovrà essere come intriso di moralità magica, altrimenti non potrebbe sopportare una simile evoluzione e non potrebbe che abusarne.
Per la preparazione particolare di una simile evoluzione esiste quell’individualità che circa un secolo prima della nostra era è stata parecchio calunniata e che è presente nella letteratura ebraica, ma in una forma travisata, come Gesù ben Pandira, Gesù figlio di Pandira.
Dalle conferenze tenute a Berna alcuni di voi sanno come questo Gesù ben Pandira abbia esercitato un’azione preparatoria all’evento cristico, radunando intorno a sé discepoli fra i quali c’era per esempio anche il maestro dell’autore del Vangelo di Matteo.
Gesù ben Pandira, nobile personaggio esseno, ha preceduto di un secolo Gesù di Nazareth. Mentre quest’ultimo è stato solo vicino agli Esseni, in Gesù ben Pandira abbiamo davanti a noi una figura essena.
Chi era costui?
Nel corpo fisico di Gesù ben Pandira era incarnato il successore di quel bodhisattva che nel ventinovesimo anno della sua ultima incarnazione terrena era asceso al livello di Buddha. Ogni bodhisattva che diventi un Buddha ha un successore. Questa tradizione orientale corrisponde pienamente alle ricerche scientifico-spirituali. E quel bodhisattva che a quei tempi ha operato per la preparazione dell’evento cristico ha continuato a incarnarsi.
Una di queste incarnazioni è prevista anche nel ventesimo secolo. Ora non è possibile parlare più dettagliatamente della reincarnazione di quel bodhisattva, ma si può dire qualcosa su come poterlo riconoscere nella sua reincarnazione.
Per una legge che potrà essere illustrata e convalidata in future conferenze, una caratteristica peculiare di questo bodhisattva è che, quando compare reincarnato – cosa che continua a verificarsi nel corso dei secoli –, da giovane è molto diverso da quello che diventerà in seguito e sempre in un preciso momento della sua vita subentra una sorta di cambiamento radicale, una grande trasformazione.
In termini concreti: gli uomini vedranno che in un posto o in un altro vive un bambino più o meno dotato, che non dà a vedere di avere un compito particolare da svolgere per la preparazione della futura evoluzione dell’umanità. La ricerca occulta dice che nessuno come colui che si reincarna come bodhisattva mostra così poco in gioventù e nei primi anni di vita la sua vera natura. In un momento ben preciso della vita di un bodhisattva che si reincarna subentra infatti un grande cambiamento.
Quando si incarna un’individualità dei tempi remoti, per esempio Mosè, le cose non stanno come nel caso dell’individualità del Cristo, dove l’altra individualità (Zarathustra) ha abbandonato gli involucri di Gesù di Nazareth. Anche nel bodhisattva si verifica qualcosa di simile a una “sostituzione”, ma l’individualità permane in un certo modo. E l’individualità che arriva dal passato come patriarca o qualcosa del genere e deve portare nuove forze per l’evoluzione dell’umanità si immerge in quella persona, che sperimenta così una forte trasformazione.
Questa trasformazione ha luogo soprattutto fra i trenta e i trentatré anni, e prima di allora non si può mai sapere che proprio quel corpo verrà afferrato dal bodhisattva. Questo non si manifesta mai negli anni giovanili, ma nel fatto che gli anni successivi sono così diversi da quelli della giovinezza. Questo è il segno distintivo.
Colui che era incarnato in Gesù ben Pandira e che poi ha continuato a incarnarsi, il bodhisattva successore del Buddha Gautama, si prepara alla sua incarnazione da bodhisattva. Anche qui la ricerca occulta coincide con le tradizioni orientali secondo le quali potrà comparire e ascendere alla dignità di Buddha cinquemila anni dopo l’illuminazione del Buddha Gautama.
Allora, tremila anni dopo la nostra era, riconsiderando tutto ciò che è accaduto nella nuova epoca con l’impulso cristico e tutto ciò che è in relazione con esso, quel bodhisattva parlerà in modo che dalle sue labbra esca un linguaggio in grado di realizzare quanto ho appena illustrato: l’immediata coincidenza di intellettualità e moralità.
Il futuro bodhisattva sarà un portatore del bene attraverso la parola, tramite il Logos, e metterà tutto ciò che ha al servizio dell’impulso cristico e si esprimerà in una lingua che oggi ancora nessun uomo possiede, ma che è così sacra da far sì che egli venga definito “un portatore del bene”. Questo non si manifesterà nella sua giovinezza, ma intorno ai trentatré anni apparirà come un uomo nuovo e si mostrerà come colui che può essere ricolmato da un’individualità superiore.
Il verificarsi di un’unica incarnazione nella carne vale solo per il Cristo Gesù. Tutti i bodhisattva attraversano ripetute incarnazioni nel mondo fisico.
Così fra tremila anni quel bodhisattva sarà talmente evoluto da poter diventare un portatore del bene, un Buddha Maitreya che metterà le sue parole di bontà al servizio dell’impulso cristico, del quale nel frattempo si sarà compenetrata una quantità sufficiente di esseri umani. Questo ci dice oggi la prospettiva per la futura evoluzione dell’umanità.
Che cos’era necessario affinché gli uomini potessero arrivare a poco a poco a quell’epoca evolutiva? Ce lo possiamo spiegare nel seguente modo.
Se vogliamo esprimere in un grafico quanto è accaduto nell’antica epoca lemurica per l’evoluzione terrena dell’uomo, possiamo dire: a quel tempo l’uomo è sceso dalle altezze divine. Era destinato a evolversi in un certo modo, ma per via dell’influsso luciferico l’uomo è stato gettato più profondamente nella materia di quanto sarebbe accaduto senza questo influsso. In tal modo il suo progresso nell’evoluzione è stato diverso.
Dato che l’uomo era caduto profondamente in basso, necessitava di un forte impulso verso l’alto. Questo ha potuto avvenire solo grazie al fatto che quell’Entità delle Gerarchie superiori che noi chiamiamo Entità cristica ha preso una decisione nei mondi superiori che non era necessaria per la sua evoluzione. L’Entità cristica infatti avrebbe raggiunto la propria evoluzione anche se avesse preso un’altra strada, ben al di sopra di dove il suo cammino incrociava quello degli uomini.
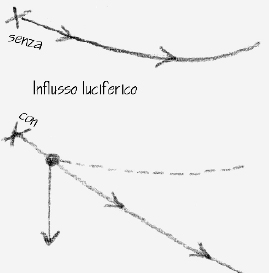
E l’Entità cristica avrebbe, per così dire, potuto nelle altezze passare oltre l’evoluzione degli uomini. Ma allora l’evoluzione dell’umanità, se non ci fosse stato l’impulso verso l’alto, avrebbe dovuto continuare il percorso verso il basso. Allora l’Entità cristica avrebbe avuto un’ascesa e l’umanità solo una caduta.
Solo in virtù del fatto che l’Entità cristica ha preso la decisione di unirsi a un uomo al momento degli eventi della Palestina, di incarnarsi in un uomo e di rendere possibile per l’umanità la via verso l’alto, solo per questo fatto è stata resa possibile quell’evoluzione dell’umanità che possiamo definire una liberazione del genere umano dall’impulso delle forze luciferiche, e che la Bibbia chiama il peccato originale, la seduzione del serpente e il compimento del peccato originale.
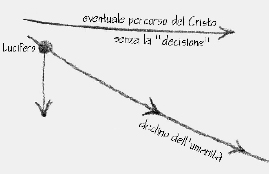
Il Cristo ha compiuto qualcosa che per lui stesso non era necessario. Di che azione si è trattato? Di un’azione dell’amore divino!
Dev’esserci chiaro che nessun sentimento umano è in grado di provare a tutta prima quell’intensità d’amore necessaria a far sì che un essere divino prendesse la decisione, di cui non aveva bisogno, di agire sulla Terra in un corpo umano. È questo – un atto d’amore – che ha realizzato quell’evento di primaria importanza nell’evoluzione dell’umanità.
E quando gli uomini capiscono questo atto di amore dell’essere divino, quando cercano di sentirlo come un grande ideale, in confronto al quale ogni atto d’amore umano appare piccolo, allora questo sentimento di incommensurabilità dell’amore umano rispetto a quell’amore divino, necessario per il mistero del Golgota, avvicina gli uomini anche alla formazione, alla nascita di quelle immagini che ci pongono davanti agli occhi spirituali questo importantissimo evento del Golgota.
Sì, è davvero possibile arrivare alla visione spirituale del monte su cui è stata innalzata la croce, quella croce da cui pendeva un essere divino in un corpo di uomo, un dio che ha compiuto un’azione per libera scelta – cioè per amore – affinché la Terra e l’umanità potessero giungere alla propria meta.
Se a suo tempo quel dio che viene chiamato con il nome di Dio Padre non avesse permesso che gli influssi luciferici entrassero nell’uomo, quest’ultimo non avrebbe sviluppato la libera disposizione all’Io. Con l’influsso luciferico si è sviluppata la facoltà dell’Io libero. Ciò doveva essere permesso da Dio Padre.
Ma dopo che l’Io – per amore della libertà – ha dovuto irretirsi nella materia, tutto l’amore del Figlio ha dovuto portare all’evento del Golgota per liberarlo da questo irretimento. Solo questo ha reso possibile la libertà dell’uomo, la piena dignità umana.
È grazie a un atto d’amore divino che possiamo essere liberi. Così in quanto uomini possiamo sentirci esseri liberi, ma non dobbiamo dimenticare che questa libertà la dobbiamo all’atto di amore dell’essere divino. Se pensiamo in questo modo, al centro del nostro sentire si troverà questo pensiero: «Puoi raggiungere la dignità umana, ma una cosa non devi dimenticare: che ciò che sei lo devi a Colui che ti ha riportato il tuo archetipo umano con la redenzione sul Golgota!».
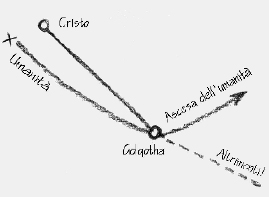
Gli uomini non dovrebbero poter cogliere l’idea della libertà senza l’idea della redenzione per mezzo del Cristo. Solo così l’idea della libertà è giustificata.
Se vogliamo essere liberi, dobbiamo in offerta ringraziare il Cristo per la nostra libertà! Solo così possiamo viverla realmente. E gli uomini che vedono la loro dignità umana compromessa per il fatto di attribuirla al Cristo, dovrebbero dare atto che i giudizi umani non hanno alcun peso di fronte ai fatti cosmici. Un giorno saranno anch’essi contenti di riconoscere che la loro libertà è stata conquistata dal Cristo.
Non è molto quello che in questo ciclo di conferenze si è potuto fare per una comprensione più precisa dell’impulso cristico e dell’intero corso dell’evoluzione dell’umanità sulla Terra dal punto di vista della scienza dello spirito.
Possiamo sempre contribuire solo con singoli elementi. Ma se questi agiscono nella nostra anima in modo da spronarci a darci ulteriormente da fare, a evolvere ulteriormente sulla via della conoscenza, allora questi singoli elementi avranno contribuito alla costruzione del grande tempio spirituale dell’umanità.
E il meglio che possiamo ricavare da tali considerazioni scientifico-spirituali è che in vista di un certo scopo abbiamo di nuovo imparato qualcosa, che abbiamo arricchito ancora un po’ il nostro sapere. In vista di quale scopo?
È stato in vista dello scopo di sapere più precisamente di quanto abbiamo ancora bisogno per sapere di più, così da poter essere sempre più convinti della verità dell’antica massima socratica: più si impara e più si sa di sapere poco!
Ma ciò è bene solo quando non diviene una rassegnazione inattiva e priva di slancio, bensì una dichiarazione di volontà e anelito vitali verso conoscenze sempre più vaste. Non dobbiamo ammettere di sapere poco dicendo: «Non possiamo sapere tutto, quindi è meglio se non impariamo niente e incrociamo le braccia». Questo sarebbe un risultato sbagliato delle osservazioni scientifico-spirituali!
La cosa giusta può solo consistere nel nostro essere sempre più stimolati ad applicarci ulteriormente e a considerare ogni nuovo apprendimento come un gradino, pronti a compiere i passi necessari per salire sempre più in alto.
Proprio in questa serie di conferenze abbiamo dovuto parlare molto del concetto di redenzione senza tuttavia aver usato spesso questa parola. Lo scienziato spirituale dovrebbe sentire questa idea così come l’ha sentita un grande precursore della nostra scienza dello spirito occidentale, Goethe: che in definitiva essa ci diventa affine e familiare nell’anima come conseguenza del nostro anelito alle mete somme del conoscere, del sentire e del volere.
E come questo grande precursore della nostra scienza dello spirito occidentale ha espresso il pensiero che unisce il concetto di redenzione con quello di anelito dicendo: «Noi possiamo redimere chi, sempre tendendo, si affatica!», così lo scienziato spirituale dovrebbe sempre sentire che solo chi vive sempre la tensione interiore può comprendere e sentire la vera redenzione per intendere e agire all’interno della sua sfera.
Anche questo ciclo di conferenze, che mi è stato particolarmente a cuore poiché in esso si è molto parlato dell’idea di redenzione, sia dunque uno stimolo a farci compiere ulteriori sforzi, in modo da poterci unificare sempre più in questa e nelle successive incarnazioni. Siano questi i frutti che ricaviamo da tali considerazioni.
Vogliamo concludere queste conferenze portando con noi l’ardore che ci spinge a impegnarci con lena, così che da un lato capiamo chi è il Cristo e dall’altro ci avviciniamo sempre più alla redenzione, che non è una semplice liberazione dalla via e dalla sorte terrene inferiori, ma che dev’essere anche la liberazione da tutto ciò che ostacola l’uomo verso il conseguimento della sua dignità umana.
Queste cose sono però scritte nella loro verità soltanto negli annali dello spirito, poiché solo la scrittura che può essere letta nel mondo degli spiriti è vera. Adoperiamoci quindi a leggere il capitolo sulla dignità e la missione dell’uomo nella scrittura che parla di queste cose nei mondi spirituali.
Le conferenze di Rudolf Steiner
Rudolf Steiner ha tenuto alcune migliaia di conferenze, molte delle quali pubbliche, davanti alle platee più diverse. Non erano destinate alla stampa, ma molte persone volevano anche leggere queste conferenze. A tal proposito egli scrive nella sua autobiografia Mein Lebensgang (cap. 35): «Si dovrà appunto solo accettare che nelle trascrizioni che io non ho rivisto si trovino degli errori.»
In un’epoca in cui non esistevano registratori il percorso della parola pronunciata fino al testo stampato non era facile. Diversi uditori hanno stenografato con differente abilità, poi trasposto lo stenogramma in un testo in chiaro e a seconda delle circostanze l’hanno sottoposto a una redazione. Così nel volume GA 137 (HDD 2004, p. 233): «Questa edizione si è basata sugli appunti stenografici di Franz Seiler, Berlino, che, su incarico di Marie Steiner-von Sivers, è stata corretta ovvero rielaborata per la stampa da Adolf Arenson.»
Oggi, un secolo dopo, Rudolf Steiner è divenuto un personaggio storico. Per molte persone non sono più importanti o decisive le disposizioni che lui ha preso o ciò che ha dovuto accettare riguardo alle proprie conferenze quand’era in vita. Oggi conta indagare la “qualità delle fonti” e rendere accessibili i documenti disponibili a tutte le persone che se ne interessano.
Tutte le scelte redazionali di questo volume sono state fatte nella convinzione che l’intera umanità ha diritto di verificare tutti i documenti che erano a disposizione del redattore. Non è affatto un caso, ma fa invece parte del karma forse più importante dell’umanità, quali trascrizioni delle conferenze di Rudolf Steiner si sono conservate. Non poche persone oggi vogliono sapere nel modo più preciso possibile, cosa abbia detto Rudolf Steiner.
Desiderano perciò sapere quali dei documenti rimasti sono più vicini alle parole pronunciate da Rudolf Steiner. Per accertare questo, ci vogliono un esame coscienzioso dei documenti e una grande familiarità col pensiero e col linguaggio di Rudolf Steiner.
L’Archiati Verlag e le Edizioni Archiati si sono posti il duplice obiettivo di giungere più vicino possibile alle parole dette da Rudolf Steiner e insieme di rendere accessibile la sua scienza spirituale a tutti gli uomini, poiché è proprio nella sua natura farsi immediatamente vita immediata. Per prima cosa sono importanti gli originali delle trasposizioni in chiaro, in secondo luogo contano la scelta dei testi, il modo di redigerli, ma anche la veste editoriale e, non ultimo, il prezzo.
Come si possa unire precisione scientifica a un’ampia accessibilità, lo si può vedere nel caso di parole che oggi sono in disuso o che hanno assunto un significato diverso. Nella versione tedesca queste vengono sostituite con un termine facilmente comprensibile e segnate con un cerchietto. Nella traduzione italiana si traduce in modo corrispondente, senza tuttavia segnalare la parola sostituita, sia perché bisognerebbe riportare i termini tedeschi, sia perché, traducendo, il problema molto spesso non si pone.
Quando Rudolf Steiner lasciò la Società Teosofica dette disposizioni affinché nelle sue conferenze i termini “teosofia” e “teosofico” venissero sostituiti da “antroposofia” e “antroposofico”. Qualcuno potrebbe sostenere che si tratti di una falsificazione. Per Rudolf Steiner però la scienza spirituale è soprattutto vita e per servire la vita bisogna rimanere flessibili riguardo alla terminologia. Egli ha sottolineato a più riprese che la terminologia è solo un mezzo per un fine.