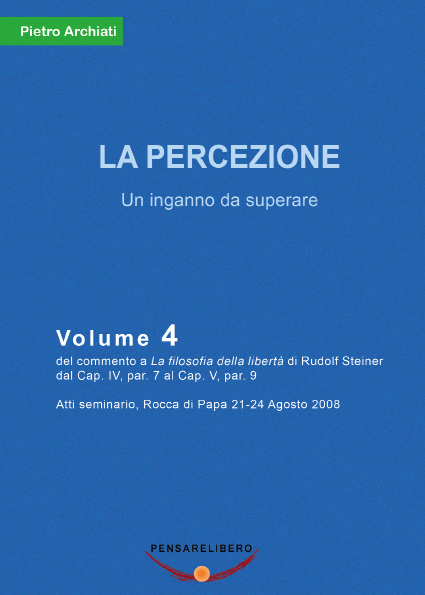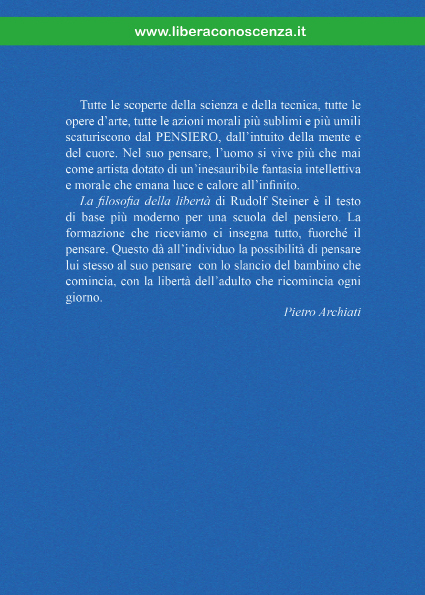Pietro Archiati
LA PERCEZIONE
un inganno da superare
Commento a
LA FILOSOFIA DELLA LIBERTÀ
di Rudolf Steiner
Volume IV
dal Cap. IV, par. 7 al Cap. V, par. 9
Redazione di Stefania Carosi non rivista dall’autore
Indice
Venerdì 22 agosto 2008, mattina
Sabato 23 agosto 2008, mattina
Sabato 23 agosto 2008, pomeriggio
Domenica 24 agosto 2008, mattina
A proposito di Pietro Archiati
Note introduttive
Il testo La filosofia della libertà di Rudolf Steiner su cui Pietro Archiati svolge il suo seminario è quello tradotto in italiano da Dante Vigevani per l’Editrice Antroposofica – Milano 1966.
Le parti riportate in neretto si riferiscono al testo di Rudolf Steiner. Ogni corsivo in neretto è di Rudolf Steiner.
Può capitare che Pietro Archiati rilegga più volte uno stesso brano: in quel caso non viene di nuovo segnalato in neretto, ma tra virgolette.
I commenti di Pietro Archiati durante la lettura, se brevi, e le sue indicazioni di diversa traduzione sono riportati fra parentesi graffe.
Per facilitare la consultazione del testo, che i lettori potrebbero avere in altre edizioni e traduzioni, gli inizi di paragrafo sono stati numerati e visualizzati con rientro di capoverso, accompagnati sempre dal capitolo in numeri romani – es. IV,7 ecc.
Gli stessi numeri sono riportati in parentesi, senza rientro, quando indicano la ripresa della lettura dello stesso paragrafo, sospesa dal commento del relatore.
I riferimenti ai vari volumi di trascrizione di questa serie di Seminari su La filosofia della libertà, sono indicati con le sigle FdL1, FdL2, FdL3, ecc.”
Giovedì, 21 agosto 2008, sera
Benvenuti a tutti, buonasera a tutti!
Siamo nel bel mezzo del quarto capitolo, e perciò vorrei iniziare con un piccolo avvio soprattutto per coloro che partecipano per la prima volta a questo lavoro.
Un pensiero fondamentale è che l’essere umano, l’uomo che siamo tutti noi, si distingue dai minerali, dalle piante e dagli animali non per il fatto di esistere, perché questo ce l’ha in comune anche con i minerali; non per il fatto di vivere, di essere vivente, perché la vita mi risulta che ce l’abbiano anche le piante; non si distingue per il fatto di avere sentimenti, emozioni, passionalità, pulsioni, istinti perché questi li ha in comune con l’animale.
L’uomo si distingue in assoluto grazie a ciò che il minerale, il vegetale e l’animale non hanno per niente. Quelli addetti ai lavori hanno subito pensato: eh vuole arrivare al pensare! L’essere umano si distingue per il pensare.
Però la cosa non è così semplice! Chiediamoci un pochino: gli animali hanno coscienza o no? Sì che ce l’hanno, perché ogni sentire – per esempio l’animale sente il dolore fisico –, ogni vissuto è un con-sapere di tutto l’organismo. La differenza fondamentale tra la pianta e l’animale è che quando c’è uno stimolo – supponiamo che si punga una foglia con uno spillo, oppure un animaletto entra e mangiucchia qualcosina – quello che avviene in quel punto della foglia resta assolutamente puntuale, localizzato, nelle altre parti della pianta non c’è nessuna ripercussione.
Voi direte: sta di fatto, però, che con certe persone che amano i fiori le piante fioriscono più abbondantemente, se invece uno non gli vuol bene e non le cura deperiscono. Allora c’è una risposta complessiva della pianta. L’essere umano può avere un influsso sulla totalità delle forze vitali della pianta, cioè su quello che la scienza dello spirito chiama corpo eterico, o corpo delle forze vitali, che pervade tutta la pianta (ve lo disegno in verde perché abbiamo a che fare col vivente).

il corpo vitale pervade la pianta
Fig.1
Uno stimolo puntuale, in un certo senso, stimola tutta la vitalità della pianta, ma la pianta non sente nulla, non vive nulla. Per esempio, se tiro via una foglia non sente dolore. Le piante hanno un’anima ma non dentro la pianta: c’è un’anima comune di tutte le piante che è nella Terra e perciò, quando recido qualche rametto di una pianta nella potatura, per esempio, la Terra ha un sentimento di gioia, di voluttà – è come quando la mamma allatta il bambino. Quando invece si estirpa, si strappa via anche la radice, allora l’anima comune delle piante (ci sono sette anime principali che fanno capo alla Terra) sente dolore.

l’anima è fuori dalla pianta
Fig.2
Nell’animale sopravviene il fenomeno dell’anima, tant’è vero che l’animale è appunto anima-le, è l’essere dotato di anima (da lì anche il nome latino animal), oltre che di corpo fisico e di corpo eterico. L’anima significa che, attraverso un sistema neurosensoriale centralizzato, ogni stimolo esercitato su un punto A si ripercuote e viene vissuto, viene sentito, in tutto il corpo.
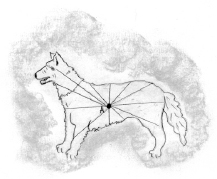
corpo vitale e anima pervadono l’animale
Fig.3
Quando io pungo una pianta la puntura non viene sentita proprio: viene vissuta, influisce sul vitale della pianta, ma la pianta non ha una possibilità di sentire. Per l’animale, invece, per il fatto che c’è il ripercuotersi di un impulso su tutta la corporeità, possiamo parlare in un certo senso di coscienza: perché coscienza significa un sapere complessivo di tutto l’organismo.
Spesso, siccome viviamo in tempi un pochino poveri di pensiero, non si distingue tra coscienza e autocoscienza: l’autocoscienza è la coscienza di sé, l’autocoscienza è l’essere coscienti di essere coscienti. L’autocoscienza l’animale non ce l’ha. L’animale sente dolore ma non sa di sentire dolore, ed è diverso.
Prendiamo un bambino piccolo di un anno, lo pungiamo un pochino (non è che lo facciamo davvero, è per fare un esempio): sente dolore? Certo! Sa di sentire dolore? No, a un anno no. Non c’è ancora l’autocoscienza.
Il fenomeno umano si contraddistingue per l’autocoscienza, cioè la coscienza di sé, la coscienza di essere un io. Io sono un io. L’essenziale dell’autocoscienza è rendersi conto di essere coscienti di pensare. Sapere di sapere significa pensare.
L’animale sa, in un certo senso, perché l’istinto in base al quale si comporta è un sapere «sapienziale», per così dire, profondissimo, pieno di armonia. Però l’animale non sa di sapere, non ha coscienza di questo istinto intriso di sapienza che lo porta a comportarsi come si comporta. Questo diventare coscienti di sé, questa riflessione, questo riflettere il pensare su di sé dicendo: io sono un io pensante, già Agostino, grande preannunciatore di tempi futuri, lo chiamava recurvatio in se ipsum. Io so di essere un io, io so di pensare. (Fig. 4)
Cosa vuol dire essere autocoscienti? Vuol dire essere autonomi. Se io ho coscienza della mia coscienza, se io so del mio sapere, mi metto nella posizione di prendere in mano io stesso i fenomeni della mia coscienza e di gestirli.
Se io sono cosciente della mia coscienza sono autocosciente, posso prendere posizione nei confronti della mia coscienza e gestirla nei suoi atti, nei suoi contenuti, nei suoi passi evolutivi ecc. Quindi divento sempre di più uno spirito liberamente creatore: rendendomi conto di essere un essere cosciente, prendo in mano i destini della coscienza umana, i destini della mia coscienza. Perlomeno ne ho la potenzialità, direbbe Aristotele.
Nel momento in cui porto a coscienza la mia coscienza pensante, divento capace di prendere posizione e di gestirla, quindi mi riconosco come uno spirito potenzialmente libero, creatore, autonomo, che gestisce in proprio tutti i fenomeni di coscienza.
Fino a questo punto tutte le riflessioni che abbiamo fatto dicevano: ci sono due modi fondamentali di infanzia della coscienza umana – e l’infanzia è una cosa bella finché si è piccoli: se uno resta bambino a trent’anni diventa anacronistica, la cosa.
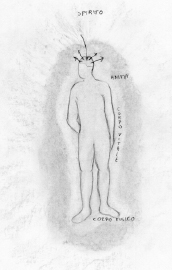
corpo fisico – corpo vitale – anima – spirito
l’autocoscienza nell’uomo
Fig.4
La scienza tradizionale è la prima forma di infanzia dell’umanità, e la religione tradizionale è la seconda forma fondamentale di infanzia. Intendo per infanzia un periodo, uno stadio evolutivo in cui l’essere umano non ha ancora assunto in proprio le sorti della sua coscienza, del suo pensare.
Lo scienziato è l’essere umano che, nei confronti del mondo, della natura, non è ancora diventato attivo. Lo scienziato è passivo nei confronti del mondo materiale. Cosa fa la scienza? Guarda e descrive quello che vede: una poltroneria più grossa non si può proprio immaginare!! Mai che si metta in testa di aggiungerci qualcosa di suo: non sarebbe più uno scienziato oggettivo!
La religione tradizionale è non meno passiva. Noi, naturalmente, vogliamo indicare l’avvenire, i passi successivi sia della scienza sia della religione: ma la religione tradizionale è un’assoluta passività nei confronti del mondo spirituale.
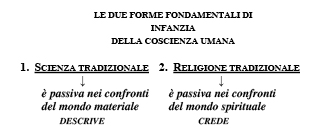
La passività dello scienziato si manifesta nel suo descrivere – io ti descrivo le cose come sono, non ci metto nulla di mio – e la passività del religioso si manifesta nel credere. Cosa vuol dire credere? Vuol dire: non è farina del mio sacco, ma tutto è stato tramandato in dogmi, di generazione in generazione. La religione può essere bellissima nei suoi contenuti, ma per quanto mi riguarda, in quanto credente, io ci devo credere.
Un paio di giorni fa sono venute due persone dal nord della Germania a trovarci al sud, e ci hanno raccontato di aver ascoltato in Austria un vescovo che predicava sull’ascensione in cielo di Maria, anima e corpo. Questo vescovo era una botticella, proprio bello in carne, rotondino, e la gente poi, uscendo dalla chiesa, diceva: però quello lì, se dovesse salire in paradiso anima e corpo, non è che ci farebbe una gran bella figura! Il credente crede che la Madre di Gesù Cristo sia salita in cielo anima e corpo. Ci crede.
Non molti giorni fa ho fatto un colloquio, una conversazione simpaticissima, interessantissima, con un certo Omar, un somalo che coltiva le piante, e gli ho chiesto: Omar, dimmi un po’, nel tuo Corano, alla 19a sura che è intitolata «Maria» – tu la conosci questa sura? Ma certo!, io leggo il Corano ogni mattina, almeno alcune pagine, e certo che la conosco! –, dimmi, allora, cosa viene raccontato in questa 19a sura?
Che questa Maria si è trovata incinta – dice Omar – ma non conosceva nessun maschio, e si è spaventata perché temeva di essere presa per una prostituta ed è scappata via dalla vergogna. E il bambino, ancora nel grembo della mamma, le diceva: non preoccuparti, lascia fare a me, appena io nasco lo dico io a quelli là come è successa la faccenda.
E tra l’altro, un certo Rudolf Steiner di cui voi avete già sentito parlare, dice che è vero: lui conferma, da quello che osserva nel mondo spirituale, che questo Gesù di Nazareth appena nato era in grado di parlare – cosa che nessun essere umano normalmente sa fare –, parlava una specie di lingua che solo la madre poteva capire.
Omar dice che appena il bambino è nato, Maria è tornata col bambino sulle spalle e alla sua parentela che le chiedeva: ma da dove viene ‘sto bambino?, diceva: vi spiegherà lui come sono avvenute le cose. E cosa ha detto questo Gesù appena nato? Io sono nato dallo Spirito Santo perché Allah può fare tutto quello che vuole.
Omar mi ha raccontato tutto questo in un modo così bello, così caldo, così col cuore, che se io gli avessi chiesto: ma tu, Omar, ci credi veramente che qui nasce un bambino contro la legge di natura? – ditelo voi allo scienziato che il bambino è nato senza il seme paterno! –, se io gli avessi chiesto questo, sono sicuro che l’avrei offeso in un modo incredibile. Era chiarissimo che per lui non c’era nessun problema.
La coscienza occidentale si trovava nel passato in questo bellissimo stadio di coscienza infantile, dove si poteva credere a questi bei miracoli: adesso è passato, adesso ci troviamo in un periodo di enorme transizione dove, nella cultura occidentale, diventano sempre meno numerose le persone che sono in grado di credere semplicemente. Nell’area musulmana sono molto più numerose.
E dicevo già nel precedente incontro che il senso de La filosofia della libertà (testo fondamentale sull’evoluzione della coscienza umana, sull’evoluzione del pensiero) è che il passo successivo della coscienza umana è di vincere questa doppia passività, che era necessaria nella fase infantile dell’evoluzione dell’uomo. Questa è l’affermazione fondamentale che poi cercheremo di sminuzzare e di verificare nei minimi particolari.
Di fronte alla percezione l’uomo scienziato, che siamo tutti noi, è chiamato a diventare sempre più attivo, e di fronte al dogma finora creduto l’uomo religioso, se non vuol perdere la religione, è anch’esso chiamato a diventare sempre più attivo.
Come si diventa attivi nei confronti del mondo materiale, e come si diventa attivi nei confronti del mondo spirituale?
Nel mondo materiale, che è il mondo della percezione (l’abbiamo già visto nel I, nel II e nel III capitolo), lo spirito umano diventa sempre più attivo, sempre più creatore, sempre più artisticamente fantasioso e libero nella misura in cui dice: la percezione, ciò che gli occhi vedono, non è nulla. Quando io do un nome alle cose, quando io dico «rosa», sono già uscito dalla percezione, sono già nell’elemento del pensiero.
Di che cosa parla lo scienziato classico tradizionale? Del mondo della percezione, del mondo diventato nulla – e non se n’è ancora accorto. Lui pensa che la realtà sia nella percezione, fuori di lui, e non si accorge che il mondo diventa reale soltanto quando lui crea i concetti.
Per il bambino piccolo c’è la realtà della rosa? No! Altrimenti dovrebbe poter dire: quella è una rosa, e allora sarebbe una realtà. La rosa opera, vegeta, vige dentro il bambino – nel suo corpo astrale, nel suo animo –, ma la rosa in quanto realtà spirituale assoluta non c’è ancora per il bambino piccolo, perché non è ancora capace neanche di linguaggio, ancor meno di pensiero.
Quindi il pensiero è l’elemento cosmico dentro il quale il mondo diventa reale.
La sapienza orientale ha sempre chiamato la percezione «maja». Illusione. È una parvenza di realtà, ma non è realtà. Maja è una contrazione di MAHA A-JA, ve lo ricordate, forse.
Maha (magnus, grande) A (non) JA (essere)
IL GRANDE NON ESSERE
Quindi il concetto orientale di ciò che il materialista occidentale, lo scienziato occidentale, chiama realtà è la non realtà. E per lo scienziato occidentale cos’è che è diventato una non realtà? Lo spirito.
Chi è più avanti nell’evoluzione, l’orientale che ci dice: il mondo della percezione è illusione non è una realtà, realtà è lo spirito; oppure è più evoluto lo scienziato occidentale che dice: no, la realtà è il mondo che vedo?
È più avanti l’uomo occidentale. Perché? Bisogna andare indietro di millenni e allora vedremo che l’affermazione che dice: «il mondo fisico percepibile è illusione, non è una realtà, lo spirito è una realtà», non era un’esperienza conquistata dall’io in chiave di autocoscienza, ma era una credenza. Tant’è vero che anche oggi l’orientale crede, ha il convincimento che lo spirito è una realtà e il mondo della materia è una non realtà.
Ma il mondo spirituale a cui credo non è una realtà, è soltanto una credenza. Quindi, una dopo l’altra, l’essere umano ha perso sia la realtà del mondo spirituale (che è lo spirito puro: gli Angeli, gli Arcangeli, la Trinità…), sia la realtà del mondo materiale (che è lo spirito incarnato nella materia). Gli resta così il compito evolutivo più bello che si possa immaginare, quello di riconquistarsi individualmente e liberamente la realtà sia dello spirito puro, sia dello spirito incarnato nella materia.
• Lo spirito incarnato nella materia ce lo conquistiamo ogni volta che di fronte alla percezione creiamo un concetto.
• E dove conquistiamo la realtà dello spirito puro? Nel pensare. Il pensare è la cruna dell’ago che reintroduce l’uomo dentro la realtà assoluta dello spirito. Cos’è il pensare? L’autoesperienza dell’uomo di essere uno spirito puro, creatore, con una potenzialità all’infinito. Questo elemento del pensare che diventa autocosciente attraverso l’io che lo porta a coscienza, potenzialmente è capace di ridare realtà a tutto il mondo creato dalla Divinità.
Il mondo non l’abbiamo creato noi: il pensare è l’elemento della ricreazione del mondo dentro lo spirito umano. È più bello il mondo creato dallo spirito divino o il mondo creato dal pensare umano? Lo spirito divino può trovare più bello il mondo che lui stesso ha creato, ma per quanto riguarda l’uomo è mille volte più bello il mondo in quanto creato dal pensare umano, perché solo quel mondo è creazione specifica dell’uomo.
E che differenza c’è tra il mondo come pensare divino e il mondo come pensare umano? La differenza è enorme. Attraverso il pensare umano, in ogni uomo sorge nel cosmo un nuovo spirito. È un arricchimento del cosmo all’infinito!
L’altra volta eravamo arrivati a questo punto, alla fine del paragrafo 7.
Intervento: No, eravamo arrivati alla fine del 6.
Intervento: C’è una discrepanza fra i paragrafi tedeschi e quelli italiani. Il tedesco è avanti di un paragrafo.
Archiati: Va bene, rileggo dal IV,5 «Ma ora è il momento di passare dal pensare all’essere pensante {che è l’uomo}, perché attraverso l’essere pensante il pensare viene collegato con l’osservazione. La coscienza umana è il palcoscenico dove concetto e osservazione si incontrano e vengono collegati fra loro. Una tale coscienza (umana) viene però con questo già caratterizzata. Essa è l’intermediario fra pensiero e osservazione. In quanto l’uomo osserva un oggetto, questo gli appare come dato: in quanto pensa egli appare a se stesso come attivo».
Il bambino piccolo piccolo, di fronte alla pianta di mele è passivo, non è ancora capace di dire: quello è un melo. Dire: quello è un melo, è un prendere posizione attiva, è diventare attivi nei confronti del melo. Quindi il pensare è proprio l’elemento attivo.
IV,5 «Considera la cosa come oggetto e se stesso come soggetto pensante {che prende posizione, che decreta, che decide che cosa le cose sono}. In quanto dirige il suo pensare sull’osservazione ha coscienza degli oggetti, in quanto dirige il pensare su se stesso ha coscienza di sé o autocoscienza. La coscienza umana deve necessariamente essere sempre anche autocoscienza, poiché è coscienza pensante {coscienza pensante significa che sa di pensare, sa di sapere, riflette sul proprio riflettere, pensa sul proprio pensare}. Infatti, se il pensare rivolge lo sguardo sulla sua propria attività ha, come oggetto, la sua originaria essenza, dunque il suo soggetto».
Ogni essere umano può dire a se stesso: io sono colui che pensa.
Chi sono io, in quanto uomo, nel mondo? Abbiamo detto che l’esistere (corpo fisico) ce l’ho in comune con i minerali; il vivere (corpo vitale o eterico) ce l’ho in comune con le piante; il sentire, l’avere sentimenti (anima), ce l’ho in comune con l’animale; ciò che è mio specifico, che è solo umano (io spirituale) è il pensare. Io penso.
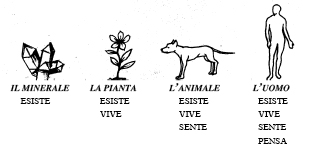
Fig.5
Cartesio diceva: io penso dunque sono.
Di notte non penso, dunque non sono! Quando noi diciamo «io penso», intendiamo l’io penso originario? No, no, quando diciamo «io penso», intendiamo che ci accorgiamo di pensare. Nella coscienza diurna, dove siamo connessi con il cervello, l’affermazione che dice «io penso» ci inganna, perché in fondo non è giusta. Non è che io penso solo quando sono sveglio, è che quando sono sveglio so di pensare, questa è la differenza. Quando io sconnetto il mio pensare dal cervello, io penso né più né meno di prima! Però non so di pensare.
Quindi l’affermazione della coscienza diurna che dice «io penso», non si riferisce al pensare originario, ma sta soltanto a dire: mi rendo conto, porto a coscienza il fatto di pensare, grazie al cervello. Se grazie al congiungimento col cervello porto a coscienza il fatto di pensare, significa che penso sempre, anche senza cervello, e che però, per avere coscienza del mio pensare, devo svegliarmi.
Svegliarsi significa ricongiungere l’attività pensante col cervello. Il cervello fa, proprio in senso fisiologico, da sostrato speculare e riflette il processo del pensare: riflettendolo lo porta a coscienza.
Quindi l’affermazione di Cartesio non si riferisce al pensare originario, si riferisce al fatto che il pensare, in quanto connesso col cervello, si rende conto di pensare, porta a coscienza il suo pensare. Ah, io penso! Se grazie al cervello mi rendo conto di essere un essere pensante, vuol dire che il cervello non serve a pensare, ma serve a rendersi conto di pensare, e quindi il pensare non ha nulla a che fare col cervello! Il pensare avviene senza cervello.
In Germania (e in Italia sarà analogo), a Francoforte, nell’Istituto Max Plank, c’è un neurobiologo abbastanza famoso, Wolf Singer (sui giornali nella Frankfurter Allgemeine Zeitung ci sono sempre diatribe micidiali che lo riguardano). Dieci giorni fa, ha invitato un filosofo nel suo laboratorio per dimostrargli (applicandogli elettrodi in testa) che senza il sostrato biologico non avviene nessun fenomeno di coscienza.
Si rifà a un altro scienziato, Beniamino Libet (sono cose di cui abbiamo già parlato[1], ma ve le ripeto), che ha fatto degli esperimenti e voleva dimostrare che il volere è un atto spirituale indipendente dal cervello, perché se un individuo ha una pistola, con l’indice poggiato sul grilletto, chi muove quel dito? Se è il fattore biologico, caso mai dobbiamo mettere in prigione il fattore biologico, ma non questo essere umano. C’è la libera volontà, oppure, se tu hai avuto da fattori ereditari una certa mistura di geni, quella mistura di geni muove il dito e il colpo parte, mentre se tu hai avuto un’altra mistura di geni il dito non si muove?
Questo Libet voleva dimostrare, tramite esperimenti su vari pazienti, che la decisione della volontà precede almeno di un minimo (un decimo, un ventesimo di secondo) qualunque cosa avvenga nel cervello. Se invece ciò che avviene nel cervello accade prima che non la decisione di volontà, allora uno dice: la causa è ciò che avviene nel cervello, e ciò che avviene nella cosiddetta volontà è una conseguenza necessaria, è un effetto necessario, non libero. Libet voleva dimostrare che ogni minimo movimento nel cervello è preceduto, un momentino prima, da un atto di volontà. Invece gli esperimenti gli hanno dimostrato il contrario: quello che avveniva nel cervello era prima.
Intervento: E lui ha rilevato questo?
Archiati: Sì, già nel 1985, nel suo primo scritto famoso. Poi la neurobiologia è diventata sempre più complessa, e oggi è strabiliante quello che si può rilevare applicando catodi in tutte le indagini sul cervello. Quindi è stato sempre più confermato che i fenomeni di coscienza vengono dopo.
Il filosofo tradizionale non conosce un tertium est datur. Uno dei cardini della scienza dello spirito[2], anche de La filosofia della libertà, è che Steiner tira fuori una terza possibilità, una terza soluzione, che né la religione né la scienza tradizionale conoscono.
Steiner dice: sono tre i momenti nel tempo. (Fig. 6)
Il 3, cioè quello che si verifica alla fine, è ciò che avviene nella coscienza; quel che avviene nel cervello è il momento 2, non 1: lo scienziato dà per scontato che se la coscienza viene in un secondo momento, ciò che avviene nel fattore biologico, neurologico, deve per forza essere il primo, l’1. Perché? Perché non conosce altra realtà.
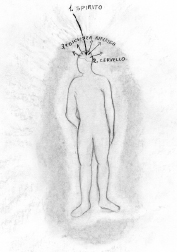
la sequenza temporale dei fenomeni di coscienza
Fig.6
Dire che dietro al fattore biologico non ci può essere nessun’altra realtà, dire che il fattore biologico è originario in assoluto è un dogma. Tu lo dici, ti devo credere? Allora, perlomeno come ipotesi, possiamo dire: e se fosse così che in un primo momento c’è lo spirito puro che pensa (1), in un secondo momento questo spirito che pensa crea realtà nel cervello, crea e ricrea realtà, cambia qualcosa nel cervello (2), e in un terzo momento viene portato a coscienza (3)?
Se così fosse, cosa avverrebbe quando l’essere umano dice: quella è una rosa? Adesso io ve lo riassumo in tre passi, ma riassumiamo in tre passi nel tempo qualcosa che sarebbe ancora molto più complesso (una volta Steiner ha descritto il fenomeno della percezione in quattro pagine, le più complesse che si possano immaginare: cosa avviene nell’io, cosa avviene nel corpo astrale, cosa avviene nel corpo eterico, cosa avviene nel corpo fisico).
Allora, riassumiamo in tre passi fondamentali ciò che avviene quando un essere umano dice: quella è una rosa.
1. il primo passo è che l’io, lo spirito umano, pensa – e questo è un agire puramente nel mondo spirituale;
2. il secondo passo è che pensando «rosa», dicendo «rosa», imprime movimenti rosacei al cervello;
3. il terzo passo è che, avendo lo spirito impresso movimenti specificamente rosacei al cervello, la coscienza ordinaria può dire: quella è una rosa. Cioè, mi rendo conto di aver pensato la rosa. Quando io dico: quella è una rosa, mi porto a coscienza, rifletto il fatto che il mio Io spirituale, il mio spirito, ha pensato una rosa.
Tra il fatto che il mio spirito pensante pensi la rosa, e il fatto che io me ne renda conto e dica: è una rosa, là in mezzo deve essere successo qualcosa nel cervello (qualcosa di fisiologico, non soltanto di metafisico), altrimenti non potrei portare nulla a coscienza.
Quindi abbiamo a che fare con realtà complessissime, e questa bella scienza dello spirito ci dà la possibilità di orientarci. Teniamo presente che la religione tradizionale conosce soltanto fenomeni di coscienza: il credere è un fenomeno di coscienza, non è una realtà spirituale e lo scienziato conosce solo fenomeni nell’elemento della materia – l’ultima volta lo scienziato Wolf Singer è stato veramente rigido quando ha detto: basta con questi colpi bassi di voi filosofi che non capite nulla.
Ciò che a tutti e due manca (al credente e allo scienziato naturale) è la realtà creante dello spirito. Ed è giusto che manchi: il fatto che sia venuta meno nell’evoluzione dell’umanità dà a ogni individuo umano la possibilità di riconquistarsi la realtà dello spirito pensante per libertà propria, in base al gioire proprio, individualissimo. L’essere umano non è costretto a farlo, se non vuole può benissimo farne a meno. Però è ovvio che questa è la grande prospettiva dell’avvenire dello spirito umano e quindi dell’umanità.
Rileggo il paragrafo successivo: IV,6 «Non si deve però trascurare che soltanto con l’aiuto del pensare noi possiamo designarci come soggetto e contrapporci agli oggetti. Perciò il pensare non deve mai venire considerato come un’attività puramente soggettiva. Il pensare è al di là di soggetto e oggetto. Esso forma questi due concetti come forma tutti gli altri. Quando noi, come soggetto pensante, ci formiamo il concetto di un oggetto, non dobbiamo prendere il relativo processo come qualcosa di puramente soggettivo. Quello che compie il processo non è il soggetto, ma il pensare. Non è che il soggetto pensi per il fatto di essere soggetto; bensì esso appare a se stesso come soggetto {cioè come attivo} perché ha la facoltà di pensare. L’attività che l’uomo svolge come essere pensante non è dunque puramente soggettiva: non è né soggettiva né oggettiva, è al di là di questi due concetti. Io non posso mai dire che il mio soggetto individuale pensa: esso vive, piuttosto, grazie al pensare. Il pensare è con ciò un elemento che mi porta oltre me stesso e mi collega con gli oggetti. Però nello stesso tempo mi divide da essi in quanto mi contrappone ad essi come soggetto».
Cos’è allora il pensare? Nella Fig. 6 il pensare, lo spirito che pensa, io l’ho messo sopra.
Il pensare è far luce. Immaginiamo questa stanza buia: non si vede nulla. Facciamo luce: riconosciamo tutte le cose. Il pensare è lo spirito che fa luce. E il soggetto è l’uomo che se ne rende conto, che porta a coscienza questo mistero: sono un soggetto in quanto so di pensare. Ma il pensare non è soggettivo, così come la luce non è soggettiva.
Può sbagliare il pensare? Può errare il pensare? No!
Ho appena finito una Prefazione a un tascabile tedesco che stiamo per sfornare fra due o tre settimane Wahr und Irrtum. Eine Frage der Toleranz? Verità ed errore. Una questione di tolleranza? Spero che verrà tradotto anche in italiano: tre conferenze di Steiner bellissime sulla verità e sull’errore. Io, nella Prefazione, mi sono arrabbiato, ma proprio micidialmente, con la presidenza della Società Antroposofica in Germania che nel suo bollettino del 4 aprile 2008, cita Hegel dall’Introduzione alla Fenomenologia dello spirito, un testo fondamentale del pensiero. Conoscete Hegel, no? Io sono stato felicissimo che un certo Croce e un certo Gentile, che erano i migliori idealisti in Italia, abbiano fatto una riforma scolastica (voi ancora non eravate a questo mondo, perciò ve lo devo dire io) in base alla quale la materia «Storia della filosofia» è diventata una delle più importanti. Per me è stata una felicità, perché nella mia vita io ho fatto quasi solo Storia della filosofia.
Allora, stiamo parlando di Hegel che è il corifeo degli idealisti tedeschi: Hegel, Fichte e Shelling sono i tre grandi. Un testo fondamentale di Hegel è la Fenomenologia dello spirito, un testo poderoso. Nell’Introduzione Hegel si arrabbia con i teologi che si mettono contro di lui dicendo che si presenta come un padreterno che non perde un colpo, sforna un pensiero dopo l’altro con la prosopopea di chi dice: finché tu rimani nel pensiero l’errore è escluso. Se errare umanum est, beh, diventa un superuomo, e allora superi l’errore.
Piccola parentesi: qualcuno di voi avrà sentito parlare di Hans Küng, un teologo che ha un po’ rumoreggiato contro Roma sull’infallibilità del papa: a Tubinga tutti gli studenti hanno fatto un’enorme dimostrazione in suo favore (lui era contro Ratzinger, ma poi l’hanno fatto addirittura papa...) con striscioni enormi dove c’era scritto: errare romanum est! L’hanno fatto vedere dappertutto, non lo dimenticherò mai!! Bello!
Allora, il concetto è che Hegel si arrabbia contro coloro che hanno paura dell’errore e dice: la paura di errare è l’errore stesso. Cioè è un errore aver paura di errare. Finché l’essere umano resta nell’elemento del pensare non c’è errore, quando l’essere umano erra è perché è uscito dal pensare, è perché manca il pensare. E la presidenza della Società Antroposofica cita come se Hegel avesse detto il contrario.
Nella mia prefazione io porto l’esempio della bussola: noi siamo su una nave da dieci, venti giorni in mezzo all’oceano senza nessun orientamento ed ecco arrivano tempesta e burrasca, le stelle non si vedono, l’unica è la bussola. Esiste il fatto che la bussola possa errare? No. O è rotta, non funziona, e quindi la calamita non indica nessuna direzione, oppure indica il Nord.
Un’altra immagine del pensare è la luce: quando nel crepuscolo c’è poca luce e noi possiamo scambiare una sedia per uno sgabellino, o un libro per una scatoletta, è la luce che ci fa sbagliare? No, è la mancanza di luce. Quindi l’errore è possibile soltanto per mancanza di pensiero, ma finché si rimane nel pensare, nel pensiero, l’errore è assolutamente escluso.
Tommaso d’Aquino dice di Aristotele: Aristoteles non errat. Tommaso d’Aquino ha commentato Aristotele dall’inizio alla fine, frase per frase, il che significa che ha avuto la possibilità di appurare che Aristotele si muove sempre nell’elemento del pensiero, nella luce del pensiero, non ne esce mai fuori.
In base a questo travisamento, per me tragico, la presidenza della Società Antroposofica usa la frase di Hegel «la paura di errare è l’errore stesso» capovolta nel suo opposto per dire (vi cito letteralmente): soltanto chi è ingenuo e soltanto chi è ignorante non sa che anche in Steiner per forza ci devono essere tantissime cose erronee.
Il che significa che Steiner è una persona che continuamente esce dall’elemento del pensare, perché quando si esce dall’elemento del pensare l’errore c’è subito. Ma l’errore non è mai dovuto al pensare, non è mai commesso dal pensare, avviene quando il pensare non c’è, o è soltanto embrionale, è soltanto incipiente, rudimentale. Così come la luce crepuscolare, la luce fioca, ci rende soggetti a errare nell’identificare le cose: l’errore, però, non è dovuto alla luce, ma alla mancanza di luce, e la differenza è enorme.
Quindi, nella misura il cui il pensare c’è, va a colpo sicuro, altrimenti non è pensare. Cosa vuol dire questo dogma della falsa tolleranza che dice che ci sono soltanto opinioni, ma non c’è verità oggettiva, non esiste verità assoluta? È il dogma di una umanità che non sa più pensare, e vuol proibire di pensare a chi magari si dà da fare a pensare sempre di più.
Se noi abbiamo una umanità che non è più capace di pensare, la luce del pensare non c’è e quindi saltano fuori solo errori e non ci sono verità, ci sono soltanto opinioni. Però il tutto funziona col presupposto di una umanità che non sa più pensare e non sa più neanche che cos’è il pensare.
Il pensare è luce in assoluto.
Su un tavolo c’è un libro, d’accordo? La luce c’è e si vede che è un libro, se lo prendo in mano ci sono fogli stampati ecc. È un libro. Uno che guarda sul tavolo si può sbagliare? O non sa cos’è un libro, e allora non dice che è una farfalla, chiede: cos’è?, ma se sa cos’è un libro dirà: è un libro.
Adesso io vi chiedo: è possibile l’errore? No, non è possibile se la luce c’è. Se la luce invece è fioca fioca fioca, io dico: sul tavolo c’è una scatoletta. Questa affermazione erronea è dovuta alla luce? No, alla mancanza di luce. Nel momento in cui la luce diventa più chiara dico: no no, è un libro, non è una scatoletta!
Quindi, diciamoci: noi viviamo in una umanità che si è quasi messa d’accordo, per pigrizia spirituale mentale, che è impossibile trovare la verità oggettiva nell’elemento del pensare. La filosofia della libertà è un manifesto contro questo dogma: l’essere umano è creato per illuminare, per far sempre più luce sulle cose, e più c’è luce e più vai a colpo sicuro, l’errore è escluso. Quando la luce è fioca, non sei sicuro di cosa c’è sul tavolo; ugualmente, quando io una cosa non la capisco perché la luce del pensiero è fioca, se sono onesto dico che non sono sicuro, che non lo so.
E quando dico che non lo so, che non sono sicuro, non sto facendo un errore di pensiero, sto dicendo che non lo so, così come, con la luce fioca, dico: non riesco a distinguere, fai un po’ più luce. Anche nel pensiero si fa più luce e si distingue sempre meglio.
L’arte del pensare degli scolastici – che sono quelli che hanno esercitato il pensare come arte della vita: Tommaso d’Aquino ha passato tutta una vita sull’arte del pensare – si basava su una metodica che diceva: distinguo, sub-distinguo, sub-sub-distinguo…, quindi distinzioni sempre più sottili. Finché mi dici: distinguo il tavolo dalla sedia, fai una distinzione molto più grossolana di quando cerchi di distinguere se quel piccolo parallelepipedo sul tavolo è una scatola o un libro.
Cosa vuol dire distinguere a un livello più sottile? Vuol dire che ci vuole più luce! Quindi, più luce di pensiero c’è e più il pensiero cesella, distingue, e di una distinzione fa di nuovo due elementi: sottodistingue, e poi di nuovo e poi di nuovo.
Come è stato creato il mondo? Quattro distinzioni fondamentali, ma così grosse che sarebbe stato tutto noioso: il minerale sia! – hanno detto gli Spiriti creatori pensanti –, il vegetale sia!, l’animale sia!, l’umano sia! Se non avessero sotto-sotto-sottodistinto avremmo un violino a quattro corde con quattro note fisse: invece abbiamo la creazione di un violino a quattro corde e su queste quattro corde si possono fare distinzioni e variazioni all’infinito. E quindi abbiamo un’infinità di minerali, un’infinità di piante, un’infinità di animali e un’infinità di esseri umani: distinguo, sottodistinguo, sottodistinguo, sottodistinguo. Questo io è del tutto diverso da quest’altro io, e il terzo io è tutto diverso ancora...
L’elemento assoluto del cosmo in cui noi viviamo è l’inesauribilità del pensare che crea, distingue, distingue sempre cose nuove, diverse. Come un pittore che mica si mette a ripetere un quadro tale e quale, se no lo mandiamo a pascere i gallinacci, come si diceva una volta.
IV,7 Su ciò riposa la doppia natura dell’uomo: egli pensa, e con questo abbraccia se stesso e il resto del mondo {quindi il pensare è la luce che fa luce su tutto}; ma nello stesso tempo egli deve, per mezzo del pensare, determinarsi come un individuo che sta di fronte alle cose.
Non soltanto il pensare pensa, non soltanto il pensare fa luce, ma io, io, io penso: il pensare cosmico si esprime in me. Chi sono io? Un soggetto in cui si esprime e si porta a coscienza l’oggettivo assoluto della realtà. Il soggetto nel quale l’oggettività del mondo diventa conscia di sé.
La triade, il ternario di Hegel, visto che parlavamo di lui, tutta la filosofia di Hegel è: tesi – antitesi – sintesi.
La grande tesi, la logica, è l’idea in sé (Hegel ha scritto due volumi Die wissenschaft der Logik). La logica è l’idea, o il pensare, in sé – questa è la prima sezione della filosofia di Hegel.
Seconda è la filosofia della natura che chiama l’idea fuori di sé – che bella pensata! Tra l’altro, in italiano «fuori di sé» ha anche l’altra componente psicologica dell’essere fuori di sé. Che significa essere fuori di sé?
Intervento: Dare i numeri.
Archiati: Eh, quindi il mondo della percezione, la natura, è lo spirito umano che dà i numeri, perché pensa erroneamente che là sia la realtà, invece lì l’idea è fuori di sé, si è persa.
Il terzo passo? 1) Logica, 2) natura, 3) filosofia dello spirito. Cos’è lo spirito? L’idea in sé e per sé. Che bello! Io da liceale mi beavo di queste cose! Non soltanto l’idea è in sé, ma diventa conscia di sé, quindi per sé, torna a sé, portata a coscienza attraverso l’alienazione nella natura.
LA GRANDE TRIADE DI HEGEL
tesi la logica l’idea in sé
antitesi la filosofia della natura l’idea fuori di sé
sintesi la filosofia dello spirito l’idea in sé e per sé
L’idea, cioè il pensare divino, il pensare cosmico, si è alienato per l’uomo nella natura: quindi la natura è l’oscuramento della coscienza umana, la natura è dove lo spirito umano perde la luce del pensiero, quindi è buio e non ha la realtà – tanto è vero che la sapienza orientale dice: la cosiddetta natura è illusione. Però questa illusione fa disilludere l’uomo, lo fa ritornare dentro lo spirito, riaccende la luce dello spirito, e adesso l’uomo ha lo spirito in sé e per sé.
La logica è l’idea in sé, la natura è l’idea fuori di sé, lo spirito è l’idea in sé e per sé. Quelli sì che erano pensatori!
Teniamo presente che la scienza dello spirito di Steiner, La filosofia della libertà in particolare, si aggancia direttamente a questo idealismo tedesco e lo porta un passo ancora più avanti. Non sarebbe pensabile La filosofia della libertà senza questi energumeni dello spirito che erano gli idealisti tedeschi.
Per Hegel la natura è il buio nel pensare umano, come provocazione a riaccendere la luce. Perché, detto fra noi: cos’è una pianta? Cos’è un pero? È un’intuizione pensante dello spirito che ama il pero. Come è nato il melo? Lo spirito divino deve averlo pensato: il melo sia! Deve aver pensato queste forme, queste metamorfosi, queste accelerazioni, questi tempi di crescita ecc… quindi la legge immanente di evoluzione del melo è tutta una catena di illuminazioni dello spirito divino.
Chi ha concepito il melo? Ogni concetto deve essere concepito, se no non c’è – e l’italiano dice: «concepito», che vuol dire partorito. Quindi lo spirito concepisce luce con contenuti sempre diversi, sempre più distinti, distinti, distinti… È una gran bella cosa! Fantasia creatrice all’infinito! In Germania c’è stato un agosto pieno di pioggia, però un po’ di insetti e grilli c’erano, e io pensavo: ma guarda nel mondo degli insetti quante migliaia di tipi ci sono! E non si confondono, non è che uno è così e poi diventa come un altro… no no no. Da dove vengono? Dalla luce del pensare che concepisce concetti sempre nuovi. Qualcuno vuole dire qualcosa o ci diciamo buonanotte?
Intervento: E la mutazione genetica?
Archiati: Visto che stiamo parlando di insetti, mi concedi di mettere solo una pulce nell’orecchio, come avvio di pensiero che poi serve a creare altri pensieri, perché la tua domanda si potrebbe svolgere all’infinito, è una domanda di enorme complessità e non ci sono risposte oracolari.
Quello che noi chiamiamo mutazione genetica è un primo partecipare dell’essere umano alla creazione. Ora, siccome l’essere umano in tutto quello che fa aggiunge alla creazione il fattore di libertà – nell’animale, nella pianta, nella pietra non c’è la libertà –, allora questa partecipazione al pensare divino che varia (il pero e il melo sono due variazioni sul concetto «albero da frutto»: il concetto comune è «albero da frutto», però il pensiero lo cesella, lo varia e saltano fuori il melo, il pero, il pesco ecc…) è in fondo il distinguere, sottodistinguere, sotto-sottodistinguere di cui parlavamo prima.
La libertà umana dà la possibilità che questa partecipazione avvenga sia in modo positivo, sia in modo negativo: anzi no, mi rimangio queste due parole perché vanno nel senso della morale, e guai se diventiamo moraleggianti. Diciamo che può favorire l’evoluzione umana oppure ritardarla, perché se non fossero possibili tutte e due le possibilità, non ci sarebbe libertà.
Allora chiediamoci: a quali condizioni la mutazione genetica favorisce l’evoluzione umana e a quali condizioni la fa involvere? Favorisce l’evoluzione umana nella misura in cui il pensare umano sa ciò che fa, perché allora il pensiero va sempre più avanti.
Nella misura in cui l’essere umano entra nella legge genetica specifica, sempre più minuta di varie creature e, in base al ricostruire i pensieri divini nella loro purezza, partecipa a questa creazione divina e aggiunge sottodistinzioni, lo spirito divino gioisce perché dice: ti ho creato non con l’avarizia di tenerti a bada, godo che tu diventi sempre più creatore. Il Creatore non ha paura che gli facciamo concorrenza!
Nella misura in cui sperimentiamo alla cieca, senza luce del pensiero, quindi lasciamo fare alle forze di natura combinandole insieme e rinunciando già in partenza all’evoluzione del pensiero, nella misura in cui operiamo allo scopo di far saltar fuori qualcosa come risultato da poter vendere sul mercato (farmaci ecc.), abbiamo un fenomeno che ributta indietro l’essere umano, e quindi moralmente disumano. Perché?
Perché il pensare umano invece di andare avanti va indietro, e il fattore del potere obnubila sempre di più il pensare. Un pensare che si sente responsabile nei confronti dell’umano specifico che è la creatività del pensiero direbbe: no, non voglio fare nessun passo che non sia illuminato dal pensare. Ma ogni passo che è illuminato dal pensiero umano favorisce l’umano.
Forse qualcuno qui sta pensando: e se l’essere umano, nel suo pensiero, capisce che cosa salta fuori da questa mutazione genetica però la vuole lo stesso, sa che eserciterà un potere, sa che magari renderà più debole il corpo umano, però la fa lo stesso?
Platone ha fatto, col suo Socrate che aveva sempre ragione coi giovincelli, un esercizio di pensiero ponendo una domanda molto importante: può l’essere umano volere il male? Può volere ciò che riconosce nel pensiero come male? No, non può! Colui che compie il cosiddetto male lo può compiere soltanto perché gli appare come un bene[3]. Le due torri gemelle possono essere scaraventate a terra soltanto se coloro che lo fanno riescono a presentare alla loro coscienza questo atto come un bene per l’umanità. Lo spirito è per natura costruttivo.
Come arriva l’essere umano a vedere qualcosa che è oggettivamente male come un bene? Per fioca, fioca, fioca luce di pensiero. E allora erra, considera bene ciò che in effetti è male. Ma, ma, ma… – vedi il Faust di Goethe – c’è una regia di pensiero molto più vasta, che sa trasformare tutto il male umano in bene. Però questo non va detto troppo alla svelta, troppo ad alta voce, altrimenti favoriremmo tutti i potenziali terroristi di questo mondo.
Buona notte a tutti, a domani.
Venerdì 22 agosto 2008, mattina
Auguro una buona giornata a tutti!
Ieri sera ho descritto l’attività del pensare come un accendere luce, luce, luce: e allora si vede, si vede, si vede, si distingue questo e quest’altro, si colgono i rapporti, i nessi e i connessi ecc… Questo era il fulcro del III capitolo: cosa avviene col pensare.
Il IV capitolo è una specie di contraccolpo, di contraltare, che si chiede: cos’è la percezione, allora? Per sapere cos’è la percezione pura bisogna tirar via da quello che noi facciamo tutto ciò che ci mette il pensare. Questo è il senso del IV capitolo: il mondo come percezione.
Ora vi anticipo, come tesi da verificare, che cosa resta quando tiriamo via dal mondo il pensare, proprio per rispondere alla domanda: cos’è la percezione pura senza pensiero? Nulla. Non resta nulla! Questo è il senso delle riflessioni che stiamo facendo nel IV capitolo: renderci conto, portare a coscienza il fatto che il pensare crea la realtà, e la percezione ci fa uscire dalla realtà.
Certo che noi stiamo creando il concetto di percezione pura in chiave di pensiero! – questa è, come dire?, la furbizia, quindi anche di questo ci dobbiamo rendere conto. Noi, grazie al pensare, stiamo creando il concetto di percezione pura: se al concetto di percezione pura tiriamo via il pensare che ha creato questo concetto, cosa resta? Niente. Però anche il concetto di «niente» è creato dal pensare!
In altre parole, se noi vogliamo indicare veramente, pulitamente in chiave di pensiero la percezione pura, cosa dobbiamo fare? Star zitti! Non dire più nulla (il relatore fa una pausa silenziosa ndr). Perché anche nel momento in cui io dico di star zitti, sto parlando – perciò sono stato un momentino zitto, cosa non da poco, nel caso mio, che sono un chiacchierone nato!
Chi è che sta zitto sempre? La pietra sta zitta, perché non sa pensare; la pianta sta zitta, non mi venite a dire che le piante parlano; l’animale sta zitto.
Intervento: Abbaia.
Archiati: Abbaia, ma abbaiare è un concetto creato dal pensare umano ed è un concetto molto complesso – perché c’è abbaiare e abbaiare, eh?, il cane mio abbaia un pochino più intelligentemente che non il cagnolino di quella signora là! Quindi abbaiare è un concetto creato dal pensare. Tu mi volevi dire che il cane abbaiando parla? No, sta zitto.
L’essere umano parla perché parlando esprime i concetti che il pensare crea. Ma io volevo arrivare a un altro tipo di essere che non è né pietra, né pianta, né animale ma che sta sempre zitto: è il bambino piccolo che ancora non parla. Sta sempre zitto, e perché sta sempre zitto? Perché ancora non sa pensare.
L’acquisizione del linguaggio è l’inizio, è l’avvio al pensare. Perché? I tre grandi elementi di umanizzazione dell’uomo sono: la posizione eretta che consente di camminare e che gli animali non hanno. Le scimmie ci hanno provato, però non ci sono riuscite, e nemmeno il canguro, che con la posizione eretta non ha nulla a che fare: fisiologicamente dovremmo fare discussioni molto articolate per dimostrarlo.
Allora, i tre gradini del diventare pienamente uomo sono:
1. posizione eretta per camminare,
2. parlare
3. pensare
Perché dicevo che il linguaggio è il primo avvio al pensare? Perché il linguaggio è il pensare del passato cristallizzato nel linguaggio. Il linguaggio è l’insieme cristallizzato del passato del pensare di tutta la cultura di un popolo. In base al già pensato del mio popolo, cristallizzato nella mia lingua materna, io imparo a parlare, incomincio a capire cosa vuol dire pane, cane, mucca, strada ecc… Quindi il bambino piccolo sta zitto, non parla perché il pensare non c’è ancora.
Allora ho pensato che questa mattina, mentre riflettiamo sempre in chiave di pensiero sul IV capitolo de La filosofia della libertà, vi darò una falsariga di ciò che avviene, attraverso il pensare, nell’elemento della testa, nell’elemento del cuore – quindi tutta una riflessione sull’arte, sul bello e sul brutto – e cosa avviene nell’elemento della volontà.
Se è vero che l’essere umano in base ai pensieri accende i sentimenti, e in base a pensieri e sentimenti intride di forze volitive le sue braccia, i suoi piedi, allora dobbiamo dirci che la percezione pura è il nulla di pensiero, il nulla di sentimento e il nulla di volontà. E questo ci verrà proprio di verificarlo, spero in un modo convincente, e poi ci sarà la discussione che è fatta per mettere le cose in discussione, appunto, in base a quello che direte voi – supponendo che dietro al linguaggio ci sia un barlume di pensiero, cosa da non dare per scontata perché c’è gente che parla e fa parlare il linguaggio, non ci mette nulla di suo.
Rudolf Steiner, una volta, nel 1914, addirittura in una riunione annuale degli antroposofi (o teosofi, allora) – quattro conferenze importantissime che sono tra l’altro stampate in italiano, le potete comprare per 8 euro: Il pensiero nell’uomo e nel mondo[4] –, nella prima conferenza dice: la maggior parte degli uomini d’oggi (voleva essere gentile, perché altrimenti doveva dire: tutti quanti) non ha nessun pensiero, nessun concetto, ha soltanto il linguaggio. Per automatismo lascia dire al linguaggio ciò che il linguaggio dice, ma non ci mette nulla di attività propria, di intuizione propria che riafferra il linguaggio.
Io ho la fortuna di parlare quasi sempre in una lingua che non è la mia materna – tra l’altro la mia lingua materna non è l’italiano, lo devo sempre sottolineare, è il lombardo, il bresciano, anzi, che è tutta un’altra cosa. Andavo a scuola, da piccolo, avevo sei anni, e c’erano dei quadretti sul muro, per esempio c’era l’immagine di un imbuto e sotto c’era scritto IMBUTO. Io tornavo a casa e piangevo perché il «tortaröl» non è un «imbuto»!! Ma la maestra non sa che quello è un tortaröl? Una tragedia, per me! Quindi non mi dite che la mia lingua materna è l’italiano: io ho imparato l’italiano, capito? C’è una bella differenza fra imbuto e tortaröl: imbuto viene da «imbevere», invece in tortaröl, torrrrtarrrröl, sentite che c’è due volte questo girare per andar giù – come in Trichter, imbuto in tedesco.
Stavo dicendo che non essendo il tedesco la mia lingua materna, devo essere presente al linguaggio, quindi gli ascoltatori se la godono perché sanno che devo stare attento continuamente, non ci sono automatismi di linguaggio. E tra l’altro mi succede anche in italiano, perché ormai l’ho talmente dimenticato che quando vengo in Italia devo stare attento a ricordare le parole.
Se non c’è questa specie di aiuto karmico, se volete, di portare il linguaggio individualmente, artisticamente a coscienza, il linguaggio rischia di farci addormentare perché è una cosa così comoda, è già stato tutto pensato – e mica pensato male eh?! Il linguaggio è stato creato non al livello di coscienza dell’Angelo, ma al livello di coscienza dell’Arcangelo, quindi due gradini cosmici più alti del pensare umano: perciò ogni linguaggio ne ha di saggezza!
Se ci fosse più gente che veramente mastica la Divina commedia dall’inizio alla fine, troverebbe anche tantissime parole che sono state messe nel dimenticatoio. «Indiare»[5], per esempio: rendere l’essere umano nel suo pensiero, nella sua arte, nella sua creatività sempre più divino, farlo entrare sempre più nel divino come spirito creatore. Il linguaggio italiano in Dante ha creato «indiare», e io vi chiedo: perché ce la siamo persa questa parola? È bellissima.
Io, prima di scoprire Steiner, ero eremita sul lago di Como, e ho studiato, ve lo confesso perché è vero, la Divina Commedia dall’inizio alla fine, ogni parola, 11 volte. Stavo cominciando per la dodicesima volta quando mi è successo il patatrac di scoprire Steiner, e allora ho avuto molto meno tempo per Dante.
Se è vero che il linguaggio rischia di farci addormentare il pensiero, perché è così bello comodo e ci permette di dire tantissime cose, allora io dico: se decidiamo di farci portare comodamente dal linguaggio, prendiamolo almeno là dove è bello ricco, e non impariamo l’italiano soltanto leggendo i giornali.
Poi, l’altro passo sarebbe di afferrare il linguaggio in modo creativo e individuale e di mettere la propria attenzione pensante dentro ogni parola: allora non soltanto il linguaggio si arricchirebbe sempre di più ma si individualizzerebbe sempre di più, e ognuno ne ha la possibilità. Le lettere dell’alfabeto sono 21 in italiano, le parole sono tantissime, le combinazioni possibili sono all’infinito! Così come le note sono 7, 12 coi mezzi toni, e le variazioni sono all’infinito. Quindi una persona che nel linguaggio ci mette poco pensiero parla in un modo automatico, soltanto con modi di dire, e tende a voler codificare il linguaggio, a correggere un altro che parla diversamente – no, non si dice così! – e a proibire che l’individuo diventi creativo nei confronti del linguaggio.
Due fenomeni polarmente opposti in fatto di creatività individuale nei confronti del linguaggio sono il francese e il tedesco: sono veramente come una polarità. L’italiano oscilla, è aperto sia di qua, sia di là.
francese tedesco
italiano
Il francese tende a codificare il linguaggio in tutto e per tutto, è proprio una caratteristica del francese: questo rende morto il linguaggio, perché manco tu apri la bocca ti correggono – io ho tenuto conferenze a Chartres, a Parigi in francese e mi dicevano: no, no, no, così non si dice! È già tutto codificato, l’individuo non ha nessuna possibilità di agire artisticamente col linguaggio.
Il tedesco per natura – basta leggere Goethe: io ho letto quasi tutto Goethe quando gli antroposofi dicevano peste e corna di me (e lo fanno ancora) e non avevo nessun invito a tenere conferenze – il tedesco per natura, dicevo, anche se adesso ci sono tendenze opposte, ti lascia talmente libertà che tu in ogni frase, anche scrivendo, puoi spostare l’io avanti e indietro, tutta la disposizione delle parole: c’è un massimo di libertà individuale, e questa è una gran bella cosa! Adesso c’è stata una riforma del linguaggio, non so se l’avete seguita un po’ in Italia, e questa tendenza a voler codificare di più non è bella, perché proibisce all’individuo di essere artistico.
L’italiano è aperto in tutte e due le direzioni.
In un linguaggio dove è stato tutto precisato – per cui tu o parli in un modo giusto o parli in un modo sbagliato, perché ci sono soltanto il giusto o lo sbagliato – non c’è più creatività, e questo impoverisce il linguaggio.
Un estremo sarebbe il linguaggio per nulla codificato: pura arbitrarietà, aleatorietà, e questo non deve essere, altrimenti non sarebbe un linguaggio. Un linguaggio deve essere una base comune. Però ci deve essere un giusto equilibrio, un ugual peso, tra la comunicabilità, la comunità, la comunanza – quindi un certo concento, un accordo di popolo che le parole hanno questi significati a cui ci si deve attenere – e la libertà e creatività individuale.
Questa mobilità dell’artistico è una cosa non da poco, e al livello di un popolo si tratta di agire coscientemente nei confronti del linguaggio, sapendo che si tratta di un equilibrio giusto tra la comunanza per cui è importante capirsi – e ci si può capire soltanto se colui che parla non ha la possibilità di essere del tutto arbitrario nel maneggiare il linguaggio –, e la tendenza del linguaggio a diventare morto, mortificante per l’individuo che non ci può mettere nulla di individuale e artistico, nulla di creativo.
In Germania stiamo facendo l’edizione, in tedesco, di 14 conferenze di Steiner tenute ad Hannover del 1907, (speriamo di averle presto anche in italiano[6]), conferenze così attuali visto che spiegano in tutto e per tutto la guerra tra la Georgia e la Russia di oggi: in tedesco si intitola Zwischen Ost und West. Ursachen des neuzeitlichen Weltgerschehens (Tra l’Oriente e l’Occidente), un volume di quattrocento pagine. Nell’Opera Omnia è esaurito da dieci anni e non si fidavano a ripubblicarlo perché avevano paura dell’Inghilterra, paura della Russia. Sono conferenze bellissime, una summa della scienza dello spirito.
In queste conferenze ci sono citazioni che Steiner fa e non si sa dov’è la fonte: ma basta andare su Google con una serie di 5-6 parole e ti salta fuori da dove sono state stralciate. È possibile avere due fonti con la stessa sequenza di parole? Quasi impossibile: è possibile solo se uno ha copiato dall’altro. Quindi rendiamoci conto di quanto posto c’è per la creatività lasciata all’individuo nei confronti del linguaggio.
Allora, in queste conferenze Steiner dice: adesso che la Germania ha invaso il Belgio (si era nella prima guerra mondiale), eccetera, eccetera eccetera, l’Inghilterra dice peste e corna della Germania. Ma andiamo indietro al 1870, quando è stato creato l’impero, Deutsches Reich, ed erano i tempi di Bismark: cosa c’era allora? C’era il militarismo micidiale della Francia, a Occidente, e il militarismo enorme della Russia dall’altra parte. Nel dicembre del 1870, dice Steiner, sul The Times stava scritto: finalmente è sorto tra la Francia e la Russia un potere che argina queste due forze imperialistiche, finalmente è sorto quel potere là in mezzo, auspicato da sempre da tutti i politici inglesi. Nel Times.
Nelle trascrizioni delle conferenze è detto che Steiner cita questo articolo di giornale: dicembre 1870. Oh, è passato un secolo, e sia a Dornach (l’Opera Omnia), sia in Inghilterra quando hanno tradotto il testo di Steiner in inglese, nessuno ha trovato la citazione. Come dicevo, noi in casa editrice ci siamo messi a cercarla. Monika Grimm, l’editrice che è qui, dice: siccome l’Inghilterra un minimo di rimorso di coscienza ce l’ha per aver dovuto mettere in piedi due guerre mondiali per dare una botta alla Germania che stava lì in mezzo, allora come contentino ogni persona privata può avere accesso tramite Google a tutti i giornali inglesi. Ma deve essere una persona privata: noi ci eravamo presentati come casa editrice e ci hanno detto no. Allora ci siamo ripresentati con un altro indirizzo di persona privata. È bastato dare due o tre parole in sequenza – io ho detto a Monika Grimm: dagli all english statesman (tutti i politici inglesi) – e subito compare la pagina 10 del Times dell’8 dicembre 1870! E lì c’è proprio quello che Steiner ha letto. Nell’Opera Omnia volume 173 è tutto raffazzonato, perché non si è trovata la fonte ed è stato cambiato tutto. In italiano non è neanche tradotto[7].
In queste conferenze si capisce subito che cosa c’è dietro l’odierna guerra fra la Georgia e la Russia: dove dice «Inghilterra» basta metterci «Stati Uniti» e torna tutto, i conti sono perfetti.
Prima di entrare nel merito del testo sulla «pura percezione», chiedo: la guerra tra la Russia e la Georgia c’è stata anche sui giornali italiani, no? Allora, supponiamo che tutti noi andiamo là con l’intento di dire che vogliamo avere la pura percezione e non soltanto leggere quello che i giornalisti scrivono sui giornali. Cosa vedremmo?
Prima riflessione: il percepibile, cioè quello che si potrebbe percepire, è infinito.
Seconda riflessione: ognuno di noi ne vedrebbe un frammento.
Terza riflessione: nessuno di noi potrebbe percepire senza al contempo pensare.
Supponiamo, cosa possibilissima, che una certa parte di noi sia maggiormente favorevole alla Russia: intriderebbe subito le percezioni di questo suo convincimento, che in fondo ha più torto la Georgia che non la Russia. E questo cos’è? È un pensiero. Se noi avessimo in braccio un bambino piccolo di sei mesi, quello non direbbe: eh, qui la Georgia ha fatto apposta, pagata dall’America, a farli venire in modo che… sono tutti pensieri!
E chi di noi fosse più orientato a favore della Georgia, vedrebbe le cose in un altro modo, interpreterebbe le percezioni in un altro modo. Perché? Perché porrebbe alla base altri pensieri. Non stiamo a dire, adesso, che cosa è meglio o peggio, non è questo che ci interessa: ci interessa renderci conto di che cosa noi, col pensare, da sempre facciamo. Facciamo tutto col pensare, e ho soltanto aggiunto che l’avvio del pensare, evolutivamente, proprio nel corso della vita, è il linguaggio. Il linguaggio è il pensare passato di un popolo, cristallizzato nel significato delle parole.
Allora, prima di riprendere la lettura, dobbiamo mettere un po’ di ordine qui nei paragrafi: questi risvolti tecnici non ci devono far perdere troppo tempo, però ogni tanto un piccolo accenno ci vuole, perché se non correggete, vi sembrerà sempre di sentire da me i paragrafi sbagliati, visto che io vado secondo quelli tedeschi.
Quindi io avevo letto il IV,8 (da noi segnalato come 7 ndr)[8] «Su ciò riposa la doppia natura dell’uomo: egli pensa e con questo abbraccia se stesso e il resto del mondo; ma nello stesso tempo egli deve, per mezzo del pensare, determinarsi come un individuo che sta di fronte alle cose».
A questo punto, nel testo tradotto dal Vigevani, non c’è un nuovo paragrafo, invece ci deve essere: qui comincia il paragrafo 9, dove il processo di pensiero fa proprio una cesura particolare: chi traduce in italiano si deve attenere ai paragrafi dell’originale tedesco. Se la scienza dello spirito fosse sorta in italiano, e adesso non vogliamo discutere se sarebbe andato bene o no, allora ci dovremmo attenere ai paragrafi italiani, ma visto che fa parte del karma dell’umanità il dover tradurre dal tedesco, è importante attenersi ai paragrafi tedeschi, soprattutto per non creare problemi quando si studia.
Con il paragrafo 9 comincia tutto un altro processo di pensiero (tant’è che sul mio testo fra il paragrafo 8 e il 9 ho messo una bella riga) che dice: cosa ho quando ho la percezione pura? Devo togliere via tutto quello che il pensare ci ha aggiunto.
IV,9 Ora però ci viene da chiederci: «In che modo l’altro elemento, che abbiamo finora indicato solo come oggetto dell’osservazione e che si incontra con il pensare nella coscienza {meglio sarebbe: e che nella coscienza si incontra con il pensare}, penetra nella coscienza stessa?»
L’altro elemento è la percezione, o l’osservazione: come entra nella coscienza? L’albero di mele è là davanti a me: io mi giro e ho la rappresentazione dell’albero di mele. Come è arrivato in me quell’albero? È il grande problema anche della filosofia di Immanuel Kant: come fanno le cose che sono fuori di me a entrare dentro di me? Se una cosa è fuori, è fuori. Se appena appena sbatto la testa contro quell’albero mi faccio un bernoccolo, eppure può addirittura entrare dentro la mia coscienza senza nessun bernoccolo!
IV,10 Dobbiamo, per rispondere a tale domanda, togliere via dal nostro campo di osservazione tutto quello che vi è stato già portato col pensiero. Infatti il contenuto della nostra coscienza è sempre pervaso {intriso} da concetti nei modi più variati {svariati}.
IV,11 Dobbiamo rappresentarci un essere che, sorgendo dal nulla con intelligenza umana pienamente sviluppata, si affacci al mondo {adesso bisogna diventare fantasiosi perché ci viene chiesto di immaginare qualcosa che non c’è: un essere umano di 30 anni sorto dal nulla, dotato di pensiero e che per la prima volta guarda il mondo nel quale non ha ancora messo nulla del suo pensiero. Che cosa vede?}. Quello di cui si accorgerebbe prima di mettere in attività il suo pensare è il puro contenuto dell’osservazione. Il mondo non gli mostrerebbe che un aggregato sconnesso di oggetti di sensazione: colori, suoni, sensazioni di pressione, di calore, gustative, olfattive e poi sentimenti di piacere e dispiacere. Questo aggregato {questa farragine} è il contenuto dell’osservazione pura, priva di pensiero.
Mica è vero, Steiner sta barando! Oh, dice che gli si mostra un aggregato: «aggregato» è un concetto complessissimo creato dal pensare. Un aggregato sconnesso: «sconnesso» è un concetto che sorge solo col pensare. Un «aggregato sconnesso di oggetti di sensazione»: ma allora sta già pensando se gli si presentano «oggetti di sensazione: colori e suoni…» – ma se quello non ha ancora cominciato a pensare, che ne sa di colori, che ne sa di suoni? Sente i suoni ma non pensa ai suoni: se uno non pensa al suono, lo sente?
Vi ho fatto tante volte l’esempio del monaco (prendo l’esempio del monaco, perché normalmente non succede più) che è tutto concentrato a studiare Tommaso d’Aquino, o Aristotele: sono le 10 di mattina, la campana suona 10 rintocchi, e all’improvviso il suo pensiero si rivolge alla campana, conta i rintocchi – dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan –: sono 7. E gli altri 3?
Sinceramente, chi di voi ha davvero fatto questa esperienza alzi la mano. Meno male che c’è ancora qualcuno, meno male, meno male!, perché se non ci fosse più nessuno a fare questa esperienza, non avremmo più la possibilità di capire cos’è la percezione pura. I primi 3 rintocchi l’orecchio li ha sentiti, non è che era chiuso: li ha sentiti, li ha vissuti, ma il monaco in quanto soggetto pensante non li ha sentiti nel pensare. Quindi l’attenzione pensante non era rivolta ai suoni della campana, perché lui stava studiando Aristotele.
Allora, li ha sentiti o non li ha sentiti? Li ha vissuti. Il sentire, nel linguaggio italiano, è una categoria rivolta in tutte e due le direzioni: il sentire lo possiamo riferire al pensare conscio e anche al vivere non conscio.
Sento dolore, dico io; ma il bambino piccolo può sentire dolore senza rendersene conto, senza che ci sia il pensiero. Quindi vedete che se noi prendiamo il sentire italiano e lo sceveriamo in chiave di pensiero, ci rendiamo conto che è una categoria molto complessa perché è aperta in tutte e due le direzioni. È aperta nella direzione di una percezione pura – sentire inconscio, come percezione pura che vale per i primi 3 rintocchi – oppure sentire conscio, che è aperto dalla parte del pensare e riguarda gli altri 7 rintocchi.
In quanto vissuto astrale o eterico sono stati sentiti tutti e 10, ma sentiti consciamente solo 7. Se noi gli chiediamo: ne hai sentiti 7 o 10?, spontaneamente ti risponde che ne ha sentiti 7.
Intervento: Se noi abbiamo 12 sensi, il sentire è una cosa infinita, con diversissime gradazioni e combinazioni, quindi «sentire» è una parola proprio complicatissima.
Archiati: Perciò ho preso questa parola, perché l’area semantica del concetto di «sentire» italiano è vastissima e là dove vogliamo minimamente specificarla viene riferita all’udito; questo perché – l’Arcangelo del linguaggio italiano lo sa – il primo senso che è nato nell’evoluzione saturnia della Terra è stato l’udito. E perciò il linguaggio italiano riferisce questo primo senso dell’udire, chiamandolo «sentire», a tutti i sensi: ho sentito un gusto, ho sentito un profumo… Quindi «sentire» è una categoria complessa perché si riferisce un po’ a tutti i sensi, però in modo particolare all’udito: mi senti o non mi senti? Riguarda l’orecchio. Ma c’è anche: senti caldo o senti freddo? Sento piacere, sento dispiacere. Mi sento male.
Cosa stiamo facendo noi adesso? Stiamo recuperando il linguaggio al livello di presa di coscienza in chiave di pensiero. Il linguaggio diventa molto più bello nella misura in cui uno si rende sempre più cosciente di quanto c’è depositato nel linguaggio.
Allora: IV,11 «Questo aggregato è il contenuto dell’osservazione pura priva di pensiero».
(IV,11) Di fronte ad esso sta il pensare, pronto a svolgere la sua attività non appena trovi un punto di presa. L’esperienza presto insegna che esso se lo trova. Il pensare è in grado di tirar dei fili da un elemento di osservazione ad un altro. Esso congiunge determinati concetti con questi elementi, e così li mette in rapporto. Abbiamo visto più sopra come un improvviso fruscìo venga collegato subito con un’altra osservazione attraverso il fatto che noi riconosciamo {pensiamo} il primo come effetto della seconda.
Il fruscìo è un effetto: un fruscìo di foglie non può causare se stesso, deve essere causato dal vento, o da una pernice che passa tra i fili d’erba. Può un fruscìo causare se stesso? No, deve essere causato. Chi lo dice? Il pensare! Fruscìo è effetto. Un fruscìo da solo non esiste, deve avere una causa, quindi il pensare pensa il fruscìo come effetto e cerca la causa, perché se non trova la causa non si dà spiegazione. Un altro esempio: un cagnolino sente il fruscìo delle fronde dell’albero, cosa fa? Cerca una spiegazione? L’uomo dice che è il vento, il cane non cerca una spiegazione perché non ha il concetto di fruscìo di fronde in quanto effetto di qualcos’altro, che ne è causa.
IV,12 Se noi ci ricorderemo che l’attività del pensare non deve affatto essere concepita come soggettiva, non saremo nemmeno tentati a credere che tali rapporti stabiliti dal pensare abbiano un valore puramente soggettivo.
IV,13 Si tratta ora di cercare, per mezzo della riflessione pensante, quale rapporto vi sia fra il contenuto dell’osservazione datoci per via immediata, di cui abbiamo sopra parlato, e il nostro soggetto cosciente.
Dal paragrafo 14 in poi c’è una precisazione del concetto di percezione dove Steiner dice: io chiamo percezione tutto ciò che non è pensare. Adesso è importantissimo ritornare a chiederci che cos’è il mondo senza il pensare, per capire, per portare a coscienza in un modo sempre più ricco, profondo e vasto, che cosa fa il nostro pensare continuamente, e che questo pensare è più una potenzialità che non qualcosa di già attualizzato dagli esseri umani.
Noi esseri umani, infatti, a questo punto dell’evoluzione, abbiamo soltanto iniziato a pensare, siamo proprio agli inizi: ed è importantissimo renderci conto, in chiave pensante ovviamente, che questo pensare è una facoltà passibile di essere sviluppata ancora all’infinito. Siamo soltanto all’inizio. La gioia, la bellezza, l’esperienza di essere artisti sta proprio nel diventare sempre più creativi, più vasti nel pensare stesso.
Allora, facciamo di nuovo questo esercizio di fondo che si chiede: cos’è il mondo senza il pensare? Pura percezione.
Un papà e una mamma, con in braccio un bambino di sei mesi, stanno facendo la spesa in un supermercato. Il bambino, che ha già gli organi di percezione, cosa vive? Pura percezione: percepisce tutto e di pensiero nulla! Non mi dite che il bambino ha meno possibilità dei genitori di percepire: gli occhi ce li ha, illesi, anzi forse meno obnubilati, meno indottrinati dalla pubblicità, perché gli occhi della mamma vanno subito a quel detersivo lì che era in televisione, invece il bambino li percepisce tutti, non ha preferenze. La pubblicità è l’occhio abbindolato, crea una selezione impoverente, depauperante della percezione perché te la orienta, te la manipola.
Oltre a percepire tutto, la mamma ha il concetto di prezzo, di denaro, di carrello, di negozio, di formaggio, di pane… adesso dice al bambino: me la fai tu la spesa? Qual è il primo problema del bambino? Che non sa cos’è la spesa, sente le parole ma non capisce nulla.
Adesso non mi dite: vengo a Roma dalla Sardegna, dal Piemonte per fare un seminario su La filosofia della libertà, penso di spendere soldi per qualcosa di profondissimo, di metafisico… e questo mi viene a parlare della spesa!! Piano, adesso arriva il contraccolpo.
Ho paragonato lo stato di coscienza del bambino, dove c’è la pura percezione, con quello della mamma che è uno stato di coscienza normale. Adesso vi metto accanto alla mamma una persona che pure fa la spesa, si trova nello stesso supermercato, vede le stesse cose, però si è data un pochino da fare per sviluppare il pensiero – non deve essere per forza un antroposofo, eh?!
Mettiamo questa persona accanto a questa mamma normale – che non vogliamo disdegnare: il normale è il normale – per evidenziare quale evolubilità, quale possibilità enorme di ulteriore futura evoluzione del pensiero sia intrinseca nell’uomo normale di oggi. Paragonata al tipo di coscienza, al livello di pensiero che ha questo pensatore, la mamma è come un bambino.
Intervento: Visto che stava col marito, questo pensatore sarà il marito!
Archiati: Il marito non per vera evoluzione, ma per grazia ricevuta, solo per il fatto che è marito! Guarda che io volevo essere gentile con i maschietti, perché se il paragone lo facevo tra il pensatore e il papà, in fatto di spesa magari le idee e i concetti erano ancora più poverelli!
Allora, così come facciamo fatica a reimmergerci nello stato di coscienza del bambino piccolo, perché noi la percezione pura non ce l’abbiamo più, adesso di nuovo dobbiamo un po’ sforzarci a metterci dentro a quest’altro tipo di coscienza, perché ci è avanti di un bel po’ – così come questo testo ci è un po’ avanti.
Supponiamo che questa mamma e questo papà normali non abbiano nessun concetto, non si rendano conto, non abbiano un minimo di coscienza pensante del fatto che i beni di consumo, le merci che ci sono e soprattutto le merci che non ci sono in questo supermercato sono un riflesso di tutta l’economia mondiale e del sociale nell’umanità. E che nel prezzo di questo formaggio, di questo litro di latte, di questo pezzo di pane io trovo cristallizzato – in un certo risvolto, se guardo al livello capillare dei centesimi, perché il prezzo è fatto anche di centesimi e se tutti i generi alimentari crescono anche soltanto di 5-10 centesimi fa una bella differenza per la spesa – anche il prezzo del petrolio che negli ultimi mesi è salito alle stelle.
Ora, che accanto a questo papà dalla coscienza normale ci possa essere un tipo di coscienza che si è fatta molti più pensieri su tutti questi generi alimentari, e li vede nel suo pensiero come effetto di tutta la situazione sociale mondiale, di tutta la somma di egoismo, di materialismo che c’è ecc…, che differenza fa?
Così come c’è una differenza abissale tra la coscienza del bambino che vive soltanto la percezione nel suo vissuto e la coscienza dell’adulto che ben conosciamo, così c’è una differenza altrettanto abissale tra il gradino ordinario della coscienza adulta e il salto qualitativo nell’evoluzione del pensiero che ha compiuto la seconda persona. E questo salto qualitativo è addirittura all’infinito, perché il pensabile su questi generi alimentari, e quindi tutti i nessi che si possono creare col pensiero, sono infiniti.
In altre parole, io ho la possibilità di trovarmi in un supermercato, nel quotidiano più normale, però con la consapevolezza che essere in evoluzione significa essere nel mezzo di un cammino di pensiero aperto all’infinito, che può diventare sempre più ricco, sempre più vasto, sempre più cosciente, sempre più profondo.
E la gioia della vita in che cosa consiste? La gioia della vita è la coscienza. Il bambino di sei mesi può sentire gioia? No, sente piacere, non gioia. La gioia è un fenomeno di coscienza, non c’è gioia senza sapere di avere gioia, e perciò il linguaggio distingue tra gioia e piacere.
Piacere è un oscillare tra l’animico e il corporeo.
La gioia è un oscillare tra l’animico e lo spirituale.
Quindi la gioia è un’interazione fra l’anima e lo spirito, perché la gioia viene sentita nell’anima che sta vivendo un riflesso di ciò che c’è nello spirito. Quella noi chiamiamo gioia. Quando invece l’anima vive un riflesso di ciò che c’è nel corpo lo chiamiamo piacere, e il fatto che tante persone non distinguono più tra gioia e piacere è proprio una catastrofe enorme.
L’anima in interazione con lo spirito sente gioia, dolore, sofferenza. L’anima in interazione col corpo sente piacere oppure dispiacere. Le tre parole negative – dolore, sofferenza e dispiacere – oggi sono tutte rivolte al corporeo, perché è molto più difficile sentire dolore e sofferenza per la mancanza di spirito nell’umanità. Quindi la gioia nel vivere ciò che è spirituale viene da sé, invece la sofferenza perché lo spirito manca non viene da sé, va portata a coscienza.
Nel linguaggio c’è questo risvolto psicologico, soprattutto in quello italiano che è eminentemente psicologico: se noi togliamo il corpo, all’uomo, sente dolore? No. Sente sofferenza? No. Sente dispiacere? No. Se invece io sento sofferenza per il fatto che l’umanità è diventata così materialistica, così povera, il corpo non c’entra nulla. Però questo tipo di sofferenza va conquistata, non la dà la natura: tutto ciò che è corporeo lo dà la natura, tutto ciò che è spirituale è un fattore di libertà. Sentire gioia o sofferenza nei confronti delle sorti dell’umanità – cosa che non c’entra nulla col corpo – è una conquista di evoluzione dello spirito.
Non c’è difatti un contrario di gioia, perché la gioia esula dal corporeo e non c’è un suo negativo che esuli altrettanto dal corporeo. Nella sfera di ciò che è spirituale la lingua tedesca è veramente molto più ricca – questo non significa che è migliore o peggiore, non facciamo riflessioni discriminanti, però dobbiamo essere sinceri e oggettivi.
Per tutti i fenomeni dello spirito Hegel ti mette lì un testo fondamentale: Fenomenologia dello spirito, quindi è chiaro che già in base all’idealismo il linguaggio tedesco è diventato molto più ricco sui fenomeni dello spirito. Sul fenomeno dell’anima il linguaggio tedesco ha meno parole, meno sfumature dell’italiano. Chi deve tradurre dall’italiano al tedesco fenomeni dell’anima, delle volte arranca perché il tedesco è più povero, non ha un repertorio così sfumato.
Parlavamo di «sentire», prima: eh, gli ho detto una cosa e si è risentito! Spiegate a un tedesco cosa vuol dire che si è «risentito». Quello ti dice: io guardo sul vocabolario, il prefisso «ri» significa ripetere, allora risentito vuol dire che ha sentito un’altra volta. In tedesco non lo potete dire, risentito, non esiste!
Intervento: Comunque vuol dire che ha sentito due volte: al presente e al passato.
Archiati: Certo che nel risentirsi c’è il raddoppiare del sentirsi, però il linguaggio ti dà il risultato psicologico del vissuto e quindi andare a monte per far vedere che difatti si tratta di un sentire che si ripete sarebbe una cosa complessissima. Perciò il concetto di sentire è così composito. Qui però sfocia nel fatto che quel tipo lì si è risentito. In altre parole, non si può tradurre senza tradire. Traduttori traditori.
Intervento: Si può tradurre letteralmente.
Archiati: Tradurre di sana pianta lessicalmente significa non capire che da un linguaggio all’altro c’è sempre un abisso. E come si risolve la faccenda dell’abisso? Bisogna prendere la parola «risentirsi», lasciar perdere il linguaggio italiano e assurgere al concetto: bisogna salire dal livello del linguaggio al livello del pensiero, cosicché l’italiano sparisce e io devo crearmi il concetto di risentimento. Quando me lo sono creato, il pensiero è ugualmente sovrastante il linguaggio tedesco, e allora dal concetto puro di risentimento lascio dire al linguaggio tedesco quello che il linguaggio tedesco sa dire, e quello che non può dire in fatto di risentimento, non glielo faccio dire.
Una traduzione che rispetta veramente il carattere unico di ogni linguaggio, deve lasciare il linguaggio di partenza per assurgere al livello del pensare: perciò anche in questo contesto è importantissima la riflessione sul pensare.
Rispetto al pensare, che cos’è il linguaggio? Pura percezione, perché il pensare prende posizione di fronte a tutti i fenomeni del linguaggio, come di fronte a tutte le altre percezioni. E io vi stavo dicendo: rendiamoci conto di quanto complesso sia creare il concetto puro di risentimento. Però, nella misura in cui io creo il concetto, so poi come posso o non posso esprimerlo in tedesco.
Intervento: Ci sono anche i sinonimi.
Archiati: Dimmi un sinonimo di risentito.
Replica: Arrabbiato, offeso.
Archiati: Se offeso significasse in tutto e per tutto risentito, non ci sarebbe bisogno di creare un’altra parola. I sinonimi sono approssimazioni del pensiero, e il pensiero cesella, distingue sempre meglio, sempre meglio. Da studente facevo esercizi di sinonimi – al gabinetto o quando aspettavo l’autobus: non perdevo tempo – e dicevo: dico una parola e ne devo trovare almeno sette altre. Di solito ci riuscivo.
Intervento: Scusa, ci fai un esempio contrario? Una parola tedesca intraducibile in italiano.
Archiati: Ma non servirebbe, perché bisognerebbe supporre che tutti i presenti sappiano, sentano cosa significa questa parola tedesca: sennò è una pura astrazione. Invece qui, suppongo, tutti sanno esattamente, a livello di linguaggio, che cosa significa «risentito» in italiano.
Comunque, proviamo: Michael, suggerisci una parola tedesca intraducibile in italiano.
Michael: Gemütlich.
Archiati: Allora, gemütlich: Gemüt è l’animo, però l’animo tedesco, non quello italiano, e non è la stessa cosa. Mut è il coraggio, l’ardimento (coraggio, è la virtù del cuore, dal latino cor, cordis). Gemüt è l’animo e gemütlich vuol dire che entri in una stanza e ti trovi talmente gemütlich che… Chi sa cosa vuol dire?
Intervento: Confortevole. Comodo.
Archiati: No, nel confortevole l’animo non c’è.
Intervento: Sentirsi a proprio agio.
Archiati: Ma l’animo non c’è. Quindi bisogna metterci un’altra parola, non è traducibile. Così come «risentirsi» non è traducibile in tedesco, non esiste una parola che lo dica con quella precisione. E prendendo insieme quattro o cinque parole tedesche, avrai un barlume di «risentito». Ma dai, dimmene una sola! No, le devi prendere tutte, e poi nemmeno bastano, perché non è esattamente quello (e se lo fosse, non ci sarebbe differenza fra l’italiano e il tedesco).
Il pensare è l’elemento che è sfumabile all’infinito perché il modo di percepire e il modo si sentire il mondo è sfumato all’infinito, e perciò abbiamo bisogno di tanti linguaggi. I modi di percepire, i modi di sentire e di vivere il mondo sono sfumabili all’infinito.
Mi sento male, mi sento svenire: cosa vuol dire «mi sento»? Son tutti frammenti di percezione, modi di percepire questo pezzo di mondo che è il mio corpo, e una sfumatura di percezione di questo pezzo di mondo dice: mi sento male.
Ho fame. Il tedesco non dice «ho fame», dice: «io sono famoso», ich bin hungrig.
Intervento: Affamato, non famoso.
Archiati: Che differenza c’è tra fame e fama? Sono parenti, no?
Intervento: Sicuro che son parenti?
Archiati: Ma certo: la fame è fame riferita al corpo, la fama è fame riferita all’anima. È una fame di riconoscimento, di plauso da parte degli altri. Certo che in tedesco c’è anche: ich habe Hunger (ho fame), ma è una traduzione da italiano. Il tedesco dice: ich bin hungrig.
Adesso datemi due minuti (questo sproloquio finora è stato un’introduzione) per metterci un paio di pulci nell’orecchio. Cercheremo di vedere come la percezione pura e il pensare sono vissuti nel pensiero, nel sentimento e nella volontà.
COME LA PERCEZIONE PURA e IL PENSARE
sono vissuti
1. nel pensiero
2. nel sentimento
3. nella volontà
1. La percezione pura come pensiero è il nulla, se no non è pura percezione. Che immagine abbiamo usato ieri per indicare la percezione pura in chiave di pensiero? La tenebra. La tenebra è assenza di pensiero. Non capisco. Pura percezione significa: non capire nulla, non pensare nulla, tenebra, sonno, incoscienza (vedi lo schema seguente). Percezione pura è incoscienza. Se l’essere umano adulto, da sveglio, potesse fare l’esperienza della percezione pura, dovrebbe fare l’esperienza di essere dormiente. Se noi alla coscienza ordinaria togliamo via tutto quello che il pensiero ci aggiunge, siamo nel sonno.
Un’altra categoria è l’incoscienza. Il bambino di sei mesi, che ha la percezione pura di tutto ciò che c’è nel supermercato, riguardo al pensiero è in uno stato di assoluta tenebra, perché non c’è nessuna luce di pensiero: il suo pensiero è in uno stato di puro sonno, non c’è la coscienza sveglia, è in uno stato di incoscienza. Qui a sinistra (vedi schema seguente) è percezione pura a tutti i livelli. Qui a destra è quello che ci aggiunge il pensare. Il pensare è luce, il pensare fa vedere le cose: lì c’è la teca dei formaggi, lì il pane, laggiù la cassa per pagare ecc… quindi nella percezione pura la coscienza umana è in assoluta tenebra, è nell’oscurità, non vede e non distingue nulla.
Però ci siamo detti che questo stato, per l’adulto normale, di giorno non esiste, nella coscienza sveglia non c’è e qui stiamo facendo soltanto l’esercizio negativo di togliere tutto ciò che noi aggiungiamo alla percezione con il pensare. Il pensiero è uno svegliarsi.
LA PERCEZIONE PURA IL PENSARE
vissuta al livello del pensare vissuto al livello del pensare
è è
tenebra luce
sonno risveglio
incoscienza coscienza
Cosa avviene quando ci svegliamo?
Intervento: C’è la coscienza.
Archiati: Diventiamo coscienti! Immaginavo che qualcuno dicesse: quando mi sveglio comincio a percepire le cose. Mmmhhh, mmmhh… i primi 3 colpi delle ore 10 li ho sentiti, la percezione c’era, ma ci mancava il pensare, non li ho portati a coscienza. Quindi il pensare è uno svegliarsi, uno svegliarsi nell’elemento del pensiero, però, non uno svegliarsi alla percezione perché quella c’è sempre, anche di notte. Le orecchie sono aperte anche di notte, tanto è vero che se cade giù il quadro dalla parete l’orecchio sente e mi fa svegliare. Quindi, nello schema abbiamo messo a sinistra l’incoscienza, a destra invece il sorgere della coscienza. Quello che sto scrivendo alla lavagna è soltanto una falsariga, uno schemino da usare all’infinito: come le lettere dell’alfabeto o le dieci categorie di Aristotele che consentono, se uno le sa maneggiare, di sviluppare il pensiero all’infinito.
2. Veniamo ora al sentimento: qui abbiamo le persone del cuore, l’arte. Siamo in Italia, e quindi l’ho svolto in modo più articolato. Che sentimento c’è nella percezione pura? Il bambino non lo sa di avere questo sentimento, ma se anche alla mamma che è lì nel supermercato all’improvviso venisse portato via tutto quello che il suo pensiero aggiunge, cosa sentirebbe? Solitudine, disorientamento (vedi schema seguente). Non saprebbe più nulla, non saprebbe più dov’è il formaggio, non saprebbe neanche di essere in un supermercato, non saprebbe come si fa la spesa…, più nulla!
Il pensare è l’esperienza vissuta della comunione in assoluto, perché mi oriento, so cos’è questo, so che ho i soldi per quello, per quello, per quello…, crea rapporti all’infinito, nessi e connessi. Quindi più uno capisce in chiave di pensiero e meno vive solitudine, meno uno capisce, perché il pensiero è povero, e più sente solitudine, disorientamento.
Al livello del sentimento la mancanza di pensiero si sente come una carenza: mi manca qualcosa. Una povertà, una mancanza. E ancora desiderio, nostalgia. La nostalgia di ritorno nella ricchezza del Logos è un vissuto: e se non ci fosse questa nostalgia che dà una propulsione al pensare per diventare sempre più ricco non avremmo motivo di volerci risvegliare. La libertà di pensiero va sentita come nostalgia, come desiderio, mancanza, carenza. E tristezza: vorrei capire di più ma il mondo è diventato così complesso che non ci capisco nulla. Il cuore mi dice: sono triste.
Se andiamo di un passo indietro, di 2160 anni, un ciclo solare, quando il Sole in primavera sorgeva nell’ariete, al tempo dei greci e dei romani, possiamo chiederci: come hanno espresso i greci questo mistero della parte mediana, del sentimento che sente gioia quando c’è la luce del pensiero, lo svegliarsi, la coscienza, e sente tristezza quando il pensare manca?
Allora? Dove sono gli artisti qui in sala?
Il greco diceva: quando manca il pensiero il mondo è c£oj (chàos), caos! L’abbiamo letto, nel testo: una farragine caotica, «un aggregato sconnesso di oggetti di sensazione, colori, suoni, sensazioni di pressione, di calore, gustative, olfattive; e poi sentimenti di piacere e dispiacere. Questo aggregato è il contenuto dell’osservazione pura, priva di pensiero». Caos.
Cosa percepisce il bambino nel supermercato? Caos. Non c’è nessun nesso, è tutto sconnesso, caos. Il pensare coi nessi e connessi che dice quello è causa quello è effetto ecc.. fa del caos (che è brutto), un cosmo. Cosa vuol dire kÒsmoj (kòsmos)? Bello. Quindi la categoria greca dell’elemento artistico del bello è la qualità del Logos, del pensiero, di porre ordine negli elementi del mondo, e allora è bello! Vi ho sempre detto, e le femminucce devono accettarla così, che la moderna cosmesi è l’ultima spremuta di questa arancia greca (di cui è rimasta soltanto la buccia) del kÒsmoj (kòsmos), del mondo ordinato dal pensare.
|
LA Percezione pura |
IL pensare |
|
vissuta al livello del sentire |
vissuto al livello del sentire |
|
è |
è |
|
solitudine |
comunanza |
|
disorientamento |
orientamento |
|
povertà |
ricchezza |
|
mancanza, carenza |
rapporti, relazioni, nessi |
|
nostalgia |
libertà |
|
desiderio |
soddisfazione |
|
tristezza |
gioia |
|
CAOS |
KOSMOS |
Il pensare pone ordine nel senso che ti dice: questa è causa, questo è effetto, questo viene prima, questo viene dopo, questo è più importante, questo è meno importante. L’arte di tutte le arti è il pensare che pone ordine e rende il mondo bello: kÒsmoj (kòsmos) significa bello, perché è ordinato. È l’opposto del c£oj (chàos), caos.
Allora perché i creatori divini presentano il mondo all’uomo dalla parte del caos? Cos’è il caos? È la percezione pura! Caos è il concetto greco di percezione pura. Ma perché, ripeto, la conduzione divina del mondo presenta il mondo all’uomo da questo lato così misero, disordinato, brutto? Per lasciare a lui la gioia di ordinarlo, per arte sua, col pensiero. Se non gli fosse stato dato lo strumento per trasformare il caos in un cosmo, allora l’uomo avrebbe il diritto di ribellarsi di fronte al Creatore: tu non hai il diritto di presentarmi un caos senza darmi la capacità, la facoltà di ordinarlo! Invece ce l’hai!, ce l’hai! Datti una mossa, hai poltrito finora! Fatti non foste per viver come bruti – percezione pura – ma per seguir virtude e conoscenza[9]: e la virtude arriva qui al punto 3 – virtus, in latino, è l’attività della volontà.
3. Cos’è la percezione pura vissuta nella volontà? Nella volontà dell’essere umano la percezione pura è passività. Sono passivo: è una categoria della volontà, non del sentimento e non del pensiero. Il bambino piccolo è passivo, non è ancora capace di diventare attivo nei confronti del mondo. Qual è l’elemento che ci consente di diventare attivi nei confronti del mondo? Il pensare. È così logico! Quindi, come nella percezione pura sono passivo, così nel pensare sono attivo (vedi schema seguente).
Intervento: Reattivo.
Archiati: No, no! Il bambino è reattivo. Attento, attento. La mamma normale, il papà normale è reattivo come tu dici, perché non è ancora assurto al livello di attività di cui io parlavo prima. Nella misura in cui anche il cosiddetto pensato (che non è pensato) mi viene dato dal linguaggio, non sono ancora nell’elemento del pensare, sono nell’elemento del linguaggio: e quello è reattivo, automatico.
Intervento: Anche passivo.
Archiati: Passivo se paragonato a un gradino ulteriore dell’evoluzione del pensiero, ma paragonato al bambino è un’enorme attività, perché la mamma muove lei i suoi piedi verso il formaggio, verso il pane, verso il latte ecc… quindi non è soltanto reattivo, è anche attivo. Decide cosa comprare e cosa non comprare, quindi non è soltanto reattivo.
Intervento: E uno scienziato?
Archiati: C’è scienziato e scienziato: la mamma che sta facendo la spesa può essere professoressa di chimica, eh?, non mettiamo lo scienziato oltre l’umano. Capito? Quindi la percezione pura è una posizione di passività che mi evidenzia che il pensare, perlomeno potenzialmente, può diventare sempre più attivo. Però l’inizio del pensare, rispetto a stadi ulteriori più attivi, è naturalmente anch’esso passivo, reattivo. Tutto è relativo, naturalmente.
Un’altra categoria che potete usare è questa: in chiave di pura passività cosa sono nella volontà? Debole. Deboluccio. E perché il pensare rende la volontà più forte, sempre più forte? Perché nel pensare l’essere umano diventa sempre più attivo, e diventare sempre più attivo significa diventare sempre più forte.
Intervento: Un’altra categoria è l’automatismo.
Archiati: Sì, aggiungiamo anche questa categoria che dite voi. Poi, un’altra categoria che nella scienza moderna, nella neurobiologia, è diventata importantissima, è che se io mi vivo come puro percipiente mi sento in tutto e per tutto un effetto. Il cervello, i geni agiscono in me, e io mi sento come un puro effetto.
Nella misura in cui attivo questo elemento creatore, volitivo, dove c’è tutta la mia volontà, mi vivo e mi sento sempre di più come causa. Io sono la causa, io decido cosa compro, io decido se fare la spesa o no.
Sono io a decidere o sono le strutture del cervello a decidere in me? Se io ometto di pensare decidono in me sempre di più le strutture del cervello: tutta questa serie di destra (vedi i tre schemi in generale) può anche mancare, perché è un fattore di libertà: nessuno è costretto ad accendere la luce del pensiero, nessuno è costretto a svegliarsi sempre di più, nessuno è costretto ad avere sempre più coscienza, nessuno è costretto a porre ordine artistico nel mondo, nessuno è costretto a diventare sempre più attivo. Allora, nella misura in cui non mi sveglio, dormo, sono incosciente ecc… mi vivo sempre di più come in balia del mondo della percezione.
Intervento: Come un coatto.
Archiati: Spiegate a un povero tedesco cosa vuol dire coatto.
Intervento: È uno che non può che fare quello che fa. È obbligato.
Archiati: La parola viene da cum-actus: il coatto viene agito, viene coagito da mille fattori, fuorché dal suo pensare.
Intervento: È mosso dal di fuori.
Archiati: Tutta una farragine di fattori, che sono il mondo della percezione, agisce in lui, lo rende co-atto, perché non è lui ad agire.
Intervento: Quindi potremmo anche scrivere a sinistra «ripetizione» e a destra «novità».
|
LA Percezione pura |
iL pensare |
|
vissuta al livello del volere |
vissuto al livello del volere |
|
è |
è |
|
passività |
attività |
|
debolezza |
forza |
|
automatismo |
creatività |
|
viversi come effetto |
viversi come causa |
|
essere coatto |
essere libero |
|
ripetizione |
novità |
Archiati: Potete aggiungerne all’infinito: io vi ho tracciato una specie di falsariga che si può svolgere all’infinito, come un tema passibile di infinite variazioni.
Riassumo ora l’intero schema (vedi pagina seguente).
Facciamo una pausa.
*******
|
Percezione pura |
pensare |
|
è |
è |
|
nel PENSIERO |
|
|
tenebra |
luce |
|
sonno |
risveglio |
|
incoscienza |
coscienza |
|
nel SENTIMENTO |
|
|
solitudine |
comunanza |
|
disorientamento |
orientamento |
|
povertà |
ricchezza |
|
mancanza, carenza |
rapporti, relazioni, nessi |
|
nostalgia |
libertà |
|
desiderio |
soddisfazione |
|
tristezza |
gioia |
|
CAOS |
KOSMOS |
|
nella VOLONTÀ |
|
|
passività |
attività |
|
debolezza |
forza |
|
automatismo |
creatività |
|
viversi come effetto |
viversi come causa |
|
essere coatto |
essere libero |
|
ripetizione |
novità |
*******
Archiati: Ho la grande gioia di presentarvi Maria Nieddu[10]. Allora, ci sono domande?
Intervento: La Bibbia parla della Torre di Babele e della confusione delle lingue: che cos’è in realtà? È la nascita di un diverso modo di percepire, quindi la nascita del pensiero, oppure le lingue già c’erano ed erano comuni?
Archiati: Bella domanda, importante. Partiamo dal presupposto che lo spirito umano – io naturalmente mi esprimo un po’ come son fatto, cercate di capire: se qualcosa è un po’ troppo filosofica posso precisarla, posso abbassare un po’ il tiro. La mia formazione è stata micidialmente filosofica, per cui mi dovete perdonare, ma d’altra parte è consona alle cose che stiamo studiando – partiamo dal presupposto, dicevo, che lo spirito ai primordi era più puramente spirituale, e poi passo per passo si è incarnato, si è connesso sempre di più alla materia.
Logos significa linguaggio, però è anche la logica. Logos è il pensare cosmico, Logos è il linguaggio cosmico. Logos ha dunque due significati: pensiero (la logica) e parola – lšgein (lèghein) significa anche parlare, dire.
Il linguaggio originario esprimeva il puro spirituale, e nel puro spirituale non c’è la frammentazione del mondo della percezione. Man mano che gli esseri umani hanno vissuto sempre di più le forze dei diversi territori in Africa, in Asia, in Europa, man mano che hanno percepito sempre di più flora e fauna tutte diverse eccetera, eccetera, eccetera, il linguaggio, che ai primordi esprimeva in chiave unitaria il puro spirituale, si è sempre più frammentato, proprio perché il dato di percezione lì era fatto in un modo, qui in un altro, all’infinito.
La Torre di Babele esprime in un’immagine questo cammino di differenziazione del linguaggio in base a una sempre più profonda e diversificata connessione col mondo della percezione. Adesso abbiamo il linguaggio frammentato, non abbiamo più il linguaggio unitario ma i vari linguaggi, perché il clima, le esperienze di percezione che si fanno in Italia sono diverse da tutte le esperienze di percezione che si fanno in Germania. Questo è il motivo fondamentale per cui i due linguaggi sono diversi.
È una bella cosa o una brutta cosa? A seconda di ciò che la libertà ne fa! Se noi facciamo di questa frammentazione del linguaggio (il caos delle lingue per cui gli uomini non si capivano più a vicenda) una sfida a ritornare, a riassurgere, per cammino individuale del pensiero, dal linguaggio al pensiero, rifacciamo l’unità. La rifacciamo al livello del pensiero, però, e possiamo muoverci a tutti e due i livelli.
Quando vogliamo vivere maggiormente l’unità, l’uguaglianza degli esseri umani, assurgiamo al pensiero; quando vogliamo vivere maggiormente la ricchezza variopinta, infinita, ritorniamo giù nel linguaggio e parliamo di più a livello della percezione.
L’artistico del futuro sta proprio nel muoversi liberamente tra un modo di trattare il linguaggio che estrae da esso i pensieri comuni a tutti i linguaggi, e un modo di trattarlo che esprime all’infinito variazioni. Ogni concetto puro è un tema, e in quanto espresso in lingue diverse mostra le variazioni infinite di questo tema.
Il concetto di betulla che cosa contiene in quanto comune a tutti i linguaggi? Contiene esattamente le forze formanti specifiche della specie betulla. Queste forze formanti specifiche della specie betulla che sono insite nel concetto di betulla, sono uguali per tutti i linguaggi, per tutti i soggetti pensanti nel mondo.
Il linguaggio italiano dice «betulla», e così dicendo aggiunge al concetto il modo in cui questo albero viene percepito in Italia; il tedesco lo chiama Birken, e dicendo Birken non ha solo il concetto puro per tutti, ma ha la percezione di come la betulla cresce in Germania – siccome fa più freddo, le foglie sono un pochino più piccole rispetto alle betulle italiane.
Nel passato dell’umanità abbiamo due unilateralità: la prima era quella dello spirito puro, dove c’era comunanza ma non varietà, non differenziazione; la seconda è che siamo piombati dentro al mondo della percezione dove abbiamo un’infinita variazione quasi senza esperienza di comunanza, perché il pensiero è diventato sempre più povero.
Il futuro sta nel libero movimento che si gode tutti e due i mondi, perché la ricchezza, la bellezza della molteplicità non può prescindere dall’unità, e viceversa. Si può avere il concetto di molteplicità senza avere il concetto di unità? No, sennò è la molteplicità di che cosa? E non si può avere il concetto di unità senza sapere che questa unità si può esprimere all’infinito.
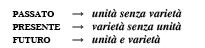
Il futuro, il cammino in avanti del pensare, è una continua interazione tra percezione e pensare: percezione significa che il tema del concetto si esprime in infinite variazioni, però io so che in ogni variazione si tratta dello stesso tema. Ci si muove continuamente tra percezione e pensare: la percezione è la ricchezza all’infinito, la variabilità all’infinito dei pensieri divini, e nel pensare ci rimettiamo d’accordo. La betulla è la stessa cosa in Germania e in Italia? A livello del concetto è la stessissima cosa, a livello della percezione sono due cose diverse.
Cosa è meglio: unità o pluralità? È meglio averle tutte e due. Non si può cogliere l’unità dei linguaggi della Torre di Babele senza risalire alla loro unità, e la loro unità non è al livello del linguaggio, è al livello del pensiero, è al livello del Logos, dei concetti. Il concetto di mela è uguale su tutta la Terra, la percezione cambia.
Intervento: Se uno guarda semplicemente un paesaggio e quindi è assorto in questa contemplazione e non pone l’attenzione su nessuna cosa in particolare, siamo ancora nell’elemento della percezione pura e quindi devo dedurre che non c’è l’elemento del pensare, ancora. Il pensare ci sarà soltanto nel momento in cui pongo attenzione a qualche cosa di specifico, quando cioè la mia osservazione sarà diretta verso un particolare. Però in questo caso non siamo nel caos perché nel paesaggio c’è comunque già un ordine. Non siamo nel caos, cioè non siamo in percezioni sconnesse fra di loro.
Archiati: Fa parte del concetto di percezione pura che essa, di fatto, per l’adulto normale come esperienza non esista, perché nel momento in cui un uomo avesse la percezione pura si addormenterebbe, e addormentandosi non avrebbe nessun dato di coscienza. In quello che tu descrivi c’è un minimo di pensare che accompagna la percezione: però questo minimo di pensare sta proprio a dire che il pensare è un fattore di evoluzione, il pensare non è una realtà assoluta che c’è o non c’è. È passibile di infinite evoluzioni, ogni essere umano lo riceve come realtà incipiente – ciò che Aristotele chiama una facoltà.
Una facoltà pura non esiste. Una facoltà è una potenzialità soltanto nella misura in cui porta in sé il dinamismo intrinseco di attualizzarsi sempre di più. Quindi nel momento in cui uno si rende conto che sta più sognando che non pensando su un paesaggio, capisce che questo elemento del pensiero è passibile di evoluzione all’infinito. E allora si chiede: perché la natura mi dà il pensare a un livello di massimo depotenziamento? – non dico al livello di assenza assoluta, altrimenti non potrei neanche averne il concetto. Me lo dà così incipiente per lasciare a me la possibilità di svilupparlo.
Tu parli di paesaggio: se quella persona avesse la percezione pura non potrebbe parlare di paesaggio. Il concetto di paesaggio è già il concetto complessissimo di un enorme ordine, è già nell’elemento del pensiero. Però è paragonabile alla mamma nel supermercato, che io ho messo a raffronto con un altro gradino di coscienza possibile, dove il tipo di coscienza normale, che rispetto al bambino è del tutto sveglia, appare di nuovo sognante.
Questo ci evidenzia che il pensare è l’elemento che in assoluto è passibile di evoluzione all’infinito. E l’evoluzione, posta nel senso del pensiero, è sempre più luce, sempre più svegliarsi, sempre più coscienza; nel sentimento, nell’elemento artistico, è porre sempre più ordine, sempre più gioia, sempre più bellezza – paesaggio è un concetto di bellezza: esistono paesaggi brutti?
Intervento: Sì.
Archiati: No, no. Pensateci bene. Se è brutto allora non parlo di paesaggio, parlo di uno scenario. Il bello è insito nel concetto di paesaggio, sennò non è un paesaggio. Uno scenario di distruzione non è un paesaggio. Tu dicevi: paesaggio è ciò che mi si squaderna davanti. No, il paesaggio contiene qualcosa di più.
Intervento: Implica allora qualcosa di naturale?
Archiati: Esatto, e la natura non è disordinata. Tra l’altro sarebbe interessante studiare l’etimologia della parola paesaggio, e da dove viene la parola paese.
Intervento: A proposito della percezione pura senza il pensare, nell’esempio che c’è qui nel libro (dove si chiede di immaginare un uomo pienamente sviluppato che si accorge delle cose intorno a sé per la prima volta), Steiner dice che prima sente sensazioni di colori, suoni, poi sente anche dei sentimenti di piacere e dispiacere e poi attiva il pensare e inizia a collegare quello che vede. Quindi pur senza il pensare, che arriva dopo, lui non si addormenta. Allora è cosciente?
Archiati: In altre parole, Steiner sta dicendo: questo essere umano che da adulto per la prima volta percepisce il mondo è una finzione del pensiero, perché non esiste nella realtà. Questo essere umano non è percepibile, non esiste. A che cosa serve questa finzione del pensiero dove il pensare inventa qualcosa che non c’è? Serve a renderci conto di ciò che noi da sempre, inevitabilmente, grazie al pensare, aggiungiamo alla cosiddetta percezione pura.
Cosa sarebbe la percezione pura senza il pensare? Nulla. Cos’è il nulla? Il nulla non è qualcosa è l’assenza di pensiero. Dove manca lo spirito c’è il nulla. Quindi la realtà è o lo spirito pensante oppure nulla. Il concetto del nulla deve restare negativo e non diventare qualcosa, perché se il nulla diventa qualcosa non è più nulla.
Intervento: È lei che dice che è il nulla. Allora io le chiedo: e una stella? Io la chiamo stella ma comunque vedo una cosa luminosa, qualcosa di acceso e mi interessa, anche se io non la penso, anche se non la percepisco, quella c’è…
Archiati: No, no, no, hai già espresso enormi pensieri: «qualcosa» è già un pensiero, «di acceso» è un altro pensiero, due pensieri enormi. Non mi dire che non hai espresso nulla di pensiero.
Replica: Vabbè, ma è perché cerco di farmi capire. Comunque quello che vedrei è una luce, quella la vedo.
Archiati: Ma tu parli già di vedere, e il vedere è una realtà.
Replica: Allora non dico vedere, dico: c’è qualcosa attorno a me, non sono solo.
Archiati: Cosa intendi con «qualcosa»? Non puoi uscire dal pensare, perché se esci dal pensare ti addormenti, e guarda che se ti addormenti hai finito di controbattere. Si può uscire dal pensare soltanto entrando nel nulla del pensare, che noi chiamiamo sonno. Però noi non abbiamo il diritto di parlare del sonno come se fossimo svegli nel sonno.
Replica: Io posso anche addormentarmi ma sempre quella cosa c’è! Non è importante che sia pensata, esiste!
Archiati: Come fai a sapere che esiste? Per te non esiste.
Replica: Come no? Perché tutte le volte che io penso e tocco un essere vicino a me, sento che non sono io, anche se adesso questo è un concetto… ma insomma, sappiamo tutti che esistono le cose.
Archiati: Tu non stai dicendo che quello che tu descrivi è qualcosa per me, se io sono sveglio; stai dicendo che per te è qualcosa. Ma nel momento in cui tu ti addormenti, tutto il mondo è nulla per te.
Replica: Ma non per questo non continua a esistere! Ossia, è irrilevante che ci sia una persona che dice: io penso quella cosa. Quella cosa esiste fuori di me, e io lo so che esiste. Ad esempio una pianta: il fatto stesso che abbia un interscambio, che assorba l’ossigeno ecc., è un fatto oggettivo, perciò anche se la pianta non pensa, ha l’esperienza dell’ossigeno che entra nelle sue… vabbè!
Archiati: Il problema è che tu stai mettendo le cose come se fossero così ovvie, così semplici, invece sono di una complessità enorme: solo quello è il problema. Per fare un minimo di pulizia che evidenzi la complessità del fenomeno, ritorniamo al concetto di ieri sera: ci sono (Fig. 6 a pag. 22) le strutture del cervello, cioè l’elemento corporeo, e c’è lo spirito operante: attraverso l’interazione dello spirito col cervello ci sono i fenomeni di coscienza. Tutto quello che tu adesso hai detto sono fenomeni di coscienza, perché se fossi addormentato non diresti nulla.
Noi dicevamo: se la connessione col cervello mi serve a diventare cosciente della pianta, questo vuol dire che non è che la pianta nasce o sparisce in base alla mia coscienza, ma è che la connessione col cervello, che mi porta a coscienza il mio rapporto con la pianta, mi evidenzia che il mio spirito ha da sempre il concetto di pianta.
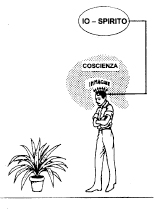
connessione con la pianta fisica nella coscienza ordinaria di veglia
Fig.7
Quando io mi addormento, stacco la connessione del mio spirito col cervello, quindi si annienta la coscienza, ma resto nel mio spirito in rapporto con la realtà della pianta: e la realtà della pianta non è qualcosa di fisicamente percepibile, è un concetto.
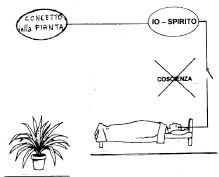
connessione incosciente con la realtà spirituale della pianta durante il sonno
Fig.8
Perché diventi qualcosa di fisicamente percepibile bisogna che il mio spirito sia connesso col cervello: la connessione col cervello attiva i sensi e la percezione sensibile. Quando l’uomo si addormenta ritorna ad essere spirito puro che ha in sé tutti i concetti delle cose, senza però portarli a coscienza, sennò sarebbe sveglio.
Replica: Ho capito, ma allora cosa intende, lei, quando dice che uno «si addormenta»?
Archiati: Vuol dire che tutti i fenomeni di coscienza cadono nel nulla, spariscono, non ha coscienza. Tutti i pensieri che tu adesso hai espresso spariscono, non dici più nulla. Lo sai, no? Cosa vuol dire addormentarsi? Dillo tu con parole tue.
Replica: Che perdo la connessione col mondo.
Archiati: No, no, no, vacci piano. Il fatto che il mio spirito, in quanto spirito puro, abbia tutti i concetti delle cose del mondo, non mi fa essere sicuro che li perda, andiamoci piano! Se io voglio essere pulito ho soltanto il diritto di dire: tutto ciò che c’è nella coscienza ordinaria sparisce. Sparisce cioè quella coscienza condizionata dalla connessione col cervello. Che in me ci sia soltanto la coscienza ordinaria questo non lo so. Andiamoci piano.
Se la coscienza ordinaria mi dà soltanto realtà di riflesso, e allora ci deve essere una realtà che si riflette. Quindi nella coscienza ordinaria io ho soltanto immagini, rappresentazioni: le immagini possono sorgere soltanto in base a una realtà che si riflette.
Perciò, se la cosa viene pensata pulitamente fino in fondo, bisogna dire: ci sono tre livelli. Il primo livello è quello dello spirito puro che col pensare alberga in sé tutti i concetti di tutte le cose. Poi questo spirito umano, in base alla connessione col cervello, crea tutto un mondo di immagini riflesse che noi chiamiamo la coscienza, e questo è il secondo livello. Ogni volta che si addormenta toglie la connessione col cervello, e questo è il terzo livello. Risvegliarsi significa che tutti i contenuti dello spirito si rispecchiano attraverso il cervello nella coscienza.
Intervento: Mi è passato per la mente questo pensiero: tutto quello che tu hai espresso nella prima parte del dibattito, questo rapporto tra il Logos che è collegato da una parte con il pensiero e dall’altro con il linguaggio-percezione, tutto questo processo che noi facciamo, che relazione ha con il processo di realizzare dentro di noi l’esperienza del Cristo? È connesso, attraverso questa modalità, con il lavoro interiore in cui la cristificazione è un’esperienza della nostra vita interiore?
Archiati: Tu hai usato la categoria, la parola, il concetto «Cristo». Mettiamolo fra virgolette, perché forse mille anni fa la gente si capiva quando diceva questa parola, ma adesso in Italia non ci si capisce proprio. Poiché la Chiesa cattolica ha fatto di questo Cristo una certa realtà, un sacco di gente la manda a ramengo. I libri nostri, dove c’è il Cristo, sono quelli che si vendono di meno.
Allora, io prima faccio una riflessione poi ti pongo una domanda.
Le cose che dicevamo sono fondamentalissime, perché esprimono l’essenza dello spirito e dell’anima umana: l’anima è maggiormente il lato di percezione, del sentito (perché la percezione viene sentita), lo spirito è il lato maggiormente di pensiero. Allora, se noi stiamo parlando dei fenomeni fondamentali dello spirito e dell’anima, o quello che tu chiami Cristo ha a che fare in modo fondamentale con questi fenomeni oppure a me non interessa assolutamente. D’accordo? Perché qui stiamo parlando dell’umano, e se il Cristo ha a che fare soltanto con cose marginali proprio non mi interessa, le cose sono troppo importanti.
A questo punto io chiedo a te: cosa intendi per Cristo? Perché io non so cosa tu intendi per Cristo. Ti devo dire che, guardando l’umanità di oggi, «Cristo» è una parola, non è un concetto. È un fatto di linguaggio. Io ho percepito almeno 24 concetti diversi di questo Cristo. Cosa intendi dire per Cristo? Io non ne ho mai sentito parlare: dimmelo tu.
Replica: Quello che intendo deriva da un vivere e sentire nella mia interiorità, dal fare esperienza nella mia interiorità di un qualche cosa che è oltre la percezione del mio io individuale, che espande il sentimento del mio io. È un qualche cosa che mi fa presentire che la coscienza che ho di me stesso non è la coscienza vera, che posso in qualche modo fare un cammino per trovare più compiutamente e più ampiamente una forza, un qualcosa che non sia solamente l’io abitudinario. Questa è la mia esperienza.
Archiati: Supponiamo che io non ci abbia capito nulla. C’è qualcuno che mi aiuta? Tu non la prendi personalmente, vero? Sono cose importanti. Ah, ecco che mi viene in aiuto uno che ha capito!
Intervento: Non è un problema di capire. Noi viviamo in un’epoca in cui l’ego è molto forte, tanto che ha creato anche un nuovo pensare, che è il pensare dialettico.
Archiati: No, già ti devo fermare. Noi eravamo sulla categoria del Cristo.
Replica: Il primo versetto del vangelo di Giovanni spiega molto bene: io volevo arrivare al Logos, partendo dal pensare dialettico che ci accomuna, che parte dalla frammentazione empirica e arriva al pensiero puro.
Archiati: Devi spiegarci cosa intendi per pensare dialettico, usi categorie…
Replica: Certo. Il pensare dialettico è quello che crea i pensieri riflessi. Il pensiero puro che nasce dal mondo intuitivo che passa per il cervello, fa esperienza nella riflessità e ci ritorna come pensiero-oggetto, che non è più il pensiero-soggetto. Io ho conosciuto Steiner attraverso Scaligero...
Archiati: Anch’io!
Replica: …e io amo Scaligero che dice: l’esperienza del pensare puro che non si rifà al pensiero-oggetto ma al pensiero-soggetto, è una fase esperienziale che ci fa sapere che non può essere esaustivo solo il mondo del pensare mentale, che potrebbe soltanto apportarci a un ulteriore errore nel labirinto mentale…
Archiati: Scusa, ti devo fermare, perché stai usando tutta una terminologia sulla quale presupponi che ci intendiamo.
Replica: Io, del Cristo, ho fatto esperienza dentro…
Archiati: No, no, no, noi ti possiamo capire soltanto se è stata fatta prima tutta una serie di chiarificazioni sulla terminologia di Scaligero ecc… altrimenti non ti capiamo! Già è complesso riferirsi tutti quanti al mio tipo di terminologia: tu ne aggiungi una alternativa, caos assoluto!
Replica: Non è alternativa.
Archiati: È alternativa, lasciatelo dire da me, scusa! Tu pretendi che noi crediamo a quello che tu dici, perché per non credere dovresti avere ancora più tempo di quello che ho io a disposizione per chiarificarci la terminologia in chiave scaligeriana e poi cominceremmo a capire quello che tu stai dicendo. Ma soltanto allora. Però non siamo venuti qui per dare a te la possibilità di spiegarci Scaligero e la sua terminologia, per poi capirlo.
Replica: Non volevo dire questo, allora mi sto zitto, non voglio favorire il pensiero dialettico.
Archiati: Pensiero dialettico? Ma tu pensi che ognuno capisca la stessa cosa quando dici «pensiero dialettico»? Tu presupponi che ognuno sappia! Questo modo di presupporre è veramente ingenuo, questo ti sto dicendo! Altrimenti creiamo ancora più confusione nel pensiero.
Allora, chi aveva fatto la domanda sul Cristo? Ah, tu. L’evangelista Giovanni il Cristo lo chiama Logos. Quindi già può essere interessante il fatto che Giovanni, il quale ti dà sull’evento del Cristo la fenomenologia fondamentale, quella più pulita, non usi questa parola greca CristÒj (Christòs)[11]. Allora io propongo di ritornare a questa parola greca, Logos, perché la parola Cristo soprattutto in Italia si è densificata con tutto un portato di sentimento che non ci dà più la possibilità di far pulizia di pensiero nei confronti di questa Entità spirituale.
Cos’è il Logos di cui parla il vangelo di Giovanni? Il Logos – lo dico con parole mie, naturalmente: il mio intento non è quello di porre i miei pensieri nella chiave specifica di questo o quest’altro pensatore, io cerco di esprimere i miei pensieri in un modo accessibile a tutti, mi sforzo, senza però calare di livello. Io ho letto un libro di Scaligero e poi, quando per suo tramite ho scoperto Steiner, non ho più letto neanche una pagina di Scaligero, perché secondo me del pensare puro non ha neanche una minima idea: ne parla ne parla ma non sa neanche che cosa sia, detto fra parentesi –, il Logos è il pensare cosmico, lo spirito cosmico che ha pensato e che pensa tutti i contenuti del mondo e che, in chiave di amore per l’uomo, dentro a ogni uomo diventa potenzialità di pensiero.
Il cosiddetto Cristo è, in quanto essere cosmico, quello spirito pensatore che artisticamente, fantasiosamente, pensa e crea tutti i contenuti del cosmo, e diventa in me potenzialità individuale – ed è lasciata alla mia libertà l’attualizzazione di questa potenzialità – di ricreare tutti questi suoi pensieri, a partire dal mio pensare.
Lui dice, duemila anni fa: Io sono venuto come percezione (nel Gesù di Nazareth si è reso percepibile, questo Logos), però il senso di questa percezione è che è destinata a sparire. Nei discorsi dell’ultima cena, nel vangelo di Giovanni, dice: io devo andare via, morire, sparire, diventare impercepibile, perché se io non vado via non viene lo Spirito Santo[12]. L’esperienza dello Spirito Santo è il Logos, il pensare potenziale che l’individuo realizza nel suo spirito pensante annientando la percezione.
Il concetto è l’annientamento della percezione. Nel concetto di melo io dico: la percezione del melo non è la realtà del melo, la realtà del melo ce l’ho nel pensiero, nel concetto. Allora il Cristo dice: nella misura in cui Io vado via – quindi il Logos non viene più vissuto come una percezione esteriore: Lui, Lui, Lui, ecco il Cristo, ecco, ci sta dicendo questo e quest’altro… – sorge l’esperienza dello Spirito Santo.
Lo Spirito Santo è lo spirito puro: «santo» e «puro» sono la stessa cosa. In altre parole, è il pensare umano che dice: io ho la realtà delle cose soltanto se dico alla percezione: tu sei nulla, perché sei il nulla del pensiero! Questo è il passaggio dalla potenzialità del Logos amante, che è diventato in me potenzialità, all’attualizzazione di questa facoltà pensante, al pensare, che è l’esperienza dello Spirito Santo.
La facoltà di pensiero puro ci viene data per amore del Cristo, ma l’attualizzazione di questa facoltà è lasciata in tutto e per tutto alla libertà individuale. Il cosiddetto Spirito Santo, il pensare reale dell’individuo, avviene solo nella misura in cui l’individuo se lo conquista per libertà sua. Ha perciò la possibilità di omettere questa evoluzione, perché è libero.
La distinzione tra Figlio e Spirito Santo, tra Cristo e Spirito Santo è importantissima:
• la prima venuta del Cristo è il conferire a ogni essere umano per amore, in grazia del suo amore, la potenzialità, la facoltà, la capacità di pensare in un modo creativo e individuale;
• l’esperienza dello Spirito Santo è l’attualizzazione di questa facoltà, di questa potenzialità.
Torniamo così alla distinzione importantissima di Aristotele tra dÚnamij (dýnamis), la potenzialità, che è nel corpo eterico (se volete usare termini della scienza dello spirito), e ™nšrgeia (enèrgheia) en-›rgon (en-èrgon) – che è l’attualizzazione di quella potenzialità.
Potenza e atto.
Una distinzione fondamentalissima della filosofia di Aristotele. Il pensare nel bambino è una facoltà pura, una potenzialità pura: però una potenzialità talmente reale che dal bambino viene fuori un pensatore. Da un pollo non salta mai fuori un pensatore perché questa facoltà non c’è, questa potenzialità non c’è. Questa potenzialità è tutta albergata nel corpo eterico e si esprime sempre di più al livello del corpo fisico.
Buon appetito a tutti, ci vediamo alle quattro.
Venerdì 22 agosto, pomeriggio
Buon pomeriggio a tutti quanti!
Suppongo che il compito mio primigenio, al pomeriggio, sia quello di farvi interrompere la siesta, di svegliarvi! Pensavo perciò di rendervi noto un fenomeno italiano: un certo professor Vito Mancuso (molti di voi forse lo conoscono), un teologo che insegna teologia moderna al San Raffaele di Milano (suppongo sia in connessione con l’Università cattolica), ha scritto un libro L’anima e il suo destino. A una signora che è qui, e che ha letto questo libro, è parso che ci fosse una certa affinità spirituale, forse un pochino lontana, ma insomma, con la Filosofia della libertà di Steiner.
Intervento: Anch’io ho trovato un’eco, ma non con La filosofia della libertà. Premetto che io non ho letto quel libro, ho letto soltanto una recensione sul giornale che riportava alcune affermazioni. Però, in alcune di queste affermazioni, ho sentito un’eco di una certa terminologia della scienza dello spirito – mettendo da parte il fatto che Mancuso parla sempre di anima e mai di spirito –, ha fatto dei distinguo..., c’era un’eco, ecco.
Archiati: Allora, questa signora ha scritto al professor Mancuso una e-mail corta, che vi leggo: «Gentile professore ho letto il suo ultimo libro L’anima e il suo destino. Sono una donna vecchia e circa 7 anni fa ho letto La filosofia della libertà di Steiner. Ho continuato con fatica a cercare di sviluppare la mia mente e, nella mia ignoranza, leggendo ciò che lei ha scritto, mi è sembrato sulla stessa linea, con le dovute differenze, e ne sono stata sorpresa. Lei che ne pensa? So bene che sarà piena la sua posta e con ogni probabilità non potrà rispondermi, ma non scriverle mi sarebbe sembrata una omissione {i grossi peccati, infatti, sono quelli di omissione}. Grazie comunque per quello che mi ha donato. Aurelia F. A.».
Al che il professore ha risposto, due righe, eh?, mica di più: «Gentile signora, la ringrazio dell’attenzione verso il mio lavoro. Più di uno mi ha segnalato delle analogie con Steiner che però io non ho mai letto. Ora però sono incuriosito a farlo. Spero di averne presto il tempo. Un caro saluto. Vito Mancuso».
Io ho pensato: se il tempo non lo trova in questa vita, diamogliene un’altra, via! Comunque è una bella cosa che diverse persone gli abbiano fatto presente che c’è un certo Rudolf Steiner, finora ignorato, però di una grandezza gigantesca per quanto riguarda l’avvenire dell’evoluzione dello spirito umano.
Allora, nell’ultima riflessione, qualcuno aveva posto la domanda sul cosiddetto «Cristo». La parola «Cristo» traduce letteralmente – cosa che abbiamo spiegato nel seminario sul vangelo di Giovanni – l’ebraico Mashiah, Messia, che vuol dire l’Unto: massàh è ungere (massaggiare viene proprio da lì), mashiah è participio e significa «unto». I greci hanno tradotto letteralmente dall’ebraico: CristÒj (Christòs), participio del verbo cr…w (chrìo), ungo, da cui viene per esempio la parola crisma. Quindi «Cristo» è la traduzione letterale greca del concetto ebraico di Unto, secondo il Vecchio Testamento.
Chi è l’Unto? L’Unto è l’Essere del Sole. I re, i profeti e i sacerdoti venivano unti perché l’olio dell’olivo è proprio non soltanto l’immagine, ma è l’operare archetipico del Sole sulla Terra, tant’è vero che anche il colore dell’olio è l’oro del Sole.
I profeti sono gli esperti del futuro dell’evoluzione, il re è l’esperto del sociale nel presente, il sacerdote custodisce come dogma la tradizione, il passato dell’umanità.
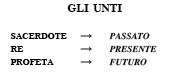
Quindi nel sacerdote, nel re e nel profeta c’è il tutto dell’evoluzione umana, e il tutto dell’evoluzione umana ha senso soltanto se è «unto», cioè se si intride di forze solari.
Perché l’Essere Solare è il tutto del passato, il tutto del futuro e il tutto del presente dell’evoluzione? Perché il tutto dell’evoluzione sta nel fatto di diventare, come spiriti umani, sempre più solari. Se uno si unge, si intride di forze solari, cosa salta fuori? Le forze del sole cosa fanno? Beh, guardatelo, il sole, no? Io sono venuto apposta in Italia perché in Germania piove, piove, piove, e il sole non si vede. Il sole cosa fa? È sorgente di luce, è sorgente di calore.
Il senso dell’evoluzione, il senso del passato, del presente e del futuro è di sprigionare sempre più luce dal pensiero, e sempre più calore dell’amore dal cuore. Ogni sacerdote, ogni re e ogni profeta venivano unti, il che voleva dire: sei un vero sacerdote, un vero re e un vero profeta nella misura in cui ti intridi di forze solari, e diventi tu stesso sempre di più sorgente di luce nella creatività del tuo pensiero, e sorgente di calore nelle tue forze di amore.
Una cosa bellissima. E la si capisce.
Chi è l’Unto archetipico? Il Sole stesso, lo Spirito del Sole, perciò è stato chiamato in ebraico Mashiah, l’Unto del Padre cosmico. Il Padre cosmico l’ha unto, l’ha intriso di forze solari per dire: porta nella Terra e nell’umanità tutti i cammini di pensiero, tutti i cammini di amore. CristÒj (Christòs) è l’Unto, l’Essere del Sole che è unto e unge e chiama ogni essere umano, non soltanto i preti, non soltanto i re o i Berlusconi, per esempio, e non soltanto i profeti dell’Antico Testamento. No, no, no.
Ogni essere umano che si rispetti è tale in quanto diventa lui sacerdote, cioè comprende e realizza il senso di tutto il passato; diventa lui re e regge le sorti dell’umanità nel presente; e diventa profeta nel senso che anticipa, in chiave di ideali, in chiave di progetti, tutto l’avvenire, tutto il divenire, l’evoluzione futura dello spirito umano.
Dante dice: «io mi corono e mitrio»[13]. Mi corono, mi faccio io imperatore, e mitrio, mi faccio io papa: la mitra è del papa, la corona è dell’imperatore. Che mi serve il papa fuori, se non divento papa io? A che mi serve l’imperatore fuori, se non divento imperatore io?
La parola Cristo significa l’Unto, e l’essere umano diventa umano nella misura in cui si intride di forze solari e diventa uno spirito del Sole lui stesso, cioè fa posto dentro di sé allo spirito del Sole e diventa sorgente: perché il Sole non si fa scaldare, il Sole non si fa illuminare, ma origina luce, origina calore.
La prospettiva dell’evoluzione umana non è farsi illuminare da una rivelazione che viene dal di fuori, ma è originare pensieri, originare luce. E l’evoluzione futura dell’amore non è per grazia ricevuta, ma è originare forze di amore dal di dentro, da questo Cristo, o Logos, interiorizzato.
Ogni cosa fatta per senso di dovere deve sparire: o è fatta per amore, perché la amo, o non ha nulla da cercare in me. Quindi vedete che il dovere è propedeutico e ha un senso soltanto se si propone già in partenza di sfociare nell’elemento della libertà.
Cosa significa libertà? Fare le cose per amore.
Perché uno le vede belle, le vede propulsive, le vede nel loro favorire l’evoluzione dell’umano. Del dovere non c’è bisogno, il dovere è una povertà morale, lo vedremo in tutta la seconda parte de La filosofia della libertà, che è il superamento del dovere.
Come la prima parte è il superamento della percezione per generare la realtà del cosmo a partire dal pensare, così la seconda parte è il superamento di ogni dovere, di ogni legge, è l’agire dalla sorgiva della gioia dell’amore che vuol favorire la propria evoluzione e quella di ogni essere umano. A quel punto lì non serve più a nulla il dovere: per un essere umano che vuole il bene non esiste il dovere, perché un bene che si fa per dovere è per tre quarti male. Come fa a essere un bene morale se è fatto per dovere, a denti stretti? In Germania si fanno talmente tante cose a denti stretti che i dentisti fanno un sacco di soldi!
Naturalmente le cose da dire sarebbero tantissime: io vi metto lì degli spunti, poi ognuno, ovviamente, ne fa quello che vuole. Si diceva prima che il senso della caduta, il peccato originale della coscienza sta nel fatto che la coscienza caduta ritiene la percezione, l’albero che ho qui davanti, più sostanziale e reale dell’albero che ho nel pensiero. Una catastrofe dello spirito umano! Questa è la caduta della coscienza!
L’essenza del cosiddetto cristianesimo, ma ve lo garantisco io che è così, è la transustanziazione. Cosa vuol dire transustanziazione?
Vuol dire che nello stato di coscienza caduta, nel peccato originale della coscienza, io vivo il mondo della percezione, il cosiddetto mondo della materia, come più sostanziale che non lo spirito – è una cosa incredibile! –: allora il mio spirito si evolve, transustanzia il mondo per cui l’albero che ho nello spirito, nel concetto, nel pensare, mi diventa realmente più sostanziale che non l’albero nella percezione.
E io dico: l’albero nella percezione non è sostanziale, non è sostanza è soltanto una parvenza! Tra qualche tempo, quell’albero lì non ci sarà più. Invece l’albero, il concetto che ho nello spirito, nel pensare, quello sì che è sostanziale, perché quello crea tutti gli alberi che esistono.
Nella misura in cui, nell’evoluzione, ciò che è elemento di pensiero, ciò che è spirituale, diventa (nell’autoesperienza, però, non soltanto in teoria) più sostanziale della percezione, cioè viene vissuto come più reale e creatore che non la percezione, in quella misura viene letteralmente transustanziato il mondo.
Quindi il destino di tutto il mondo della materia è di venire spiritualizzato, transustanziato dal pensare umano: sparisce! In questo è il suo scopo: dare agli esseri umani una svegliata! La caduta della coscienza umana è il grande dormitorio del pensare – che è il mondo della percezione. Che senso ha questo dormitorio? Di farci risvegliare! Parlo cinese o si capisce? Io le dico un po’ così, ma per me queste sono cose fondamentali, sono il senso della vita! Quando uno afferra queste cose, la vita diventa veramente bella, perché allora inquadra i fattori fondamentali dell’esistenza. Il cristianesimo, finora, non è stato neanche incipientemente capito. Chiedete voi a un sacerdote normale di spiegarvi cos’è la transustanziazione. Vi farà di quei rimbambolimenti che non ci capirete nulla. Ma questo è perché non ci capisce nulla neanche lui.
Eravamo al IV,13 «Si tratta ora di cercare, per mezzo della riflessione pensante, quale rapporto vi sia fra il contenuto dell’osservazione datoci per via immediata, di cui abbiamo sopra parlato, e il nostro soggetto cosciente».
IV,14 Data l’indeterminatezza del linguaggio corrente, mi sembra necessario intendermi col lettore riguardo all’uso di una parola che adopererò spesso in seguito {intende la parola «percezione»}. Chiamerò gli oggetti immediati di sensazioni dei quali ho più sopra parlato, percezioni, in quanto il soggetto cosciente ne prende conoscenza attraverso l’osservazione. Con tale nome non indico dunque il processo dell’osservare ma l’oggetto dell’osservazione stessa. {quindi non intende per percezione il processo dell’osservare l’albero, intende l’albero che viene osservato, intende l’oggetto, il contenuto della percezione}.
IV,15 Non scelgo il vocabolo sensazione perché esso ha in fisiologia un senso determinato che è più ristretto di quello del mio concetto di percezione. Un sentimento in me stesso posso ben designarlo come percezione, ma non come sensazione nel senso fisiologico.
Ora vi farò una riflessione maggiormente in chiave di linguaggio italiano, perché la cosa calza anche in italiano. Cos’è un sentimento? Qualcosa che percepisco in me, nella mia anima, quindi è una percezione. La rabbia cos’è? Qualcosa che percepisco in me, una percezione: una percezione fatta non sul corpo, ma fatta sull’anima. È una percezione tale e quale, però, è qualcosa che percepisco in me: rabbia, gioia, stanchezza, dolore, quello che sia.
Quindi il concetto di percezione è applicabile a tutto ciò che non sia il pensare attuale puro, il pensare in atto. Il già pensato cos’è? Una percezione, perché per parlarne lo devo percepire. Un concetto cos’è? Una percezione fatta nello spirito. Un sentimento cos’è? Una percezione fatta nell’anima. Una sensazione cos’è? Una percezione fatta sul corpo, nel corpo. Sono tutte percezioni.
concetto = è una percezione fatta nello spirito
sentimento = è una percezione fatta nell’ anima
sensazione = è una percezione fatta nel corpo
Tutto questo per chiarire un po’ la terminologia in italiano: ognuno, poi, queste cose se le gestisce a modo suo, e ognuno può andare in tantissime direzioni. Quella che facciamo qui è una specie di impalcatura. Ma possiamo ancora approfondire, precisare, scrivere altre cose su questa prima traccia.
Qual è la percezione archetipica sul corpo? La sensazione.
Qual è la percezione archetipica sull’animico? Il sentimento. Nell’animico il linguaggio italiano non sgarra, è preciso, è ricco! Il sentimento è una percezione sull’animico.
Il concetto è una percezione che faccio quando percepisco il mio spirito, l’operato del mio spirito.
Ora, cosa ci mettiamo tra corpo e anima, tra sensazione e sentimento? La rappresentazione, perché questa può sorgere nell’anima solo in base alla percezione corporea.
Posso avere io una rappresentazione della «bontà»? No, perché non c’è una percezione sensibile corporea. Posso avere la rappresentazione di una persona buona che ho percepito fisicamente. La rappresentazione è un oscillare tra il corporeo e l’animico: vedo qualcosa, ho la percezione corporea sensibile di qualcosa, mi resta nell’anima la rappresentazione. La rappresentazione è il risultato di un’interazione tra corpo e anima – ma ci vuole l’interazione, altrimenti non sorge la rappresentazione.
Cosa mettiamo, poi, tra sentimento e concetto, tra anima e spirito? Nell’anima deve essere qualcosa di rappresentativo, un’immagine, e quali immagini sorgono nell’anima non elicitate dal corpo ma dallo spirito? Quelle della fantasia. Seguendo la terminologia di Rosmini, che è andato un passo più avanti rispetto a Tommaso d’Aquino – se soffrite d’insonnia leggete gli 8 volumi della Teosofia di Rosmini, tutti in italiano, che vi faranno andare in brodo di giuggiole… spero che non vi facciano addormentare subito: Rosmini è un gigante dello spirito, ed è una tragedia che non sia riconosciuto –, possiamo inserire la parola fantasia, prima di usare il termine tecnico della scienza dello spirito che è immaginazione.
concetto = è una percezione fatta nello spirito
fantasia = è una percezione fatta nell’interazione fra anima e spirito
sentimento = è una percezione fatta nell’ anima
rappresentazione = è una percezione fatta nell’interazione fra anima e corpo
sensazione = è una percezione fatta nel corpo
Fantasia come sorgente di immagini. Ma la fantasia, questo è l’importante, non fa sorgere immagini in base a percezione sensibile, ma in base a un’interazione tra anima e spirito.
Esplico, spiego questa interazione: Michelangelo vuol fare un Mosè. Come salta fuori il Mosè? La percezione sensibile del Mosè corporeo non c’è, è già sparita da millenni. Si presuppone, se Michelangelo vuol essere veramente un artista, che abbia lui il concetto di Mosè. Il concetto di Mosè che aveva Michelangelo – quello che io capisco guardando il suo Mosè – è quello del precursore dei tempi a venire che porta giù, dal colloquio con la Divinità, le Leggi del divenire umano e le schianta sulla gente, sulla massa che vuol restare indietro, che vuol tornare in Egitto e danza attorno al vitello d’oro, al vitello Apis degli egiziani.
Il concetto di Mosè è questo cozzare, questa scintilla che sorge e che fa bene, tra il dinamismo del divenire e la quiescenza, il sentirsi andare in brodo di giuggiole godendosi il passato. Gliele scaraventa addosso, le due tavole della Legge. Il concetto di Mosè è quello dello stridore necessario nell’evoluzione tra l’avvenire e il presente, e crea nella fantasia l’immagine di una statua che quando uno la guarda, nella sua immaginativa dice: quello è Mosè! Perché mi rappresenta il cozzare stridente fra l’avvenire che ancora non c’è e il passato, e il presente che non si vuol muovere.
La fantasia, l’immaginazione, è un’interazione tra concetto e sentimento, tra spirito e anima, e crea immagini nella fantasia.
Tutto questo: sensazione, rappresentazione, sentimento, fantasia, immaginazione e concetto sono tutte percezioni, viene tutto percepito. Il Mosè di Michelangelo o c’è o non c’è, e se c’è è una percezione. Quando Michelangelo l’ha concepito, ad un certo punto ha percepito dentro di sé, nella sua anima, il parto del suo spirito. Il concetto ha partorito nella fantasia una rappresentazione, e poi l’ha resa fisicamente percepibile. Quindi il concetto del Mosè attraverso la fantasia arriva all’anima che si innamora di questo fantasma, ne fa sorgere una rappresentazione concreta e la rende a livello di sensazione del corporeo una percezione sensibile. E noi andiamo a Roma e vediamo, contempliamo, abbiamo la percezione sensibile, corporea, del Mosè di Michelangelo.
Intervento: E l’intuizione?
Archiati: Per ora, per non complicare le cose ulteriormente a questo livello de La filosofia della libertà che non presuppone le complicazioni successive della scienza dello spirito, ci conviene prendere «intuizione» come sinonimo di concetto. Cos’è un concetto? Un’intuizione. Il concetto è intuire l’essere, l’essenza di una cosa, e l’essenza di una cosa il pensiero la coglie per intuizione.
Intervento: E un ideale?
Archiati: Si concepisce un ideale? L’ideale è un concetto, «la pace nel mondo» è un concetto, «la fratellanza» è un concetto. Cosa dici? Se non parlate col microfono non vi si sente!
Intervento: Perché non mettere «intuizione» fra concetto e sensazione? Intus-ire.
Archiati: No, no, l’intuizione non ha nulla a che fare con la sensazione. L’intuizione è un atto puramente spirituale, l’intuizione è un puro illuminarsi dello spirito pensante per cui uno dice: capisco! È un puro fenomeno di pensiero, di spirito. Prendete questa falsariga come uno dei modi di procedere, ma è certo che si possono disporre le cose anche in modo diverso. Però penso che questo modo qui aiuti, perché distingue tra fenomeni preminentemente corporei, fenomeni preminentemente animici e fenomeni preminentemente spirituali.
Rileggo: IV,15 «Non scelgo il vocabolo sensazione perché esso ha in fisiologia un senso determinato che è più ristretto di quello del mio concetto di percezione {quindi vedete che nel grafico ho messo che percezione abbraccia sia la sensazione, sia il sentimento, sia il concetto, che son tutte percezioni; invece la sensazione è più ristretta}. Un sentimento in me stesso posso ben designarlo come percezione, ma non come sensazione nel senso fisiologico».
Perciò abbiamo detto che il sentimento è un fenomeno animico, non corporeo. Il sentimento è una percezione che faccio sull’anima, la sensazione è una percezione che faccio sul corpo, il concetto è una percezione che faccio sullo spirito.
(IV,15) Anche del mio sentimento io prendo conoscenza mediante il fatto che esso diventa per me percezione. E il modo in cui per mezzo dell’osservazione acquistiamo conoscenza del nostro pensare, è tale che anche questo pensare, al suo primo rivelarsi alla nostra coscienza, possiamo chiamarlo una percezione.
Percepiamo i concetti che sono stati creati dal pensare. Quindi anche l’operato del pensare diventa oggetto di percezione, i concetti diventano oggetti di percezione tanto quanto i sentimenti, tanto quanto le sensazioni. Vengono percepiti, vengono appurati, vengono trovati già bell’e fatti.
IV,16 L’uomo semplice {ingenuo} considera le sue percezioni nel senso in cui immediatamente gli appaiono, come cose che hanno un’esistenza completamente indipendente da lui {era quello che qualcuno diceva questa mattina: l’albero che vedo è indipendente da me, come si può dire che la percezione non è una realtà? Se gli vado contro sento bene che è una realtà!}. Quando vede un albero, pensa dapprima che esso veramente stia lì nel posto ove è diretto il suo sguardo, con la figura che egli vede, con i colori che hanno le sue varie parti, e così via {voi direte: ma è ovvio no? Stiamo a vedere}. Quando lo stesso uomo vede, al mattino, apparire il sole all’orizzonte come un disco, e segue poi il cammino di questo disco, egli ritiene che tutto ciò esista e si svolga veramente (in sé) {in sé e per sé} nel modo che egli osserva. E rimane attaccato a tale opinione fino a che non incontra altre percezioni che ad essa contraddicono. Il bambino che non ha ancora esperienze di distanze cerca di afferrare con le mani la luna {allora la percezione ci dice la verità o ci inganna?} e corregge ciò che a prima vista aveva ritenuto per reale soltanto quando una seconda percezione si trova in contraddizione con la prima. Ogni ampliamento della cerchia delle mie percezioni mi costringe a correggere la mia immagine del mondo. Ciò si verifica sia nella vita quotidiana sia nella vita spirituale dell’umanità. L’immagine che gli antichi si facevano della relazione della terra con il sole e gli altri corpi celesti, dovette essere sostituita da Copernico con un’altra, perché non andava più d’accordo con altre percezioni che prima erano sconosciute. Quando il dottor Franz operò un cieco nato, questi dichiarò che prima dell’operazione, attraverso le percezioni del suo senso del tatto, si era fatto una tutt’altra immagine della grandezza degli oggetti. Egli dovette correggere le sue percezioni tattili per mezzo delle sue percezioni visive.
IV,17 Da che cosa proviene che noi siamo obbligati, costretti a tali continue rettificazioni delle nostre osservazioni?
La percezione è per natura soggetta ad errore, e il pensiero no. Il pensiero non è mai soggetto ad errore, erriamo quando usciamo dal pensiero e ci affidiamo alla percezione, ma nella misura in cui usciamo dalla percezione e ritorniamo nell’elemento del pensiero, diventiamo infallibili.
IV,18 Una semplice riflessione dà la risposta a questa domanda: quando mi trovo a una estremità di un viale, gli alberi all’altra estremità, lontana da me, mi appaiono {li percepisco} più piccoli e più ravvicinati fra loro che non quelli prossimi a me.
Ma se le cose sono così come le vedo, allora gli alberi più lontani sono davvero più piccoli, visto che li vedo più piccoli. Sono più piccoli o no? Come la mettiamo? Una cosa non semplice, mica da poco.

percorro un viale
Fig.9
Ma come? L’occhio vede le cose sbagliate? Cammino lungo il viale, vado avanti, e gli alberi diventano sempre più grossi… Mi giro, e adesso sono piccoli quelli dietro!

arrivo in fondo e poi mi giro
Fig.10
Allora torno indietro: adesso ridiventano grossi quelli di prima. Che cosa ho nella percezione? Una parvenza!
(IV,18) Non appena cambio posto d’osservazione {di percezione}, la mia immagine percettiva diventa un’altra. Quindi l’aspetto sotto cui essa mi si presenta dipende da una circostanza che non è connessa con l’oggetto, bensì con me che percepisco.
La percezione non mi dà nulla di oggettivo, la percezione dipende in tutto e per tutto da me, dalla mia costituzione fisiologica e dal mio posto di osservazione: la percezione è un fattore in tutto e per tutto soggettivo. Come mi può dare l’oggettività del mondo se dipende in tutto e per tutto dal posto in cui sono, e il posto in cui sono decide quali cose sono grosse (quelle più vicine a me) e quali cose sono piccole (quelle lontane), e dipende in tutto e per tutto dalla mia costituzione fisica, dai miei sensi – se sono miope, se sono cieco, se sono sordo ecc…? La percezione è un’esperienza del tutto soggettiva, non ha nulla a che fare con l’oggettività del mondo.
(IV,18) Per il viale, è del tutto indifferente il posto in cui io mi trovo, ma l’immagine che io ricevo da esso ne dipende invece sostanzialmente. Parimenti per il sole e per il sistema planetario è del tutto indifferente che gli uomini li guardino proprio dalla terra {se noi fossimo su Marte vedremmo tutt’altri movimenti, altre distanze, altre vicinanze}. Ma l’immagine percettiva {del sistema solare} che agli uomini si presenta è determinata da questa loro sede {la Terra}. Questa dipendenza dell’immagine percettiva dal nostro posto di osservazione è la più facile a riconoscere. Già più difficile è l’imparare a conoscere la dipendenza del mondo delle percezioni dalla nostra organizzazione corporea e spirituale {quindi non soltanto il punto di osservazione e la costituzione fisica determinano l’immagine percettiva, ma anche la costituzione animica e spirituale, la nostra costituzione interiore}. La fisica ci insegna che dentro lo spazio in cui udiamo un suono si verificano delle vibrazioni dell’aria, e che anche il corpo, in cui cerchiamo l’origine del suono, presenta un movimento vibratorio delle sue parti. Noi percepiamo tale movimento come suono soltanto se abbiamo un orecchio normalmente organizzato: senza di questo, il mondo ci rimarrebbe eternamente muto.
Il modo in cui noi percepiamo i suoni dipende in tutto e per tutto dalla costituzione fisiologica del nostro apparato uditivo. Se uno è sordo i rumori, i suoni che riecheggiano nel mondo li sente in tutt’altro modo che non uno che sente bene. Uno sente un rumore forte, lo stesso rumore l’altro lo sente debole: io vi chiedo, chi ha ragione? Non c’è un’oggettività del suono senza rapporto con l’orecchio, perché il suono sorge soltanto in rapporto con l’orecchio.
Quindi l’oggettività del rapporto tra il suono e l’orecchio 1 è che il suono è forte, e l’oggettività del rapporto tra il suono e l’orecchio 2 è che il suono è debole: tutti e due sono oggettivi. Un suono oggettivo non c’è, c’è soltanto l’interazione tra vibrazioni nell’aria e un certo apparato uditivo: oggettivamente c’è un tipo di interazione 1 e c’è un tipo di interazione 2. Oggettivamente di carattere diverso. Ma in tutti e due i casi si tratta di un’interazione fra vibrazioni dell’aria e apparato uditivo.
Una terza persona, esposta allo stesso suono, non sente nulla: ugualmente oggettivo. Il nulla di suono è ugualmente un fenomeno oggettivo. Oggettivamente non c’è nulla, non riecheggia nulla in quell’orecchio lì: è sordo. Voi direte: ma è perché l’orecchio è scassato! No, quell’orecchio è guasto solo se lo paragoniamo a 1 e a 2, ma perché lo paragoniamo? Quella persona è fatta così! Tante volte, quando uno non vuol sentire è ben volentieri sordo. E l’orecchio non è scassato.
E i primi 3 suoni di campana, quando uno, dicevamo, è tutto concentrato e non li sente? Non è perché l’orecchio è scassato, ma perché la persona è concentrata in altre cose. I primi 3 suoni sono un fenomeno sonoro per quell’orecchio? No, non li ha percepiti, oggettivamente non ci sono stati. Voi direte: i tre ossicini dell’orecchio hanno vibrato, però! Sì, ma il fatto che vibrino non è il fattore sonoro, il fattore sonoro c’è soltanto quando viene portato a coscienza. Perciò dicevamo che la percezione è un fenomeno molto complesso, che comprende la presa di posizione da parte del pensiero.
Abbiamo già fatto l’esercizio che diceva: gli animali non hanno percezione, perché la percezione è la potenzialità al pensare, è l’esperienza animica che mi manca il concetto, è la propulsione, è il desiderio di creare il concetto. Ora, soltanto un essere che ha la potenzialità al pensiero può fare l’esperienza della percezione, può sentire la mancanza di pensiero. Perciò l’animale non può avere percezione: può soltanto avere sensazione. La percezione è una sensazione portata a coscienza attraverso il pensiero.
(IV,18) La fisiologia ci dice che esistono uomini i quali non percepiscono nulla della splendida festa di colori che ci circonda: la loro immagine percettiva presenta soltanto gradazioni di chiaro e di scuro {grigio}. Ad altri manca solo la percezione di un determinato colore, per esempio del rosso: la loro immagine del mondo manca di questo tono di colore, ed è quindi effettivamente diversa da quella dell’uomo comune.
Se gli manca la percezione del verde, lasciamogli pure guidare la macchina, ma se gli manca quella del rosso, poveri noi!
Intervento: A Roma guidano lo stesso.
Archiati: A Roma le regole non esistono. Io ho preso la patente a Roma, e mi hanno detto che le regole stradali non servono per sapere come uno si deve comportare, ma servono soltanto per sapere chi ha ragione quando succede qualcosa.
C’è una macchina complessa, che noi in casa editrice abbiamo dovuto comprare, con cui si stampano le copertine colorate. È importantissimo sapere come i colori saltano fuori: con quattro colori di base si arriva ad avere tutto. Ti manca il rosso: anche gli altri colori sono sfasati, la qualità della percezione cambia tantissimo, non quadra nulla, una cosa che ripugna, da buttar via. Bisogna rimettere a posto le tinte in modo che funzionino tutti e quattro. Quindi, se una persona vede tutti i colori fuorché il rosso, la visione del mondo in senso percettivo è tutta diversa.
(IV,18) La dipendenza della mia immagine percettiva dal mio luogo d’osservazione, la chiamerei una dipendenza matematica {geometrica, se vogliamo: in questo disegno del viale qui sulla lavagna è di tipo matematico-geometrico, riguarda le distanze Figg. 9 e 10}, quella dalla mia organizzazione una dipendenza qualitativa. Dalla prima sono determinati i rapporti di grandezza e le reciproche distanze delle mie percezioni, dalla seconda la qualità di queste. Che io veda rossa una superficie rossa, è una determinazione qualitativa che dipende dall’organizzazione del mio occhio.
IV,19 Le mie immagini percettive sono dunque a tutta prima soggettive {dipendono in tutto e per tutto dalla posizione del soggetto e dalla sua costituzione fisiologica, quindi ognuno ha una serie di percezioni diverse: una percezione oggettiva non esiste perché dipende dal soggetto, perlomeno dal punto di osservazione, di percezione che il soggetto prende}. Il riconoscimento del carattere soggettivo delle nostre percezioni può facilmente portare a dubitare se a base di esse vi sia veramente qualcosa di oggettivo.
Ma come possono essere oggettivi questi alberi qui (Figg.9 e 10) se dipendono per la loro grandezza e piccolezza dal mio posto di osservazione? Se tutto è così soggettivo, dove esiste una realtà oggettiva?
Il realismo ingenuo, la prima posizione spontanea nella percezione dice che le cose sono così come le percepiamo. Questo realismo, poi, ha un contraccolpo, va all’estremo opposto quando si rende conto che il modo in cui percepiamo non è per niente oggettivo ma è del tutto soggettivo. Va all’estremo opposto e dice: non c’è più nulla di oggettivo.
Non c’è nulla di oggettivo nella percezione. E se ci fosse qualcos’altro, oltre alla percezione, in cui è possibile cogliere l’oggettività del mondo? Un qualcos’altro che non c’entra con la percezione, perché in campo di percezione ci tocca dire che non c’è nulla di oggettivo. Se restiamo nella percezione non c’è nulla di oggettivo, perché dipende in tutto e per tutto dal punto di osservazione e dalla fisiologia del soggetto.
(IV,19) Quando sappiamo che una percezione, per esempio quella del colore rosso o di una certa nota musicale, non è possibile senza una determinata conformazione del nostro organismo, si può facilmente essere portati a credere che essa, prescindendo dal nostro organismo soggettivo, non abbia alcuna consistenza, e che senza l’atto del percepire, del quale è oggetto, essa non abbia alcun genere di esistenza.
Se quegli alberi là lontani sono così piccoli, e la loro realtà di alberi piccoli dipende dal mio percepirli, e perciò quando io mi volto non ci sono più, vuol dire che non sono una realtà oggettiva, sono una percezione: la loro natura di alberi piccoli o grandi è decisa dalla mia percezione. Scompaiono dalla percezione, scompaiono come percezione, e non ci sono più. Chi mi dice che sono qualcos’altro oltre la percezione? Io ho soltanto la percezione. Quando io mi volto, per quanto mi riguarda, sono spariti, non ci sono più.
(IV,19) Questa idea ha trovato un classico sostenitore in George Berkeley, il quale riteneva che l’uomo, dal momento in cui fosse diventato cosciente dell’importanza del soggetto per la percezione, non potesse più credere ad un mondo esistente senza lo spirito cosciente. Egli dice: «Alcune verità sono così vicine a noi e così evidenti che basta aprire gli occhi per vederle {ci voleva l’inglese, eh?, per farci capire queste cose così evidenti: forse che tutti i pensatori tedeschi non c’erano arrivati?}. Una di queste è, a mio parere {è Berkeley che parla}, l’importante sentenza {la massima} che tutto il coro dei cieli e tutto ciò che appartiene alla terra, in una parola tutti i corpi che compongono il possente edificio del mondo, non hanno nessuna sussistenza al di fuori dello spirito {che li percepisce}; che il loro essere consiste nel loro venire percepiti o venir conosciuti; e che di conseguenza, fino a che non vengano realmente percepiti da me o non esistono nella mia coscienza né in quella di un altro spirito creato, essi, o non esistono affatto, o esistono solo nella coscienza di uno spirito eterno».
Quindi secondo Berkeley le cose del mondo possono esistere soltanto come contenuti della coscienza. Io sto qui all’inizio del viale: cosa sono quegli alberi? Contenuti della mia coscienza. Sono qualcosa fuori di me? È un dogma infantile e ingenuo dire che esiste qualcosa fuori di me, perché ciò che è fuori di me per me non è una realtà, non sono competente a parlarne proprio perché è fuori di me.
Quindi Berkeley dice che le cosiddette cose o sono contenuti della coscienza, umana o divina non importa, o non sono nulla: per essere qualcosa le cose devono essere contenuti di una coscienza.
(IV,19) Secondo questo modo di vedere, della percezione non rimane nulla se si fa astrazione dal «venir percepita» {l’esistenza di quegli alberi consiste nel loro venir percepiti, e se non venissero percepiti da nessuno non ci sarebbero, non esisterebbero}. Non ci sono colori se non si vedono; non ci sono suoni quando non si odono.
Un suono non udito da nessuno è un suono? No. Un suono diventa un suono nel venir udito, se no non è un suono, dice Berkeley. Vedete che il realismo ingenuo comincia a far fatica, e dice: mannaggia, qui mi stanno portando via tutto il mondo! Io pensavo che la realtà fosse così come la vedo, e invece no, adesso se io mi volto non c’è nulla. Se nessuno sente non c’è nessun suono! Se nessuno vede non c’è nessun colore! Se nessuno annusa non c’è nessun odore! Cos’è il mondo della percezione? Un inganno! Per far venir la voglia di disingannarsi! E il disinganno è il pensare.
Torniamo ai 3 suoni di campana non uditi: se i primi 3 non sono stati uditi, non c’è l’inganno proprio perché non sono stati uditi! Gli altri 7 sono un inganno, perché sono stati percepiti: in quanto percezione sono un inganno e servono a farmi disingannare, e allora dico: i primi 3 sono più reali degli altri 7 perché non li ho percepiti sensibilmente! Però, rispetto ai primi 3, non ho la gioia di potermi disingannare, perché non c’è stato l’inganno e allora preferisco i 7 che sono venuti dopo, perché quelli mi danno la gioia di disingannarmi e dire: no, no, no, questi fanno come se fossero reali, come suoni, invece è il concetto di suono che è reale.
I morti cosa sentono dei 10 rintocchi di campana? Per i primi 3 sentono la gioia dello spirito incarnato che si concentra, e per gli altri 7 sentono l’esperienza animica del suono come chiamata a disingannarsi. Il suono fisico ovviamente non lo sentono, perché non hanno le orecchie fisiche: sentono l’esperienza animica che l’uomo fa, quella la vivono.
Anche l’Angelo dice: quell’uomo era così concentrato che i primi 3 rintocchi l’anima non li ha sentiti, non li ha vissuti e gli altri 7, invece, li ha vissuti. Vedo, sento il suo vissuto, e l’inganno (cioè che il dato di percezione sensibile sia una realtà) ha il suo senso nell’essere una provocazione a ritransustanziare il mondo, trasformandolo dalla sua parvenza di materia nella sua realtà di spirito.
Cos’è un rintocco di campana? Un invito a svegliarsi, a uscire dalla percezione per ritornare nel pensare, perché come percezione pura è un piccolo addormentamento del pensare. Allora dico: ah, la campana suona e sono di nuovo nel pensare, nel pensiero.
IV,19 «Non ci sono colori se non si vedono, non ci sono suoni quando non si odono».
(IV,19) E altrettanto come colori e suoni, non esistono estensione, forma, movimento al di fuori dell’atto percettivo. In nessun caso noi vediamo soltanto estensione o soltanto forma; queste sono sempre congiunte col colore o con altre proprietà indiscutibilmente indipendenti dalla nostra soggettività. Se queste ultime scompaiono insieme con la nostra percezione, deve avvenire lo stesso delle prime, che sono ad essa legate.
Quindi anche tutte le dimensioni, anche l’elemento matematico-geometrico che dipende dalla posizione scompare se scompare la percezione, perché fa parte della percezione, che è soggettiva. Tutti questi alberi del viale ci sono nel soggetto percipiente della Fig.9, perché se abbiamo un altro soggetto percipiente o lo stesso soggetto si sposta (Fig.10 a pag. 86) bisogna invertire la prospettiva, c’è tutta un’altra realtà di percezione.
La realtà di percezione diventa realtà nel soggetto percipiente: se quello va via, cosa c’è? Nulla! Voi mi direte: sì, però se io volo in elicottero lo vedo un viale di pini! Sì, però non li vedi qui belli grandi e là belli piccoli, li vedi tutti uguali: questa realtà di alberi all’inizio grandi e poi sempre più piccoli è sparita, non c’è più. Quale realtà oggettiva è rimasta? Nessuna. Perché se io passo in elicottero e li vedo tutti uguali (anzi, vedo tutte chiome senza tronchi), è di nuovo una percezione, e quando l’elicottero va via non c’è più.

un viale visto dall’elicottero
Fig.11
Infine, quando uno muore, non ha più il corpo, non c’è più nulla del mondo della percezione.
IV,20 All’obiezione che, se anche figura, colore, suono, ecc. non hanno altra esistenza che quella entro l’atto percettivo, vi debbano pur essere cose che esistono senza la coscienza, ed a cui le immagini percettive coscienti sono simili, la predetta corrente di pensiero risponde: «Un colore può essere simile soltanto a un colore, e una figura ad una figura. Le nostre percezioni possono essere simili solo a nostre percezioni, e a nessun’altra cosa.
Quindi, una percezione può essere simile soltanto a una percezione, non a un albero reale. L’obiezione a Berkeley dice: l’immagine percepibile deve essere simile a qualche cosa di reale. Ma l’immagine può essere simile soltanto a un’altra immagine, non a qualcosa che non è immagine. Cercare la realtà degli alberi significa che s’intende questa realtà come opposto a immagine. Ora, come può una realtà che non è immagine essere simile a un’immagine e creare di sé qualcosa che non ha nulla a che fare con la realtà?
Quindi un’immagine percettiva può essere simile soltanto a qualcosa di immaginario, non a qualcosa di reale.
(IV,20) Anche ciò che chiamiamo un oggetto non è altro che un gruppo di percezioni che son legate fra loro in un determinato modo. Se da una tavola tolgo via forma, colore, estensione ecc., cioè tutto quello che è solo mia percezione, non ne resta nulla». Un tal modo di ragionare proseguito conseguentemente, porta a sostenere quanto segue: «Gli oggetti delle mie percezioni esistono solamente grazie a me, cioè in quanto e per quanto io le percepisco: scompaiono col cessare della percezione e non hanno senso senza di essa {tutto il mondo percepito è una fantasmagoria di immagini senza corrispondenza di realtà}. Al di fuori delle mie percezioni, io non so nulla e non posso sapere nulla di nessun oggetto».
Allora uno dice: ma la gamba del tavolo deve essere una realtà anche senza la mia percezione! Quale realtà? Per quanto mi riguarda io ne ho soltanto la percezione. Se do un calcio alla gamba del tavolo e sento la resistenza, questa è una percezione tattile: che c’entra questo con la gamba del tavolo? C’entra con la mia gamba: io sento la resistenza. Sono tutte percezioni fatte sul soggetto che percepisce, e basta! Percezioni fatte sull’oggetto sono una cosa assurda, perché l’oggetto non può percepire, e il percepito è il modo in cui io vivo ciò che percepisco, è l’eco dentro di me – uditivo, visivo ecc. – di ciò che percepisco.
Quindi il mondo in quanto percezione è qualcosa che osservo in tutto e per tutto sul soggetto che percepisce. Allora non c’è nulla di oggettivo? Di oggettivo al livello della percezione non c’è nulla, perché tutte le percezioni che ho le faccio sul mio soggetto.
Intervento: È relativo.
Archiati: Soggettivo. Relativo al soggetto: soggettivo. Il concetto di «soggettivo» è sufficiente, non portare in campo quello di «relativo». Quindi tutte le percezioni di cui io posso parlare hanno a che fare unicamente con me stesso, sono tutte cose che osservo su di me. Quando io do un calcio alla gamba del tavolo, cosa percepisco? Percepisco qualcosa che avviene in me. Io dico: ma la gamba del tavolo è fuori di me! Questo è un inganno, perché io della gamba del tavolo ho soltanto ciò che percepisco in me. La gamba del tavolo fuori di me non la posso percepire, quindi non ne ho nulla.
Intervento: La vedi!
Archiati: Sì, ma la percezione visiva, l’immagine visiva, è anche quella una percezione che faccio in me.
Intervento: Il cieco non la vede.
Archiati: Giusto.
Intervento: Però il cieco lo urta, il tavolo.
Archiati: Non è la gamba del tavolo che urta me, sono io che percepisco in me un vibrare della mia gamba. Dalle il microfono, visto che parla a nome di tutti i realisti ingenui. Continua, non mollare, questi sono esercizi da rifare sempre di nuovo.
Replica: La forza di gravità io credo che sia oggettiva, nel senso che non dipende dalla mia percezione. Se io sono sonnambula e cado nel vuoto mi rompo una gamba comunque, sia se ho coscienza, sia se non ho coscienza di quello che percepisco.
Archiati: No, no, un momento! La gamba rotta è una percezione che tu fai su di te.
Replica: Però la fanno tutti se cadono nel vuoto.
Archiati: No, no, no: noi siamo lì a guardare il sonnambulo che cade giù, ma la percezione della gamba rotta ce l’ha soltanto lui. Se la gamba si è spaccata in due, che percezione è per noi? Una percezione visiva, ma non di dolore.
Replica: Quello che voglio dire è che non è una percezione il fatto che abbiamo la terra sotto i piedi. Per me è un dato di fatto, perché se non ci fosse cadrei.
Archiati: No, è un dato di fatto che tu percepisci la terra sotto i piedi.
Replica: Però tutti la facciamo questa percezione, per tutti è oggettivo.
Archiati: No, abbiamo tutti la stessa percezione fatta sul soggetto, una percezione analoga. Sta’ attenta: la percezione della terra sotto i piedi, è una percezione dura o molle?
Replica: Dura.
Archiati: E uno che passa sulla sabbia?
Replica: È un altro tipo di terreno, però per tutti è molle la sabbia. Nel senso che prima si faceva la differenza fra il daltonico, il ben vedente, il cieco, chi sta in una prospettiva piuttosto che in un’altra, ecc., però ci sono delle cose che universalmente sono tali.
Archiati: No, perché tu devi essere sulla sabbia per percepire il molle, il posto di percezione è fondamentale. Se io sono sulla sabbia non posso percepire la durezza del suolo, quindi la durezza del suolo non esiste per me in quel momento, esiste la mollezza del suolo. Tutto il percepito viene osservato sul soggetto percipiente, perché oltre al soggetto percipiente non ho null’altro.
Io non posso percepire l’albero fuori di me, perché io sono io, non sono l’albero fuori di me. Io posso percepire l’albero soltanto nella misura in cui l’albero ha un effetto sul mio essere, e quindi ciò che io di fatto percepisco è l’effetto che io vivo del supposto albero; ma cosa l’albero sia oltre ciò che fa a me non lo posso sapere, perché non lo posso percepire: solo il percepibile è conoscibile.
Siccome non posso percepire cosa sia l’albero in quanto supposta realtà materiale fuori di me, non esiste l’albero fuori di me, perché non posso percepirlo fuori di me.
In campo di percezione io percepisco soltanto ciò che l’albero è dentro di me.
Nel pensare, però, io colgo l’albero oggettivo fuori di me? No! Nel pensare io divento albero! Nel concetto di albero sono io albero, come spirito pensante, e sono nell’oggettivo.
Ogni spirito umano pensante che nel suo pensare crea il concetto di albero diventa oggettivamente albero: c’è soltanto un concetto di albero, così come c’è solo un concetto di triangolo, un concetto solo di cerchio.
Intervento: L’albero, in effetti, non verrà mai conosciuto.
Archiati: L’albero in quanto realtà fuori di me non può essere conosciuto, perché l’albero fuori di me non esiste. L’albero fuori di me è un’illusione. L’essenza dell’albero non soltanto è dentro di me, ma sono io quando penso «albero».
Replica: Se tu pensi dell’albero, non saprai mai cos’è l’albero in essenza.
Archiati: Vedi, il grosso problema del materialismo è quello di prendere la cosiddetta percezione come un’osservazione fatta fuori di sé, anziché un’osservazione fatta sul soggetto percipiente. Una percezione che sia fuori dal soggetto percipiente è un assurdo, perché non si può percepire qualcosa che non mi coinvolge. Certo che non è facile vincere il materialismo.
Rileggo le affermazioni di Berkeley IV,20 «Gli oggetti delle mie percezioni esistono solamente grazie a me, cioè in quanto e per quanto io li percepisco: scompaiono col cessare della percezione e non hanno senso senza di essa. Al di fuori delle mie percezioni io non so nulla, e non posso sapere nulla di nessuno oggetto».
IV,21 Contro questa opinione non c’è niente da opporre, finché si considera solo in generale la circostanza {il dato di fatto} che la percezione è condizionata dall’organizzazione del soggetto.
In altre parole, se l’albero è soltanto un fenomeno di percezione esso c’è quando viene percepito, c’è come fenomeno di percezione: quando non viene percepito non c’è. Questo, però, se partiamo dal presupposto che sia soltanto un fenomeno di percezione.
Se invece, oltre al fenomeno di percezione, l’albero è un fenomeno di pensiero, allora è in tutto e per tutto oggettivo. Quindi, come la percezione è dipendente in tutto e per tutto dal soggetto, il pensare è in tutto e per tutto oggettivo.
(IV,21) La cosa si presenterebbe però essenzialmente diversa se noi fossimo in grado di indicare qual è la funzione che il nostro percepire ha nel formarsi di una percezione.
Disattendiamo che ciò che noi chiamiamo percezione, di fatto, è già un interagire tra il modo di operare del cosiddetto percepito sul nostro corpo, sulla nostra fisiologia, e la presa di posizione del pensare. Quindi disattendiamo l’elemento che dà realtà oggettiva alle cose: il pensare.
Però, se consideriamo il fatto che la percezione, in quanto le si dà un nome, è già un concetto, siamo già al livello dello spirito, e allora siamo nell’oggettivo.
Cos’è che mi dà l’essenza del tavolo? Il concetto.
Il concetto mi dà l’essenza del tavolo perché soltanto il concetto di tavolo è in grado di creare tutti i tavoli che diventano percepibili. Se io non ho il concetto di tavolo non posso creare nessun tavolo a livello di percezione, perché non so cos’è un tavolo. La ruota come è nata?
Un primo essere umano si è creato il concetto della ruota, dicevamo la volta scorsa, il concetto di come architettare i mozzi ecc., e in base al concetto sono nate le ruote percepibili. Ma, finché non è sorto il concetto di ruota, come si fa a evidenziare la ruota in modo percepibile?
Tutto il mondo della percezione è un rendersi visibile dei concetti pensati dal pensare. In altre parole, una percezione è un concetto intriso di materia.
Quando la materia va via resta il concetto, e quindi l’essenza è proprio quello che non si percepisce sensibilmente. L’essenza è in ciò che si pensa, nel concetto.
(IV,21) Sapremmo allora che cosa avviene nella {non «nella», ma «alla»} percezione durante il percepire, e potremmo anche determinare che cosa vi deve essere già prima che essa venga percepita.
La cosiddetta percezione è soltanto possibile se prima della percezione c’è stato il pensare: per un momento il pensare viene sospeso e ho la percezione del tavolo. La percezione è una momentanea sospensione del pensiero, poi io dico: è un tavolo. È una percezione dire: «è un tavolo»? No, sono di nuovo nel pensiero. Quindi la percezione pura non c’è.
Il realista ingenuo parla dell’albero reale e pensa che sia una percezione, invece è un concetto: questo è l’inganno.
Se sul viale disegnato sulla lavagna ci mettiamo un cane, che cosa percepisce? Gli alberi grossi e gli alberi piccoli? Beh?, siete ammutoliti? Ripeto la domanda: cosa vede? Gli alberi grossi e piccoli? Nooo! Soltanto il soggetto che pensa può dire «alberi grossi e alberi piccoli»: un cane non percepisce nulla. La percezione è la potenzialità pura al pensare, e l’animale non ha questa potenzialità. Il cane vive nel suo astrale l’operare degli alberi, e gli alberi più vicini a lui hanno un influsso più forte, gli alberi più lontani hanno un influsso più debole. La percezione pensante che dice: questi alberi sono più grossi perché sono più vicini a me, quelli li vedo più piccoli perché sono più lontani, è un processo enorme di pensiero.
Intervento: Ma il cane non vede la prospettiva?
Archiati: No, la prospettiva è un concetto.
Intervento: Gli occhi a che gli servono?
Archiati: Nel cane gli occhi seguono soltanto la scia del fiuto, tutto il resto gli occhi del cane non lo vedono. Noi siamo pieni di antropomorfismi, ma dobbiamo rendercene conto. Il cane non vede nulla, i suoi cosiddetti occhi funzionano in tutt’altro modo che non per l’uomo: il fiuto crea una corrente astrale da qui a un chilometro di distanza e i cosiddetti occhi servono soltanto a restare nella fiumana di questo fiuto.
Facciamo una pausa e poi sentiamo che cosa avete da dire voi.
*******
Intervento: Se la percezione è intrisa di idee, il bambino che vede al supermercato una serie di oggetti e li percepisce in maniera comunque caotica, che pensieri ha, visto che tu oggi pomeriggio dici che la percezione è intrisa di pensieri?
Archiati: Per rispondere alla tua domanda bisogna avere in fondo il coraggio di entrare un minimo nella complessità del fenomeno, perché anche nel caso del bambino abbiamo a che fare con uno spirito umano individualizzato.
Ora, complessificando un minimo le cose, vi butto lì certi elementi e, poiché siamo in chiave di discussione, poi potete immediatamente prendere posizione. Se invece fossi nell’esposizione, dovrei essere meno dogmatico e presupporre meno cose.
Se il bambino non fosse uno spirito umano che ha già millenni di evoluzione che gli hanno consentito di individualizzarsi, non avrebbe la percezione, sarebbe al livello dell’animale che non può percepire le cose. Se invece noi diciamo che il bambino è uno spirito, uno spirito che aleggia ancora intorno al corpo perché sta ulteriormente strutturando il cervello per poi potervi interagire – in altre parole, è uno spirito che ancora non interagisce col cervello –, allora una percezione vera e propria non può ancora esserci.
Però, essendo uno spirito che si sta incarnando, che sta architettando il corpo proprio per permettersi di vivere una serie infinita di percezioni, e in base a queste percezioni di esercitare il pensare, possiamo presupporre che un certo orientamento degli occhi già comincia da parte di questo spirito, di questo Io superiore.
Perché se questo spirito non fosse già, anche nel bambino di sei mesi, in via di orientamento dei sensi, non sarebbe uno spirito che si sta incarnando. Se non ci fosse nessun operare dello spirito nei sensi, negli organi di senso, non ci sarebbe percezione, e perciò si dovrebbe dire che il bambino non vede nulla, perché non distingue nulla: vedere le cose significa distinguerle, ma noi distinguiamo col pensiero. Quindi quando manca il pensiero le cose non si vedono.
L’animale che non ha il pensiero non percepisce cose singole, perché le cose singole le individua solo il pensiero. Allora diciamo: lo spirito individualizzato del bambino che sta ancora lavorando al corpo per renderlo capace di percezione, per poter poi avere la possibilità di pensare in base alla percezione, ci consente di parlare di una percezione potenziale, perché anche il pensare è potenziale. Invece nell’animale non c’è nulla di percezione, perché non c’è nulla di pensiero.
Ora, una potenzialità che è soltanto incipiente, che sta soltanto cominciando, è di una complessità infinita, perché quando noi chiediamo: come fa un bambino a diventare adulto?, ci rendiamo conto che è un processo complessissimo.
E lo stesso vale quando ci domandiamo: cosa vede il bambino? Vive un primo inizio di percezione, perché il suo spirito si sta riproponendo di portare i sensi a un punto tale che la percezione sia perfetta, per consentirgli, per dargli la possibilità di pensare come reazione alla percezione.
Cos’è, allora, la percezione? È la nullificazione di cose singole, per permettere al pensare di ricrearle, però individuate, singole, a partire dal pensare. Il bambino vede le mele e le pere e il pane e il burro soltanto incipientemente come distinti gli uni dagli altri. Il fenomeno è molto complesso. Un mese dopo la mamma parla di mele, di pere, di pane e il bambino comincia un pochino di più, sempre un pochino di più, a distinguere, e poi viene il momento in cui dice: pane…, burro…, marmellata…
Quindi, a monte di tutte queste riflessioni, c’è il fatto che o siamo convinti che questo cosiddetto bambino è uno spirito adulto, che ha un’evoluzione molto lunga già alle spalle ed è già profondamente individualizzato, oppure ignoriamo questo fatto. E la decisione di pensarla in un modo o nell’altro è questione del singolo essere umano.
Replica: Infatti quando tu parlavi di caos, sempre riferendoti al bambino, al supermercato ecc., e successivamente parlavi di cosmo, quale mondo ordinato e quindi pieno di bellezza, io ho pensato che è stato scientificamente dimostrato che il bambino, anche piccolissimo, sogna. Cosa sognerebbe se non avesse esperienze? Forse magari di mondi pregressi? Quali immagini si presenterebbero alla sua mente se non avesse già qualche esperienza di un mondo altro? È una sciocchezza questa, secondo te? Quando io l’ho sentita mi ha dato tanto da pensare. I bambini piccoli sognano: ma cosa sognano? Quali esperienze si possono presentare a un bambino piccolissimo, se non ha già esperienze in questa vita?
Archiati: Quello che tu dici, naturalmente, andrebbe molto meglio, sarebbe in consonanza con la prima ipotesi che io ho fatto: che si tratta di uno spirito che ha già un’evoluzione...
Replica: Sì, infatti.
Archiati: Però non è una cosa che puoi dimostrare a un’altra persona.
Replica: Però per quanto riguarda i sogni, pare proprio che lo abbiano dimostrato con delle apparecchiature idonee a registrarli.
Archiati: Sì, ma quando tu parli dei sogni di un bambino, anche piccolissimo, c’è già il sostrato corporeo, quindi uno scienziato ti può dire che, in modi misteriosi, l’origine di queste immagini è il corporeo. Tu non gli potrai mai dimostrare…
Replica: Non me lo può dire, perché non ha fatto ancora esperienza questo bambino…
Archiati: No, lo dici tu.
Replica: In questo mondo un bambino piccolissimo che tipo di esperienza ha fatto?
Archiati: Il corpo c’è tutto, in un bambino piccolissimo il corpo c’è tutto, e il corpo è una sorgente inesauribile di immagini, di esperienze, di sensazioni ecc…
In un bambino piccolo, anche appena nato, c’è già tutto: è un groviglio di sensibilità, di origine di immagini. Tutti gli organi sono stati formati in base alle immagini: il cuore è un’immagine del cuore, sennò non salta fuori il cuore come diverso dal polmone.
Un’altra riflessione, un’altra porta che aiuta molto chi è aperto ad avvalorare il fatto che non abbiamo a che fare soltanto con un fenomeno corporeo, ma abbiamo a che fare con la realtà di un essere spirituale – tu dai per scontato che lo spirito sia una realtà, ma non lo puoi dimostrare di acchito allo scienziato che ha il dogma assoluto che ciò che la religione chiama spirito non esiste, è una invenzione: devi accettare che, per ora, lui l’accesso alla realtà dello spirito non ce l’ha, ed è inutile star lì a dar martellate – un’altra porta, dicevo, è il bambino di fronte alla fiaba.
Sta di fatto che, finché il bambino non viene rovinato (cosa che oggi avviene prematuramente) è spontaneo per lui, in tutte le culture, di prendere come realtà le immagini bellissime della fiaba. Lì anche lo scienziato dovrebbe porsi la domanda: da dove proviene questa spontaneità del bambino che, nei confronti del diavolo nella fiaba, ha veramente paura? Tu dirai: se non è quella una prova della realtà del mondo spirituale! No, non è una prova. Però, per chi fa sempre di più l’esperienza della realtà dello spirito, certo che è un fattore di enorme conferma. Per un bambino piccolo il lupo, la principessa, sono tutte realtà spontanee, ma non c’è neanche da discutere.
Intervento: Fiaba, non favola, vero?
Archiati: Le vere fiabe. Ormai le fiabe vengono talmente disdegnate, modernizzate, cambiate, che le fiabe classiche dei fratelli Grimm non ci sono più sul mercato, non le legge più nessuno. A noi, in Germania, è venuta l’idea – diteci voi cosa ne pensate perché si potrebbe fare anche in Italia[14] – di fare in questi libricini da 2 euro una serie sulle fiabe, però con un minimo di spiegazione, un minimo di lettura interpretativa della fiaba. Se riusciamo a rilanciare le fiabe con un minimo di spiegazione, di interpretazione in chiave di scienza dello spirito, ci può essere la possibilità di recuperarle, soprattutto quelle dei fratelli Grimm, e in questo modo raggiungere il 5-10 % delle librerie che altrimenti Steiner proprio non lo vogliono. In questi libricini potremmo introdurre un minimo di bibliografia di altre cose che si potrebbero leggere. Cosa che si può fare anche in Italia.
Le fiabe, o le recuperiamo reinterpretandole in chiave di scienza dello spirito, oppure vanno perse. E se vanno perse io lo considero un impoverimento tragico per l’umanità. In Germania le fiabe dei fratelli Grimm non le legge quasi più nessuno. Circolano fiabe moderne, inventate, così stupide, dove non calza nulla: se uno conosce l’oggettività dello spirituale, si accorge che sono talmente arbitrarie che non calza nulla, ma vanno in voga. E le fiabe dei fratelli Grimm, che sono immaginazioni pure tramandate per secoli e millenni, non le vuol leggere più nessuno.
In italiano, nell’edizione Mondadori, c’è una bellissima traduzione italiana delle fiabe dei fratelli Grimm, in due volumi.
Intervento: Posso fare un’altra domanda? È in riferimento al primo intervento, quello relativo alla torre di Babele. In termini di evoluzione dello spirito, la torre di Babele, quale a me risulta essere, cioè un momento drammatico e doloroso in cui la comunicazione tra gli esseri di fatto non esisteva più, che cosa rappresenta?
Archiati: Rappresenta il passaggio evolutivamente necessario, quindi né positivo né negativo, né buono né brutto in senso morale, dal linguaggio unitario alla pluralità di linguaggi. La pluralità di linguaggi sorge per il fatto che il fenomeno acqua, ad esempio – essendo vissuto non più soltanto dal lato spirituale del concetto di acqua, che è consono col concetto di sapienza iniziale, ma sempre di più dal lato della percezione, dell’esperienza cosiddetta materiale –, a seconda dei meridiani offre un’esperienza dell’acqua diversa.
Quindi, come in origine la parola per l’acqua era una sola, perché la parola esprimeva il concetto, così, quando la parola comincia a esprimere sempre di più l’esperienza di percezione diversificata, sorgono parole diverse, linguaggi diversi.
Ho spesso fatto l’esempio della differenza tra «acqua» in italiano e «Wasser» in tedesco. Se tu stai facendo un bagno in acqua, e l’acqua è bella calda ti viene di dire: aaaacquaaa. Adesso immaginate che la temperatura dell’acqua sia di 8°, ci andate dentro e dite aaaacquaaa? E no! Wasssserrrr, Wassserrrr!!
Il popolo che percepisce l’acqua bella calda dice giustamente «acqua», altrimenti mentirebbe, barerebbe. Il popolo che percepisce, che vive l’acqua bella fredda dice «Wasser». È concepibile un linguaggio, a livello di percezione, che usi la stessa parola per un’acqua così diversa come temperatura? No, sarebbe un linguaggio contraddittorio. Quindi, nella misura in cui gli esseri umani sono calati nell’elemento di percezione del mondo, percepibile è diventato diverso da regione a regione, da fisiologia a fisiologia, e ogni linguaggio ha privilegiato elementi diversi di percezione dello stesso concetto. L’acqua, a livello di concetto, è uguale per tutti i popoli, ma a livello di percezione è diversa di popolo in popolo.
Replica: Da qui è scaturita la diversa e dolorosa difficoltà di giungere, poi, alla comunicazione tra gli esseri?
Archiati: Ma perché sottolinei il doloroso?
Replica: Perché non ci si intende più, tante volte. Io avevo capito che prima c’era proprio questa possibilità – al di là e al di sopra di una giusta settorializzazione del linguaggio o differenziazione legata all’esperienza diversa, al nascere in una regione piuttosto che in un’altra –, c’era la possibilità di comunicare lo stesso, di interagire gli uni con gli altri, meglio. È come se si fosse persa l’unità nella molteplicità, non so se mi sono spiegata.
Archiati: No, no, c’era unità senza complessità. L’intesa di tutti gli uomini che non è già data, l’intesa che non c’è già in partenza e che va conquistata, tu la chiami dolorosa? Io la chiamo una gioia maggiore! Perché la frammentazione che ci consente di riconquistare l’unità, trascendendo il fenomeno puro del linguaggio, per ritornare al livello del Logos in quanto pensiero, non è un processo doloroso. È tutta gioia! La fatica di una unità che va riconquistata, perché metterla in negativo? È molto meglio metterla in positivo, no?
I linguaggi al plurale sono la sfida a riconquistarsi il linguaggio universale. E qual è il linguaggio universale? Il pensare.
Intervento: Si è parlato di percezione come interazione dello spirito con un corpo sano, abbiamo parlato poi di un bambino che inizialmente non ha percezioni e poi comincia ad averne: ma un’anima che si incarna in un corpo non sano, non avrà mai percezioni?
Archiati: Tu vuoi dire uno spirito…
Replica: Sì, uno spirito che si incarna…
Archiati: No, non esiste. Ogni spirito forgia il suo corpo a sua immagine, non esiste un corpo in cui ci si incarna. Esiste soltanto un corpo che uno spirito si fabbrica, e ognuno si fabbrica il corpo che gli corrisponde[15]. Tu dici: però un certo tipo di corpo funziona diversamente – non mi dire che funziona peggio...
Replica: Funziona diversamente. Può creare un concetto una persona che ha un cervello malformato?
Archiati: Sta’ attenta, sta’ attenta. Ti porto un esempio concreto, e tu non mi potrai mai dire che questo esempio non può essere reale. Prendiamo uno spirito un tantino più evoluto, più forte della media, uno spirito che dice: a me non va di crearmi un corpo normale, perché un corpo normale è troppo comodo per me, io sono capace di cammini molto più forti. Allora, essendo più evoluto della maggioranza, mi creo un corpo che, presentandomi un ostacolo più forte, mi concede cammini evolutivi più forti della media. È un corpo privilegiato e noi lo chiamiamo corpo malato, handicappato. Siamo bacati noi! Chi proibisce a uno spirito forte di crearsi un corpo che dà più resistenze del normale? È più forte e dice: che me ne faccio di un corpo normale? Mi sembra di poltrire tutta la vita!
Replica: E com’è il rapporto di questo corpo con il mondo? Sicuramente diverso da quello comune.
Archiati: Non c’è un rapporto del corpo con il mondo.
Replica: Qual è il rapporto dello spirito, attraverso questo corpo, con il mondo? Sarà diverso dal comune.
Archiati: Fa passi molto più da gigante che non certi esseri normali che vanno come le lumache. Padrone di farlo, se è capace!
Siamo sinceri: non consideriamo soltanto la persona che noi, col nostro pensare veramente bacato, chiamiamo handicappata, ma pensiamo anche al karma, al destino, alle enormi forze di dedizione dei genitori ecc., … mica tutti lo sanno fare! E chi non è capace di farlo ci pensa due volte prima di crearsi un corpo che chiede una misura enorme di dedizione a genitori che forse non ce le hanno. E noi parliamo di persone handicappate? Ma siamo stupidi, proprio bacati nel pensiero!
Intervento: Siamo noi gli handicappati.
Archiati: Eccome! Vi ho citato già un paio di volte il caso reale di una persona, di uno spirito osservato e descritto da Steiner. Dice Steiner: questo spirito, ancora prima di nascere, ha deciso di venire al mondo in un modo che noi chiamiamo mentalmente handicappato (un caso di idiozia, per usare un termine tecnico), sapendo quale misura di dedizione, di offerta, di sacrificio avrebbe chiesto ai genitori. Vivere da handicappato mentale significa che lo spirito decide di costruire un cervello diverso da quello normale, per cui, questo spirito, dovrà aleggiare intorno al corpo e non avrà la possibilità di servirsi in tutto e per tutto delle strutture del cervello. Ma questo spirito sa, sempre ancora prima di nascere, che questa vita vissuta insieme a tutti i suoi parenti e genitori nella dedizione e nell’offerta, creerà i presupposti per poter nascere, nella vita successiva, come un genio di umanità. È un fatto vero. Questa persona ebbe poi una vita successiva piena di intuizioni morali, di dedizione all’umanità: e queste forze del cuore le sono state rese possibili soltanto da una vita intera vissuta da handicappato mentale, volutamente e liberamente scelta.
Intervento: Ha un nome questo signore?
Archiati: No. No. Guardiamoci bene dal fare culto di persone!
Cosa avviene quando noi parliamo di handicappato mentale? Prendiamo il dato di percezione come se fosse una realtà, e la realtà dello spirito non la vediamo. Vediamo un corpo che funziona in modo diverso dagli altri e diciamo che è handicappato. Invece di vedere la realtà di uno spirito più forte della media, più pieno di forze di amore, diciamo che è handicappato. Questo è il materialismo che considera il dato di percezione come realtà e ignora lo spirito.
Intervento: Nel pensiero non ci può essere errore: perché questo?
Archiati: Ti rispondo con una controdomanda, perché non si può rispondere alla tua domanda direttamente. Quando c’è la luce ci si vede: perché? Perché quando c’è luce si vede! Lo puoi spiegare perché? No, non lo puoi spiegare: o il tuo interlocutore ha fatto l’esperienza della luce, e allora sa che dove c’è luce si vede, oppure, se non ha fatto questa esperienza, non glielo puoi spiegare, proprio perché manca l’esperienza. Nella misura in cui l’essere umano fa l’esperienza del pensare, sa che pensare significa gettare luce sulle cose. Ma nella misura in cui non ha fatto questa esperienza, per lui è aria fritta quando glielo dici.
Replica: Sì, quello della luce è un esempio. Però, secondo la mia esperienza, tante volte il mio pensare mi ha portato fuori strada.
Archiati: No, no.
Replica: Sì, invece.
Archiati: No. Interpreti il fenomeno in un modo errato: non è il pensare che ti ha portato fuori strada, è che tu sei uscito dal pensare. E questa è una cosa diversa.
Replica: Ho pensato in un modo sbagliato.
Archiati: No, non esiste il pensare in un modo sbagliato.
Replica: Secondo me l’uomo è fatto di pensiero, di Logos, di ragione, di sentimento e quindi c’è anche il cuore: a volte, quando ascolto il sentimento, quello che sento…
Archiati: …sei fuori dal pensare!
Replica: Però tante volte, quando ascolto una stimolazione esterna, quello che mi dà un’altra persona, capisco veramente quello che sento e quello che mi fa bene; invece, se penso a quello che mi è stato dato, forse il pensiero mi porta all’errore, mi porta a travisare quello che mi è stato dato. Invece il cuore mi fa capire. Almeno a me, come esperienza di vita, è successo questo. Quindi mi sembrava strano che nel pensare non ci può essere errore, secondo me è un dogma, perché si può supporre che nel pensare ci sia errore.
Archiati: Il problema è che non ci siamo capiti. Pongo la domanda in un altro modo: si può capire qualcosa in un modo sbagliato? No, o si capisce o non si capisce. Posso capire il teorema di Pitagora in modo sbagliato? No, o lo capisco, e allora lo capisco in un modo giusto, o non lo capisco. Ma non lo posso capire in un modo sbagliato.
Replica: Però una cosa è capire il teorema di Pitagora, e una cosa è capire, o non capire, l’amore che ti sta dando l’altra persona. È un po’ più complessa la faccenda. Cioè io, col pensiero, posso capire se l’altra persona mi sta amando o no? No. Invece con il cuore e con il sentimento sì, secondo me. Io ho vissuto così: il pensiero mi stava facendo capire una cosa, il cuore un’altra.
Archiati: Aiuto, aiuto!
Intervento: Pensare è una cosa, giudicare è un’altra.
Intervento: Secondo me entrano in gioco i desideri suoi, che gli fanno capire male l’amore dell’altra persona, ma non è il pensiero pulito. Si lascia coinvolgere e desidera quello che la persona non gli dà, ma è il suo desiderio, forse, quel pensare sbagliato che lui dice.
Archiati: Dunque, l’errore classico del pensiero è l’unilateralità[16]. Un’unilateralità è un errore. Scrivo:
Il mondo è fatto di materia
È un pensiero giusto o è un pensiero errato?
Intervento: È parziale.
Archiati: È parziale, non si può dire che è errato. Manca qualcosa, quindi è un pensiero incompleto.
Intervento: E quindi, come dicevo, è un pensiero errato.
Archiati: No, non è un pensiero sbagliato. «Il mondo è fatto di materia» non è un pensiero sbagliato», perché il mondo è fatto anche di materia.
Replica: Però uno può pensare tutta la vita che il mondo è fatto solo di materia, c’è chi lo pensa e quindi è un errore. Se lui segue il pensiero, il pensiero lo porta nell’errore.
Archiati: «Il mondo è fatto solo di materia»: questo pensiero non è errato, è un pensiero carente. Se colui che dice questa cosa del mondo conosce solo la materia, la sua affermazione è giusta per lui, perché lui del mondo conosce solo la materia. Quindi la sua affermazione non è errata, è verace. Per lui il mondo è fatto solo di materia.
Replica: Però, se lui usasse anche il sentimento, capirebbe che nel mondo c’è anche lo spirito.
Archiati: No, no, no. Lui ti dice: tu non venirmi a parlare di sentimento o di spirito, per me il mondo è fatto solo di materia. Ed è vero, per lui è così. Tu non hai nessun diritto di dire: no, non dovrebbe essere così. Per lui l’affermazione non è errata: è giusta, è verace.
Intervento: In questo caso dov’è l’oggettività del pensare?
Archiati: Sta nel fatto che quello che il pensare dice è giusto, non errato. L’errore non è in quello che dice, ma in quello che ci manca. E questo è ben diverso[17].
Il cosiddetto errore non è nel pensiero, ma è nei buchi del pensiero – l’abbiamo detto mille volte. Quindi una cosa è dire che il pensiero afferma qualcosa di sbagliato, e un’altra cosa è dire che, dove manca il pensiero, manca un frammento di realtà oggettiva: ma è perché manca, il pensiero, non perché erra. L’errore è sempre una carenza di pensiero. L’errore non è mai dovuto al pensare, ma è sempre dovuto alla mancanza, alla carenza o all’insufficienza del pensare.
Nella misura in cui il pensare c’è, c’è la verità, non l’errore.
Nella misura in cui c’è l’errore, manca il pensare, o è manchevole il pensare.
E sono due cose diverse: io erro, mi sbaglio nell’identificare le cose, nella misura in cui la luce manca; nella misura in cui la luce c’è, identifico le cose. Perciò, dicevamo la volta scorsa, il pensare nella misura in cui c’è va a colpo sicuro. Dove sorge l’errore è perché il pensare è carente, è manchevole.
Una cosa è dire che l’errore è dovuto al pensare, tutt’altra cosa è dire che l’errore è dovuto alla carenza del pensare: scusate, l’una affermazione è l’opposto dell’altra! Se l’errare fosse del pensare, per natura, dovremmo sempre errare nel pensare.
Intervento: Riflettevo se è possibile differenziare il pensiero. Pensieri di livello più alto e quelli che sono anche coazioni a ripetere cose già sentite – uno può pensare una cosa che ha sentito dire e la ripete, oppure, in un impulso di gelosia, comincia a pensare che la moglie lo tradisce, si fissa con questa cosa e chiama il detective, per dire. Mi ha fatto venire in mente questo quel ragazzo che prima faceva la differenza tra cuore e mente: uno avverte che un pensiero è di livello più basso, non so se è giusto definirlo così, o più alto. Il pensiero creativo e il pensiero che è dato da impulsi.
Archiati: Diciamo che ci sono due modi fondamentali di pensare:
• un modo di pensare più passivo, più modesto, più carente, che pensa sulla falsariga della percezione
• un modo di pensare molto più attivo, molto più forte, capace di gettare molta più luce, che parte dal presupposto che la percezione è un inganno da superare
A seconda della posizione di partenza, seguono due modi profondamente diversi di pensare.
Replica: Forse è per questo che il ragazzo diceva che a volte si sbaglia. Forse vive questi due livelli.
Archiati: Si sbaglia quando il pensare si orienta secondo la percezione, che nel suo caso è il sentimento: l’orientamento alla percezione è come noi sentiamo quel che la percezione ci fa. Se noi restiamo alla percezione di un corpo diverso dalla norma, la percezione ci dice che è malato, è handicappato. Allora io dico: sta’ attento, ti inganna pensare che sia un corpo malato, ti inganna! Se ti riferisci allo spirito, può saltar fuori che quel corpo lì è uno strumento privilegiato per camminare spiritualmente ancora di più della media.
Intervento: Non a caso nel linguaggio si usano anche dei termini diversi per indicare queste due modalità del pensare: un conto è il pensare elevato, puro, che è il pensiero che non erra, l’altro è un tipo di pensare che è più un giudicare, un credere. Non sempre si dice: «io penso», ma «io credo», «secondo me», «secondo il mio giudizio», e questi sono modi di dire più legati al percepire.
Archiati: Allora diciamo che il pensare che si orienta secondo la percezione è soggetto dall’inizio alla fine all’errore, perché la percezione è per natura un inganno, una parvenza. Però questo pensare che si orienta secondo la percezione, che segue la percezione e si fa dettare i contenuti dalla percezione, non è quello che noi qui stiamo chiamando «pensare». Il pensare che si lascia guidare dalla percezione io lo chiamo sentire, non pensare.
Intervento: Mi scuso con tutti, ma da questa mattina io faccio fatica a superare quel nodo cruciale che dice: non esiste la realtà quando io mi distolgo dalla percezione diretta…
Archiati: No, non è che la realtà cessa di esistere, non c’è mai stata una realtà di pura percezione. Non c’è mai stata.
Replica: Si parlava del tavolo, e mi ricordo che ho già fatto un intervento perché mi fa fatica pensare che non esiste. Come si fa a dire che non esiste il tavolo? E se gli do un calcio percepisco…
Archiati: Percepisci il fisiologico creato nel tuo corpo.
Replica: Ma causato da chi? Quando parli di percepito vuol dire che il percepito esiste, se c’è un percepito.
Archiati: No, no. È causato dal tuo corpo, perché il tavolo c’è tale e quale anche per l’Angelo: ora, la causa è causa soltanto se di necessità sortisce l’effetto, sennò non è una causa. Quindi, se il tavolo è la causa dell’esperienza, della sensazione di urto, il tavolo deve causare questa sensazione anche nell’Angelo. Ma siccome non è così, ne consegue che la causa della sensazione di urto è il tuo corpo, non il tavolo!
Replica: Ma cos’è che non esiste? Dimmelo per piacere!
Archiati: La cosiddetta percezione non esiste fuori dall’uomo, è dentro il soggetto che percepisce.
Replica: Certo, certo, però mi sembrava di aver capito che l’albero, il tavolo, tutte le cose quando io non percepisco è come se non ci fossero più.
Archiati: Ma se tu dici: non c’è più, intendi dire che prima c’era. Quello è l’errore, non c’era neanche prima!
Replica: Oh porca miseria!! (risate e applausi dal pubblico, ndr). Dopo quanti anni si comprende questa cosa? Dimmelo! Così mi metto in silenzio e aspetto! È difficilissimo, non so se sono così materialista io da non…
Archiati: Io auguro a tutti quanti un buon appetito. Che ciò che mangiamo sia oggettivo fuori di me o no, non me ne importa nulla, l’importante è che mi faccia bene e che mi senta sazio!
Venerdì 22 agosto 2008, sera
Siamo nella seconda parte del capitolo IV, che è il passaggio un pochino più difficile, più ostico, de La filosofia della libertà. Siccome noi siamo individui che godiamo l’ostacolo, allora ci rallegreremo ancora di più per questa parte un po’ più difficilina!
È una disamina del mondo della percezione. Un concetto fondamentale è questo: noi percepiamo cose soltanto nel nostro corpo, nella nostra anima e nel nostro spirito. Oltre al percepire una sensazione nel corpo, un sentimento o un’emozione, ecc. nell’anima, e oltre a percepire un concetto che è creato nello spirito, ditemi voi che altro ci può essere?
Il tavolo fuori di me, se è fuori di me, per me non esiste. Il concetto di «fuori di me» significa: per me inesistente. Per me.
In altre parole, l’affermazione non è che il tavolo fuori di me non esiste, non è quella l’affermazione: su questo tavolo fuori di me, se c’è o non c’è, io non posso dire nulla! Perché è fuori di me quindi esula, non posso fare nessuna affermazione su ciò che è fuori di me: questo è il concetto fondamentale. Posso cominciare a fare un’affermazione soltanto se percepisco qualcosa dentro il mio corpo, dentro la mia anima o dentro il mio spirito: allora percepisco qualcosa.
Il concetto del «fuori di me», per quanto riguarda me, è il concetto del nulla. Perché se io percepissi qualcosa del tavolo fuori di me, nel momento stesso in cui lo percepissi, questo qualcosa sarebbe subito dentro di me.
Quindi è un cavillo parlare del tavolo fuori di me, è una dicitura assurda, è una contraddizione in termini. Nel momento in cui io, di questo fantomatico tavolo, vivo qualcosa, questo qualcosa che vivo fa parte di me:
• fa parte della mia realtà corporea in chiave di sensazione – ho la sensazione che puzza, perché è sporco, oppure lo urto, e allora percepisco nella mia gamba un urto;
• o fa parte della mia realtà animica in chiave di sentimento – il tavolo mi piace;
• oppure fa parte della mia realtà spirituale in quanto percepisco nel mio spirito il concetto di tavolo – come diverso dalla sedia o dallo sgabello.
Ho una realtà, per quanto mi riguarda, soltanto se è in me in qualche modo. Se noi parliamo del Cristo là fuori, del tavolo là fuori, dell’albero là fuori, o del Padreterno là fuori per aria, tutto quello che è là fuori, è un’invenzione, un’astrazione, una non realtà. Perché è una non realtà? Perché non c’è nulla di percezione!
Per avere una realtà ci vuole il lato di percezione: cosa percepisco io del tavolo fuori di me? Nulla! È così evidente! Lo percepisco soltanto se entra a far parte della mia realtà corporea, della mia realtà animica o della mia realtà spirituale, e allora sì che diventa qualcosa per me: diventa una percezione e in base alla percezione, se ci metto il concetto, ho una realtà.
Parlare del tavolo, dell’albero fuori di me è un’astrazione che mi fa uscire dalla realtà. Quindi l’affermazione non dice «il tavolo fuori di me non esiste», oppure «il tavolo fuori di me esiste». L’affermazione è: non posso fare nessuna affermazione su un tavolo fuori di me, perché di un tavolo fuori di me non esperisco nulla. Nel momento in cui io dico: questa gamba di tavolo è bella dura, cosa ho percepito del tavolo? Una botta dura.
Adesso andiamo avanti, arrivano le pagine un pochino più ostiche, ve le leggo velocemente, per poi tornare alla domanda di fondo che dice: ma allora, cos’è la realtà? E la risposta sarà: la realtà ce l’ho soltanto quando congiungo la percezione col concetto. Però ritorniamo a dire che del tavolo io ho una percezione nel senso di sensazione corporea, una percezione nel senso di sentimento animico, una percezione nel senso di concetto. Di fronte alla percezione, se ci aggiungo col pensare il concetto, ho la realtà del tavolo. Quindi la realtà del tavolo è il dato di percezione che io percepisco o nel mio corpo, o nella mia anima, o nel mio spirito: aggiungendoci il pensare ho la realtà del tavolo.
Intervento: Del tavolo, o di quel tavolo che sta lì?
Archiati: Tu torni a parlare del tavolo «là fuori», vedi? Te lo leggevo sulla faccia! Sul cosiddetto tavolo là fuori non puoi fare nessuna affermazione perché non hai in mano nulla. Se lo vuoi cogliere dal lato di percezione, mi devi dire che cosa percepisci di quel tavolo nel tuo corpo, o nella tua anima, o nel tuo spirito, se no non hai nulla!
Come aiuto per tirarci via da questo materialismo che vede la realtà del tavolo soltanto nel tavolo là fuori, pensiamo ai morti – se siamo convinti che i morti non siano spariti, ma siano spiriti senza corpo –, oppure pensiamo agli Angeli, naturalmente se siamo convinti che gli Angeli ci siano.
Cos’è il tavolo materiale per i morti? Stando a Steiner, essi «vedono» un buco nel mondo eterico, nella sostanza eterica, un buco nella sostanza astrale: un buco, una carenza di eterico e di astrale. Per noi il cosiddetto «tavolo là fuori» si rende percepibile, ma si rende percepibile in quanto agisce sul mio corpo, in quanto agisce sulla mia anima, in quanto agisce sul mio spirito − e non «là fuori». Quindi parlo del modo in cui il tavolo agisce sul mio corpo e descrivo la sensazione che ho del tavolo; parlo del modo in cui il tavolo agisce sulla mia anima, parlo del sentimento che vivo in me... ma parlare di una realtà fuori di me significa parlare di aria fritta, perché manca la percezione.
Voi direte: ma io percepisco il tavolo fuori di me! No! Io percepisco l’immagine del tavolo che entra dentro di me! Quando io guardo il tavolo, che cosa ho dentro di me del tavolo? Il pezzo di materia? Ma scusate, sta a dieci metri! Del tavolo percepisco in me l’immagine. Adesso vado vicino e do un calcio a questo podio: cosa percepisco del podio?
Intervento: La resistenza al piede.
Archiati: No, non la resistenza! La sensazione che sento nel piede.
Intervento: In realtà percepisco me stesso!
Archiati: È questo che dico!! O meglio, percepisco un frammento della mia realtà corporea…
Replica: Una modificazione di me stesso.
Archiati: Sì, una modificazione di me stesso, un’affezione, si diceva nella filosofia antica. Percepisco o il modo in cui viene affetto il mio corpo, o il modo in cui viene affetta la mia anima, o il modo in cui viene affetto il mio spirito. Ma se do un calcio a questo podio là fuori, cosa percepisco, io? Io percepisco il mio piede, scusate, sento una sensazione al piede.
Intervento: Anche all’orecchio.
Archiati: Sì anche all’orecchio, sento il rumore.
IV,22 Con ciò la nostra attenzione è trasportata dall’oggetto della percezione {dal tavolo là fuori} al soggetto della medesima {al percipiente}. Io percepisco non solo altre cose, ma anche me stesso. La percezione di me stesso ha anzitutto questo contenuto: che io sono ciò che è permanente di fronte al continuo andirivieni delle immagini percettive.
Sto andando per una strada di città e ho tantissime percezioni – prendiamo quelle visive, che sono le più variopinte. Tantissime percezioni. C’è qualcosa di costante in questo andirivieni, in questo cambiare delle percezioni? Io. Io sono costante, perché approdano tutte qui.
(IV,22) La percezione dell’io può sempre sorgere nella mia coscienza mentre ho altre percezioni.
Sono io a vedere, sono io guardare, sono io a incamerare immagini... Quando io, per esempio, dal guardare la vetrina di una libreria rivolgo l’attenzione a me che incamero queste immagini, sto percependo me stesso. Quando invece disattendo me e guardo la vetrina, sto percependo la vetrina. Ma chi è che sta percependo la vetrina? Io, solo che non ci sto pensando direttamente.
Posso però disattendere i contenuti della vetrina e percepire me stesso in quanto percipiente la vetrina, e allora dico: ah, sono io che sto incamerando tutte queste immagini, sto passando da un libro all’altro, da una copertina all’altra. Quindi posso sia concentrare la mia osservazione percettiva sui libri, sia concentrare la mia osservazione percettiva su di me che incamero tutte queste percezioni di libri. E dico: mi rendo conto che tutte queste immagini approdano qui, qui le percepisco: nel mio io.
(IV,22) Quando sono immerso nella percezione di un dato oggetto, io ho da principio coscienza solamente di esso {sto guardando la copertina di quel libro che mi interessa in vetrina}. A ciò può {sempre} aggiungersi la percezione di me stesso: allora non sono cosciente soltanto dell’oggetto {la copertina}, ma anche della mia personalità che si contrappone all’oggetto e lo osserva {e dico: sono io che sto osservando quella copertina}. Non vedo soltanto un albero, ma so anche che sono io che lo vedo.
Quando io non penso, quando non mi concentro sul fatto che sono io a vedere un albero, significa che non sono io a vedere un albero? No, lo sono tale e quale, solo che sono maggiormente concentrato sull’albero che sto vedendo: però, il fenomeno di vedere l’albero è che io percepisco in me l’immagine dell’albero. Dove sorge l’immagine dell’albero? In me, anche se io non ci penso espressamente. Nel momento in cui ci penso espressamente, porto a coscienza il fatto (già esistente) che è in me, nel mio corpo, nella mia anima, nell’interazione tra corpo e anima che io percepisco l’immagine, la rappresentazione dell’albero.
Diciamo che la percezione è un’interazione – però la cosa adesso diventa un po’ difficile perché sembrerebbe che vogliamo dire che il mondo esterno è una realtà – tra il cosiddetto mondo esterno materiale e il mio corpo, la realtà dei miei sensi; poi l’interazione tra il corpo e l’anima fa sorgere la rappresentazione; l’interazione fra l’anima e lo spirito fa sorgere il sentimento; l’interazione tra lo spirito e il mondo spirituale fa sorgere il concetto. (vedi schema alla pagina seguente)
Abbiamo la serie: percezione – rappresentazione – sentimento – concetto.
La percezione sorge nell’interazione tra il cosiddetto mondo materiale e il corpo, ma di questo mondo materiale, però, ho soltanto il lato di percezione e finché ho solo la percezione non ho la realtà. La realtà del mondo materiale ce l’ho soltanto quando col pensare ci aggiungo il concetto, quindi quando ho fatto tutta la trafila.
L’interazione fra il corpo e l’anima fa nascere la rappresentazione, l’interazione fra l’anima e lo spirito fa sorgere il sentimento…
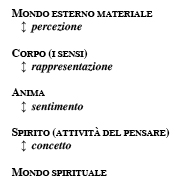
Intervento: Non ho capito bene cos’è la rappresentazione.
Archiati: La rappresentazione è quando io guardo l’albero, in quanto presupposto frammento di mondo materiale esterno, e ho la percezione: poi mi giro, oppure chiudo gli occhi, e non sono più in rapporto col mondo esterno, sono in rapporto col mio corpo che ha guardato l’albero, e cos’è rimasto, in me, dell’albero? La rappresentazione, l’immagine interiorizzata dell’albero.
Intervento: Qual è la differenza tra rappresentazione e ricordo?
Archiati: I ricordi sono tutte rappresentazioni, però rappresentazioni formate nel passato e cadute nel dimenticatoio. Il ricordo è un rapporto con i contenuti dell’anima del passato, ma questo renderebbe ancora più complessa la cosa, perciò prendiamola al presente, la rappresentazione.
Ripeto: nell’interazione tra l’albero e il mio corpo dotato di sensi sorge la percezione; nell’interazione tra il mio corpo e la mia anima la percezione si trasforma in rappresentazione; la rappresentazione fa sorgere in me un sentimento: mi piace, non mi piace, mi fa rabbia ecc…; percezione, rappresentazione e sentimento insieme fanno sorgere un concetto. Però il concetto non lo posso creare se non attivando lo spirito in me, lo spirito in quanto frammento del mondo spirituale.
Il concetto è un confluire di percezione e rappresentazione nell’attività del pensare, quindi lo spirito è l’attività del pensare. L’attività del pensare dice: la realtà di questa percezione, la realtà di questa rappresentazione è questo concetto.
Lo spirito serve a dire: se io ho soltanto una percezione, se io ho soltanto una rappresentazione ho una mezza realtà, non ho una realtà completa. Ho una realtà completa quando io, in chiave di pensiero, ci aggiungo il concetto; però, se io ho soltanto il concetto di una cosa senza una rappresentazione, che presuppone la percezione, ho di nuovo una mezza realtà non una realtà completa.
L’uomo è strutturato in modo tale che per avere una realtà completa deve congiungere l’elemento di percezione – che compie sul suo corpo, sulla sua anima, sul suo spirito – con l’elemento di concetto.
L’unilateralità dello spiritualismo è che vorrebbe trovare la realtà senza la percezione.
L’unilateralità del materialismo è che vorrebbe avere la realtà senza il concetto, e pensa di avere nella percezione una realtà completa.
L’affermazione sul tavolo esterno, fuori di me, diventa in me quella metà di realtà – la percezione – che diventa completa soltanto se ci aggiungo il concetto. Allora diventa una realtà completa.
L’essere umano è quell’essere che scinde la realtà in due metà di non realtà. Scindendo ha dalla parte della percezione una non realtà (perché la percezione è soltanto metà della realtà) e dalla parte del concetto ha ancora una non realtà (perché il concetto è di nuovo soltanto la metà della realtà). Unicamente quando congiunge insieme percezione e concetto ha la realtà completa.
Allora, quando uno mi dice: il tavolo là fuori è una realtà, io gli rispondo: è una realtà soltanto se tu mi dici qual è il lato di percezione e qual è il concetto.
Voi direte: ma che cosa aggiunge il concetto al tavolo che sta là? È già completo! Il tavolo, senza il concetto di tavolo, non è nulla!! È il concetto che ha messo insieme quelle gambe e la tavola sopra. Il tavolo è un concetto diventato visibile, ma senza il concetto non ci sarebbe nessun tavolo percepibile. Il tavolo diventa percepibile soltanto per il fatto che c’è stato il concetto di tavolo. Questo è il discorso che stiamo facendo.
Quindi non è vero che io, nella percezione, ho soltanto il tavolo materiale, perché disattendo il fatto che dicendo «tavolo», ho anche il concetto di tavolo. Dicendo «tavolo» io ho la percezione e il concetto, allora sì che ho una realtà. Però è importante capire che ho una realtà, perché dicendo «tavolo» ci aggiungo il concetto, e il concetto è la realtà. Finché non è sorto nell’umanità il concetto di ruota, o di tavolo, non ci sono mai state ruote o tavoli percepibili.
Intervento: Tu dici che se non c’è il concetto non è completa la definizione di quella realtà che vedo fuori. Stavo pensando non al tavolo, ma al caso della rosa, al profumo e quindi al lato percettivo che è importante. Il concetto di rosa va bene, ma quando io poi la completo col discorso del profumo è ancora più vera, più completa, no? Quindi in questo caso il lato della percezione è molto importante.
Archiati: No, non ci siamo capiti.
Replica: Mi riferisco anche all’esistenzialismo che diceva: la rosa è una rosa, il concetto di rosa è pieno di tanti particolari, tra i quali il profumo, la bellezza e cose varie. Qual è il concetto di rosa di per sé?
Archiati: Guarda non ci siamo capiti. Il discorso non è che io ti voglio proibire di goderti il profumo della rosa, non è questo. Io ti dico che tu il profumo della rosa non lo potresti mai godere perché non ci sarebbe nessuna rosa profumata se non fosse sorto nel pensare divino, o in quello che vuoi, il concetto di rosa, perché senza il concetto di rosa non nasce nessuna rosa.
Il concetto di rosa è quel tipo di pensare che configura l’etericità del vivente con la struttura di rosa e col profumo di rosa, col colore ecc. Soltanto in base a quel pensiero, che ti struttura il vivente con le leggi specifiche della rosa, ti è dato di avere una rosa. Cos’è che dal suolo, che è uguale per tutte le piante, fa saltar fuori proprio una rosa? È quel pensiero vivace, operante, che struttura l’eterico in forma di rosa, e gli dà la forza di raccogliere e prendere tutti i succhi, tutti i materiali che servono alla rosa, che fanno parte del concetto di rosa, e lasciar stare gli altri, in modo da strutturare la materia in forma di rosa. Altrimenti tu, il profumo, te lo puoi sognare.
In altre parola cos’è la causa reale della rosa? Il concetto!
Intervento: L’idea.
Archiati: Sì, l’idea è un concetto più complesso.
Intervento: L’idea creativa della rosa iniziale è la cosa più importante rispetto a tutti gli altri particolari?
Archiati: È la realtà della rosa che muove i succhi, i minerali del suolo in un modo rosaceo.
Replica: In maniera specifica da creare la rosa, insomma.
Archiati: Sì. Quindi vedete che gli esercizi di pensiero che ci portano al punto di vedere la realtà operante dei concetti sono molto importanti, sono fondamentali, non all’acqua di rose, perché se uno pensa che l’essenza della rosa sia la materia, i minerali, si sbaglia di grosso, perché la rosa in quanto materia oggi c’è e domani è sparita. Come ne sorge una nuova?
Intervento: Chiedo scusa, forse dirò un banalità. Prescinde comunque da un progetto iniziale?
Archiati: Cosa intendi per progetto iniziale?
Replica: La percezione che io ho di tavolo non è una percezione astrale è una percezione fisica, che prescinde, a mio avviso, da un progetto. Ho capito forse male?
Archiati: La domanda è: che cosa ha conferito realtà al tavolo?
Replica: Colui che l’ha eseguito.
Archiati: E cosa intendi per progetto?
Replica: Progetto in senso fisico, intendo, ossia dell’ingegnere che ha tirato fuori il disegno, e dell’artigiano che l’ha fatto.
Archiati: E il disegno che cos’è? È un pensiero, è un concetto!
Replica: Certo, sono d’accordo.
Archiati: Ma di questo stiamo parlando. Il pensare è una realtà o no?, questa è la domanda di fondo. È talmente reale che senza il pensare non ci sarebbe nessun tavolo, nessuna rosa, nessun tulipano. Nulla! Il cosiddetto pensare, i concetti, sono realtà assolute, molto più operanti che non la cosiddetta materia.
IV,22 «Non vedo soltanto un albero, ma so anche che sono io che lo vedo».
(IV,22) Riconosco inoltre che qualcosa avviene in me, mentre osservo l’albero. Se l’albero scompare dal mio campo visivo, nella mia coscienza rimane una traccia di quel processo: un’immagine dell’albero {adesso stiamo passando dalla percezione alla rappresentazione}. Questa immagine, durante la mia osservazione, si è legata con il mio sé {col mio io, si è collegata con me}.
Quindi, come la percezione era un’interazione tra i miei sensi corporei e l’albero cosiddetto là fuori, così ciò che rimane in me quando mi giro è qualcosa che percepisco in me: l’immagine dell’albero. E l’immagine dell’albero, nella terminologia filosofica, viene chiamata la rappresentazione dell’albero.
(IV,22) Il mio sé si è arricchito: il suo contenuto ha accolto un nuovo elemento. Io chiamo tale elemento la mia rappresentazione dell’albero. Non arriverei mai a poter parlare di rappresentazioni se non le sperimentassi nella percezione del mio sé {del mio interno, della mia anima, chiamatelo come volete. Quindi le rappresentazioni le percepisco in me, sono io ad averle}. Le percezioni andrebbero e verrebbero: io le lascerei passare.
La percezione dell’albero viene e scompare: quando io vado via dall’albero la percezione non c’è più. Invece la rappresentazione rimane in me, e anche se la dimentico è passibile di rammemorazione. Rimane in me. Se volete, tecnicamente il dimenticare significa far cadere dall’astrale nell’eterico: una rappresentazione dimenticata è caduta dall’astrale nell’eterico, però è sempre passibile di essere ripescata e riportata nell’astrale, e quindi ritornare a coscienza.
(IV,22) Solo per il fatto che io percepisco il mio sé e osservo che con ogni percezione si modifica anche il contenuto di esso {poiché aggiungo rappresentazioni}, mi vedo obbligato a mettere in relazione l’osservazione dell’oggetto col mio proprio cambiamento di stato e a parlare di una mia rappresentazione.
Non ho soltanto la percezione dell’albero, che ci può essere solo in presenza dell’albero e che scompare quando non sono in presenza dell’albero, ma ho, diciamo, un albero incamerato nel mio interno, nella mia anima, che è la rappresentazione dell’albero: e quella c’è sempre, resta con me, fa parte di me. Quando io dico «albero» – qui in sala non abbiamo la percezione di un albero –, cosa viene evocato in voi? La rappresentazione dell’albero, è chiaro. In base ai tipi di albero che ognuno ha percepito. Ci possono essere esseri umani senza la rappresentazione dell’albero?
Intervento: Chi ha vissuto sempre e solo nel deserto.
Archiati: Oppure gli eschimesi che hanno visto soltanto neve, soltanto igloo, e non hanno mai visto alberi. Quindi una persona che non avesse mai avuto la percezione di un albero non potrebbe averne neanche la rappresentazione. La rappresentazione presuppone la percezione.
Intervento: Parlando di rappresentazione ci si riferisce a quell’albero in particolare, o all’albero in generale?
Archiati: Se tu ne hai percepito uno solo, hai soltanto la rappresentazione di quell’albero. Se ne hai visti cento, nella tua rappresentazione dell’albero hai ciò che tutti questi cento alberi hanno in comune. Che cosa hanno in comune cento alberi? Due cose fondamentali: un tronco e una chioma. Quindi, se tu hai la rappresentazione di un albero e ne hai visti diversi, la tua rappresentazione deve avere un tronco e una chioma: se la chioma è più grossa o più piccola dipende da come era la maggioranza degli alberi che tu hai percepito.
Replica: Parlando poi di concetto, cosa c’è in più rispetto alla rappresentazione?
Archiati: Continueremo a fare questi esercizi, soprattutto al capitolo V. Un piccolo anticipo: una differenza fondamentale tra percezione e concetto è che la percezione non distingue tra ciò che è essenziale all’albero e ciò che è accidentale. Mi dà tutto, senza distinzione.
Creare il concetto significa mettere in moto un processo di pensiero che distingue, scevera ciò che in un albero è accidentale – direbbe Aristotele –, quindi non fa parte dell’essenza dell’albero, da ciò che è essenziale, dall’essenza, quindi da quegli elementi che non possono mancare. Il concetto è l’essenza.
Se noi adesso ci chiedessimo – sarebbe un esercizio di pensiero non da poco perché dovremmo andare per sfumature – quali sono gli elementi essenziali per avere un albero, siccome ci troviamo a interagire con un fattore di linguaggio (albero è una parola italiana, in inglese, per esempio, si dice tree), non è detto che il concetto di albero nel linguaggio italiano ritenga esattamente gli stessi tratti essenziali del concetto di tree. Quindi la domanda è: il linguaggio inglese che cosa ritiene essenziale per avere un tree e cosa, invece, non essenziale? E il linguaggio italiano che cosa ritiene essenziale per avere un albero e cosa no? Mettiamo che io devo imparare l’italiano e quindi non lo so: trovo nel vocabolario «albero», leggo la spiegazione e vi compare la parola «pianta»: sono due concetti diversi?
Intervento: Sì!
Archiati: Sì, dimmi che diversità c’è.
Replica: Oddio…
Archiati: L’albero è un albero, la pianta è una pianta! Grazie! Vedi la complessità? Tu pensavi di partire in quarta, e ti sei fermato. Finché noi non prendiamo soltanto gli elementi essenziali, ma consideriamo l’albero come percezione, a livello di percezione la pianta è un albero e l’albero è una pianta. Ma a livello di concetto devi tirarmi fuori, devi sceverare tutti gli elementi non essenziali, accidentali, e dirmi l’essenza. Cosa non può mancare perché sia una pianta, e cosa non può mancare perché sia un albero. Quindi qual è la differenza?
Intervento: In questo caso abbiamo la radice, il fusto, lo stelo, le foglie per la pianta, e la chioma per l’albero…
Intervento: Allora il rosmarino è uguale all’acero.
Replica: E no!
Archiati: Io da straniero, vengo dall’Inghilterra, non so nulla di italiano, ti ho chiesto di spiegarmi la differenza tra albero e pianta. Guarda che è difficile: sto evidenziando che, finché noi ci lasciamo aiutare dal linguaggio, ogni parola è un concetto e andiamo sicuri perché sappiamo, più o meno, cosa vuol dire albero e cosa vuol dire pianta. Me se poi si chiede a me, in chiave di pensiero, di creare il concetto di albero in quanto diverso dalla pianta… campa cavallo che l’erba cresce! Ce n’è di cammino di pensiero da fare per tirar fuori veramente il concetto puro di albero e di pianta. Quindi la differenza tra la percezione e il concetto è che la percezione mi dà tutto, senza distinguere ciò che fa parte dell’essenza e ciò che, pur essendoci, è accidentale. Il concetto, invece, mi dà l’essenza, ciò che è essenziale all’albero.
Intervento: Quindi il concetto è una definizione, è la definizione dell’albero.
Archiati: Sì, definizione è un sinonimo di concetto, cosa non facile perché è un processo di pensiero. E la percezione non ti serve a nulla, perché ti confonde tutto insieme ciò che essenziale, e fa parte della definizione, e ciò che non ne fa parte.
Intervento: Vorrei finire, per favore, perché io ero partita chiedendo la differenza fra concetto e rappresentazione, non fra concetto e percezione.
Archiati: La rappresentazione mi dà una farragine, mi dà tutto un insieme che non distingue tra ciò che è essenziale e ciò che è secondario.
Replica: Cioè, me la posso immaginare come una via in cui sono nel mezzo e vado verso il concetto.
Archiati: Allora la dico in un altro modo: la percezione mi dà questo albero, il concetto mi dà l’albero. Il concetto mi dà l’albero che è in tutti gli alberi, e quindi dev’essere l’essenziale dell’albero; la percezione me ne dà soltanto uno: questo albero.
Intervento: Ma lei vuol sapere della rappresentazione e tu continui a parlare di percezione.
Archiati: Eh, ma la rappresentazione è la copia interiore della percezione!
Intervento: Allora gli animali hanno percezione, riconoscono una persona, riconoscono il padrone.
Archiati: No, no, è una sensazione.
Replica: È solo attraverso la sensazione che riconoscono il padrone?
Archiati: Sì, non esiste alcuna percezione. È importante, è importante.
Replica: E l’anima di gruppo degli animali, allora, neanche c’è?
Archiati: L’anima di gruppo non ha un corpo per percepire, quindi nell’anima di gruppo c’è il concetto.
Replica: Non c’arrivo a tutto questo.
Intervento: L’animale si reincarna?
Archiati: L’animale non è un individuo singolo, tutti i lupi hanno un’unica «anima di gruppo», così la chiama Steiner, Aristotele la chiamava la species, la specie del lupo. Quindi ogni volta che un lupo muore, quel frammento di astralità che era dentro quel lupo ritorna nell’anima di gruppo, e quest’anima di gruppo, che è una sola per tutti i lupi, si crea un altro corpo. L’anima di gruppo del lupo è un essere spirituale che crea ogni volta una materia fatta come è fatto il lupo. Ma restiamo nell’umano, che già è complesso, lasciamo da parte quel che vive l’anima di gruppo dei lupi o dei cani.
Replica: Giusto, hai ragione.
Intervento: Dicevamo albero in italiano e tree in inglese: non è detto che nelle due lingue si abbia lo stesso concetto.
Archiati: Non è esattamente lo stesso.
Replica: Io mi chiedevo se questo passaggio del concetto è legato per forza di cose all’elaborazione del linguaggio. Il concetto di forchetta, in tutto l’occidente è scontato, nelle sue linee essenziali: sappiamo a che cosa serve. Se porto lo stesso strumento in un villaggio sperduto in Cina, probabilmente non sanno che cos’è quello strumento, perché hanno il concetto di bacchette, mangiano con le bacchette. Quindi il concetto è comunque un’elaborazione del linguaggio e del pensare.
Archiati: Guarda che stai semplificando un po’ le cose, eh? È un po’ più complesso di quello che tu dici. Prendiamo la parola forchetta in tre linguaggi:
forchetta fork gabel
italiano inglese tedesco
Adesso io vi chiedo: ho qui un attrezzo con due denti.

Fig.12
È una forchetta? Bastano due denti, due rebbi, per fare una forchetta?
Intervento: Sì.
Intervento: No, ce ne vogliono almeno tre.
Archiati: In tedesco bastano, perché il concetto Gabel è stato formato in base alla parola Gabelung, che è una strada che dopo un certo tratto si divide in due. Allora, siccome alla base di questo concetto c’è una biforcazione, bastano due. Però può darsi che in un altro linguaggio il concetto di forchetta preveda almeno tre rebbi.
Il linguaggio è un oscillare, è una specie di intesa fra il pensare puro e cosa comunemente intendiamo per forchetta. Se noi ci mettiamo d’accordo che abbiamo una forchetta anche quando ci sono due rebbi, allora possiamo chiamare forchetta anche quella che ho disegnato. Se invece il popolo italiano si è messo d’accordo e vive il concetto di forchetta in modo tale che, per essere una forchetta, deve avere almeno tre rebbi, allora sono essenziali tre rebbi: quattro o cinque rebbi sono accidentali, ma gli essenziali sono tre. In tedesco, per il fatto stesso da cui è sorta la parola, bastano due.
Intervento: Il forcone per il letame ha due rebbi. Quello disegnato è un forcone.
Archiati: Il forcone, che è grosso, ha soltanto due rebbi, la forchetta, che è più piccola, deve averne di più. C’è qualcuno di lingua inglese, qui? Bastano due denti per una forchetta?
Intervento: In inglese, per la musica c’è il fork.
Archiati: Ah, il diapason lo chiamano: tuning-fork, «la forchetta che intona». E per la forchetta da mangiare?
Replica: Mmmm.
Archiati: È indecisa, lei, non è una cosa semplice. Anche lui non era sicuro se in tedesco ne bastano due.
Replica: In inglese due rebbi non sono sufficienti per una posata.
Archiati: Sta saltando fuori che la percezione è un fenomeno di estrema semplicità rispetto ai concetti che crea il pensare, perché la percezione di volta in volta è così com’è! Se una forchetta ha due rebbi, la percezione mi dice: due rebbi. Non c’è problema. Quando invece io entro in chiave di pensiero per trovare il concetto, la cosa diventa molto più complessa, perché devo distinguere tra ciò che è essenziale e ciò che non è essenziale. Questo rovellìo di distinguere sempre meglio è quello che fa camminare, che fa evolvere il pensiero al massimo. Il pensare è l’organo che coglie l’essenza delle cose, perché l’essenza è quella che le ha create.
Intervento: Una ragazza qui aveva detto che nel deserto, o al Polo, un albero non avrebbe potuto essere percepito. Ma la fantasia non può supplire? Un essere umano, anche se non ha avuto la percezione, può dentro di sé avere un’idea che viene fuori tramite la fantasia?
Archati: La risposta alla tua domanda è molto precisa, e ve l’ho data già diverse volte portando l’esempio, che a me è capitato in Laos, di alunni delle elementari che non avevano mai visto un ascensore.[18]
Io gli dicevo: esiste una cosa che, se tu ci vai dentro, ti porta su, poi esci fuori e sei in alto. Quando non c’è la rappresentazione tu puoi creare il concetto, cioè senza percezione puoi avere il concetto di una cosa, ma senza la percezione non puoi mai avere una rappresentazione di quella cosa. Pensaci, riflettici! Come fai ad avere una rappresentazione senza percezione?
Replica: Ma questa è la domanda che facevo io, perché mi hanno raccontato di un ragazzo che ha sognato di fare l’amore. L’amico gli diceva: ma l’hai mai fatto? No, gli ha risposto. E quello gli ha detto: allora non ci credo.
Archiati: No, no, no, il fatto che non lo abbia mai fatto lui, non significa che non ne aveva mai avuto la percezione. Per esempio, la percezione di un ascensore tu la puoi avere sfogliando un libro illustrato. Tu guardi l’immagine sul libro e hai la percezione.
Replica: Sì, ma questo ragazzo ha detto che non aveva neanche mai visto i genitori fare all’amore. Allora io voglio sapere se è possibile che il cervello umano, anche se non ha un’immagine, può comunque per intuizione, per fantasia… io, per esempio, non ho mai visto un unicorno però me lo posso immaginare.
Archiati: Tu l’unicorno l’hai visto sui libri!
Intervento: Se io ti dico il nome di una cosa che non hai mai visto, come te la immagini?
Replica: Non avete risposto alla mia domanda: è possibile che un cervello umano, tramite la fantasia, possa creare un’immagine di una cosa che non ha mai visto?
Archiati: Certo, ma allora è un’immagine di fantasia, non è…
Replica: Va bene, mi basta questo.
Archiati: Ma scusa, la fantasia te l’ho messa prima nello schema quando dicevo che l’interazione tra anima e spirito – quindi non c’entra il corpo –, crea l’immagine nella fantasia. Però le immagini nella fantasia non hanno nulla a che fare con le percezioni sensibili. Se tu parli di immagini della fantasia non stai parlando di rappresentazioni: le rappresentazioni sono sempre l’immagine di una percezione esterna impressa internamente.
Replica: Ho capito. Quindi la fantasia può avere immagini che la realtà non ha. È superiore alla realtà.
Archiati: No, esula dal mondo della percezione.
Intervento: Leonardo Da Vinci non ha disegnato degli strumenti che non esistevano?
Archiati: E quindi li ha creati, è un fenomeno di fantasia non di rappresentazione.
È strabiliante! Un testo così filosofico, ostico, noioso, e noi ne facciamo una discussione così accalorata! Sono felicissimo! Sono felicissimo!
Intervento: Bravo! Anche noi.
Archiati: Bravi voi.
IV,23 Io percepisco la rappresentazione nel mio sé allo stesso modo in cui percepisco, negli altri oggetti, colori, suoni e così via {la rappresentazione che ho dentro di me la percepisco come percepisco l’albero che sta là fuori}. Posso anche fare una differenza chiamando questi altri oggetti, che stanno di fronte a me, col nome di mondo esteriore, mentre chiamo il contenuto della percezione del mio sé {con tutte le sue rappresentazioni} col nome di mondo interiore.
Il mondo esteriore mi dà una serie di percezioni, il mondo interiore mi dà una serie di rappresentazioni. Semplice, la cosa. Nel mondo là fuori ho un’infinità di percezioni; quando guardo la mia anima ho un’infinità di rappresentazioni, e se poi ci aggiungo la fantasia posso creare anche immagini che non ho mai visto fuori, tutta roba che trovo nel mio mondo interiore.
Quindi distinguo tra mondo esteriore, che mi interpella in chiave di percezione, e mondo interiore, quello che porto dentro di me. Per avere la percezione dell’albero ho bisogno del mondo esteriore, dell’albero esteriore; per avere la rappresentazione dell’albero ho bisogno di me, essa c’è sempre dove sono io.
(IV,23) Il misconoscimento {il fraintendimento} dei rapporti tra rappresentazione e oggetto ha portato i più grandi equivoci nella filosofia moderna. Si è messo in evidenza il mutamento che avviene in noi, la modificazione che il mio sé sperimenta {in chiave di rappresentazione} e si è perduto completamente di vista l’oggetto che provoca la modificazione. Si è detto: «Noi non percepiamo gli oggetti, ma soltanto le nostre rappresentazioni.
Un momento, ma allora tu hai dimenticato che la tua rappresentazione dell’albero è sorta soltanto perché hai avuto la percezione. E per avere la percezione hai bisogno del mondo esterno. Allora questi filosofi si sono concentrati sull’io, sul sé, lì ci sono soltanto rappresentazioni, e hanno detto: ma allora io, del mondo, ho soltanto le rappresentazioni. E hanno dimenticato che all’origine della rappresentazione ci deve essere assolutamente la percezione, e perché ci sia la rappresentazione c’è bisogno del mondo esteriore.
IV,23 Si è detto: «Noi non percepiamo gli oggetti, ma soltanto le nostre rappresentazioni.
(IV,23) Io non posso saper nulla della tavola in sé, che è oggetto della mia osservazione, ma solo del mutamento che avviene in me mentre percepisco la tavola».
Si è confuso, si è fatto un fascio unico di percezione e rappresentazione, e si è presa la percezione come se fosse subito, già in partenza, una rappresentazione. No, la percezione è un’interazione tra mondo esterno e mondo interno, invece la rappresentazione è un puro fatto di mondo interno, e la rappresentazione può esserci soltanto se c’è stata, previa, l’interazione col mondo esterno.
(IV,23) Questa concezione non deve essere confusa con quella di Berkeley prima ricordata. Berkeley afferma la natura soggettiva del mio contenuto percettivo, ma non dice che io posso conoscere soltanto dalle mie rappresentazioni.
Nel testo tedesco è scritto: «ma non dice che io posso sapere solo delle mie rappresentazioni», cioè che io posso conoscere solo le mie rappresentazioni. Berkeley non dice che io posso conoscere solo le mie rappresentazioni. Invece quest’altra opinione, che stiamo vedendo adesso, dice: io posso conoscere soltanto le mie rappresentazioni delle cose. Delle cose in sé non conosco nulla, non ho nulla, ho soltanto le rappresentazioni.
(IV,23) La mia conoscenza rimane per lui limitata alle mie rappresentazioni, in quanto egli ritiene che non vi siano oggetti al di fuori del campo delle rappresentazioni.
Intervento: Nega la realtà.
Archiati: Ecco, questa è la posizione che tu dicevi prima, ed è quella che Steiner sta cercando di controbattere, sostanzialmente. Questa posizione nega direttamente la realtà del percepito perché dice: io ho soltanto le rappresentazioni, esistono soltanto le rappresentazioni.
(IV,23) Ciò che io vedo come tavola, non esiste più – nel senso di Berkeley – appena io non vi dirigo più lo sguardo. Perciò Berkeley fa sorgere le mie percezioni direttamente attraverso la potenza di Dio. Io vedo una tavola perché Dio suscita in me tale percezione. Berkeley non conosce quindi altri esseri reali fuorché Dio e gli spiriti umani {questa è la negazione diretta di ogni realtà oltre lo spirito umano e lo spirito divino}. Ciò che noi chiamiamo mondo esiste solo dentro gli spiriti.
In altre parole, la realtà viene creata tutta a partire dallo spirito. Invece la tesi di Steiner è che, per l’uomo, la realtà si compone congiungendo il dato di percezione e il concetto.
Intervento: Il dato di percezione presuppone qualcosa di esterno, cosa che Berkeley invece nega.
Archiati: Sì, e senza poter fare nessuna affermazione contenutistica rispetto a questo qualcosa.
(IV,23) Quello che l’uomo semplice {l’uomo ingenuo} chiama mondo esterno, natura corporea non esiste, per Berkeley {non per Steiner, però}. Contro questa concezione sta quella kantiana, ora dominante, che limita la nostra conoscenza del mondo alle nostre rappresentazioni, non perché sia convinta che non vi possano essere altre cose al di fuori di queste rappresentazioni, ma perché ritiene che noi siamo organizzati in modo da poterci rendere conto soltanto delle modificazioni del nostro proprio sé, non però delle cose in sé che producono queste modificazioni {quindi non nega la cosa in sé dell’albero, ma dice che non è conoscibile: conoscibile dell’albero è soltanto la rappresentazione}. Dalla circostanza che io conosco soltanto le mie rappresentazioni i kantiani non deducono che non vi sia nessun’altra esistenza indipendente da quelle rappresentazioni, ma soltanto che il soggetto non può accogliere {non può conoscere} tale altra esistenza direttamente in sé, «può soltanto, per mezzo dei suoi pensieri soggettivi, immaginarla, fingerla, pensarla, conoscerla, forse neppure conoscerla!» (cfr. O. Liebmann, Per l’analisi della realtà, pag. 28). Con questo credono di dire qualcosa di assolutamente certo, qualcosa che non ha bisogno di nessuna dimostrazione. «Il primo punto fondamentale, che il filosofo deve portare in se stesso a chiara coscienza, consiste nel riconoscere che il nostro sapere non si estende da principio al di là delle nostre rappresentazioni {proprio per principio non possiamo andare oltre le nostre rappresentazioni}. Le nostre rappresentazioni sono l’unica cosa che noi direttamente apprendiamo e sperimentiamo; e appunto perché le apprendiamo direttamente, il dubbio più radicale non può sottrarci la conoscenza di esse.
Siccome portiamo dentro di noi le nostre rappresentazioni delle cose, lì andiamo sicuri: la rappresentazione dell’albero che un individuo porta in sé, è così com’è, non ci sono dubbi. E ognuno sa benissimo quale rappresentazione dell’albero ha.
(IV,23) Invece la conoscenza che va al di là delle nostre rappresentazioni – prendo la parola rappresentazioni nel senso più largo, facendovi rientrare qualunque fatto psichico {stiamo ancora leggendo la citazione, eh?} – non è protetta contro il dubbio.
Quindi, dice la concezione kantiana, io sono immune dal dubbio soltanto quando parlo delle mie rappresentazioni; quando parlo di altre cose, di realtà oltre le mie rappresentazioni, sono soggetto al dubbio, sono soggetto all’errore perché non sono sicuro di cosa sto parlando. Sono sicuro soltanto quando parlo delle mie rappresentazioni, perché ce le ho, e sono così come sono.
(IV,23) Perciò all’inizio del filosofare deve essere posto esplicitamente come incerto ogni sapere che vada al di là delle rappresentazioni». Così comincia Volkelt il suo libro La teoria della conoscenza di Emanuele Kant.
Quindi l’assunto fondamentale di Kant è: io conosco soltanto le mie rappresentazioni. Che ci sia dietro la rappresentazione una cosa in sé, l’albero in sé, può darsi, ma una conoscenza certa della cosa in sé non ci può essere. Certezza c’è soltanto riguardo alle rappresentazioni: questo è il dogma di Kant.
(IV,23) Quello che così è esposto come verità immediata e evidente, è però in realtà il risultato di un ragionamento che procede come segue {segue adesso una citazione di Eduard von Hartmann}: «L’uomo primitivo crede che gli oggetti, quali egli li percepisce, esistano anche al di fuori della sua coscienza {mica mi vuoi negare l’esistenza dell’albero là fuori?, dice l’uomo primitivo}. Ma la fisica, la fisiologia e la psicologia sembrano invece insegnare che per le nostre percezioni è necessario il nostro organismo,
Senza l’occhio non c’è la percezione visiva dell’albero, senza l’udito non c’è la percezione del suono, senza il naso non c’è la percezione del profumo della rosa. Che cosa ho, io, allora, della rosa? Soltanto sensazioni, e l’origine delle sensazioni non è la rosa, sono i miei sensi, perché senza olfatto per me la rosa sarebbe senza profumo. Cosa ho, io, allora, della rosa?
(IV,23) e che, di conseguenza, non possiamo sapere nulla di alcuna cosa, fuorché quanto ci fornisce il nostro organismo {io non conosco la rosa, non percepisco la rosa, percepisco la filtrazione della rosa operata dal mio organismo}. Le nostre percezioni sono perciò modificazioni del nostro organismo, non cose in sé» {quindi io percepisco modificazioni del mio naso, modificazioni dei miei occhi, modificazioni del mio orecchio ecc., ma non una cosa fuori di me}. Il ragionamento qui accennato è infatti quello che, secondo Eduard von Hartmann, deve portare alla convinzione della fondatezza del principio che noi non possiamo avere una conoscenza diretta se non delle nostre rappresentazioni (cfr. la sua opera Il problema fondamentale della teoria della conoscenza, pag. 16-40). Poiché noi troviamo, fuori del nostro organismo, delle vibrazioni dei corpi e dell’aria che ci si presentano come suono, se ne deduce che ciò che chiamiamo suono non è altro che una reazione soggettiva del nostro organismo di fronte a quelle vibrazioni del mondo esteriore.
Quindi il suono è creato dall’orecchio: cos’è la realtà oggettiva esterna del suono? Vibrazioni nell’aria. Che c’entra la vibrazione dell’aria col suono? L’orecchio trasforma le vibrazioni dell’aria in suono. Quindi cos’è il suono? È un fatto del tutto fisiologico – dicono loro.
(IV,23) Allo stesso modo si deduce che colore e calore sono soltanto modificazioni del nostro organismo; in particolare si è d’opinione che questi due generi di percezioni vengano suscitati in noi dall’azione di processi nel mondo esteriore che sono completamente diversi da ciò che è esperienza di calore o di colore. Quando questi processi eccitano i nervi della mia pelle, ho la percezione soggettiva del calore, quando colpiscono il nervo visivo {ottico}, percepisco luce e colore. Luce, colore e calore sono dunque il modo {fisiologico e soggettivo} di reagire dei miei nervi di senso agli stimoli esterni.
Che cos’è il colore fuori dal mio occhio? Non lo so. Io ho soltanto il colore nel mio occhio. C’è il colore fuori dal mio occhio? C’è il colore senza l’occhio? Sono pensatori di grosso calibro, eh, che hanno messo in moto questa filosofia.
(IV,23) Anche il senso del tatto non mi trasmette gli oggetti del mondo esterno, ma soltanto le mie proprie reazioni {perciò dicevo: quando do una pedata a questo podio io ho una percezione tattile. Cosa ho, io, del podio quando ho questa percezione tattile? Percepisco soltanto un evento fisiologico nel mio piede che, attraverso il sistema nervoso, si comunica a tutto l’organismo e viene portato a coscienza}. Secondo la fisica moderna, si potrebbe credere che i corpi siano composti di particelle infinitamente piccole, dette molecole, e che queste molecole non siano immediatamente a contatto le une con le altre, ma abbiano certe distanze fra loro. Tra di esse vi è dunque lo spazio vuoto, e attraverso di questo agiscono le une sulle altre per mezzo di forze di attrazione e di repulsione. Quando io avvicino la mia mano ad un corpo, le molecole della mia mano non toccano affatto le molecole del corpo direttamente, ma rimane una certa distanza fra mano e corpo, e quello che io sento come resistenza del corpo non è che l’effetto della forza repulsiva che le sue molecole esercitano sulla mia mano. Io rimango in tutto e per tutto al di fuori del corpo e percepisco soltanto la sua azione sul mio organismo {quindi, cos’è una percezione tattile? È la percezione di un evento dentro il mio organismo}.
IV,24 A completamento di queste considerazioni, accenneremo alla teoria che Joannes Müller (1801-1858) ha escogitato sulle cosiddette energie specifiche dei sensi. Essa sostiene che ogni senso ha la particolarità di rispondere a qualsiasi stimolo esterno in un’unica determinata maniera. Quando si esercita un’azione sul nervo ottico si ha sempre una percezione luminosa, tanto se l’eccitazione del nervo è prodotta da ciò che chiamiamo luce, quanto se è prodotta da una pressione meccanica o da una corrente elettrica.
Che sia una pressione meccanica, che sia un evento di luce o che sia una corrente elettrica, basta che venga a contatto col nervo ottico ed ecco che sorge in noi fisiologicamente una percezione visiva. Per avere una percezione visiva basta un esercizio di pressione fatto sul nervo ottico: basta che io tocchi il nervo ottico in qualsiasi modo e salta fuori un’immagine visiva, una rappresentazione visiva.
(IV,24) Viceversa uguali stimoli esterni suscitano, nei diversi sensi, percezioni diverse.
Uguali stimoli esterni. Supponiamo che noi facciamo uno stimolo di pressione uguale sul nervo ottico, sul nervo acustico, sul nervo olfattivo: pur essendo questo stimolo lo stesso sui tre, il nervo ottico produce un’immagine visiva, il nervo acustico produce un’esperienza sonora e il nervo olfattivo produce un odore. Ma l’impulso esterno era lo stesso. Quindi l’esperienza della sensazione è generata dall’organismo, non dalla cosa in sé, perché la cosa in sé è uguale per tutti e tre i sensi. La pressione è uguale, però le energie specifiche del nervo ottico creano sempre un’immagine visiva, le energie specifiche del nervo acustico creano sempre il sentire un suono, e le energie specifiche del nervo olfattivo creano sempre un’esperienza di olfatto. Le nostre percezioni sono perciò modificazioni del nostro organismo, non cose in sé.
(IV,24) Da questo sembra derivare che i nostri sensi ci possono fornire soltanto quello che in essi medesimi si produce, ma nulla del mondo esterno. Essi determinano le percezioni, ciascuno secondo la sua propria natura.
IV,25 La fisiologia insegna che però non è lecito parlare nemmeno di una diretta conoscenza di ciò che gli oggetti provocano nei nostri organi di senso.
Perché noi non abbiamo la percezione diretta di ciò che avviene nell’occhio, non abbiamo la percezione diretta di ciò che avviene nell’orecchio e non abbiamo la percezione diretta di ciò che avviene nel naso. Adesso io vi chiedo: pensate al colore rosso. Ve lo immaginate il rosso? Certo che ve lo immaginate. È dentro l’occhio? No, no, è una rappresentazione nell’animo, perché altrimenti dovremmo percepire i processi dentro l’occhio per percepire il rosso.
Quindi ciò che avviene nei nervi ottici non c’entra nulla: io ho l’immagine, la rappresentazione del rosso, senza aver bisogno di entrare nel merito di ciò che avviene dentro l’occhio, se no non arriverei mai ad avere l’immagine, la rappresentazione del rosso. La fisiologia dà l’ultimo colpo per far sparire ogni oggettività del mondo.
(IV,25) Quando il fisiologo segue i processi nel nostro proprio corpo, trova che già negli organi di senso le azioni delle vibrazioni esterne vengono trasformate nel modo più svariato. Questo appare nel modo più evidente nell’occhio e nell’orecchio: essi sono entrambi organi assai complicati che trasformano sostanzialmente lo stimolo esterno prima di trasmetterlo al nervo corrispondente. Dall’estremità periferica del nervo lo stimolo così trasformato viene poi trasmesso al cervello, del quale devono venire eccitati a loro volta gli organi centrali.
Cosa c’è nel cervello dello stimolo visivo? Io ho visto un albero: questa percezione dell’albero va fino al cervello per portarlo a coscienza. Dell’albero, nel cervello fisico, cosa c’è?
Intervento: La rappresentazione.
Archiati: No.
Intervento: La categoria.
Archiati: No. Sto parlando del cervello fisico!
Intervento: Un’onda.
Archiati: Sarà una pulsazione, un’onda... Noi possiamo percepire direttamente ciò che fisicamente avviene nel cervello? No, no, siamo onesti, via! Allora coraggio, eh, adesso l’ultimo coraggio per arrivare al punto che il mondo sparisce. Perché non deve essere a caso che il mondo orientale da sempre dice che il mondo esterno è illusione. Questa affermazione deve avere un suo fondamento, e adesso ci stiamo arrivando.
Intervento: Forse è per questo che alcuni artisti nell’antica Cina, che poi erano anche dei mistici, prima di dipingere un albero, si ponevano di fronte ad esso – questo per tornare al discorso della percezione, concetto e rappresentazione – per giorni, settimane e in alcuni casi mesi, e quando erano arrivati al punto che non avvertivano più la percezione esterna dell’albero, ma se lo sentivano dentro, allora a quel punto cominciavano a dipingerlo.
Archiati: Bene, bene. Ci arriviamo, eh, però dobbiamo oltrepassare tutta la serie fisiologica, lasciare dietro a noi anche il cervello per arrivare al colore, per arrivare al suono, per arrivare al profumo.
Allora: (IV,25) «Dall’estremità periferica del nervo lo stimolo così trasformato viene poi trasmesso al cervello, del quale devono venire eccitati a loro volta gli organi centrali». Perciò io stavo chiedendo: che cosa c’è nel cervello dell’albero là fuori? Prima di tutto devo rendermi conto che io, del cervello, non ho nessuna percezione, e stiamo parlando del cervello fisico non di quello metafisico.
(IV,25) Si vede dunque che il processo esterno, prima di arrivare alla coscienza, subisce una serie di trasformazioni. Quello che si svolge nel cervello è collegato col processo esterno per mezzo di tanti processi intermedi, che non si può più nemmeno pensare ad una somiglianza fra punto di partenza e punto di arrivo.
Come ci può essere una somiglianza tra l’albero che vedo, tutto bello formato con le foglie, e quello che avviene nel cervello? Nel cervello ci saranno magari delle onde, delle pulsazioni: c’è una parvenza di somiglianza tra quello che avviene nel cervello e l’albero che percepisco? No, quindi il cervello fa una trasformazione tutta sua del cosiddetto albero là fuori.
(IV,25) Quello che alla fine il cervello trasmette all’anima, non è né il processo esterno né il processo negli organi di senso, ma soltanto il processo all’interno del cervello {perché il cervello può trasmettere all’anima soltanto ciò che ha, non ciò che non ha}. Anzi neppure quest’ultimo l’anima percepisce direttamente {perché noi non abbiamo nessuna percezione del cervello}. Ciò che, alla fine, abbiamo nella coscienza non sono processi cerebrali, ma sensazioni {ho la sensazione del rosso, non di qualcosa che avviene nel cervello. E adesso sorge la domanda: da dove viene la sensazione del rosso?}. La mia sensazione del rosso non ha nessuna somiglianza col processo che avviene nel cervello quando io sento il rosso. A sua volta quest’ultimo si presenta nell’anima come effetto e viene soltanto causato dal processo cerebrale. Perciò Hartmann dice (Il problema fondamentale della teoria della conoscenza, pag. 37): «Quello che il soggetto percepisce sono sempre e solo modificazioni delle sue proprie condizioni psichiche, e nient’altro». Quando io ho le sensazioni, queste restano ancora per molto tempo non raggruppate in ciò che io percepisco come oggetto {perché se io ho la sensazione del verde, non ho l’albero verde che sta là fuori: la sensazione del verde non è l’albero verde là fuori, è la sensazione del verde}. Possono ad esempio essermi comunicate dal cervello soltanto sensazioni isolate. Le sensazioni di durezza o di morbidezza mi vengono trasmesse dal senso del tatto, quelle di colore e di luminosità dal senso della vista, eppure esse si trovano unite presso un unico e medesimo oggetto {un tavolo con una certa durezza o mollezza e con un colore e una luminosità}. Questa unione deve quindi essere effettuata soltanto dall’anima stessa. Cioè l’anima è quella che unisce insieme, facendone dei corpi, le sensazioni isolate trasmesse dal cervello. Il mio cervello mi fornisce isolatamente per vie del tutto diverse {per via dei nervi ottici, dei nervi olfattivi, dei nervi uditivi} le sensazioni visive, tattili e uditive che poi l’anima riunisce nella rappresentazione «tromba» {della tromba il nervo ottico mi trasmette l’immagine, il nervo acustico mi trasmette il suono, il nervo tattile la consistenza}. Questo termine finale di un processo (rappresentazione della tromba) è ciò che alla mia coscienza è dato come assolutamente primo {la tromba dovrebbe essere la realtà di partenza di tutto questo processo}. Non è possibile ritrovare in esso più nulla di quello che è fuori di me e che originariamente ha esercitato un’impressione sui miei sensi. L’oggetto esterno è andato completamente perduto, passando al cervello e dal cervello all’anima.
Buona notte, ci vediamo domani.
Sabato 23 agosto 2008, mattina
Una buona giornata a tutti quanti!
Ieri sera abbiamo fatto tutta la trafila della percezione partendo dall’albero, ma oggi mi sono ripromesso di mettere al centro un’altra percezione, una percezione di eccezione: e cioè cercherò di sceverare con voi il momento fatidico, la percezione fatidica (e qui in sala, in Italia più che in Germania, molte persone ricorderanno che nella loro vita c’è stata questa percezione) dove lei per la prima volta ha visto lui, oppure lui ha visto lei, e da quella percezione fatidica è saltato fuori un putiferio! Innamoramento, eccetera, eccetera, eccetera.
Oggi propongo di esaminare scientificamente cosa avviene al livello neurologico della percezione che impinge sull’occhio (non soltanto sull’occhio, supponiamo che ci sia anche il senso dell’olfatto che gioca un ruolo), rispettando i dati di scienza sperimentale, perché non si scappa da tutto ciò che la scienza rileva come dato reale, non ci son santi. Se mi dice che la pupilla viene affetta in un certo senso, va benissimo; poi l’immagine fatidica (le donne in sala sanno qual è l’immagine fatidica di lui, e i maschi sanno qual è l’immagine fatidica di lei) viene trasmessa dall’occhio al nervo ottico e lo cavalca perché da lì deve andare al cervello.
Come cavalca questa immagine sul nervo ottico? Io ho chiesto a tanti scienziati: ma spiegami bene, com’è che un’immagine cavalca su un nervo ottico? E loro mi dicevano: ma sei scemo? Arriva al cervello, punto e basta. Ma a me interesserebbe sapere come cavalca sul nervo ottico… Non me lo sapevano dire!
Adesso l’immagine è arrivata al cervello, e il cervello dice (il cervello, eh?, non io): eh, quella donna lì non è mica male! Sono meno competente a parlare di quello che dice il cervello femminile, ma è comunque il cervello che lo dice, è col cervello che noto: finché l’immagine non arriva al cervello non c’è nulla – quindi siamo al cervello, non siamo ancora all’essere umano.
Io ho chiesto a un neurobiologo, dopo aver letto una biblioteca intera di ricerche sui fenomeni del cervello sapendone meno di prima: cosa avviene nel cervello? Al livello sperimentale ci sono pulsazioni, ma quelle ci sono anche quando uno dorme. Si muovono forse più veloci quando c’è l’immagine fatidica? È il cervello che dice: quella donna lì mi piace? È il cervello che si innamora? Io non sono innamorato, è il mio cervello che lo è!
Se noi, oggi, arrivassimo scientificamente ad avere un minimo di sentore, a renderci conto che tante affermazioni pseudo scientifiche della scienza neurobiologica sono assolute assurdità, io tornerei in Germania ben felice. Il cervello viene messo lì come fosse un tipo intelligente, capace di innamorarsi e dire: quella donna lì mi piace. Io vi dico: più stupida di così l’umanità non potrà mai diventare, perché è un’assurdità assoluta.
Certo che nel cervello ci sono dei fenomeni, ma sono concomitanti all’operare di questo essere spirituale A che ha un’anima, che ha dentro di sé un portato karmico di pensieri pensati per secoli e per millenni, che ha un rapporto nel suo corpo astrale con questa persona B di cui vede l’immagine fatidica. Nella sua anima ci sono forze. Il suo Io superiore, il suo spirito, ancora prima di nascere ha deciso che a 30 anni, a 25 anni, avrebbe dovuto incontrare questa persona.
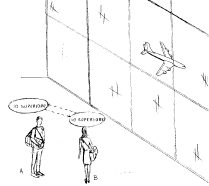
la percezione fatidica
Fig.13
Il suo spirito ha mosso tutti i passi per portarlo a quel punto, a quell’aeroporto dove ha visto quella donna, e quella donna da sempre lavora, opera nella sua anima con forze comuni a loro due.
Il suo Io superiore, il suo spirito, si è creato lui stesso il cervello con l’intento che, a 25 anni, grazie alla percezione e grazie al cervello, le forze karmiche comuni venissero portate alla coscienza ordinaria. E allora la coscienza ordinaria di A, in questa percezione fatidica, si rende conto che quella è una persona che da lungo tempo lavora dentro di lui, ha lavorato per 25 anni calamitandolo in quell’aeroporto per incontrarla.
Il cervello è la causa dei fenomeni di coscienza, e supponiamo che questo sia l’ambito della coscienza.
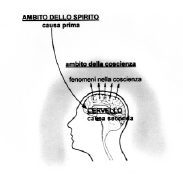
la serie delle cause
Fig.14
Che il cervello sia causante, sia determinante perché sorgano tantissimi fenomeni di coscienza, che l’operare del cervello sia necessario perché i fenomeni di coscienza vengano vissuti, è un dato scontato. La scienza dello spirito non mette in discussione questo.
Ciò a cui la scienza non pensa, perché non ha neanche i presupposti per porsi la domanda, è se il cervello, pur essendo la causa dei fenomeni di coscienza perché dà impulsi un momentino prima[19], è una causa prima oppure se, a sua volta, il cervello è mosso, è causato da un’altra causa.
Se la scienza dice: io pongo l’inizio della serie delle cause là dove vedo qualcosa, allora, se ciò che vedo fosse causato da qualcosa che non si vede, su questo qualcosa la scienza non può dire nulla perché è esperta soltanto in ciò che si vede. Allora tu, scienziato, in onestà, dimmi che la scienza naturale è fondata sul presupposto assoluto che si deve indagare soltanto ciò che è fisicamente, sensibilmente visibile, percepibile.
Ma ha diritto, la scienza, di dire: tutto ciò che non è percepibile non esiste? Questa affermazione sarebbe del tutto non scientifica, perché un’affermazione è scientifica soltanto quando se ne può sperimentare la verità o l’errore. Ma sperimentare in base a percezione ciò che non è percepibile sensibilmente, è un assurdo.
Quindi la scienza dice: io parto da questa causa, il cervello, che rispetto ai fenomeni di coscienza viene prima. I fenomeni di coscienza avvengono in base a ciò che avviene nel cervello, come conseguenza, come effetto. La scienza dello spirito amplia il campo di visuale e dice: sta’ attento però, che se tu ti rendi conto del presupposto fondamentale che fai, devi lasciare aperta la questione se forse non ci sia una realtà spirituale, cioè un essere spirituale che causa il cervello, che lo crea, che lo architetta.
È come dire che il violino causa la musica: è vero, però il violino deve essere a sua volta causato, altrimenti se non viene costruito la musica non salta fuori. Quindi, rispetto alla musica, il violino è causa, ma rispetto al costruttore il violino è effetto: il violino non ci sarebbe se non ci fosse il costruttore del violino.
Allora la domanda è: chi ha costruito il cervello?
Le forze di natura, una certa combinazione di geni dei genitori, le forze ereditarie hanno fatto saltare fuori il cervello – è la risposta corrente. Concediamolo. Pur concedendolo, se uno è onesto nel pensare, non si ferma lì. Una volta nato il cervello 1, può darsi che abbia senz’altro le forze insite di natura per far saltar fuori attraverso l’ereditarietà il cervello 2 e tutti gli altri miliardi e miliardi di cervelli di tutte le generazioni umane.
Ma come è nato il primo cervello fisico? Un altro prima non c’era: sto parlando del primo. Un pensare pulito, un po’ più illuminato, più vero, ormai non c’è più nell’umanità. La scienza, con questa fissazione sulle cause seconde, ha rovinato il pensiero, perché la domanda sulle cause prime non si pone neanche.
La grande domanda di Aristotele non era: come funzionano le cause seconde?, cioè quelle che agiscono quando c’è già un cervello in cui le forze intrinseche di natura poi si riproducono. La grande domanda della filosofia, la grande domanda del pensiero è quella sulle cause prime. Quindi: come è nato il primo cervello? Chi l’ha fatto? E come?
La scienza naturale si limita al sensibile, al materiale, e ne ha il diritto, nella misura in cui non dimentica di limitarsi a indagare appunto ciò che è visibile, ciò che è percepibile ai sensi fisici. La scienza dello spirito dice alla scienza naturale: io ti propongo un ampliamento rispetto alla causalità. I fenomeni di coscienza sono un effetto perché i fenomeni neurosensoriali nel cervello ne sono la causa. E va bene, perché in effetti tutta la sperimentazione lo conferma. Ci sono antroposofi, scienziati di scienza dello spirito, che vorrebbero dimostrare che i fenomeni di coscienza non hanno un rapporto di causa e effetto col cervello, e lì vanno male perché dicono delle cose che non sono sostenibili.
Una certa causalità – il modo di causare è molto complesso, eh?, non è che il cervello è un signorino che dice: adesso causo il fenomeno di coscienza!, e il fenomeno di coscienza c’è –, una dipendenza reale dei fenomeni di coscienza dal cervello c’è. E dire che i fenomeni di coscienza sono in tutto e per tutto indipendenti dal cervello è un’affermazione falsa, sbagliata.
La scienza dello spirito non dice che i fenomeni di coscienza non hanno nessun rapporto di effetto, di dipendenza dal cervello, perché la scienza diventa sempre più minuta, sempre più sottile nell’indagare i fenomeni del cervello e ti dimostra che c’è perlomeno un certo rapporto di causa ed effetto tra i fenomeni neurosensoriali nel cervello e i fenomeni di coscienza, che vengono dopo.
L’indagine è proprio andata in quella direzione, perché se si potesse dimostrare che prima c’è qualcosa nella coscienza e poi avviene qualcosa nel cervello, allora uno direbbe: no, bisogna invertire l’interpretazione.
La scienza dello spirito è d’accordo con questa disamina della scienza naturale, ma pone la domanda sulla causa del cervello: perché o il cervello si è creato da solo, oppure uno può chiedersi se il cervello è a sua volta stato causato.
Rudolf Steiner non dà un altro dogma, ma dice: questo spirito, l’Io superiore di questa persona A che nell’aeroporto vede la donna fatidica della sua vita, è oltre lo spazio e oltre il tempo, è un essere spirituale che è dappertutto e già operava in quell’aeroporto per portare queste due persone l’una a percepire l’altra.
Steiner dice: io questo spirito lo osservo, in chiave di immaginazione spirituale, di percezione nel soprasensibile – i tre gradini nel soprasensibile li chiama: l’immaginazione, l’ispirazione e l’intuizione. E dice ancora: se uno ha la capacità di cogliere la realtà dello spirito, vede che, ancor prima che un individuo nasca, il suo spirito si costruisce il cervello a sua immagine, in modo che gli corrisponda.
Steiner descrive in tutto e per tutto come lo spirito umano prepara non soltanto il sostrato biologico del corpo fisico, ma anche pianifica gli eventi fondamentali – quell’incontro fatidico in aeroporto –, lasciando poi alla libertà della coscienza ordinaria di reagire[20]. Quindi quell’incontro è previsto, è causato dai due Io superiori: tutti e due l’hanno preparato, l’hanno voluto e hanno condotto tutti i passi di entrambi perché avvenisse.
Steiner non dice: io teorizzo. Dice: io vedo questa realtà. Dovete concedere che una pensata del genere nella scienza naturale non la trovate, perché la scienza naturale si limita a ciò che è sensibilmente percepibile, e l’Io superiore non è sensibilmente percepibile.
Quindi già il fatto che questo Steiner tiri fuori una prospettiva aggiuntiva enorme, mi mette una pulce nell’orecchio che mi dice: vacci piano, vacci piano. Aristotele, ma anche il tuo pensiero modesto, senza essere un Aristotele, ti ha sempre detto che il cervello fisico non è la causa prima del mondo: qualcuno deve averlo fatto, questo cervello. Il mio pensiero modestissimo mi dice: il cervello deve avere una causa, magari parecchie, non può costruirsi da solo! O siamo diventati tutti matti?
E allora ecco questo Steiner che mi parla dell’architetto del cervello fisico. È l’unico che mi dice non solo che il cervello deve avere una causa ma mi dice addirittura qual è, secondo lui. A quel punto lì che faccio? Gli credo? Nooooooo! La fede no. Io sono scappato via dalla Chiesa cattolica perché mi chiedevano di credere. Io voglio capire![21]
Cosa fa una persona intelligente? Fa un esperimento, perché dice: la cosa comune alla scienza naturale e alla scienza spirituale è sperimentare. L’esperimento di come la vita è, di come si vive partendo dal presupposto che tutti i fattori di coscienza siano da attribuire al cervello, questo esperimento l’ho già fatto perché la nostra cultura conosce solo quello (quindi non mi dite che non abbiamo ancora fatto questo esperimento). Però l’altro esperimento di provare a vivere un mese, due mesi, un anno, due anni con quell’altra ipotesi e vedere come la vita è, non l’ha fatto quasi nessuno!
I bravi antroposofi, invece di darsi da fare a vedere che cosa salta fuori se si vive con la coscienza che c’è un Io che mi porta incontro tutti gli eventi karmici, credono a Rudolf Steiner perché l’ha detto lui. Credere a Steiner è un rimbambolimento del pensiero, non è meglio che credere ai dogmi cattolici. Credere a una cosa perché la dice Steiner è ancora peggio, perché le cose che dice Steiner hanno senso soltanto se uno le capisce, le sperimenta e ne vede gli effetti.
L’unica cosa intelligente è dirsi: questo Steiner tira fuori una nuova dimensione di sperimentazione e se io decido di provare a vivere in quel modo lì, poi, in base al tipo di vita che salta fuori, a ragion veduta sarò io a decidere se preferisco vivere ritenendo tutti i fenomeni del cervello come effetto, come causati dall’essere spirituale che sono io stesso, o se invece preferisco limitarmi a parlare del cervello che mi causa tutti i fenomeni di coscienza.
Se io faccio il primo esperimento dico: mi trovo all’aeroporto e, se è il cervello a causare tutto ciò che avviene nella coscienza, io percepisco quella persona, l’immagine impinge sull’occhio, poi cavalca sull’onda del nervo ottico, arriva al cervello, e il cervello dice: quella donna mi piace! Oppure: quell’uomo mi piace! E l’incontro? Ha una causa l’incontro? C’è qualcuno che ha voluto, che ha causato l’incontro? Nooooo, noooooooo!! Una volta la mente bambina credeva nella provvidenza, ma noi siamo scientifici, adesso! È a caso che ci si incontra. A caso!!
L’altro esperimento. Decido di vivere un po’ di tempo con l’altra ipotesi che dice: no, no, non è il signor Caso che ha deciso che ci incontrassimo in quell’aeroporto, ma lo spirito di lei e lo spirito mio, che ancora prima di nascere hanno costruito i nostri corpi in tempi che fossero compatibili, se siamo destinati a diventare papà e mamma di figli comuni, hanno deciso l’incontro i nostri spiriti che hanno costruito i cervelli a loro più congeniali, ecc. Il mio spirito e il suo spirito sono la causa di tutti i passi fatti finora, nessun passo della vita è avvenuto a caso, ma è stato voluto dai nostri due Io superiori.
Ognuno deve decidere per sé se preferisce vivere come effetto del caso – non chiedetemi cosa sia il caso, perché non l’ho mai capito – o se invece preferisce, trova più intelligente e più plausibile considerare tutti gli avvenimenti, tutti gli eventi della sua vita come voluti, pianificati, scelti dal suo spirito.
Logicamente, dimostrare non si può né l’una né l’altra posizione, perché non sono questioni di dimostrazione logica. La dimostrazione che i fenomeni di coscienza sono concomitanti, sono conseguenza, sono perlomeno in un certo senso effetto dei fenomeni del cervello, non lo si dimostra teoricamente, ma lo si mostra sperimentalmente: tu percepisci, vedi, ti rendi conto che i fenomeni di coscienza vengono dopo i fenomeni nel cervello (vedi gli esperimenti di Libet). Allora dici: se c’è un certo rapporto di causa-effetto, allora ciò che avviene nel cervello causa ciò che avviene dopo. Quindi non è una dimostrazione a livello di pura teoria, è proprio un mostrare come stanno le cose.
Anche l’altra posizione, se è vera, non si può dimostrare a suon di logica, perché l’Io spirituale, lo spirito dell’uomo, se è una realtà non è una questione di pura logica: è una realtà, è un essere che pensa, sente, vuole e opera, muove i piedi per 25 anni in modo che arrivino al tal giorno, alla tal ora, a quel punto, in quell’aeroporto, perché in quel momento arriva l’altra persona, ugualmente condotta dal suo Io, affinché si compia questo incontro importantissimo che determinerà gli anni successivi.
O sono realtà o non sono realtà. Una dimostrazione a livello di logica, a livello di puro pensiero è una cosa assurda. Però, se io ho il convincimento che questo Io superiore, che questo spirito umano non c’è, che è una fandonia, che quell’incontro è casuale e avviene per un’infinita mistura di fattori, e se io penso al contempo di essere libero, sono veramente un imbecille a livello di pensiero. Perché «il caso» è il dogma che dice: tutto della natura decide, fuorché tu! Pensare di essere libero è un’illusione, una imbecillità astronomica!
Quindi io devo sapere che, stando alla scienza naturale che vuole ostracizzare la realtà dello spirito, è assurdo parlare di libertà – e difatti gli scienziati più coraggiosi, più conseguenti, sono quelli che già da un bel po’ di tempo (in Germania, ma penso anche in Italia) dicono: ma che c’entra questa giurisdizione che parla del bene e del male, come se l’individuo nel suo animo, nel suo spirito fosse responsabile delle sue azioni?! Il cervello, il fattore biologico, i geni decidono! E infatti una certa mistura di geni la lasciamo andare libera perché non uccide, un’altra mistura di geni la mettiamo in prigione perché altrimenti uccide: ma tutto questo non ha nulla a che fare con la colpa morale. È solo un’altra mistura di geni che non ci va di lasciare correre libera.
Ripeto: il discorso della scienza dello spirito comprende la scienza naturale quando dice che i fenomeni del cervello hanno una funzione, complessa, di causa rispetto ai fenomeni di coscienza che hanno un certo carattere di effetto. Se lo sperimentare ci dà questo risultato, è assurdo metterlo in questione. La scienza dello spirito non ha nulla da ridire qui, accoglie tutto ciò che nella scienza naturale viene sperimentato come rilevazione oggettiva dei fatti, però aggiunge tutta un’altra sfera, ponendo la domanda: se i fenomeni neurobiologici nel cervello sono causa rispetto ai fenomeni di coscienza, questo non ci impedisce di porre la domanda sul cervello: cioè se il cervello, a sua volta, è effetto di un’altra causa che l’ha causato.
L’alternativa è quella di dire che il cervello causa se stesso, che il biologico causa tutto ciò che avviene nel biologico. E io ho chiesto: ma all’inizio, quando il biologico non c’era, che cosa ha causato il biologico? La teoria del Big Bang dice: a un certo punto il biologico è saltato fuori. La vita non c’era, poi a un certo punto è saltata fuori! Adesso c’è.
Ci sono centinaia di scienziati che stanno studiando cosa è avvenuto nei primi sessantesimi di secondo prima del Big Bang, perché prima non c’era nulla e dopo sessanta frammenti di secondo c’era tutto, è saltato tutto fuori!
Io ho sempre detto che se un Aristotele piombasse nell’umanità di oggi, e sentisse una cosa del genere, per fortuna sua non riuscirebbe a capire cosa stiamo dicendo, perché se riuscisse a capirlo si piglierebbe un infarto cardiaco e andrebbe subito all’altro mondo. Si chiederebbe: come ha fatto l’umanità a diventare così stupida?
Non chiedete a me di essere gentile, no, no, no, le responsabilità che abbiamo nei confronti delle sorti dell’umanità sono troppo grosse per fare soltanto un esercizio di gentilezza e di bontà. Se volete un discorso gentile andate da un’altra parte: se non ci diamo un paio di sberle continuiamo a dormire e guardiamo le conseguenze.
Ci chiediamo come mai la depressione, la paura, continuano ad aumentare? Se io sono convinto di essere in balia delle forze di natura, certo che devo aver paura, certo che divento depressivo: come si può vivere con un minimo di ottimismo se io so di essere comunque il risultato cieco delle forze di natura?
La vita è bella soltanto se so che io, nel mio spirito, ho deciso liberamente tutto quello che mi viene incontro come eventi, con l’intento di farne il meglio per il mio cammino successivo. Allora sì che non c’è bisogno di diventare depressivi o di aver paura.
Se una mamma è convinta che il suo bambino piccolo è accompagnato da un essere spirituale che si chiama Angelo custode, che lo custodisce, avrà un tutt’altro stato d’animo se la sua casa è vicina alla strada dove passano le macchine, che non una mamma che dice: l’Angelo custode?, che c’entrano queste fandonie? e allora deve aver paura!
Uno dice: e se l’Angelo custode non c’è? Sapete dove l’Angelo custode veramente non esiste? Nelle teste vuote. Lì l’Angelo custode veramente non esiste. C’è sempre qualcuno che dice: dimostrami l’esistenza degli Angeli. Tu stai mangiando le patate fritte, e io ti dico: dimostrami che esistono, perché se non mi dimostri che esistono non le mangio. Si può dimostrare l’esistenza delle patate fritte? No, non si può dimostrare: ciò che è reale non si può dimostrare. O ne fai l’esperienza e quella ti basta, oppure, se non ne fai l’esperienza, per te, per il tuo corpo le patate fritte non esistono.
Si può dimostrare l’esistenza degli alberi? No, non si può dimostrare, perché per l’eschimese che non li ha mai visti non ci sono, non esistono! Per un essere umano – che poi siamo noi tutti, oggi – che non ha mai fatto l’esperienza reale dello spirito reale, per lui lo spirito non esiste! Lo spirito esiste soltanto nella misura in cui io lo creo e vivo come spirito, ne faccio l’esperienza.
Se io non faccio l’esperienza, nel pensare, di cosa vuol dire essere uno spirito creatore, resta una teoria vuota a cui devo credere.
L’essere umano o diventa spirito oppure lo spirito non ce l’ha.
Tu mi dici: ma stai parlando di un Io superiore che però è al di fuori della coscienza. Ooooh, svegliamoci!! Dal momento in cui io comincio a parlarne lo porto dentro la coscienza, se no non ne parlo, no? Quindi portare a coscienza l’Io superiore, lo spirito individuale dell’uomo, significa entrarci dentro sempre di più, e diventare sempre di più spirito individuale, immedesimarsi, diventare uno, sempre di più, con l’Io superiore.
Nel momento in cui io penso: ah, è il mio Io, è il mio spirito che mi ha portato in questo aeroporto a questo incontro così fatidico! – prima di tutto porto a coscienza di essere uno spirito, quindi c’è già un inizio di unione conoscitiva. E se poi dico: sono d’accordo, perché tutto quello che decide il mio Io spirituale è tutto per il mio bene – allora c’è un’unione non soltanto intellettiva, ma anche del cuore, anche morale, perché son d’accordo con questa decisione volitiva di far avvenire questo incontro.
Quindi non mi dite che i destini di questo spirito umano siano di restare sempre e solo al di là della coscienza, se no non potremmo neanche parlarne. Cominciare a parlarne è proprio l’inizio del portare a coscienza ciò che altrimenti, in una coscienza più bambina, esula dalla coscienza.
Una coscienza bambina è quella che dello spirito non ha coscienza: questo la rende bambina. La coscienza diventa adulta, diventa matura, non soltanto intellettivamente ma soprattutto moralmente, nella misura in cui porta a coscienza la realtà assoluta operante dello spirito, e questo è permesso a tutti.
Devo capire, però, che l’alternativa è soltanto quella di dire che avviene «a caso» questo incontro che decide profondissimamente degli anni successivi, o forse di tutta la vita.
Dovrei poi onestamente chiedermi: cosa intendo dire quando dico «è a caso»? Intendo dire che non ha nessuna causa, non ha una spiegazione. Le cose più importanti della mia vita avvengono senza spiegazione e senza causa. Assurdo! Assurdo! La scienza ci dice che tutti i fenomeni della natura hanno un senso soltanto se hanno una causa che li spiega, e il fenomeno umano, che è quello più alto, più importante che ci sia, quello deve essere senza spiegazione. A caso.
Abbiamo una cultura che ha eretto l’imbecillità assoluta a dogma, con una sicumera tale che non se ne rende neanche conto. Certo che i poteri di questo mondo hanno tutto l’interesse a far sì che l’individuo non si metta in testa di essere lui l’architetto libero, sovrano, degli eventi della sua vita, riproponendosi di farne liberamente il meglio per la sua evoluzione, mandando a ramengo tutte le autorità che gli dicono come si deve comportare.
L’alternativa a essere bravi borghesi è che io mando a ramengo tutte le autorità che mi dicono come mi devo comportare. Bastano le regole concordate in base alle quali stabiliamo che nessuno ha il diritto di ammazzare l’altro, e basta! Ciò che un individuo fa, che ha da compiere nella sua vita sono affari suoi, è la decisione del suo spirito prima di nascere![22]
La Chiesa cattolica ti parla di un Cristo che, siccome ha reso forte il Logos, la sapienza, l’amorevolezza e la libertà dell’individuo, è stato ammazzato, e te l’ha talmente ammansito che ne ha fatto un potere di questo mondo. Ma questo è anticristianesimo, del cristianesimo ha soltanto tutto l’opposto, al negativo, al negativo.
Duemila anni fa questo bravo Cristo, il Logos, in una storiella che raccontava alla gente comune come noi – agli iniziati, agli addetti ai lavori che erano i dodici apostoli che poi, alla fine, sono scappati tutti, spiegava un pochino le cose –, in una storiellina (le parabole sono storielline) delle più fondamentali narra del figliol prodigo che va via dalla casa del padre: oh, ce n’ho fin sopra i capelli di te, adesso lasciami un po’ andare per conto mio! Il padre, il Padreterno, un po’ più intelligente di tanti padri di questo mondo, gli dà la sua parte e dice: vai, vai, vai!
È il senso dell’evoluzione. La morale della parabola – com’era alla fine delle favole di Esopo – è: c’è più festa in cielo per la pecorella che è andata da sola, per l’individuo che si è conquistato il destino individuale e del tutto unico della sua evoluzione, che non per il pecorume, per tutte le pecore che sono rimaste insieme.
Cosa ne ha fatto la Chiesa, di questa parabola? L’opposto! Non andar via dalla Chiesa, non andar via dalla Chiesa perché se lasci il gregge sei perduto e vai all’inferno! La parabola dice: c’è più festa in cielo per la pecorella che è andata via dal gregge, e dal pulpito dicono che se lasci il gregge vai all’inferno. Questo è anticristianesimo: non soltanto è nulla di cristianesimo, ma è tutto all’opposto!
Siamo al IV capitolo: il libro è come una partitura piena di macchie nere, però, per uno che la musica la sa, altro che macchie nere! Il IV capitolo parla della percezione: A vede B, ha la percezione di B, l’immagine impinge sull’occhio, dall’occhio al nervo ottico, poi va al cervello e poi nell’anima ecco l’immagine fatidica (vedi anche Fig.15 a pag. 179).
A, poi, se ne va, ma l’immagine di B è rimasta, A non ha dimenticato come era vestita quella donna, non ha dimenticato i tratti del suo volto: è rimasta l’immagine, la rappresentazione. Questa immagine non è spaziale. Quindi concediamo che tutti questi fenomeni – nell’occhio, nel nervo ottico, nel cervello – esistano, però dobbiamo concederci che tra il cervello, che è qualcosa di fisicamente sperimentabile, e l’immagine c’è un salto: l’immagine non è tagliabile a fette, il cervello lo posso tagliare a fette.
Di che cosa è fatta l’immagine? E lì la scienza naturale non può più dire nulla. Però, se fossimo onesti, con un minimo di forza di pensiero dovremmo concedere che qui c’è un salto: tra i fenomeni del cervello, che sono ancora osservabili, percepibili sperimentalmente, e l’immagine nell’animo.
Lo scienziato onesto dovrebbe dire: sì, in effetti, le cose a quel punto lì diventano un po’ troppo complesse, lì finisce la mia sicumera. C’è una somiglianza tra i fenomeni neurobiologici nel cervello e l’immagine? No, nessuna somiglianza. Quindi come possono fenomeni neurobiologici causare qualcosa che è del tutto diverso dalla causa? L’effetto deve portare l’impronta della causa, se no io non posso dire che è l’effetto di questa causa. Noi, invece, presupponiamo una causa che sortisce un effetto che non ha nulla a che fare con la causa.
Allora comincio a dire: no, forse non è vero che stanno in rapporto di causa e effetto. Questa immagine me la porta l’Io superiore sulle ali dell’Angelo custode, me la mette nell’animo dove scopro che c’era già, c’era già! Era inconscia l’immagine, ma c’era da sempre! È da millenni che questa immagine lavora nel mio animo e adesso la porto a coscienza. Quindi la causalità va dall’immagine al cervello, e il cervello me la porta a coscienza in direzione opposta. Ma l’immagine c’era già. Il cervello ha la funzione di portare a coscienza questa immagine, non di crearla: c’era già! Come fa il cervello a creare un’immagine nell’animo?
IV,26 Sarebbe difficile trovare nella storia dello spirito umano un altro edificio di pensiero messo insieme con maggiore acume {tutta questa trafila dalla percezione all’occhio, al nervo ottico, al cervello ecc…) e che pure, sotto un’analisi più minuta, precipita nel nulla.
Steiner adesso sta trattando tutto questo costrutto della scienza naturale come un castello di carta: t’arriva, e con un soffio fa cadere tutto per terra. Quindi concedetemi che neanche Steiner è gentile più di tanto, eh! Io certe cose le dico, lui le scrive, addirittura le stampa.
(IV,26) Guardiamo un po’ più da vicino come esso sorge. Si parte sulle prime da ciò che è dato alla coscienza primitiva, cioè dalla cosa percepita {prendiamo questo esempio dell’aeroporto dove A percepisce B}. Poi si fa vedere che tutto quanto si trova in questa cosa non esisterebbe per noi se non avessimo i sensi.
Se B non avesse gli occhi, A non esisterebbe per B: prima pensata bacata. Invece di dire: se A non avesse occhi, B sarebbe per A non percepibile – questo sarebbe un pensiero onesto –, si dice: B non ci sarebbe. Quindi si fa una cosa sola del fatto che una cosa sia non percepibile all’occhio e che non esista (e allora se un occhio è cieco, il mondo non esiste?). No, se mancano i sensi posso dire che non è percepibile, ma io non so se non c’è: sono due affermazioni ben diverse. Ma non ci si rende neanche conto della diversità di queste affermazioni.
Si pretende che «tutto quanto si trova in questa cosa non esisterebbe per noi se non avessimo i sensi»: invece, se non avessimo i sensi, la cosa non verrebbe portata a coscienza, ma non possiamo dire che non esisterebbe. Per portare a coscienza una cosa è necessaria la percezione, quindi la percezione è necessaria per portare a coscienza le cose, non per farle esistere.
(IV,26) Senza occhio nessun colore {è un detto, non è Steiner che lo afferma}. Quindi il colore non esiste ancora in ciò che agisce sull’occhio: sorge soltanto dall’azione reciproca fra occhio e oggetto. Questo dunque è privo di colore {se il colore sorge soltanto in presenza dell’occhio, senza occhio l’oggetto è incolore: come se la cosa fosse scontata}. Ma neppure nell’occhio esiste il colore; poiché nell’occhio esiste un processo chimico o fisico {fisiologico} che dal nervo viene soltanto guidato fino al cervello, ed ivi dà origine a un altro processo {nel cervello non ci sono colori, ci sono processi neurobiologici: fotografando il cervello non saltano fuori i colori della donna che A ha visto}. Ma neppure quest’altro processo è ancora il colore. Soltanto per mezzo del processo cerebrale il colore viene suscitato nell’anima.
L’immagine è colorata, ma soltanto nell’anima salta fuori il colore: il colore non c’è nell’occhio, non c’è nel nervo ottico, non c’è nel cervello, ma salta fuori nell’anima. La rappresentazione è colorata, porta il colore degli abiti che la persona B aveva. «Soltanto per mezzo del processo cerebrale il colore viene suscitato nell’anima». E non mi chiedete che cosa sia l’anima per chi la pensa così, eh?
(IV,26) Ma qui non entra ancora nella mia coscienza, anzi per mezzo dell’anima viene trasportato verso l’esterno, sopra un corpo. In questo corpo finalmente io credo di percepirlo.
Se io non so che questa immagine è l’immagine di quella persona là, vuol dire che non l’ho ancora portata a coscienza. La porto a coscienza quando dico: è lei! L’immagine diventa immagine cosciente quando io, dall’anima, esco di nuovo fuori e ritorno al punto di partenza della percezione: ah, è lei! Quindi non basta che l’immagine sia nell’anima: l’anima la porta a coscienza soltanto riferendola alla percezione.
Cosa abbiamo fatto? Un circolo vizioso, siamo ritornati al punto di partenza. Perché il punto di origine del colore dov’era? Là, nella percezione. Nell’aria in mezzo non c’è, nell’occhio non c’è, nel nervo ottico non c’è, nel cervello non c’è, nell’anima viene portato a coscienza soltanto se l’anima dice: è lei!, ma così siamo tornati al punto di partenza. E il giro che l’abbiamo fatto a fare?
(IV,26) Abbiamo così percorso un circolo completo. Siamo divenuti coscienti di un corpo colorato {che era il punto di partenza}. Questo è il primo punto. Ora comincia l’opera del pensiero. Se io non avessi occhi, il corpo sarebbe per me privo di colore {vedete, non dice: non ci sarebbe, ma sarebbe privo di colore per me, quindi qualifica un po’ di più le cose}. Quindi non posso collocare il colore nel corpo. Mi metto a cercare dove sta. Lo cerco nell’occhio: invano. Nel nervo: invano. Nel cervello: ancora invano. Nell’anima: qui lo trovo, è vero, ma non congiunto col corpo. Il corpo colorato lo ritrovo soltanto là, da dove ero partito. Il circolo è chiuso. Io credo di riconoscere come un prodotto della mia anima ciò che l’uomo ingenuo pensa esistere fuori nello spazio.
L’ingenuo dice: il corpo colorato è là, invece lo scienziato dice: no, no, no, il corpo colorato ce l’ho soltanto dopo essere passato per lo spazio intermedio, per l’occhio, per il nervo ottico, per il cervello, per l’anima, e soltanto quando ho fatto tutta questa trafila ho veramente il corpo colorato, perché esso diventa una realtà soltanto se è stato costruito dall’occhio, dal nervo, dal cervello, dall’anima e poi riferito.
La differenza è che l’uomo ingenuo si gode l’innamoramento, e lo scienziato che deve fare tutto questo circolo per ritornare al corpo colorato, l’innamoramento lo manda a spasso. Perché tu mica ci sei, è la mia anima che ti ha fatto, che ti ha costruito, è il mio occhio: tu non saresti senza il mio occhio, se non ci fosse il nervo ottico, tu, proprio aria fritta saresti, se non ci fosse il mio cervello ma neanche ti sogneresti di esistere, esisti soltanto grazie al mio occhio, al mio nervo ottico, al mio cervello e alla mia anima. Quindi io posso innamorarmi soltanto di me stesso!
La scienza moderna è l’esercizio di narcisismo più raffinato che ci possa essere: l’essere umano non esce mai da se stesso, perché tutto questo circolo, tutta la realtà la crea lui col suo occhio, col suo nervo ottico, col suo cervello e con la sua anima, e la butta lì fuori per grazia sua, se no non ci sarebbe nulla. Senza di me il mondo non esiste e tutti quanti, se fossero intelligenti, dovrebbero inginocchiarsi e ringraziarmi perché esistono soltanto grazie a me. Oh. E per ognuno è uguale, eh?, perché se uno scienziato dice: questo vale solo per me, allora non è scienza. Deve valere per tutti. Diventa psicologicamente complicata la cosa!
Tu è inutile che mi guardi storto, Luciana, eh? Il tuo borbottamento sorge soltanto in quanto impinge sul mio orecchio, poi il nervo acustico lo porta al mio cervello, il mio cervello porta a coscienza nella mia anima il tuo borbottamento e io poi te lo appiccico. Soltanto grazie a me il tuo borbottamento esiste. Vuoi o non vuoi ringraziarmi?
IV,27 Finché ci si ferma qui, tutto appare nell’ordine più bello. Ma invece è necessario ricominciare ancora una volta da principio {o santa pace, abbiamo già fatto il giro, e adesso ricominciamo da capo?}. Infatti fino a ora ho trafficato con una cosa: cioè con la percezione esterna di cui prima, come uomo ingenuo, avevo avuto un’idea completamente falsa.
Come uomo ingenuo pensavo che la percezione fosse la realtà, pensavo che quella persona lì che percepisco fosse la realtà. No, lo scienziato mi dice: sei ingenuo a pensare che è la realtà, ma sei tu che la crei in base al passare per l’occhio, il nervo ottico, ecc. (stiamo semplificando le cose, eh?, perché se il circuito lo facessimo con uno scienziato ci metteremmo tre ore per descrivere tutto quello che avviene nell’occhio, nel nervo ottico, nel cervello ecc.), e le cose esistono per grazia tua! Quindi la realtà non è data dalla percezione ma è data da tutto il circolo che la crea.
(IV,27) Avevo prima creduto che essa, così come la percepivo, avesse un’esistenza obiettiva. Ora io noto che essa scompare con lo scomparire della mia rappresentazione, che essa è solo una modificazione dello stato della mia anima.
Diciamolo più scientificamente: una modificazione dello stato del mio occhio, una modificazione dello stato complessissimo del mio nervo ottico, una modificazione complessa del mio cervello, una modificazione della mia anima che si è colorata e si è formata con una certo colore e una certa forma.
(IV,27) Ho dunque io ancora diritto di partire da essa {dalla percezione} nelle mie considerazioni {visto che la percezione ha subito una serie infinita di trasformazioni}? Posso io dire che essa agisce sulla mia anima? D’ora in poi la tavola, che prima avevo creduto agisse su di me e suscitasse in me una rappresentazione, devo trattarla a sua volta come rappresentazione.
Io non vedo una tavola reale, vedo un’immagine: è realismo ingenuo pensare che ciò che vedo è una tavola reale (dice lo scienziato). Qualcuno qui, ancora ieri, veniva con questa ingenuità: ma è reale la tavola che vedo, se ci do una pedata sento qualcosa! Sì, ma io sento qualcosa, la tavola dov’è? Il fatto che io sento qualcosa mi dimostra che esisto io, non la tavola.
(IV,27) Di conseguenza, sono allora puramente soggettivi anche gli organi di senso e i relativi processi.
Quindi io non ho la realtà dell’occhio, ma ho l’immagine dell’occhio: l’immagine percettiva agisce sull’immagine dell’occhio, l’immagine dell’occhio agisce sull’immagine del nervo ottico che agisce sull’immagine del cervello. In altre parole, questo scienziato moderno dimostra quanto è ingenuo colui che ritiene la tavola come realtà che può causare qualcosa, però lui tratta l’occhio, il nervo ottico e il cervello esattamente con la stessa ingenuità. Perché l’occhio, il nervo ottico e il cervello per causare qualcosa devono essere una realtà, non possono essere un’immagine, perché un’immagine non causa nulla.
Lo scienziato disdegna il realista ingenuo che prende la tavola come una realtà, e invece di essere conseguente e dire: anche nell’occhio non ho una realtà, ho soltanto un’immagine, anche nel nervo ottico non ho una realtà ma soltanto un’immagine e anche del cervello ho soltanto l’immagine, lo scienziato dice: no, no, no, quando io percepisco il cervello percepisco una realtà. Il cervello causa veramente qualcosa. Ma allora che differenza c’è tra percepire il cervello e percepire la tavola? Nessuna, sono entrambe percezioni!
Di questa imbecillità assoluta neanche ci si accorge! Perché se dici che ogni percezione non mi dà una realtà ma un’immagine, allora, coerentemente, devi dire lo stesso sull’occhio, sul nervo ottico, sul cervello. Tu hai la percezione del cervello, e la percezione, stando al tuo dogma, ti dà un’immagine non una realtà, e un’immagine non può causare qualcosa: vorrei vedere l’immagine nello specchio che mi dà un pugno!
A quel punto lì dobbiamo dire, per quanto ci spaventi l’affermazione, che il realista ingenuo ha un pensare più sano che non lo scienziato che mette alla base della sua scienza una contraddizione di pensiero così stridente che neanche se ne accorge. Perché se fosse conseguente dovrebbe dire: anche la percezione del cervello mi dà un’immagine, quindi a livello di percezione non ho nessuna realtà, la realtà ce l’ho soltanto quando unisco il dato di percezione col dato di pensiero, e questo vale per tutte le percezioni – sia che percepisco il tavolo, sia che percepisco il cervello, sia che percepisco l’occhio. Tutto.
(IV,27) Non ho diritto di parlare di un occhio reale, ma soltanto della mia rappresentazione dell’occhio. Altrettanto si dica dei processi nei nervi conduttori e nel cervello, e persino del processo nell’anima {anche quella è una percezione, quindi un’immagine, non una realtà}, per mezzo del quale dal caos delle molteplici sensazioni si costruiscono le cose. Se io, presupponendo esatto il primo circolo descritto dal mio pensiero, percorro ancora una volta le diverse parti del mio atto conoscitivo, questo appare come una trama di rappresentazioni, che proprio come tali non possono agire le une sulle altre.
La percezione del tavolo mi dà una rappresentazione, cioè un’immagine, la percezione dell’occhio mi dà una rappresentazione, cioè un’immagine, la percezione del nervo ottico mi dà una rappresentazione, cioè un’immagine, la percezione del cervello mi dà una rappresentazione, cioè un’immagine non una realtà, la percezione dell’immagine nell’anima mi dà una rappresentazione, quindi ancora un’immagine non una realtà.
Dov’è la realtà? Da nessuna parte nel percepibile! Tutte le percezioni – la tavola, l’occhio, il nervo ottico, il cervello, l’immagine nell’anima – sono dappertutto immagini e da nessuna parte realtà che opera, che fa qualcosa!
Esiste una realtà? Se esiste non può esistere a livello della percezione. La forza dinamica che opera, che costruisce il cervello, che non è soltanto un’immagine ma è una realtà, è ciò che l’umanità moderna ha perso di vista, è ciò che l’umanità ha sempre chiamato lo spirito.
E lì l’infarto salta fuori di fronte alla domanda: ma come può lo spirito essere più reale, più operante della tavola? La tavola sì che è una realtà! E io vi dico – però non avete bisogno di credermi, basta che riflettiate un po’ –: da quando in qua quella tavola che sta là ha fatto qualcosa? Vi assicuro che non ha fatto mai nulla da sé! E vi assicuro che lo spirito è una tale realtà che crea, forgia, costruisce non solo la tavola, ma anche il cervello.
L’umanità moderna ha perso di vista la realtà, e prende per reale ciò che è soltanto immagine del reale. Lo spirito non è fuori dal mondo della percezione, è nascosto dentro, ma siccome è nascosto dentro non lo vedo e allora invece di dire che nel cervello lavora lo spirito attribuisco al cervello ciò che lo spirito fa nel cervello. Ma lo spirito non è fuori dal cervello, è nel cervello.
Attribuisco alla materia del cervello la capacità di decidere, di fare: il cervello è diventato intelligente, la materia è diventata intelligente... Allora lo scienziato dovrebbe dirmi, nel caso dell’incontro fatale di cui parlavamo: questo evento non è avvenuto a caso, ma è avvenuto in base alla sapienza intelligente del cervello, le sue cellule sono così intelligenti che hanno deciso, hanno condotto tutti i passi fino all’aeroporto. Allora sì che avrebbe un minimo di barlume, perché allora non mi parlerebbe più di caso, ma mi direbbe: la materia è così intelligente che ha architettato l’incontro, l’ha voluto, non è avvenuto a caso!
Cos’è allora il caso? Non spiega nulla, è un’assurdità.
Ritorno al pensiero fondamentale che Steiner non ti mette lì un dogma, ma ti dice soltanto: guarda che la scienza ti apre un campo legittimo, quello della sperimentazione, dell’analisi, dell’indagine del mondo dove c’è la percezione sensibile. La scienza dello spirito ti amplia il campo e lascia a te, al tuo spirito, di vedere se tu spieghi meglio i fenomeni soltanto con un campo, o se li spieghi meglio quando li hai tutti e due. Però il fatto di averli tutti e due non significa che viene messo in questione ciò che la scienza naturale dice in merito alle cose sensibili.
La scienza dello spirito aggiunge ciò che nessuna scienza naturale è in grado di dire, ma non mette mai in discussione ciò che la scienza naturale dice. Un conto è affermare: ciò che mi dice la scienza naturale mi basta per spiegare i fenomeni, un altro conto è dire: no, io ho una struttura di pensiero per cui non mi basta, perché io voglio una spiegazione che mi dica come è nato quel cervello che mi porta i fenomeni di coscienza.
La filosofia classica non era l’indagine del pensiero umano sulle cause, prese così, alla rinfusa: quello è il campo specifico delle scienze naturali. Il campo d’indagine specifico della filosofia classica era la disamina delle cause prime. Certo che una volta che tu hai posto in essere le prime cose, quelle diventano a loro volta causa di tante altre cose; certo che il mondo della materia, la natura con tutte le sue leggi, causa tantissime cose: però, come è sorta la materia? Da sola?
Non so se ve l’ho già detto: ho comprato un libricino sul Big Bang, Urknall in tedesco (letteralmente: il patatrac primigenio) e mi sono messo a studiarlo. Sapevo di essere modesto nel mio pensare, ma proprio non ci capivo nulla! Possibile? Lo rileggo. Dopo la quinta lettura ho capito: non capivo nulla perché non c’era nulla da capire. Però mi sono sforzato.
Delle baggianate incredibili, una farragine di assurdità spacciate per scientifiche: un millesimo di secondo prima non c’era nulla, dopo c’era tutto! Il credente classico, religioso, cattolico che crede ai miracoli, è un mini-mini-mini credente rispetto allo scienziato che crede in questo super-miracolo, di assoluta irrazionalità. Senza questo super miracolo il mondo non ci sarebbe.
Facciamo una pausa. Non mi ero accorto di aver parlato così a lungo.
*******
Intervento: In questo tuo schema in cui il mondo dello spirito ha in sé i concetti e poi me li fa riverberare nell’anima, cosa succede quando io col mio pensare creo il concetto di una cosa che non è in natura, ad esempio un orologio? Questo concetto già esiste nel mondo spirituale e io lo riscopro, o è un processo creativo, libero, dell’uomo come spirito?
Archiati: Dobbiamo distinguere da una parte ciò che fa parte della natura – natura viene da «nascere», e significa che è nata in base a una creazione degli spiriti divini, precedente al creare dello spirito umano –, e dall’altra le cose che sono state create dallo spirito umano, per esempio la ruota, tutto il mondo della tecnica, degli utensili, ecc.
Lo spirito creatore ha intuitivamente creato il concetto di rosa: quando io nel pensare capisco la rosa, non mi accorgo di rifare lo stesso processo creatore. Tu adesso parlavi del momento in cui io porto a coscienza il fatto che anche il mio spirito crea, se no non saprei cos’è la rosa. Quando io capisco che cosa la rosa è, sono dentro al pensare attivo, al processo creatore; il riflesso di questo processo viene a coscienza in me e io dico: da sempre sono uno spirito che pensando crea concetti.
Se li ha già creati prima nel tempo un altro spirito, non importa nulla: spirito è spirito dappertutto. L’anima è la coscienza e fa sorgere un’immagine di questo spirito creatore: quindi i concetti sono il già pensato. Lo spirito è per natura concettualizzante, produce concetti e il concetto in quanto percepito è l’immagine di ciò che lo spirito fa. I concetti io li percepisco come ogni altra cosa: il concetto di tavolo è un’immagine riflessa nell’anima di ciò che fa lo spirito quando tavoleggia.
La prova apodittica che lo spirito umano è dello stesso genere dello spirito divino – perché spirito è spirito – e quindi è creatore per natura, sta nel fatto che lo spirito umano crea una dimensione del reale che lo spirito divino ha lasciato allo spirito umano, ed è il mondo della tecnica.
La realtà dell’orologio è l’idea, il concetto di orologio: quella è la realtà, quella l’ha prodotto. Però questo concetto non ce l’ha dato la Divinità creatrice già presente nella natura, è sorto in base al pensare dello spirito umano. Questo per evidenziare a livello di percezione che lo spirito è spirito creatore, altrimenti non è spirito.
Allora, se io mi rendo conto, anche soltanto partendo dalla tecnica, che spirito è spirito creatore, che la realtà assoluta del tavolo è il concetto di tavolo, che la realtà assoluta della ruota è il concetto di ruota, allora dico: prendendo lo spirito creatore umano dal lato della tecnica, di ciò che è specifico umano, posso diventare creatore, ricreando nel mio spirito tutti i concetti creati dagli esseri divini – che sono i concetti del mondo minerale, vegetale, animale e i concetti di tutto il mondo umano. Spirito è spirito. Creatività all’infinito.
Cos’è la percezione? L’inganno animico dello spirito quando pensa che l’immagine sia la realtà. E qual è il senso evolutivo dell’inganno: il disinganno. Quando uno vive il disinganno e dice: no, la realtà non ce l’ho nell’immagine di percezione ma la realtà è il concetto, questo disinganno diventa un portare a coscienza la propria creatività di spirito pensante.
Lo spirito umano porta a coscienza il fatto di essere spirito per via di disinganno, e il disinganno è possibile solo se prima c’è l’inganno. Il mondo orientale da sempre ci dice che tutto il mondo materiale è un inganno, è maja, per darti la possibilità di disingannarti.
Allora cos’è ciò che vedo? Cosa vedo, io, quando guardo il tavolo? Se porto a coscienza solo la percezione non ho la realtà del tavolo; se invece mi disinganno e mi dico: no, la realtà del tavolo è il concetto, il pensiero di tavolo che l’ha architettato, allora vivo nel disinganno dello spirito e porto a coscienza la creatività dello spirito, perché l’immagine che ho nella percezione è morta, non è una realtà. Il dato di percezione del tavolo (che non è il vero tavolo) non è una realtà, è un’immagine morta.
Si capisce, il discorso, anche se poi scappa via e bisogna riacchiapparlo, riacchiapparlo…? Lo spirito non vive di automatismi.
Intervento: Cervello e mente sono la stessa cosa?
Archiati: No, no. Il cervello lo pesi, lo percepisci; la mente è una specie di sinonimo di spirito. Anzi, lascia perdere quello che ho detto. Fa’ conto che io sia straniero e ti chiedo: cosa intendi per mente?
Replica: Io penso che la mente sia un’espressione dello spirito, che fa da intermediario con il cervello e quindi con il corpo.
Archiati: Tutti quelli che hanno l’italiano come lingua materna sono d’accordo che questo è il significato italiano di «mente»?
Interventi: (mormorii, ndr).
Archiati: In un certo senso sì, in un certo senso no. Tu hai preso una parola italiana, però il linguaggio non è mai un fatto privato, soggettivo, devi metterti d’accordo con gli altri che parlano italiano. «Mente» viene dal latino mens che viene dal sanscrito Manas. Da questa parola sanscrita l’italiano ha derivato la parola «mente» che indica una parte dell’uomo, invece il tedesco l’ha presa per indicare l’uomo intero Mensch.
Tu hai esposto della mente un aspetto che questo spirito crea nell’anima: un’immagine di sé. «Mente» fa parte dello spirito, però non è la parte più importante, è la parte di riflesso di sé. La mente è il luogo animico dove lo spirito fa sorgere la coscienza di sé. La mente secondo l’italiano, però. Invece la lingua tedesca ha preso Manas, spirito pensatore, come l’essenza dell’uomo e l’ha chiamato direttamente Manas (Mensch): in tedesco l’uomo si chiama Manas, spirito pensatore, creatore, che crea concetti, crea concetti, crea concetti intuitivamente.
|
dal sanscrito |
MANAS = Spirito creatore |
|
derivano |
|
|
Tedesco |
Italiano |
|
MENSCH |
MENTE |
|
(uomo) |
(una parte dell’uomo) |
Il cammino del materialismo ha poi fatto perdere di vista lo spirito e, siccome si è detto che l’uomo consta soltanto di anima e di corpo, praticamente l’italiano normale identifica la mente con l’anima: non conosce più la realtà dello spirito. In origine, però, la parola indica direttamente la realtà dello spirito, Manas.
La Chiesa ha tagliato via la testa all’uomo: dei tre arti che lo costituivano – corpo anima e spirito, la famosa tricotomia dell’uomo, la triarticolazione dell’uomo – la Chiesa ha detto: tagliamogli via la testa, l’uomo consta soltanto di anima e corpo.
Arriva la scienza moderna e dice: tagliamo via anche l’anima, va’, ed è rimasto soltanto il corpo come unica realtà. Perché? Perché l’anima è diventata così rachitica, ormai, è rimasta soltanto l’animuccia degli animi non scientifici, e allora mandiamola via. L’unica vera realtà è il corpo. Che cos’è, infatti, la mente per tanti scienziati di scienze naturali? Un’essudazione dei processi del cervello: la realtà reale, però, è il cervello.
|
l’uomo |
l’uomo |
l’uomo |
|
spirito |
||
|
anima |
anima |
|
|
corpo |
corpo |
corpo |
Replica: Si può dire che l’immagine della percezione si forma nella mente?
Archiati: Se per mente intendi l’anima, sì. Tu, l’immagine della persona che hai visto dove ce l’hai? Dov’è l’immagine? Il problema dell’umanità di oggi è che si è talmente materializzata che non riesce più a concepire le cose che sono oltre lo spazio e oltre il tempo: l’immagine nell’animo è oltre lo spazio, non si può dire dov’è, in quale scatola è. Però il pensiero si è talmente depauperato che non riesce più a pensare cose che sono oltre lo spazio e il tempo. Un concetto non è in un posto, è grottesco metterlo in una scatoletta. Un concetto è un concetto, si illumina in ogni spirito pensante. Quando uno pensa «America», è in America, senza bisogno dell’aereo.
Intervento: Si è parlato di spirito, di corpo e si parla molto spesso di anima: mi potrebbe per favore spiegare cosa intende Steiner per anima?
Archiati: A noi non interessa cosa intende Steiner, interessa cosa intendiamo noi. Noi siamo i pensatori, qua, e se quello che leggiamo da Steiner feconda il nostro pensiero, ben venga. Io mi appello, usando il mio pensiero, al tuo pensiero, altrimenti dovrei chiederti di credere a Steiner. E a che ti servirebbe?
Allora, partiamo da un fenomeno fondamentale che è
1. la percezione: per avere la percezione bisogna che ci sia qualcosa di materiale e di corporeo. il corpo, la materia, mi dà la percezione: per esempio, percepisco questo leggìo.
2. Mi giro e del leggìo mi rimane l’immagine: questa immagine è una rappresentazione, un’immagine riflessa, un’immagine interiore. Questa area di autoesperienza, dove c’è un’infinità di immagini interiori, la chiamiamo anima. L’anima (un nome glielo dobbiamo dare, sennò non ci capiamo) è la somma infinita di rappresentazioni, fermo restando che le rappresentazioni sono immagini riflesse, quindi morte, e dunque non sono realtà. La rappresentazione del leggìo che io ho è un’immagine morta, non è che ci posso davvero poggiare un libro sopra.
3. Poi c’è un terzo fenomeno fondamentale, che non è né percezione, né rappresentazione ma è il cosiddetto concetto. La rappresentazione sorge in base alla percezione. Il concetto viene causato? No, non viene causato, viene creato intuitivamente da ciò che noi nel nostro linguaggio chiamiamo spirito. Quindi lo spirito è il creatore all’infinito di concetti: li rende percepibili dal di fuori attraverso la percezione così da far sorgere nell’anima l’immagine riflessa, che è la rappresentazione. Possono la percezione e la rappresentazione creare il concetto? No, il concetto può venir creato soltanto intuitivamente dallo spirito che pensa. Il pensare crea i concetti. La causalità dei concetti è soltanto nel pensare, mai un concetto può venir fuori dall’anima o dal corpo. Le parole del linguaggio fanno sorgere i concetti? No, le parole del linguaggio ci danno, in linea di automatismo, la rappresentazione delle cose, ma non il concetto. Per creare il concetto devo attivare il mio spirito pensante.
Intervento: Vorrei sapere dove mettiamo l’ego e la mente in quello schema?
Archiati: Cosa intendi per ego?
Replica: L’io inferiore, l’io ordinario.
Archiati: Siccome l’umanità di oggi non conosce più la realtà dello spirito perché va riconquistata, praticamente tutta la gamma dei termini del vocabolario che non si riferisce a qualcosa di corporeo e di materiale, è riferibile all’anima. L’uomo d’oggi, se è fortunato, conosce solo l’anima, lo spirito non lo conosce. Quindi tutto ciò che viene detto sull’ego riguarda i fenomeni dell’anima, tutto ciò che viene detto sull’io inferiore riguarda i fenomeni di anima. La scienza dello spirito chiama lo spirito «Io superiore», ma tu chiamalo come vuoi. Non va fatta della realtà una questione di pura terminologia, perciò io ti devo chiedere: che cosa intendi, tu, per ego?
Replica: La coscienza ordinaria.
Archiati: Eh, l’anima è la coscienza ordinaria.
Replica: E la mente dove la mettiamo? Perché io ho sempre pensato che la mente fosse lo strumento dell’io inferiore.
Archiati: Io vi dicevo: il concetto di mente in origine è aperto sia dalla parte dello spirito, sia dalla parte dell’anima. Però l’umanità, in questo caso il popolo italiano, ha spostato sempre di più questo vocabolo, che in sanscrito significa direttamente «spirito», sempre di più a significare l’anima.
Replica: L’ha portato a un piano inferiore.
Archiati: Sì, perché si è perso di vista sempre di più lo spirito.
Replica: Quindi dire che la mente mente è una verità? Cioè, c’è la menzogna nell’etimologia di «mente»?
Archiati: No, l’inganno non è una menzogna.
Replica: Ah, è l’inganno, ok.
Archiati: Se l’inganno serve al disinganno è una gran bella cosa, perché l’inganno è un vero inganno, sincero inganno e ha un senso, però, solo se lo comprendo come inganno e lo realizzo disingannandomi.
Replica: Quindi la mente potrebbe essere lo strumento attraverso il quale noi misuriamo, pesiamo, svolgiamo le attività del mondo fisico?
Archiati: Il problema è che tu fai questioni di vocabolario. Cosa intendi per mente? Tu dai per scontato che tutti siamo d’accordo su cosa significa la mente.
Replica: No, no, io stavo chiedendo di metterci d’accordo sul significato della parola mente.
Archiati: E qual è la tua proposta? Ci mettiamo d’accordo in che modo?
Replica: Non lo so, ci dovrei pensare.
Archiati: Siccome la mente è un termine troppo complesso e già i problemi sono enormi, è più semplice ritornare a questo orientamento fondamentale triplice: corpo, anima e spirito. Questo chiarifica: allora capisci che la mente, secondo il linguaggio italiano, in questo schema oscilla tra 1. e 2. Quindi sarà difficile mettersi d’accordo, perché oscilla: l’uno te lo sposta un po’ di più in giù, l’altro te lo sposta un po’ di più in su, e hanno ragione tutti e due, proprio perché oscilla. Tu non troverai mai gli italiani che si mettono d’accordo su ciò che significa mente, perché per natura questo concetto nel linguaggio italiano di oggi oscilla.
Intervento: Anche nel vocabolario è oscillante.
Archiati: Proprio questo sto dicendo.
Intervento: A volte scende anche più giù.
Archiati: Sì, certo, quando il neurobiologo ti dice che tutti i fenomeni di coscienza sono essudati della materia del cervello, porta giù la mente ancora di più verso il corpo, certo. Quindi va sempre chiesto: cosa intendi, tu, per mente? Queste non sono riflessioni di terminologia, perché la terminologia ha un significato soltanto se mi serve. Le riflessioni vogliono servire a un cammino di pensiero.
Anima è tutto quello che già è stato pensato e spirito è ciò che io penso adesso, che è nel processo vivente, creante del pensare.
L’anima è il passato dello spirito: tutto quello che lo spirito ha già fatto è anima, tutti i concetti già pensati sono anima. Quindi qual è la differenza fondamentale tra anima e spirito? Che l’anima è passiva, è un serbatoio di cose già pensate; invece lo spirito è per natura attivo, nello spirito c’è soltanto ciò che crea hic et nunc, qui e ora. Lo spirito è creazione pura al presente.
Intervento: Vorrei sapere se la morte della creatività dell’essere umano può essere causata, paradossalmente, dal carattere estremamente competitivo della società contemporanea.
Archiati: Hai ragione, è importante il pensiero che stai dicendo. Il mio compito è quello di metterlo un po’ più a fuoco. Una delle caratteristiche fondamentali del cosiddetto materialismo, quindi della fissazione su ciò che è corporeo, è il successo visibile, tangibile: il denaro, la macchina, l’aggeggio migliore di quello che ha l’altro. Questo fissarsi sull’essere l’uno più bravo dell’altro nelle cose materiali, comporta un trascurare infinito della creatività al livello dello spirito.
È questo che tu vuoi dire, ed è molto vero! Dicendo questo cogli un tratto essenziale della cultura borghese materialistica: si fissa a un punto tale sul corporeo che fa sparire la realtà dello spirito e non capisce più neanche la realtà dell’anima.
La religione all’anima ci crede, ma non ne fa l’esperienza vera e propria perché la scienza la intimorisce sempre di più e le spiega che tutto ciò che dovrebbe essere fattore di anima non è qualcosa di a sé stante, ma è soltanto una funzione del corporeo.
Il materialismo è una corsa da matti nel successo dell’avere, trascurando in assoluto l’essere. L’essere viene trascurato a un punto tale che io vi ho parlato con accaloramento di «imbecillità assoluta»: pensavo che mi avreste ammazzato, ma poi nella discussione nessuno ha replicato niente! Ma se me la lasciate passare questa affermazione – che l’umanità è diventata imbecille del tutto –, allora mi date ragione quando dico che le sorti dello spirito sono sparite. Proprio non si ha più neanche un’idea di che cosa sia l’essere umano, tanto è l’impoverimento, tanta è la fissazione su ciò che è materiale.
Invece il senso del corpo è di essere strumento per l’evoluzione dell’anima, e il senso del corpo e dell’anima è di essere un duplice strumento per l’evoluzione dello spirito: altrimenti non hanno senso, sono un duplice controsenso. Un corpo che non funge da strumento per l’evoluzione dello spirito è disumano, lavora contro l’umano.
Intervento: Volevo unire due o tre cose che sono già state dette: il concetto è un processo attivo…
Archiati: La creazione di concetti.
Replica: Sì, la creazione di concetti è un processo attivo, lo spirito opera intuitivamente. La relazione che c’è tra lo spirito e l’anima è temporale: lo spirito, l’intuizione, è atemporale, l’anima invece è legata al tempo ed è legata al passato.
Archiati: Ti avverto che quel che dico ora non è una piccola pulce nell’orecchio, ma una grossa, che non va presa come dogma ma come falsariga per fare cammini di pensiero.
L’elemento dello spirito esula da ciò che noi chiamiamo spazio e tempo, e perciò è difficile, perché l’umanità moderna è piombata in tutto e per tutto nello spazio e nel tempo. L’elemento animico dischiude il mistero del tempo, e il corpo dischiude il mistero dello spazio. Il corporeo apre la dimensione dello spazio, l’anima apre la dimensione del tempo e lo spirito, trasformando la percezione in concetto, riportando la rappresentazione al suo concetto, spiritualizza tutta la creazione spaziale e temporale facendola assurgere allo spirito, riportandola nell’eternità dello spirito. Perché lo spirito crea il tempo e crea lo spazio.
Replica: Grazie.
Archiati: Però, se tu lo ripeti soltanto come l’ho detto io, sarebbe stato meglio non dirlo. Prendilo come una specie di falsariga per cammini all’infinito, perché questi orientamenti sono veramente importanti. Io li devo alla filosofia aristotelico-tomistica che ho masticato da studente a Roma, e ancora di più alla scienza dello spirito di Steiner.
Quando incontro, in certe conferenze di Steiner, queste piste di pensiero, dico: bene, bene, bene, qui posso camminare. E allora vengono pensieri in una direzione, pensieri in un’altra. E Steiner dice: non ripetere lo schemino, ma usalo, usalo, usalo!
È convincente, è una gran bella cosa capire che il mistero del corporeo è il mistero dello spazio e che lo spazio è l’ultima alienazione dello spirito, per poi ritornare a sé. L’anima, il tempo, è la prima alienazione dello spirito per ritornare nell’eternità.
Quindi il senso del corporeo è di abituarci a spaziare, spaziare, spaziare. Spaziare: una parola che il tedesco non ha. Cosa vuol dire spaziare? Ampliare, ampliare finché lo spazio diventa così ampio che… qual è l’ampliamento ultimo dello spazio? L’onnipresenza. E l’ampliamento ultimo del tempo? L’eternità.
Lo spirito è per natura onnipresente ed eterno. Si aliena nel tempo, creando i fenomeni dell’anima e si aliena nello spazio, creando i fenomeni del corpo: è l’idea, il concetto fuori di sé, per ritornare coscientemente in sé.
Quindi il peccato originale è il temporalizzarsi e lo spazializzarsi dello spirito, e la redenzione è il ritornare del tempo nell’eternità e dello spazio nell’onnipresenza, nella compresenza[23].
Cosa vuol dire spaziare? Spazia, spazia, spaziamo... È l’anima che vuole respirare sempre di più spaziando, e spaziando trascende lo spazio: rammemorando e anticipando il futuro spazia nel tempo.
Come si fa ad ampliare il tempo nell’eternità, come si fa ad abbracciare tutto il tempo? Il tempo è triarticolato, il tempo è trinitario: c’è il presente, perché l’anima è presente; la memoria porta il passato, e gli ideali anticipano il futuro. L’eternità è il tutto del passato, è il tutto del futuro nel presente.
A questo proposito c’è una parola in tedesco che l’italiano non ha: Geistesgegenwart, presenza di spirito. Nella presenza di spirito è presente tutto il passato, perché lo capiamo, tutto il futuro perché lo anticipiamo, capiamo i destini dell’uomo. Tutto il passato e tutto il futuro sono nel presente, nella presenza di spirito. Si potrebbe mai dire presenza di animo? No, no: presenza di spirito.
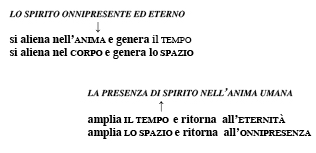
Lo spirito è l’ampliamento ultimo dell’anima. E come avviene questo ampliamento ultimo? Avviene se lo spirito è creatore, creatore, creatore all’infinito. Più ampliamento di così, non c’è. Lo spirito è ampliabile all’infinito, crea sempre, sempre, sempre. All’infinito.
Buon appetito ci rivediamo alle quattro.
Sabato 23 agosto 2008, pomeriggio
Ci stiamo avviando verso la fine del IV capitolo. Poi, affrontando il V, andremo volando. Il IV è quello un po’ più impegnativo.
Torniamo al processo di percezione: l’occhio dell’essere umano percepisce l’albero, dal nervo ottico va al cervello, poi nell’animo c’è la rappresentazione, l’immagine dell’albero.
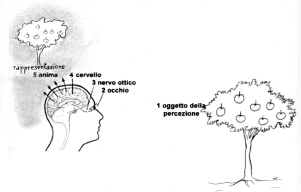
il processo della percezione secondo l’idealismo critico
Fig.15
Ci sono tre posizioni fondamentali:
1. l’essere umano ingenuo dice che la realtà dell’albero è quella lì fuori: prende la percezione come una realtà completa. La realtà dell’albero è ciò che percepisco, dice. Niente di male, perché questa posizione spontanea non è sbagliata: non essendo ancora un filosofo non articola il discorso, non dice che nella percezione c’è il tutto dell’albero, lascia aperta la cosa. Quello lì è l’albero di mele. In fondo è vero, perché dentro la percezione c’è il concetto: il concetto dell’albero non è fuori dalla percezione è l’essenza di ciò che percepisco. Il concetto dell’albero è l’essenza di ciò che percepisco perché è ciò che lo fa essere. Quindi l’affermazione del realismo ingenuo non è sbagliata, è incompleta, è incipiente.
2. Poi arriva il realista critico, il filosofo critico e dice: no, tu sei troppo ingenuo! Nella percezione tu non hai la realtà dell’albero, hai soltanto la rappresentazione dell’albero, ne hai soltanto l’immagine. Questa immagine comporta una mutazione, un processo dentro l’occhio e questo processo si trasmette al nervo ottico, dal nervo ottico si trasmette al cervello e il cervello fa sorgere in te l’immagine dell’albero, che noi chiamiamo rappresentazione.
3. Ed eravamo al punto in cui dicevamo: un momento, ricominciamo da capo. Questo filosofo che disdegna, che disprezza il realismo ingenuo, prendiamolo sul serio: se lui dice che quando io percepisco l’albero non ho la realtà dell’albero ma ho soltanto un’immagine di percezione, allora devo fare lo stesso discorso sull’occhio. Anche l’occhio è qualcosa che percepisco, dunque non ho la realtà dell’occhio: ho soltanto una percezione, un’immagine. Poi, anche riguardo a ciò che avviene nel nervo ottico, la percezione non mi dà la realtà, e così via. L’idealismo critico prende l’occhio, il nervo ottico e il cervello come se fossero realtà, perché soltanto una realtà può causare un’immagine reale. Invece, se fosse conseguente, se restasse alla sua affermazione fondamentale direbbe che, come nella percezione dell’albero abbiamo un’immagine dell’albero, così anche nella percezione dell’occhio non abbiamo la realtà dell’occhio, ma un’immagine, e nella percezione del nervo ottico non abbiamo una realtà, ma soltanto un’immagine e così anche nella percezione del cervello. Allora una prima immagine causa un’altra immagine tutta diversa, la seconda immagine causa un’altra immagine ancora diversa, e poi ancora una terza. Nell’albero, c’è una prima immagine, nell’occhio una seconda immagine, nel nervo ottico una terza immagine, nel cervello una quarta immagine e nell’animo una quinta immagine. Come fanno delle immagini a causare davvero realtà del tutto diverse da sé? La cosa si dimostra del tutto assurda.
Eravamo a questo punto: questa terza è la posizione de La filosofia della liberà che dice: no, restiamo al fatto oggettivo che la percezione mi dà un’immagine. Percepisco l’albero e ho un’immagine dell’albero, non ho una realtà; percepisco l’occhio e ho un’immagine dell’occhio, non posso parlare di realtà; percepisco il nervo ottico e ho un’immagine del nervo ottico, come faccio a dire di avere una realtà?
La percezione non mi dà una realtà, mi dà un’immagine. Poi percepisco l’immagine rappresentativa dell’albero che ho in me: è una percezione anche questa, e di fronte a questa percezione lo so che è un’immagine. Se ho una rappresentazione di un albero di mele belle mature, lo so che quelle mele lì appese non me le posso mangiare. È un’immagine.
Allora diciamo che noi abbiamo dappertutto percezioni che ci danno immagini e allora si pone la questione: se la percezione per natura mi dà sempre e solo immagini, ne consegue che nel mondo c’è soltanto immagine, oppure che ci deve essere qualcosa, oltre la percezione, che mi dà la realtà. La nostra amica, ricordate?, diceva: ma questo podio qui, questo leggìo, è qualcosa di reale!
La percezione mi dà soltanto un’immagine, la percezione mi diluisce, mi svuota il reale perché mi presenta soltanto il lato di immagine. C’è però una facoltà che mi dà la realtà dell’albero, ed è il pensare che mi dà il concetto.
Se io metto insieme il pensare che crea il concetto dell’albero e la percezione dell’albero, se io metto insieme la percezione e il concetto, ho la realtà dell’albero.
La realtà di un melo qual è? È il concetto, è l’idea dell’albero di mele, è la sua legge evolutiva così come l’ha pensata lo spirito creatore: il suo modo di crescere, quanto deve essere grande, quali forze eteriche, vitali ci vogliono per far saltar fuori le mele… Tutti questi pensieri sono la realtà eterna del melo.
Perciò, quale spirito incarnato nel mondo materiale, l’uomo ha la realtà totale delle cose soltanto se congiunge la percezione col concetto. Il solo concetto di melo non mi dà la realtà totale del melo: ce l’ho soltanto se colgo la sostanzialità del melo col pensiero, col concetto, e dal lato della percezione colgo la sua parvenza a livello di materia esteriore. Quindi ho la realtà totale del melo congiungendo la percezione, cioè l’elemento di immagine, col concetto. L’immagine me la dà la percezione resa possibile dai sensi, e il concetto lo creo col pensare.
Riprendiamo la lettura dall’inizio del paragrafo 27, dove comincia l’esposizione del punto 3 di cui ho parlato adesso: IV,27 «Finché ci si ferma qui, tutto appare nell’ordine più bello. Ma invece è necessario ricominciare ancora una volta da principio. Infatti fino ad ora ho trafficato con una cosa: cioè con la percezione esterna di cui prima, come un uomo ingenuo, avevo avuto un’idea completamente falsa. Avevo prima creduto che essa, così come la percepivo, avesse un’esistenza obiettiva {in quanto percezione}. Ora io noto che essa scompare con lo scomparire della mia rappresentazione, che essa è solo una modificazione dello stato della mia anima».
Perché, come dicevamo, l’immagine dell’albero, quando io vado ad analizzare ciò che è rimasto nel nervo ottico, non c’è più. E anche nel cervello non c’è più nulla dell’albero. Cosa percepisco osservando il cervello? Eventi neurosensoriali, magari complessissimi, ma di sicuro non mi salta fuori l’immagine dell’albero.
IV,27 «Ho dunque io ancora diritto di partire da essa {dalla percezione} nelle mie considerazioni? Posso io dire che essa agisce sulla mia anima? D’ora in poi la tavola, che prima avevo creduto agisse su di me e suscitasse in me una rappresentazione, devo trattarla a sua volta come rappresentazione {è un’immagine}. Di conseguenza, sono allora puramente soggettivi anche gli organi di senso e i relativi processi. Non ho diritto di parlare di un occhio reale, ma soltanto della mia rappresentazione dell’occhio. Altrettanto si dica dei processi nei nervi conduttori e nel cervello, e persino del processo nell’anima, per mezzo del quale dal caos delle molteplici sensazioni si costruiscono le cose. Se io, presupponendo esatto il primo circolo descritto dal mio pensiero (Fig.15), percorro ancora una volta le diverse parti del mio atto conoscitivo, questo appare come una trama di rappresentazioni, che proprio come tali non possono agire le une sulle altre».
La percezione dell’albero mi dà un’immagine dell’albero, l’immagine non può agire realmente sull’occhio, perché è un’immagine; così se percepisco l’occhio ho un’immagine dell’occhio, e l’immagine dell’occhio non può agire sul nervo ottico, come l’immagine del nervo ottico non può agire realmente sul cervello. Le immagini sono un nulla di realtà.
Quindi, in questa presunta dimostrazione scientifica del processo conoscitivo che Steiner sta facendo cadere come un castello di carte, io passo da una percezione all’altra, ma ogni volta che percepisco qualcosa ho solo un’immagine, e un’immagine, per definizione, non combina nulla, non fa nulla, non è una realtà che opera, che causa qualcosa. Quando io vedo me stesso nello specchio, l’immagine non può fare nulla, perché è un’immagine riflessa, è un nulla di realtà.
(IV,27) Non posso dire: «La mia rappresentazione dell’oggetto agisce sulla mia rappresentazione dell’occhio, e da questa azione reciproca sorge la rappresentazione del colore».
Sarebbe come dire: stiamo uno accanto all’altro, ci rispecchiamo nello specchio, e l’immagine di me dà un pugno a te senza che io mi muova (o una carezza, se volete, non cambia nulla). Se noi non facciamo nulla, l’immagine non dà né schiaffi né carezze.
(IV,27) Ma non ne ho neppure bisogno. Infatti, appena mi si fa chiaro che i miei organi di senso e la loro attività, che i processi nei miei nervi e quelli nella mia anima possono venirmi dati soltanto attraverso la percezione, risulta per me evidente anche l’assoluta assurdità di tutto il processo di pensiero sopra descritto.
Non c’è nessuna causazione. L’immagine rappresentativa non causa nulla, e perciò tutta la serie delle percezioni/immagini – 1. albero, 2. occhio, 3. nervo ottico, 4. cervello, 5. anima – parte dal presupposto sbagliato che siano realtà che possono causare qualcosa l’una sull’altra (Fig.15). Invece non abbiamo realtà. Ogni percezione è un’immagine e le immagini non possono operare nulla le une sulle altre.
(IV,27) È vero che per me non vi è percezione senza il corrispondente organo di senso; ma tanto meno vi è organo di senso senza percezione.
È vero che senza l’occhio non vedo l’albero, ma è anche vero che se io non percepisco l’occhio, l’occhio non c’è per me. L’occhio è oggetto di percezione, così come l’albero: dipendono dal fatto che io li percepisco, altrimenti per me non ci sono né occhio né albero. Quindi tutti e cinque i passaggi (dall’albero, all’occhio, al nervo ottico, al cervello, all’anima) vanno trattati tutti nello stesso modo, perché in tutti abbiamo a che fare con percezioni.
Questa frase è importante: «È vero che per me non vi è percezione senza il corrispondente organo di senso; ma tanto meno vi è organo di senso senza la percezione». Quindi la percezione dell’albero non c’è senza occhio, ma anche l’occhio non c’è senza che io lo percepisca, c’è soltanto nella misura in cui lo percepisco.
La percezione esiste nel venir percepita, e non esiste nel non venir percepita. Ogni oggetto di percezione, che sia l’occhio o il cervello o quel che si voglia, c’è come oggetto di percezione in base al venir percepito, se no non c’è.
Intervento: Scusa, ma quando vengono stimolate delle zone del cervello e si hanno sensazioni, che cosa vuol dire?
Archiati: Che percepisci una sensazione.
Replica: Ma non ho usato l’occhio, in questo caso.
Archiati: Guarda che qui noi stiamo usando, come esempio, il modo di percepire attraverso la vista perché è quello più sviluppato, oggi, più significativo. Ma lo stesso discorso lo puoi fare con l’olfatto, con l’udito, ecc.
Se uno chiedesse: con quale organo di senso percepisco l’immagine dell’albero che ho entro di me? È una percezione interiore. Soltanto questa domanda basterebbe per farci capire che parlare di cinque sensi soltanto è una cosa poverella. I sensi devono essere molti di più, e molto più complessi, che non i cinque esterni che conosciamo.
Steiner, nella scienza dello spirito, presenta una gamma, proprio un sistema complessivo di dodici sensi, e con questi dodici arrivi a capire con quale organo di senso percepisci l’immagine interiore, la rappresentazione dell’albero.
La scienza ordinaria che si attiene ai cinque sensi, che si accontenta di cinque sensi, non mi sa dire con quale organo io percepisco la rappresentazione: perché la rappresentazione (l’immagine di un albero io posso farmela senza avere nessun albero davanti agli occhi) io la percepisco, è un dato di percezione. La scienza dello spirito è più complessa come scienza, richiede un rigore scientifico maggiore che non la scienza normale che si accontenta di spiegarti come percepisci ciò che è materiale, ma non ti spiega con quale organo di senso percepisci l’immagine mnemonica. Nel ricordo di una persona c’è l’immagine, tante volte bella nitida: con quale organo di senso percepisci questa immagine? Ce ne sono dodici, di sensi, e ben venga che ci siano piccoli gruppi di studio dove queste cose vengono studiate. È una cosa molto bella.
(IV,27) Dalla mia percezione della tavola posso passare all’occhio che la vede e ai nervi tattili che la toccano; ma ciò che avviene nell’occhio e nei nervi tattili, io lo posso a sua volta apprendere solo dalla percezione. E qui mi accorgo subito che nel processo che si compie nell’occhio non vi è traccia di somiglianza con ciò che percepisco come colore.
Percependo l’albero percepisco una forma, il colore verde, ecc, ma quando poi percepisco l’occhio non percepisco colore verde a forma di albero. Cosa è avvenuto dell’albero, nell’occhio? Sparito! In quanto immagine percettiva è sparito. Anche nel nervo ottico è sparito, anche nel cervello. È nell’animo che lo ritrovo: la bella forma e il colore. Da dove vengono?
(IV,27) Non posso distruggere la mia percezione del colore col mostrare il processo che avviene nell’occhio mentre vi si produce tale percezione. E nemmeno mi è possibile ritrovare il colore nei processi dei miei nervi e del mio cervello; io riesco soltanto a collegare nuove percezioni nell’interno del mio organismo con le prime che l’uomo ingenuo colloca fuori del suo organismo. Non faccio che passare da una percezione alle altre {e del tutto diverse}.
IV, 28 Oltre a ciò, l’intera serie di deduzioni contiene un salto.
Questo ve l’avevo già accennato: è un salto mortale che lo scienziato non nota, perché si trova di fronte a una problematica complessa e gli strumenti che ha in mano gli consentono di indagare soltanto il visibile. Il salto è nel passaggio tra il cervello e la rappresentazione mnemonica, l’immagine mnemonica, cioè la rappresentazione nell’anima (Fig.15).
Finché parlo della percezione dell’albero ho una percezione sensibile, finché descrivo ciò che avviene nell’occhio ne ho una percezione sensibile, finché descrivo ciò che avviene nel nervo ottico ho una percezione sensibile, finché descrivo ciò che avviene nel cervello ho delle percezioni sensibili: tutti possono ripetere queste percezioni. L’immagine nell’anima, invece, non è sensibile. Qui faccio un salto.
Intervento: Nella serie che qui abbiamo, da uno a quattro sono immagini percettive, la quinta è un’immagine rappresentativa.
Archiati: Se vuoi. Ma il senso di questa precisazione è che c’è un salto qualitativo assoluto, perché fino al cervello tu mi puoi far vedere e dimostrare cosa stai percependo, quando invece parli dei fenomeni dell’anima non mi puoi far vedere più nulla.
Ciò che avviene nel cervello di qualcuno lo possiamo guardare tutti, con i dovuti strumenti, ma ciò che lui porta come immagine nella sua anima nessuno lo può vedere.
(IV,28) Io sono in grado di seguire quello che avviene nel mio organismo fino ai processi del cervello {da 1. a 4. nella serie}, anche se i miei assunti diventano tanto più ipotetici quanto più mi avvicino ai fenomeni centrali del cervello.
Se noi apriamo la calotta cranica per vedere che cosa succede nel cervello di una persona mentre percepisce l’albero di mele, vi assicuro che non sarà facile percepire oggettivamente, in tutto e per tutto, cosa nei processi è dovuto alla percezione del melo e cosa invece è dovuto alle patate che ha mangiato un’ora prima. Quindi tutta la riflessione diventa sempre più ipotetica, ma restiamo al fatto che però c’è comunque qualcosa da vedere: il cervello è qualcosa che si può vedere, che si può percepire.
Ma quando poi mi si dice che l’immagine dell’albero è dentro la persona, che c’è da vedere? Non c’è più nulla da vedere, il dato di percezione sparisce. Quindi la rappresentazione è una percezione fatta sull’animo, che è qualitativamente di natura del tutto diversa da una percezione fatta sul corporeo: perché una percezione fatta sul corporeo ha una dimensione di oggettività, ripetibile da tutti, invece una percezione fatta sull’animico è del tutto soggettiva.
Intervento: Poi un’altra differenza potrebbe essere questa: mentre l’immagine percettiva che io faccio sul corporeo è un’immagine che io proietto fuori di me, e che in un certo senso è tridimensionale (io la vedo come tridimensionale), la seconda qualità di percezione che io ho nell’anima, e che si potrebbe chiamare immagine rappresentativa, è interiore a me, io la percepisco non esterna, e rispetto all’altra che è tridimensionale, questa volta è bidimensionale.
Archiati: Allora la pulce nell’orecchio che vi ho messo stamattina serve, vedi? Nella percezione dove c’è il corporeo ci sostiene l’elemento spaziale, sorge la realtà dello spazio: quando tu parli di tridimensionalità parli dello spazio, e adesso ti rendi conto che quando osservi, o percepisci l’animico lo spazio è sparito e sei confrontato direttamente col tempo.
Replica: Manca una dimensione.
Archiati: Essendo sparito lo spazio, sei nel puro animico che ti costringe ad andare più vicino allo spirito. Lo spirito ti porta via anche il tempo, ti fa entrare nell’eternità, perciò diventa più difficile e perciò lo scienziato, che è a casa sua soltanto nel mondo materiale dove lo spazio ti aiuta e ti orienta perché ti dà tre direzioni, si trova subito molto meno a suo agio. È tutto più difficile, non mi sa dire neanche quale organo di senso percepisce un fenomeno animico: gli è sparito lo spazio!
Replica: Infatti l’immagine che abbiamo nella nostra anima, la rappresentazione, è bidimensionale, non ha la stereotipia dell’altra.
Archiati: Certo. Ma non è neanche bidimensionale: è adimensionale, perché per avere veramente l’esperienza del bidimensionale devi avere un affresco sulla parete. Il passaggio dall’architettura alla pittura è il passaggio dal tridimensionale al bidimensionale: lì è veramente bidimensionale, vai in alto e in basso, a destra e sinistra senza sfondo e senza rilievo. Però, l’immagine dell’anima, la rappresentazione, non è un affresco.
Replica: Eh sì. E quindi ecco il salto qualitativo fra i due.
Archiati: Il salto qualitativo. E lì, in fondo, la scienza naturale, per quanto onesta, che cosa mi può dire sulla rappresentazione? Nulla, perché sparisce l’elemento portante del corporeo, la tridimensionalità: essa rappresenta l’oggettività, dove per tutti – c’è un accordo oggettivo – gli oggetti diventano oggetti attraverso lo spazio, perché soltanto lo spazio li può mettere «fuori di me». Lo spazio crea un dentro e un fuori; nell’animico non c’è più, in fondo, un dentro e un fuori. C’è soltanto il dentro.
Intervento: Anche nel cervello la complessità delle reazioni biochimiche è talmente vasta che è indefinibile. Cioè, non è solo il discorso della rappresentazione, ma in qualsiasi cervello c’è una complessità di reazioni che è difficilissimo riuscire a stabilire.
Archiati: Perciò dicevo che è una semplificazione astronomica dire che i processi che avvengono nel cervello sono dovuti alla percezione dell’albero. Fa’ conto che dietro all’albero ci sia un tramonto e tanto altro: quello non sarà portato a coscienza ma magari agisce sul cervello molto di più lo sfondo del tramonto che non l’albero. E lo scienziato ti descrive tutti i processi del cervello come se fossero causati dalla percezione dell’albero, invece per tre quarti sono causati dalla percezione del tramonto che ci sta dietro. A quel punto uno si dice: in fondo, questa povera scienza fa delle semplificazioni di fenomeni che sono complessissimi.
Diciamo allora che va benissimo dire che concomitanti (quindi né precedenti né seguenti) all’interazione tra l’occhio e l’albero ci sono processi nel cervello. Non dopo: concomitanti. È un dogma quello che dice che la rappresentazione compare dopo, nel tempo, e che prima c’è la percezione, poi c’è un processo nell’occhio, dopo c’è un processo nel nervo ottico, dopo c’è un processo nel cervello e dopo nel tempo sorge l’immagine nell’animo. Non è vero, tutto questo non lo si può provare, lo si potrebbe provare soltanto se si potessero individuare i processi del cervello che sono veramente dovuti, tutti e solo, alla percezione dell’albero. E questa è una cosa impossibile.
Perché i processi nel cervello sono, in ogni secondo, in ogni momento, infiniti. Cosa avviene in un cervello umano in un secondo di tempo? Non basterebbe una biblioteca se noi dovessimo registrare tutto nei minimi particolari. Ci sono migliaia e migliaia di cesellature nel cervello, e in ogni fibra del cervello avviene qualcosa.
È come l’errore fondamentale che si fa sulla luce: in fondo qui sono tutti fenomeni di luce senza la quale non ci sarebbe né la percezione, né l’evento nell’occhio, né nel nervo ottico ecc… Tutto questo presuppone la luce. L’elemento della luce non è nello spazio e nemmeno nel tempo: la luce è la soglia tra lo spazio/tempo e l’eterno. La luce è sovra-spazio e sovra-tempo.
La luce ci mette del tempo per andare da un posto all’altro? No, no. È un dogma sbagliato che la luce si muova. Dove la luce c’è, c’è da un lato all’altro dell’orizzonte del cielo. E dove non c’è non c’è. Einstein dice che la luce viaggia a 300.000 km al secondo.
Intervento: Puoi spiegare meglio questo passaggio?
Archiati: Lo spirito, chiamalo Io superiore, si è ripromesso, ancora prima di nascere, di compiere tutti i passi, per arrivare quel giorno in quel posto e vedere (non un albero, eh?, mettiamoci la percezione fatidica di questa mattina, che va meglio) proprio quella fanciulla. Mario deve incontrare Mariuccia.
Adesso vi descrivo il fenomeno nella sua totalità, al livello del corporeo, dell’animico e dello spirituale. Cosa avviene in Mario? In un lampo si accende la percezione, lo stesso lampo si accende nell’occhio (il fenomeno ottico), nello stesso istante si accende nel cervello la Mariuccia, il cervello diventa la Mariuccia, e nello stesso istante si accende la rappresentazione come atto volitivo creatore dello spirito. Non uno dopo l’altro, perché se fossero uno dopo l’altro allora sarebbe una causazione a catena: no, è questo spirito che li causa tutti insieme, è un fenomeno unico, unitario. (Fig. 16). È come dire, facendo un paragone, che io accendo la luce e poi devo aspettare un pochino, finché la luce arrivi alla fine della stanza, per poter vedere. Se guardo un oggetto un po’ più vicino alla luce lo vedo prima, perché la luce ci mette un po’ più di tempo per arrivare laggiù e illuminarmi quell’altro oggetto! Ma no, la luce o c’è o non c’è, non ci mette tempo per arrivare da un posto all’altro.
Quindi questa sequenza nel tempo è tutta una speculazione, e nessuno potrà mai dimostrare che c’è una sequenza nel tempo, perché non esiste proprio. Infatti la scienza, siccome l’osservazione dei fenomeni del cervello diventa sempre più minuziosa, sempre più ricca di sperimentazioni, dice che non si può parlare di qualcosa che avviene in sequenza: è tutto contemporaneo, in un lampo.
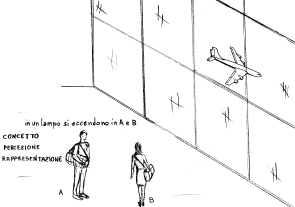
il lampo dello spirito
Fig.16
È il materialismo che smembra tutto e pensa che tutto sia meccanicamente composto di parti. È come dire: se tu percepisci questa persona, questa persona è fatta di mille frammenti, e allora li devi prima mettere tutti insieme, se no non hai tutta la persona. No, quella persona non è un composto, è una unità! Ecco un’altra immagine di qualcosa che non avviene per composizione di elementi. Ce l’ho di botto, quella persona, o non ce l’ho; non la compongo per addizione di elementi.
Il materialismo prende il mondo soltanto dalla parte dove il mondo, attraverso la percezione, è frammentato, e pensa che lo spirito consista nel fatto di mettere insieme per addizione tutti i frammenti. No, il concetto te li mette tutti insieme, la percezione frammenta il mondo. Lo spirito che pensa è l’organo per creare, con uno sprazzo di luce, unità assolute. Perché se io il tavolo, a livello di pensiero, lo devo prima comporre con tutti gli elementi per avere il concetto di tavolo, il concetto di tavolo non ce lo avrò mai. Il concetto è un lampo intuitivo in cui ho tutto il tavolo o non ho nulla.
La polarità tra percezione e pensiero sta proprio in questo: l’esperienza della percezione è in assoluto l’esperienza del frammentare il mondo, del farlo a pezzi, per dare al pensare la possibilità di fare di colpo, con l’intuizione del pensare, l’unità. Il concetto di albero è un composto di parti o è una cosa sola? È una cosa sola.
È come Zenone, ne abbiamo già parlato[24], che diceva che Achille piè veloce non potrà mai sorpassare la tartaruga che gli sta due metri avanti, perché per superare questo spazio deve prima passare la metà, e prima di passare la metà deve passare la metà della metà, e prima ancora la metà della metà della metà. Quanti tratti deve percorrere, Achille? Infiniti, e non può farlo in un tempo finito: quindi Achille non sarà mai in grado di raggiungere la tartaruga.
Questi esercizi di pensiero li faceva Zenone di Elea che voleva dimostrare che il movimento è un’illusione. A livello di concetti, o di dimostrazione, Zenone tu non lo puoi controbattere perché il suo ragionamento non fa una piega: devi soltanto mettere lì una tartaruga e poi, anche senza essere Achille, fai due passi e la sorpassi.
Hai fatto una dimostrazione? No! Hai mostrato il movimento. I concetti non si possono dimostrare: o uno li costruisce, o uno fa i passi di pensiero, oppure non ci sono. E che cosa vogliamo dimostrare se non ci sono?
Ciò che per lo spirito è una realtà unitaria, la scienza materiale te lo frammenta, te lo frantuma, te lo atomizza in infiniti frammenti e poi arranca a rimetterli insieme – dunque, quello causa quello, che poi causa quell’altro e quell’altro…. Eh, ma qui c’è un salto: come fa il cervello a causare un’immagine? È solo perché tu hai frantumato una realtà unita, ma è una realtà unitaria soltanto se la pensi, perciò datti da fare! Se ci metti il pensiero va tutto bene.
Se invece vuoi ricostruire ciò che è frammentato fai come una persona che, invece di tenersi il vaso intero, lo frantuma e poi si chiede: come faccio a rimettere insieme cinquemila pezzetti? Non ce la fai a rimetterli tutti insieme: o ti tenevi il vaso unitario oppure adesso te lo tieni frantumato. La scienza naturale ha perso la realtà unitaria dello spirito, e adesso arranca e si chiede come fare per trovare il nodo unitario che spieghi il tutto. No, non lo trovi, perché il nodo unitario è soltanto il concetto.
Allora, rileggiamo: IV,28 «Oltre a ciò l’intera serie di deduzioni contiene un salto. Io sono in grado di seguire quello che avviene nel mio organismo fino ai processi del cervello, anche se i miei assunti diventano tanto più ipotetici, quanto più mi avvicino ai fenomeni centrali del cervello».
(IV, 28) Ma la via dell’osservazione esteriore {la percezione vera e propria} cessa col processo nel mio cervello, e precisamente con quello che io percepirei se, con metodi e apparecchi fisici, chimici ecc., potessi trattare il cervello {sottoporlo a osservazione, a percezione}. La via dell’osservazione interiore comincia d’altra parte con la sensazione {la sensazione del rosso, la sensazione del freddo o quello che sia} ed arriva fino alla costruzione delle cose per mezzo del materiale delle sensazioni {ricostruisce l’albero come rappresentazione interiore}. Al passaggio dal processo cerebrale alla sensazione {rappresentazione interiore}, la via dell’osservazione è interrotta.
Cioè, io non posso osservare la rappresentazione con gli strumenti con cui osservo il cervello, perciò io chiedevo: con quale organo di senso percepisco l’immagine rappresentativa dentro di me? La cosa diventa più complessa perché c’è un salto qualitativo, e tu dicevi giustamente: esco dallo spaziale, lascio l’elemento specificamente tridimensionale. È un salto qualitativo, e di questo lo scienziato dovrebbe potersene accorgere perché è così evidente, così palese.
IV,29 La concezione esposta più sopra che, in contrasto col punto di vista della coscienza ingenua, che essa chiama realismo primitivo, si qualifica come idealismo critico, commette l’errore di prendere una percezione come rappresentazione {quella dell’albero}, e di prendere le altre proprio nello stesso senso in cui le prende il realismo primitivo, che essa apparentemente combatte.
Quindi l’idealismo critico non parla di rappresentazioni dell’occhio o di rappresentazioni del cervello, ma prende l’occhio e il cervello come se fossero realtà che combinano qualcosa, né più né meno di come fa il realista ingenuo. Contraddice il suo stesso metodo. Combatte il realismo ingenuo usandolo!
(IV,29) Vuole dimostrare il carattere rappresentativo delle percezioni, mentre assume nello stesso tempo, in modo ingenuo, le percezioni del proprio organismo come fatti di valore oggettivo {come realtà oggettive, capaci di causare qualcosa}; e, oltre a questo, non vede che confonde insieme due campi di osservazione fra i quali non può trovare nessun anello di congiunzione.
Non soltanto c’è una contraddizione di metodo – la percezione dell’albero viene presa come immagine, invece la percezione dell’occhio viene presa come realtà –, ma in più c’è il non notare il salto qualitativo che c’è nel passare dalla percezione tridimensionale spaziale alla percezione dell’immagine interna, nell’animo, che è qualitativamente del tutto diversa.
IV,30 L’idealismo critico può combattere il realismo primitivo soltanto asserendo, alla maniera stessa del realismo primitivo, che il nostro proprio organismo ha un’esistenza oggettiva.
Se il mio organismo ha un’esistenza oggettiva, perché non deve avere un’esistenza oggettiva l’albero o la persona che vedo? Sono da trattare allo stesso modo perché sono percezioni tali e quali. Uno si chiede: come ha fatto un Immanuel Kant, un così grosso pensatore, a non notare questi errori fondamentali?
(IV,30) Dall’istante in cui diviene cosciente della perfetta omogeneità delle percezioni del nostro organismo con quelle che vengono considerate dal realismo primitivo come esistenti obiettivamente, esso {l’idealismo critico} non può più appoggiarsi sulle prime come su un terreno sicuro. Dovrebbe considerare anche il suo organismo soggettivo, come un mero complesso di rappresentazioni. Ma con ciò va perduta la possibilità di concepire il contenuto del mondo percepito, come prodotto attraverso l’organismo spirituale. Si dovrebbe supporre che la rappresentazione «colore» sia solo una modificazione della rappresentazione «occhio».
La rappresentazione «colore» è una modificazione della rappresentazione «occhio», e la rappresentazione occhio è una modificazione della rappresentazione «albero». Come fanno le rappresentazioni a modificare se stesse, a produrre una modificazione di sé del tutto diversa da ciò che sono? La cosa diventa assurda.
(IV,30) Il cosiddetto idealismo critico non si può dimostrare se non si chiede un prestito al realismo primitivo: e quest’ultimo non si combatte che mantenendo arbitrariamente validi in un altro campo i suoi propri presupposti.
IV,31 Da ciò risulta chiaro che, per mezzo di ricerche all’interno del campo della percezione, l’idealismo critico non può venir dimostrato, né la percezione può venir spogliata del suo carattere oggettivo.
Restando al livello della serie di percezioni, non riusciamo a risolvere i problemi che vengono posti, non riusciamo a risolvere il problema del passaggio da ciò che è soggettivo a ciò che è oggettivo, del passaggio da ciò che è realtà di rappresentazione a ciò che è realtà oggettiva, reale, che opera qualcosa.
Se restiamo nel campo della percezione, restiamo nel campo di una mezza realtà che ci dà soltanto immagini. Il mondo della percezione – sia che io percepisca l’occhio, sia che percepisca un albero, sia che percepisca il cervello –, mi dà soltanto un mondo di immagini. Se voglio dimostrare che oltre alle immagini c’è anche qualcosa di oggettivamente reale, devo lasciare il campo della percezione, perché lì ho soltanto immagini.
IV,31 «L’idealismo critico non può venir dimostrato, né la percezione può venir spogliata del suo carattere oggettivo». Il realista ingenuo dice: l’albero che io vedo è una realtà oggettiva. Lui non dice: nella percezione in quanto tale io ho tutta la realtà dell’albero, non lo dice. E io non posso dimostrare che il realista ingenuo è nel torto, soltanto per il fatto che io mi riduco al campo della percezione e mi tocca constatare che l’albero, in quanto percezione, è soltanto un’immagine.
Il realista ingenuo che dice che l’albero è una realtà, non prende l’albero soltanto come percezione, non distingue. È l’idealista critico che vuole andare a dirgli: no, tu pensi di avere una realtà quando indichi l’albero, ma non è una realtà – perché il critico vuole ridurre l’albero a percezione, mentre il realista ingenuo non l’ha fatto. Il realista ingenuo non dice che l’albero è soltanto una percezione, dice: è una realtà, tant’è vero che se ci sbatto contro so bene che non è soltanto un’immagine. È giusto, ha ragione.
E se è vero che noi distinguiamo nel fenomeno-albero il lato di percezione, e se ci tocca dire che l’albero in quanto percepito è un’immagine e non una realtà, allora per trovare la realtà dell’albero – che ci deve ben essere, perché ci sbatto contro – devo lasciare il campo della percezione che mi dà soltanto l’immagine della realtà.
Se io voglio veramente dimostrare che l’albero è più di un’immagine, ci deve essere qualcosa oltre alla percezione, e questo qualcosa è il pensare, in cui ci tufferemo adesso, a livelli molto più profondi, nel V capitolo. Ci immergeremo nell’elemento del pensare, della conoscenza, perché la conoscenza dell’albero deve conoscere il tutto dell’albero: l’albero come immagine, ma anche l’albero come realtà oggettiva.
IV,32 Tanto meno si deve però considerare come evidente per sé, e non bisognevole di dimostrazione, l’affermazione che «il mondo percepito è una mia rappresentazione».
Questo virgolettato è di Schopenhauer che dice: io dell’albero ho soltanto la rappresentazione, non posso avere altro che la rappresentazione, quindi il mondo è fatto di rappresentazioni. Oltre alle rappresentazioni che nascono in base alle percezioni non c’è altro!
Mica gli è venuto di pensare: e se ci fosse qualcos’altro che io non conosco?! No, vuol decretare che non c’è. Uno ha l’esperienza della rappresentazione, dell’albero come immagine: finché parla di ciò che ha, va a colpo sicuro, ma deve stare attento a fare affermazioni su ciò che non ha, deve stare attento quando dice: oltre a quello che io ho, non esiste nulla. Questo non lo può sapere.
(IV,32) Schopenhauer comincia la sua opera principale, Il mondo come volontà e rappresentazione, con le parole: «Il mondo è una mia rappresentazione. Questa è la verità la quale è valida per qualsiasi essere vivente e conoscente, quantunque soltanto l’uomo possa portarla nella riflessa coscienza astratta. Se egli realmente fa ciò, è già entrato in lui il senno filosofico. Diventa allora per lui chiaro e sicuro che egli non conosce nessun sole e nessuna terra, ma sempre e soltanto un occhio che vede il sole, e una mano che tocca la terra {ah, ma allora l’occhio e la mano devono essere reali!, non si è mica accorto, lo Schopenhauer, della baggianata che sta dicendo!}; che il mondo che lo circonda esiste solo come rappresentazione, cioè solo in rapporto ad un altro che se lo rappresenta, che è egli stesso. Se mai si può stabilire a priori {cioè apoditticamente, già in partenza come evidenza assoluta} una verità è proprio questa: infatti essa è l’espressione di quella forma di ogni possibile e pensabile esperienza, che è più generale di tutte le altre come tempo, spazio, causalità: perché tutte queste presuppongono quella…» {fine della citazione}.
Schopenhauer e Hegel erano contemporanei, ed è interessantissima la lotta, o proprio le botte sotto la cinghia che i due si sono dati. Hegel vedeva il mondo dal lato dell’idea, del pensiero, invece Schopenhauer diceva che il mondo è fatto di volontà cieca, di impulsi volitivi ciechi, e che di questa realtà noi abbiamo soltanto rappresentazioni in base alle percezioni.
Ora parla Steiner:
(IV,32) L’intero discorso naufraga contro la circostanza da me prima indicata, che l’occhio e la mano sono percezioni quanto il sole e la terra {quindi è la rappresentazione della mia mano che tocca la rappresentazione della terra}. Si potrebbe, nel senso di Schopenhauer e servendosi del suo modo di esprimersi, opporgli: «Il mio occhio che vede il sole e la mia mano che tocca la terra sono mie rappresentazioni proprio come il sole stesso e la terra stessa». Ma è senz’altro evidente che con ciò io annullo tutto il suo ragionamento. Poiché soltanto il mio occhio reale e la mia mano reale, non le mie rappresentazioni occhio e mano, potrebbero avere in sé le rappresentazioni sole e terra come proprie modificazioni. Ma soltanto di queste ultime può parlare l’idealismo critico.
IV,33 L’idealismo critico {che dice peste e corna dell’uomo ingenuo, ma è altrettanto ingenuo rispetto all’occhio e alla mano} è del tutto incapace di arrivare ad afferrare il rapporto tra percezione e rappresentazione: e non può intraprendere la separazione accennata più sopra (v. pag. 56) fra ciò che avviene nella percezione durante il percepire e ciò che deve già essere in essa prima che venga percepita. Occorre dunque battere un’altra strada.
Facciamo una pausa, dopo parlerete e voi e questa sera cominceremo l’altra strada: il V capitolo.
*******
Archiati: Propongo di cominciare la nostra discussione con una scoperta sensazionale: finalmente la scienza pare che stia arrivando al punto di dimostrare che la luce non si muove da un posto all’altro, non impiega tempo. Qui c’è una persona che ci racconta cosa è successo.
Intervento: È stato fatto un esperimento recentemente a Ginevra, al CERN, io l’ho letto su Il sole 24 ore che è sempre piuttosto ben informato. La rivista a cui faceva riferimento il giornalista era Nature, la rivista più prestigiosa della scienza attuale.
L’esperimento è stato fatto così: lungo due percorsi distinti di 18 km ciascuno, su due fibre ottiche separate, sono stati sparati due fotoni cosidetti gemelli. Diciamo che i fotoni sono come sottoprodotti della luce: un fotone è un elemento di luce che ha una natura che non è mai stata risolta, nel senso che il fotone è considerato un corpuscolo che ha una certa energia, misurabile, come tutta la sostanza che è misurabile, però se lo facciamo riflettere su uno specchio diventa un’onda. Sapete tutti che la luce, secondo la fisica, ha una natura sia corpuscolare sia ondulatoria, ma questo lo dico tra parentesi, nel senso che è un dilemma che non è mai stato risolto. Comunque, i due fotoni gemelli sono stati sparati lungo questi due percorsi diversi, e durante il percorso è stato cambiato lo stato quantico del primo – non mi chiedete, adesso, cos’è lo stato quantico: è una cosa molto complessa, dove c’entra quanti giri fa lo spinner, sono una serie di parametri quantici che caratterizzano...
Archiati: È stata cambiata la ponderabilità.
Replica: Sì, penso anche la ponderabilità, perché dopo c’è anche un peso ecc… Insomma, lo stato quantico del primo fotone, durante questo suo percorso, è stato cambiato: istantaneamente nel gemello si è verificato lo stesso cambiamento. Di fronte a questo esperimento gli scienziati dicono: purtroppo la comunicazione avviene attraverso un’onda elettromagnetica che ha la velocità della luce, che non può superare la velocità della luce, cioè 300.000 km al secondo; come mai, allora, è stato rilevato istantaneamente? Allora ci deve essere per forza un fenomeno che in qualche modo supera la velocità della luce, che addirittura è quasi istantaneo, se non proprio istantaneo. Questo effetto era stato chiamato da Einstein «effetto fantasma», perché anche lui l’aveva rilevato, però avrebbe contraddetto la sua teoria della relatività: la luce non viaggia oltre i 300.000 km al secondo. L’effetto fantasma è stato poi rilevato negli anni ‘60-‘70 da altri fisici quantistici, però non è mai stato portato così all’evidenza come in questo esperimento di Ginevra fatto recentissimamente. A questo punto qui parrebbe proprio sancito il superamento della velocità della luce, attraverso questo fenomeno di comunicazione istantanea fra le due particelle.
Archiati: Grazie. «Istantanea» significa: di contemporaneità assoluta. Quindi la luce – se uno legge chiaramente e onestamente questo esperimento – è alla soglia tra il tempo e ciò che è oltre il tempo. Non è vero che la luce si muove nel tempo e ci mette del tempo, non è vero: la luce è oltre il tempo, è nel contemporaneo assoluto.
Il concetto di contemporaneità è ciò che noi chiamiamo lo spirito. Il concetto di tempo è che il tempo è misurabile: è fatto di prima, di dopo, di dopo ancora. C’è tempo soltanto nella misura in cui c’è una sequenza di frammenti di tempo, e anche i 300.000 km al secondo sono una sequenza di tempo. Quando parliamo di stelle che sono a distanza di miliardi di anni luce, parliamo di lassi di tempo enormi che la luce ci dovrebbe impiegare per arrivare fin qui: tutta roba mai percepita, tutta fantascienza, tutte cose che gli scienziati si sono inventati. Ditemi voi quando mai si può sperimentare una velocità di 300.000 km al secondo.
Replica: Potrebbe essere, però, secondo me, che il mio Io spirituale, rispetto all’io ordinario, è fuori del tempo e dello spazio, mentre invece il mio io ordinario è dentro il tempo e lo spazio. Quindi il fenomeno luce è suddiviso in due: c’è la luce spirituale e il suo sottoprodotto, che è la radiazione elettromagnetica, che va a 300.000 km al secondo.
Archiati: Perciò ho detto che la luce è alla soglia, perché la si può prendere sia da questo lato, sia dall’altro lato, dove non c’è più velocità.
Il pensiero è questo: quando io esprimo il concetto «uomo», ci metto del tempo per mettere insieme i pezzi uno dopo l’altro? Acquisisco il concetto di uomo per composizione successiva di pezzi? No, è un lampo, oppure non ho il concetto. Quindi è proprio nel concetto di spirito, di intuizione spirituale, di essere oltre il tempo.
Al livello della percezione, invece, certo che il mondo lo devo percepire un pezzo dopo l’altro, una cosa accanto all’altra. Il mondo della percezione è per natura il mondo dello spazio e del tempo: lo spazio mi dice che i pezzi sono uno accanto all’altro, e il tempo mi dice che sono uno dopo l’altro.
La scienza naturale conosce soltanto il mondo della percezione (va benissimo, però deve rendersi conto di questa unilateralità), e quindi interpreta tutti i fenomeni in termini di un frammento accanto all’altro e dopo l’altro. Però, quando la scienza dice: non esiste un altro mondo di contemporaneità, esula dal suo campo. Finché la scienza dice che nel campo della percezione c’è il fattore tempo e c’è il fattore spazio, è vero, non si scappa. Anche la luce, in quanto diventa sensibilmente percepibile, deve essere un fenomeno spaziale e temporale. Però questo è il tutto della luce? No, è il risvolto sensibilmente percepibile della luce, e lì ho bisogno dello spazio e del tempo, se no non percepisco nulla.
Però dire che non c’è nulla che travalichi lo spazio e il tempo, è fare un’affermazione su qualcosa che non conosco. L’intuizione del pensiero non ha nulla a che fare con lo spazio, con frammenti uno accanto all’altro, e non ha nulla a che fare col tempo, con frammenti uno dopo l’altro.
Tutta la trafila della percezione dell’albero, cui segue quello che avviene nell’occhio, nel nervo ottico, nel cervello e nell’animo, al livello dell’io inferiore è un insieme di fenomeni spazio-temporali, quindi è giusto dire: quello viene prima, quello viene dopo, quello è di là, quello è di qua. Ma questo non ci autorizza a dire che non ci può essere una dimensione che è oltre lo spazio e oltre il tempo. E infatti l’affermazione della scienza dello spirito è che per l’Io superiore, per il nostro spirito, è tutto un lampo.
Intervento: Ma ne prendo coscienza in tempi diversi.
Archiati: Certo, quindi il prendere coscienza è l’esperienza dello spazio e del tempo. Per prendere coscienza ho bisogno di tempo e ho bisogno di spazio: posso prendere coscienza delle cose soltanto una dopo l’altra, una accanto all’altra. Ma lo spirito non prende coscienza delle cose, le crea!
Prendiamo l’esempio di uno scultore che ha un’intuizione creatrice: la mette insieme un pezzettino dopo l’altro? Assurdo! Al livello percepibile deve realizzarla un po’ alla volta, ma l’idea della statua è tutta lì, oppure non c’è nulla. Se c’è, c’è tutta di botto.
Questi sono gli esercizi che ci aiutano a capire che ciò che chiamiamo spirito è l’altro versante del reale, e non riusciremo a capirlo se continuiamo ad arrabattarci nel mondo della percezione, perché il mondo della percezione è essenzialmente fatto di spazio e di tempo. E la luce ci sta dimostrando: guarda, sta’ attento quando parli di me, perché io, luce, sono alla soglia! Tu la luce l’acchiappi come se si muovesse quando la stai percependo, ma luce non è soltanto un fenomeno di percezione. La luce è l’elemento estremo del mondo materiale che va nello spirituale. Prendiamo adesso un esempio di incontro tra luce e materia: accendo la luce e vedo una persona. La vedo tutta in un attimo o la compongo?
Intervento: Tutta insieme, è ovvio.
Archiati: E come faccio? È una percezione di una complessità enorme! Perché sono in grado di avere la percezione di una persona di botto? Perché c’è già dentro il concetto! Se non ci fosse il concetto, la percezione da sola ci metterebbe un paio di mesi a mettere insieme tutti i pezzi, e poi non potrebbe farne una persona perché le mancherebbe il concetto.
Questa è anche la dimostrazione che un gattino non può percepire la persona, perché la persona è un concetto: il gattino va ad annusare l’alluce, poi si sposta, ecc.. quindi il gattino ha soltanto i pezzi. Invece lo spirito umano, siccome percependo pensa, di botto vede una persona. Ma se io la dovessi comporre, questa persona, quanti sarebbero i frammenti? All’infinito.
Nell’esperimento di Ginevra che tu ci hai descritto, a livello di percezione viene evidenziato questo limite del percepibile con un fenomeno di assoluta contemporaneità: non passa neanche un milionesimo di secondo nel cambiamento delle due particelle. Il fenomeno è contemporaneo, sincrono in assoluto (ci sono strumenti in grado di misurare).
Allora qui uno dice: stiamo andando oltre il tempo, perché è insita nel tempo la sequenza misurabile. Questo tipo di esperimento mette un minimo di modestia allo scienziato onesto, perché il suo dogma fondamentale, che tutto è soggetto allo spazio e al tempo, qui arriva al limite: c’è un fenomeno limite dove sia lo spazio che il tempo vengono mesi fuori gioco. Contemporaneo in assoluto significa anche co-spaziale in assoluto, compresente in assoluto: oltre lo spazio, oltre il tempo.
Intervento: Tornando all’argomento di prima sulle rappresentazioni, mi chiedevo qual è l’influenza delle rappresentazioni sulla causa e l’effetto. Stavo pensando all’autoguarigione: come si spiega l’effetto delle rappresentazioni nell’autoguarigione? Possono causare modificazioni degli avvenimenti biologici?
Archiati: Bella domanda. Parto dal presupposto (e voi potrete eventualmente contestare, il dibattito c’è apposta), dalla prospettiva che c’è il mondo della percezione spazio-temporale, e c’è il mondo spirituale oltre lo spazio e oltre il tempo.
L’Io umano, lo spirito umano, contemporaneamente nel suo intuito vede e pianifica la vita successiva come un’opera d’arte, ha l’intuito della vita successiva come lo scultore ha in un lampo la statua che verrà percepita due anni dopo. Questo spirito si costruisce un corpo, e già diversi anni prima di nascere dice: la prossima volta, una delle cose più importanti che voglio fare nel mio futuro corpo è un rene difettoso. Perché? Perché finora ho avuto diverse incarnazioni con i reni sani, ma i reni sani me li ha dati la natura, e sono stufo di far fare tutto alla natura. Nelle vite passate ho fatto un cammino spirituale – il concetto puro del rene, le forze formanti del rene –, e adesso mi pare di essere forte ed evoluto abbastanza: allora, invece di poltrire e far fare alla natura il rene sano, mi faccio fare un rene mal funzionante e a 30 anni, quando si guasterà del tutto, avrò nel mio Io, nel mio spirito, le forze renali come intuiti di forze formanti per risanarlo, ricostruirlo. Queste forze non sono soltanto relegate alla natura, ma fanno parte del mio Io.
Il motivo, l’intuizione che l’Io spirituale ha nei confronti di una malattia, prima di tutto è che la vuole liberamente, perché pensa di farcela, di essere evoluto abbastanza da ricostruire il rene. E un rene sano, ricostruito dall’uomo, vale molto di più che non un rene che mi dà la natura: il senso di tutte le incarnazioni è che, se tutto va bene in senso ideale, ognuno di noi ha la possibilità bellissima di lasciare scassare dalla natura, uno dopo l’altro, di incarnazione in incarnazione, tutti gli organi, per dare all’Io, allo spirito, la possibilità di far proprie le forze formanti e risananti in modo che diventino forze dell’Io.
Questo fenomeno enorme di evoluzione, questa intuizione contemporanea dell’Io superiore, questo baleno che diventa percepibile dopo, nel tempo, tu lo chiami «autoguarigione». Va bene, come parola, se ci rendiamo conto di cosa c’è dietro. Una guarigione che non sia autoguarigione, non è una guarigione, perché il senso di una malattia è l’intento dello spirito di generare lui stesso le forze che creano un rene sano[25]. Se lo lascia risanare alla natura, si costringe a doverlo scassare di nuovo: ma prima o poi lo vorrà fare lui, se no come fa ad evolversi? Quindi il senso di una malattia è la salute, la salute conquistata dall’Io, che vale molto di più che non la salute data dalla natura.
Intervento: Io volevo solo confermare quello che hai detto tu sulla contemporaneità, cioè che lo spirito è immediato. Io penso che un po’ tutti noi abbiamo avuto qualche esperienza di carattere artistico: chi non ha scritto una poesia? Ma io parlo per esperienza personale: è un lampo, è un attimo, e in quell’attimo c’è contenuto tutto. Dopo c’è tutto un lavoro per portarlo nella materia. Ritornando alle due persone che si incontrano, A vede B e riconosce quello che aveva preparato in una vita precedente: anche qui è un attimo e penso che sia una percezione spirituale. O no?
Archiati: È un fenomeno complesso, perché la persona A dopo un poco dice: ma, mi son preso una cotta, mi sono innamorato di questa persona, non mi lascia più in pace nella memoria, ecc. L’animo comincia a sentire il peso enorme di questo incontro, però siamo ancora lontani dal concetto, dal pensiero che mi dice: io sono uno spirito che ancora prima di nascere ha architettato tutti i cammini per incontrare B, e lo spirito di B ha fatto lo stesso.
Replica: Ma non si potrebbe collegarlo a questa illuminazione artistica? Non potremmo vedere una corrispondenza, nel senso di cogliere un qualcosa che mi viene dallo spirito come un lampo, anche lì? In fondo si parla di colpo di fulmine.
Archiati: Quell’incontro dove è stato un lampo di intuito? Nello spirito dei due prima di nascere. Nella coscienza ordinaria diventa un fenomeno di percezione, e lì i pezzi li devi costruire uno alla volta.
Replica: Però il peso di questo passato esiste e ti spinge a realizzare quello che tu hai preparato prima di nascere.
Archiati: Se io mi formo il concetto di questa creazione artistica che l’Io superiore vive quando architetta quell’incontro, che io ad altri livelli faccio quando sono artista – una poesia, una statua, un quadro –, cosa risulta? Risulta che il godimento, l’evoluzione, sta nell’esercitare sempre di più il lampo dello spirito. Però l’intuizione di quell’incontro non la può avere il mio io inferiore perché l’ha avuta il mio Io superiore prima di nascere: ma da lui imparo, e cerco di esercitarmi sempre di più a cogliere il mondo a livello intuitivo.
Intervento: Steiner parla del cuore come organo di senso, per cui volevo sapere se c’è una specifica correlazione fra la rievocazione di un evento in un’immagine, in un ricordo, e la funzione del cuore. E se, in questo caso, è già possibile parlare di una percezione sovrasensibile.
Archiati: Il cuore naturalmente è una metafora, non si intende il cuore fisiologico, ma ci si riferisce alle forze del sentimento e dell’amore. Steiner quando parla del cuore, quando parla delle forze dell’amore o del sentimento, non intende mai dire che possono andar bene da sole, mandando a ramengo la dimensione del pensiero.
Steiner dice: c’è un tipo di pensiero senza cuore, che è quello razionale, intellettualistico, invalso nella scienza moderna, il tipo di pensiero che considera e indaga la dimensione spazio temporale, la dimensione di percezione del mondo. E dice: se tu invece vuoi cogliere il mondo a un livello più profondo, non soltanto al livello del percepibile ma anche a livello dello spirito, ti occorre un tipo di pensiero dove la mente pensa con il cuore e il cuore pensa con la mente. Vanno insieme.
Allora, torniamo a quell’incontro fatidico tra A e B. Il momento in cui creo il concetto dello spirito che con un lampo creatore architetta quell’incontro, mi lascia freddo? No, mi accende il cuore di un entusiasmo, di una gioia, di una gratitudine, di un amore infinito, perché non è un fenomeno intellettuale, non è un fenomeno di conoscenza: non è che io ora so qualcosa di più, no, divento qualcosa di più.
In altre parole, lo spirito non può mai lasciare indifferente il cuore. Invece la scienza chiede assolutamente che il cuore non abbia nulla da dire, che sia freddo, oggettivo, e questo dimostra che è soltanto il lato esterno del mondo.
Il momento in cui io capisco che il rene l’ho voluto io mal funzionante, è un fattore intellettivo? No, è un fattore morale. Quindi la metafora del cuore si riferisce all’aspetto morale, la metafora della testa si riferisce all’aspetto intellettuale. La scienza moderna conosce soltanto il lato intellettuale del mondo, e non sa più cos’è la moralità, non si interessa della moralità, non si interessa neanche di cosa è bene e di cosa è male per l’uomo. Se non recuperiamo la dimensione del cuore, che è la dimensione della moralità, il convivere umano diventerà sempre più tragico, sempre più doloroso.
Intervento: Ma se quella persona che ha il rene rotto non capisce che lei stessa l’ha scelto così, e decide a 30 anni, quando si ritrova malata, di farselo trapiantare, che cosa succede a quell’Io che si è scelto quella malattia e però, poi, non l’ha accettata?
Archiati: Dalla tu la risposta.
Replica: Indebolisce il suo Io.
Archiati: No, lo costringe a riprovarci, sperando che la seconda volta ci riesca.
Replica: E il rene del donatore? Come sta la persona morta?
Archiati: Devi chiederlo a lei, non a me! I modi in cui le persone sono karmicamente connesse fra di loro, le forze di osmosi tra il corpo astrale, l’anima di una persona, e il corpo astrale di un’altra, sono realtà complessissime, e non possiamo mettere la regoletta: questo trapianto s’ha da fare, quest’altro no.
Diciamo soltanto che un conto è se abbiamo a che fare con una umanità che ignora la realtà dello spirito, e allora siamo molto più soggetti a commettere errori all’infinito perché ignoriamo la realtà più importante; se invece recepiamo nella nostra coscienza la realtà dello spirito, abbiamo premesse molto maggiori per far le cose giuste.
La domanda che lui poneva prima è proprio la domanda del cuore: supponiamo che questa persona aveva pensato di fare un trapianto del rene, durante l’attesa studia Steiner e scopre che il suo rene l’ha voluto rotto per lottare contro il rene rotto, e supponiamo che la cosa lo convinca. Non è che ha imparato soltanto qualcosa, non è che ha accumulato un sapere in più: questo convincimento è una forza per far guarire il rene, questa è la differenza, questa è la dimensione del cuore.
Nel momento in cui sono convinto che l’ho voluto io significa che ho la forza, perché il mio Io superiore sarebbe stupido se mi desse una cosa che io non posso fare. Nel momento in cui capisco che il mio Io si può proporre solo cose che sa fare, so di saperlo fare e allora lo voglio fare.
La scienza dello spirito non ha nulla a che fare con disquisizioni teoriche, è vita, crea forze reali: questa è la dimensione del cuore, la dimensione morale. Io, da spirito intelligente, non mi posso permettere un rene rotto senza aver le forze di aggiustarlo io stesso, quindi se ce l’ho rotto vuol dire che ho le forze! È una bella cosa, mi ci metto… Autoguarigione, direbbe lui.
Arriva il terapeuta e ti dice: no, tu non ce la fai, non ce la fai, non ce la fai… È l’antiterapeuta: invece di aiutarti a guarire, ti dà una botta. Il vero terapeuta è quello che ti dice: se ti sei preso questa malattia vuol dire che ce la fai a superarla, no?
Intervento: Tempo fa, qui in Italia, una persona ha avuto un cuore trapiantato, donato da una persona morta suicida. Dopo pochi mesi si è suicidata anche lei. A una donna hanno trapiantato il cuore di un uomo, e dopo un po’ ha cominciato a provare attrazione verso le donne. In Australia ad un uomo hanno trapiantato una mano e dopo un po’ di tempo ha detto: toglietemi questa mano, per favore, ridatemi l’arto meccanico. Chiedo: l’elemento eterico comunque influisce? Non possiamo trattarci come se fossimo tutti manichini.
Archiati: Nel fisico ci sono lo spazio e il tempo, poi ci sono realtà ulteriori che la scienza non conosce: c’è l’eterico dove rimane lo spazio puro, e c’è l’astrale, che è il tempo puro. Quindi l’astrale è tempo puro, l’eterico è spazio puro, sotto c’è lo spazio/tempo del mondo fisico e lo spirituale è oltre lo spazio e il tempo. Ogni organo è intriso di forze fisiche, che hanno un funzionamento in base a spazio e tempo, di forze eteriche, che sono per natura spaziali, di forze astrali che sono per natura temporali, e poi c’è lo spirito.
mondo spirituale oltre lo spazio e il tempo
mondo astrale tempo puro
mondo eterico spazio puro
mondo fisico spazio/tempo
Intervento: Noi abbiamo detto che il sapere, e di questo sono convintissimo, è una conquista esperienziale, non credo che solo per lettura si possa arrivare al sapere. Viviamo poi in un’epoca di dormienti, perché di cultura materialista. L’Io superiore, per l’incontro che ha pianificato, esige che A e B siano nel pensare?
Archiati: No. L’evoluzione del pensare è una faccenda della coscienza ordinaria, dell’io inferiore; quindi il cosiddetto Io superiore deve lasciare alla libertà della coscienza ordinaria l’evoluzione del pensare – altrimenti non ci sarebbe libertà. E perciò l’uno omette di meno l’evoluzione del pensiero, l’altro omette di più.
La tua domanda comprende un’altra domanda: come interagisce la coscienza dell’Io superiore con la coscienza ordinaria? Io ho sempre usato un paragone, quello dei genitori con i bambini piccoli. I bambini di due, tre anni hanno una coscienza più ristretta rispetto alla coscienza degli adulti. Ora, i genitori pianificano una vacanza, un fine settimana.
La coscienza dell’adulto è abbastanza evoluta da abbracciare tutto il fine settimana in uno sguardo d’insieme, come una unità. Sa che comincia al venerdì sera e finisce alla domenica, ce l’ha come unità; invece la coscienza del bambino, che non è ancora capace di queste grosse unità, vive i frammenti di tempo e vive solo nel presente. Supponiamo che i genitori abbiano pianificato di andare il sabato due ore alla spiaggia.
La tua domanda è: la coscienza più piccola (che nel tuo caso sarebbe la coscienza ordinaria) non ha nessuna possibilità di apportare delle modifiche nella coscienza superiore? Se la coscienza superiore, oltre a essere sapiente è anche amante, lascia aperto il modo di rispondere, di comportarsi dei bambini (della coscienza inferiore). Non è che i bambini saranno in grado di trasformare un fine settimana in quindici giorni di vacanza, perché allora sarebbero loro a pianificare, però possono apportare delle variazioni a seconda di come si comportano. Il tempo è così bello, i bambini sono così contenti e sarebbe un disamore portarli via dopo due ore: così le ore diventano quattro.
La coscienza superiore dei genitori (l’Io superiore, nel tuo caso), a seconda di come reagisce la coscienza inferiore, si adatta: però la regia resta alla coscienza superiore. La regia della vita resta sempre in mano all’Io superiore, che però è sovrano abbastanza da essere flessibile a seconda di come la coscienza inferiore reagisce: perde colpi o non perde colpi, reagisce bene o reagisce male, il rene se lo riaggiusta godendosi lo sforzo oppure no... insomma, a seconda di come l’io inferiore gestisce la sua libertà, l’Io superiore rincara la dose oppure dice: qui le cose vanno bene, andiamo avanti.
Lo stesso ragionamento vale nel rapporto tra la nostra coscienza ordinaria di adulti e quella dell’Angelo. La coscienza ordinaria, in chiave di memoria, di consequenzialità e causa-effetto, vede i rapporti tra i vari giorni della vita – oggi, ieri, l’altro ieri, l’altro ieri ancora – anticipa il domani, il dopodomani, pianifica, progetta, vive ideali.
Come la coscienza ordinaria abbraccia in uno sguardo d’insieme e connette i rapporti fra giorni diversi, separati da un cambio di livello di coscienza – il sonno –, così la coscienza dell’Angelo vede la connessione di causa-effetto dei «grossi giorni» dell’evoluzione umana, cioè le varie vite, separate da quel cambio di livello di coscienza che è la morte. L’Angelo ha la memoria delle vite passate e sa i progetti delle vite successive. La nostra coscienza ordinaria, nei confronti della coscienza dell’Angelo, è tale e quale alla coscienza di un bambino nei confronti della coscienza dell’adulto. È piccola la differenza? Dovete concedermi che la differenza è astronomica, perché il bambino non sa nulla di ieri e di domani, e da qui nasce l’innamoramento del bambino verso gli adulti: senza saperlo coscientemente, vuole diventare grande per essere come il papà e la mamma. Altrettanto astronomica è la differenza tra la coscienza ordinaria dell’uomo e la coscienza dell’Angelo – non parliamo poi di quella dell’Arcangelo, di quella del Principato ecc…
Intervento: Ma allora l’Angelo è sempre lo stesso per ogni individuo?
Archiati: Certo che è sempre lo stesso, vuoi che ti pianti in asso? Che Angelo sarebbe, sarebbe un diavoletto. Certo che è sempre quello.
Intervento: Non si stufa?
Archiati: Una mamma buona non si stufa con il bambino, è sempre la stessa.
Replica: Quando uno sta per nascere sceglie i genitori, ma anche i genitori scelgono lui?
Archiati: I genitori hanno scelto lui prima di nascere, e hanno detto: se vogliamo averlo come figlio, dobbiamo nascere 20 anni prima. I genitori sapevano prima di nascere quali figli avrebbero avuto? Sì e no! Sanno quali figli avrebbero desiderato, se però i figli, nella loro libertà, sono d’accordo o vanno a nascere da un’altra parte, stiamo a vedere. Ha a che fare con la libertà. Però, nell’armonia del karma, i genitori si sono detti prima di nascere: sarebbe bello se quello spirito lì e quello spirito lì diventassero nostri figli.
Intervento: Anche perché, nella preparazione delle vite successive, queste individualità si sono già frequentate in passato.
Archiati: Hanno detto: il nostro passato karmico sarebbe bello, sarebbe armonioso, se nella vita successiva, che sta per cominciare, avessimo un rapporto da genitori a figli.
Intervento: Vorrei una precisazione. In questi giorni abbiamo parlato del concetto come spirito creante, pensante: possiamo riferire la stessa cosa allo spirito generante, o c’è bisogno di fare ancora un salto qualitativo? Quando intendiamo «generato e non creato», per esempio.
Archiati: Oh poveri noi! Adesso entri nel merito del Credo cristiano: «generato e non creato» si riferisce al rapporto tra il Padre cosmico e il Figlio. «Generato e non creato» in greco andrebbe tradotto «generato e non fatto», perché tutto ciò che è fatto fa parte del mondo della percezione. Ora il Verbo che è stato generato da sempre, dall’eternità, dal Padre, non è fatto: è un essere spirituale, quindi è un parto spirituale. La traduzione giusta sarebbe «generato e non fatto».
I genitori, invece, generano i bambini in quanto li fanno, fanno nascere un corpo fisico con un elemento di percezione. Il Verbo generato e non fatto dal Padre è diventato percepibile alla svolta dei tempi, tramite il Gesù di Nazareth, inabitando il Gesù di Nazareth, parlando attraverso di lui per tre anni. Però non è mai stato fatto: si è espresso, attraverso un corpo umano, a livello percepibile.
Intervento: Allora l’io inferiore è fatto, e l’Io superiore è generato?
Archiati: Sì, perché l’io inferiore non è nulla senza l’interazione dell’anima con il corpo.
Basta così, per oggi. Questa sera cominciamo il V capitolo.
Sabato 23 agosto 2008, sera
Affrontiamo il V capitolo: La conoscenza del mondo, in tedesco Das Erkennen der Welt, il conoscere il mondo. In tedesco c’è un verbo, un’attività, e in italiano traducono «conoscenza». Che differenza c’è tra conoscere e conoscenza?
Intervento: La conoscenza è un punto d’arrivo.
Archiati: Sì, e il conoscere è essere per strada. Ovviamente anche in tedesco c’è la parola «conoscenza», è Erkenntniss, ma nel titolo non c’è. Perché, allora, in italiano traducono: «La conoscenza del mondo»? Perché se intitolassimo «Il conoscere il mondo» non renderebbe, in italiano renderebbe un po’ di meno. È così, è così. Facciamo evolvere il linguaggio in modo che anche in italiano suoni bene dire «Il conoscere il mondo», quale processo sempre in corso.
Intervento: La conoscenza te la può comunicare anche un altro, il conoscere è una cosa che devi fare da te.
Archiati: Perché il conoscere sono i passi che ognuno deve fare con le gambe sue: nessuno può sostituire il tuo camminare. Il processo del conoscere è che l’essere umano non incamera conoscenza, ma conosce, crea il conoscere congiungendo la percezione col concetto. L’apparato sensoriale, che noi chiamiamo corpo, gli dà la percezione e lo spirito crea, col pensare, i concetti. Siccome siamo abituati a conoscere, non ci rendiamo conto che spontaneamente nel percepire le cose creiamo contemporaneamente il concetto – non uno dopo l’altro.
Però l’albero non è una percezione. Anzi, prendiamo una rosa: quanti frammenti di percezione bisogna mettere insieme per percepirla tutta, la rosa? All’infinito!
Intervento: Perché?
Archiati: Perché se tu dovessi percepire tutto il percepibile della rosa, anche soltanto in termini di variazioni di luce e ombra, in ogni foglia avresti per lo meno 150 percezioni diverse, e poi di momento in momento cambiano le luci e le ombre. Il percepibile è per natura atomistico, lo dicevamo oggi. In chiave di percezione non c’è nessuna possibilità di acchiappare realtà unitarie, perché «rosa» è una unificazione di infiniti frammenti potenziali.
La tua domanda è come chiedere a Zenone quanti tratti di strada deve fare Achille per arrivare alla tartaruga: all’infinito. Li puoi dividere all’infinito. A livello di percezione il mondo si presenta atomizzato.
Ma noi non viviamo il mondo soltanto a livello di percezione, perché siamo abituati contemporaneamente a pensare, Quindi quello che solo potenzialmente sarebbe una frammentazione all’infinito, che non arriva mai a sommarsi in una unità, il pensare lo acchiappa subito come unità e dice «rosa».
Questo ci dice che il bambino piccolo, che non ha ancora il concetto di rosa, non ha neanche la percezione, di fatto: il bambino non vede la rosa. Cosa percepisce il bambino quando guarda la rosa? Nulla. Tutto e nulla. Noi abbiamo fatto l’esercizio che dice: se in via di ipotesi (perché è un’esperienza impossibile da farsi) togliamo al nostro rapporto col mondo tutto quello che da sempre, come adulti, ci mettiamo in chiave di pensiero, e poi ci chiediamo cos’è la percezione pura senza il portato del pensiero, senza il concetto, dobbiamo esprimere la percezione pura in termini di assoluta negatività. La percezione pura è il nulla di pensiero, quindi non si può dire nulla di cos’è. La percezione pura della rosa è negatività, non è qualcosa: è la pura assenza della rosa.
Intervento: Il bambino piccolo vive la rosa come l’animale, cioè ha lo stesso rapporto?
Archiati: Sì, a livello di coscienza ordinaria. Che poi, nell’essere totale del bambino piccolo, ci sia uno spirito umano individualizzato che l’animale non ha, questo è un altro discorso. Qui stiamo parlando di quello che la coscienza ordinaria vive. La rosa vive e vegeta nel corpo astrale del bambino, gli fa sorgere sentimenti ecc., ma non c’è nulla di ciò che noi chiamiamo percezione, perché la percezione mi accorgo di averla solo quando ho il concetto.
Intervento: Ma non è la stessa cosa quando vediamo un oggetto che non conosciamo?
Archiati: Se non sai cosa sia, vedi il nulla.
Replica: Ma vedo l’oggetto, lo posso descrivere.
Intervento: C’era un gioco televisivo dove facevano vedere solo un particolare di un oggetto e non si capiva che cosa fosse. Si doveva indovinare che cos’era.
Archiati: Però tu lo sapevi che era un particolare, che era un frammento di qualcosa. Sai già che è il particolare di qualcosa.
Replica: Ma non so l’insieme.
Archiati: Ma guarda che «particolare di un insieme» è un concetto. È come quando hai una scatola di puzzle piena di pezzi: io tiro fuori un pezzo e non so quale posto occupa questo pezzo nel quadro d’insieme, però so che è un pezzo di un quadro, so che ho la percezione di un pezzo: «pezzo di un quadro» è un concetto.
Questo per evidenziare che noi, come adulti, siamo sempre nel pensare: per uscire dal pensare dobbiamo addormentarci, ma quando ci addormentiamo non c’è la percezione, non c’è né percezione né pensare. Nel momento in cui ci svegliamo, sono tutti e due insieme, come quei fotoni che hanno all’improvviso creato dei fenomeni assolutamente sincroni. Quindi l’esperienza di percezione e di concetto è di una sincronicità assoluta: o ci sono tutti e due o non c’è nessuno dei due.
È perciò un errore dire che il bambino piccolo ha soltanto la percezione senza il concetto: no, non ha neanche la percezione.
Intervento: Ma qualcosa vedrà, questo bambino! Magari il mondo eterico…
Archiati: Il bambino piccolo sente, ha sensazioni, cosa ben diversa dal percepire qualcosa. Vive, sente, ma non percepisce, perché nel momento in cui percepisce deve saper dire cos’è che percepisce. La rosa, la bicicletta, l’albero, un uomo…
Il discorso di Kant che dice: io ho soltanto rappresentazioni della cosa in sé, vorrebbe dire che ci può essere la percezione senza concetto. No, no, non ti accorgi che creando il concetto hai la cosa in sé. Il concetto è la cosa in sé.
V
La conoscenza del mondo
V,1 Dalle considerazioni precedenti risulta l’impossibilità di raggiungere, attraverso l’esame del contenuto della nostra osservazione, la dimostrazione che le nostre percezioni sono rappresentazioni. Tale dimostrazione deve essere raggiunta mostrando che, se il processo della percezione avviene nel modo in cui ce lo rappresentiamo secondo gli assunti del realismo primitivo riguardo alla costituzione psicologica e fisiologica dell’individuo, non abbiamo a che fare con cose in sé ma soltanto con le nostre rappresentazioni delle cose.
Certo, se io avessi soltanto la percezione, se avessi la percezione pura, avrei soltanto la rappresentazione, ma la percezione pura non si può avere perché per natura ci aggiungiamo subito, in chiave di pensiero, in assoluta contemporaneità, il concetto.
(V,1) Ora, se il realismo primitivo, logicamente svolto, conduce a risultati che sono in diretto contrasto coi suoi presupposti, bisogna dire che questi presupposti sono inadatti a servire di base a una concezione del mondo e devono essere abbandonati. In ogni caso non è permesso di abbandonare i presupposti e di conservare le deduzioni come fa l’idealista critico ponendo a base della sua tesi il ragionamento sopra esposto, che il mondo sia una nostra rappresentazione (Eduard von Hartmann, nel suo libro Il problema fondamentale della teoria della conoscenza, dà un’ampia spiegazione di tale processo dimostrativo).
V,2 Una cosa è la giustezza dell’idealismo critico, e un’altra cosa è la forza persuasiva {dimostrativa} dei suoi argomenti. Per quanto si riferisce alla prima, vedremo più tardi che cosa pensarne in rapporto alla nostra trattazione; ma quanto alla seconda {cioè la forza persuasiva}, dobbiamo riconoscere fin d’ora che essa è uguale a zero. Quando si fabbrica una casa, e il peso del primo piano fa cadere il pian terreno, precipita insieme anche il primo piano. Il realismo primitivo e l’idealismo critico si comportano proprio come tale pian terreno rispetto al primo piano.
Abbiamo visto che l’idealismo critico condanna il realismo ingenuo e prende la percezione dell’albero come pura rappresentazione, però l’occhio che vede l’albero lo prende come una realtà e non come una rappresentazione. E abbiamo detto che se la percezione dell’albero la chiami «una pura rappresentazione», anche riguardo all’occhio che guarda devi dire che hai, né più né meno, solo una rappresentazione, non la cosa in sé, non la realtà vivace e operante dell’occhio. Albero, occhio, nervo ottico, cervello, animo: si va d’immagine in immagine, un’immagine crea l’altra, tutta diversa da sé, e questa è una cosa assurda.
V,3 Per chi è dell’opinione che tutto il mondo percepito sia solo rappresentazione, cioè solo l’effetto sulla mia anima di cose a me sconosciute, il problema della conoscenza si concentra evidentemente non nelle rappresentazioni esistenti soltanto nell’anima, bensì nelle cose situate al di là della nostra coscienza e indipendenti da noi.
Dopo aver decretato che io, nella percezione dell’albero, non ho la cosa in sé dell’albero ma ho soltanto un’immagine dell’albero, Kant si chiede: c’è o non c’è una qualche possibilità di sapere qualcosa sull’albero reale, sulla cosa in sé dell’albero? Questo è il problema di Kant. Però, se già in partenza ha detto che io dell’albero posso avere soltanto una rappresentazione, soltanto un’immagine, che cosa mi può dire l’immagine sulla realtà? Un’immagine della realtà. Kant stesso ha decretato che io alla realtà non ci posso arrivare.
La risposta di Steiner è: io, quando ho la percezione dell’albero, disattendo, non mi accorgo che contemporaneamente alla percezione, attivando il pensiero – a livelli spontanei, ordinari, ognuno di noi lo fa –, ci metto il concetto.
«Albero» non è una percezione, non è una rappresentazione: è un concetto. Un concetto che comporta l’interazione armonica tra radici, suolo, vari succhi del suolo, sali, aria, calore, acqua, poi l’interazione delle radici col fusto, l’interazione con le foglie ecc…: tutta questa complessità di elementi organicamente costituiti io la chiamo «albero».
Questa complessità, lo dicevamo, in chiave di percezione potrebbe venire atomizzata all’infinito. La tua domanda di prima, in fondo, era: se io ho un albero grande quanti fotogrammi diversi ne posso fare? La risposta sincera, oggettiva è: all’infinito! Fotogrammi diversi all’infinito, e un fotogramma è un’immagine di ciò che sarebbe la percezione pura se noi potessimo averla.
La percezione pura è passibile di atomizzazione all’infinito: quando io dico «albero», sono fuori dalla percezione, sono nel pensare che di una infinità fa un’unità assoluta: albero. E questo è opera del pensiero.
Come la percezione tende ad atomizzare il mondo, a disgregarlo, a farne una farragine senza rapporti, così il concetto, il pensare, crea organismi. Ogni concetto è un organismo, mette in rapporto le radici, il terreno, il fusto, le foglie, i rami, tutto quello che ci vuole, e quando tutto funziona in armonia, quando ogni elemento è in funzione dell’altro, hai l’albero. L’albero è il risultato di un processo di pensiero enorme, che noi siamo abituati a fare, perché siamo esseri pensanti.
Il pensare è quella capacità di luce che all’improvviso si accende e, accendendosi, ti illumina il tutto in una volta, non i pezzetti uno dopo l’altro, e ti dice: albero. Una cosa bellissima!
Quando l’essere umano arriva a rendersi conto di ciò che fa sempre a livelli spontanei, di quale energia sintetica di luce sia il pensare, si innamora talmente del pensare che diventa sempre migliore, sempre più bravo a pensare.
Qual è la tristezza o la sofferenza della vita? È il non capire perché questa cosa ha a che fare con quest’altra, perché questa malattia ha a che fare con me, perché mi è capitata, ecc… Il non capire significa avere frammenti spezzettati senza riuscire a vederli in funzione l’uno dell’altro.
L’intuizione unitaria in assoluto di tutti i concetti, quella che unisce addirittura tutti i concetti, che sono già realtà unitarie, in una realtà unica, è il concetto dell’Io. Tutti i concetti del mio pensare sono frammenti di evoluzione del mio spirito, del mio Io pensante.
Tutto il mondo esistente è potenzialità evolutiva dell’Io che pensa: basta che lo pensi e, pensandolo, lo fa assurgere a sé, ne fa un frammento del suo spirito pensatore. Quella è l’unità in assoluto: l’Io. È l’unità di tutte queste unità, perché i concetti sono già unità: se poi diventano frammenti che si riunificano nell’evoluzione dell’Io che pensa, abbiamo l’unità di tutte le unità.
L’unità del mondo è lo spirito pensante, creatore: il mondo è tutta creazione sua. Lo spirito divino l’ha creato di primo acchito, lo spirito umano lo riceve dal lato della percezione e così gli viene lasciata la gioia di ricreare il mondo a partire dal suo pensare. E ricreando il mondo genera, porta all’essere il suo spirito come spirito creatore che crea il mondo, nel pensare.
Se la creazione è l’opera d’arte di Esseri divini, per l’essere umano c’è in un certo senso una cosa ancora più bella della creazione: la ricreazione. «Ricreazione» è una bellissima parola italiana, che il linguaggio tedesco non può dire. Ricreazione significa ricreare facendosi al contempo una bella goduta: due significati bellissimi. Il pensare è la ricreazione dello spirito umano dovuta al suo ricreare il mondo.
Al liceo, quando si finiva di pensare, di fare lezione, si andava a fare ricreazione, il che vuol dire che mentre si era a scuola altro che ricreazione, c’era solo da sbuffare! L’arte sarebbe di far ricreazione senza uscire dal contesto in cui uno si trova.
Allora, torniamo all’opinione di chi ritiene il mondo soltanto una rappresentazione:
(V,3) Egli domanda: «Quanto possiamo indirettamente conoscere di queste ultime {delle cose in sé, quelle oltre la percezione} dato che non sono direttamente accessibili alla nostra osservazione?».
Il decreto di partenza della filosofia kantiana è che io dell’albero posso conoscere, posso avere in me soltanto la rappresentazione; la cosa in sé, cioè la realtà dell’albero, non può entrare in me. Allora mi resta soltanto la domanda se, studiando la rappresentazione che è l’unica cosa che ho, posso fare delle illazioni che mi fanno indirettamente conoscere qualcosa sulla cosa in sé. Però indirettamente, perché direttamente non la posso conoscere.
Questo pensiero mette alla base due presupposti che non vengono esplicitati, non vengono portati a coscienza, cosa che invece è importantissimo fare:
• il primo presupposto mi dice che la cosa in sé è dietro, è oltre la percezione: quindi è un elemento spaziale, come se la cosa in sé fosse nello spazio;
• il secondo presupposto dice che la cosa in sé si può conoscere soltanto per percezione: ma essendo più in là, essendo nascosta dietro le cose, non la posso percepire.
Le affermazioni per illazione, le affermazioni indirette mi servono a sapere qualcosa della cosa in sé, però resta il fatto che questa cosa in sé mi sta di fronte. Il reale viene concepito come qualcosa che sta di fronte all’essere umano. In altre parole, il reale viene concepito sulla falsariga del mondo materiale, perché soltanto nello spazio materiale una cosa mi può stare di fronte: io sono qui e la cosa in sé è lì.
Invece, a livello spirituale, quando io penso il concetto sono io la cosa in sé. La cosa in sé non è né oltre né dietro la percezione, ma diventa un raggio di luce del mio spirito.
Un’affermazione comune ad Aristotele, Tommaso d’Aquino e Rudolf Steiner, l’adagio importantissimo degli scolastici è: il conoscente nell’atto di conoscere e ciò che è conosciuto nell’atto di venir conosciuto, diventano una cosa sola, sono la stessissima cosa.
Quando io penso il concetto dell’albero, io sono albero nel mio spirito pensante, non c’è più nulla dietro, oltre: non soltanto ho in me la cosa in sé, ma sono io la cosa in sé in quanto spirito pensante. E quando penso a un’altra cosa sono quell’altra cosa, e poi divento un’altra cosa ancora, e poi un’altra cosa ancora.
Prendiamo di nuovo l’analogia della luce: quando la luce illumina un oggetto io vedo l’oggetto nella luce: posso distinguere la luce dall’oggetto che vedo? No, no, pensateci bene. Se porto via la luce, porto via l’oggetto: perciò l’analogia della luce è sempre stata usata per far capire il mistero del pensare. La luce del pensiero, ciò che io illumino pensando, è una cosa sola con ciò che viene pensato: quando penso «albero» sono albero nel mio spirito, mi illumino arborealmente.
(V,3) Chi si colloca da questo punto di vista si preoccupa non del legame interiore fra le sue percezioni coscienti, ma delle loro cause, non più coscienti, che hanno un’esistenza indipendente da lui, mentre, secondo il suo modo di vedere, le percezioni scompaiono appena egli distoglie i propri sensi dalle cose. La nostra coscienza, da questo punto di vista, funziona proprio come uno specchio, nel quale le immagini di determinati oggetti scompaiono nel momento in cui la superficie riflettente non è rivolta verso di essi. Ma chi non vede le cose in sé, bensì soltanto le loro immagini riflesse, deve dedurre indirettamente, dal comportamento di queste ultime, le proprietà delle prime. In questa posizione sta la coscienza naturale moderna, la quale adopera le percezioni solo come ultimo mezzo per arrivare a comprendere i processi della materia che stanno dietro alle percezioni e che soli sono veri. Se il filosofo, come idealista critico, può ammettere un’esistenza in generale, il suo sforzo conoscitivo non può che tendere, per mezzo dell’utilizzazione indiretta delle rappresentazioni, verso questa esistenza. Il suo interesse salta al di là del mondo soggettivo delle rappresentazioni e si getta su ciò che dà origine a tali rappresentazioni {e va in cerca della cosa in sé dietro alla rappresentazione o alla percezione dell’albero: in fondo presuppone che anche la cosa in sé vada individuata, vada percepita, perché è là fuori, fuori di me}.
V,4 L’idealista critico può però arrivare anche a dire: «Io rimango chiuso nel mio mondo di rappresentazioni, e non posso uscire da esso. Se penso una cosa dietro le mie rappresentazioni, anche questo pensiero non è altro che una mia rappresentazione».
Anche la cosa in sé è una rappresentazione, se io ho detto in partenza che sono capace di avere soltanto rappresentazioni. Quindi passo da una rappresentazione all’altra: dalla rappresentazione dell’albero che percepisco, a una rappresentazione della cosa in sé che neanche percepisco, perché ho già detto in partenza che posso avere soltanto rappresentazioni.
(V,4) Un tale idealista o negherà allora completamente la cosa in sé, o per lo meno spiegherà che per noi uomini essa non ha alcuna importanza, vale a dire che è come se non ci fosse perché non ne possiamo sapere nulla.
Siamo chiusi in noi stessi e siamo chiusi nel nostro mondo di rappresentazioni. Qual è l’assunto di partenza? L’assunto di partenza dice: ma se l’albero è qualcosa di duro, di consistente, come fa a entrare dentro di me? Se la cosa in sé dell’albero è spaziale, è materiale, è qualcosa di duro, qualcosa che mi fa male se gli sbatto contro, è ovvio che questa realtà, questa cosa in sé, non verrà mai dentro di me, resterà sempre fuori di me e in me io avrò soltanto la rappresentazione dell’albero.
Secondo il criticismo ognuno vive chiuso in un mondo di rappresentazioni, perché non si accorge che, avendo da sempre creato il concetto dell’albero, in quel concetto ognuno ha non soltanto la rappresentazione e la percezione dell’albero, ma il tutto dell’albero, ha la cosa in sé dell’albero.
Adesso io vi chiedo: nel concetto di albero è compresa o no la durezza? Certo che è compresa, se no non sarebbe il concetto di un albero! Quindi ce l’ho la durezza nel concetto di albero. Voi direte: ma la durezza non è mica quella che ho nel concetto, la durezza è quella che ho quando ci sbatto contro. Quando ci sbatto contro ho la percezione della durezza non la cosa in sé, non la realtà della durezza. La realtà della durezza ce l’ho mettendo insieme percezione e concetto.
Mettiamo un cagnolino che sbatte contro l’albero: ha una percezione della durezza dell’albero? Neanche per sogno. Sente male, quello sì. Ha una sensazione, quello sì. Ma mica dice: eh, lo dovevo ben sapere che l’albero è duro! Se l’avesse saputo non gli sarebbe andato a sbattere contro (a parte che non ci sbatte contro lo stesso per un altro motivo: per istinto).
Nel concetto di albero ho anche la durezza: che differenza c’è tra la durezza che mi fa sorgere un bernoccolo e la durezza pensata? La durezza pensata è più completa, perché c’è sia la percezione che il concetto, visto che non posso fare il concetto dell’albero senza percepirlo. E allora cos’è il bernoccolo? Una svista, un tentativo di avere una percezione pura senza concetto. Addormentandomi un momentino sul versante del concetto e del pensiero vado a sbattere, perché se io fossi sveglio nel concetto di albero, saprei che è duro e non ci sbatterei.
Questo sarebbe un modo per evidenziare che, nella misura in cui io vado vicino alla percezione pura, mi sto addormentando sul versante del pensiero. Perché nel concetto di albero c’è che è duro e che mi fa male se ci sbatto contro, e perciò non vado a sbatterci contro. Se uno ci sbatte contro perché non si accorge dell’albero, vuol dire che c’era poca luce o dal lato della percezione (non ci vedeva bene), o dal lato del pensiero (non ha pensato che c’era un albero): comunque c’era poca luce, e non vedendoci bene o non pensando bene ci ha sbattuto contro.
Intervento: Era distratto.
Archiati: Distratto: distratto – è uscito fuori di un bel pezzo dall’intensità del pensare che ti dice che nel concetto di albero c’è la durezza.
Se invece ha sbattuto perché era buio, che cosa è successo? Il concetto di albero ce l’aveva, però gli è mancata la percezione, non c’era luce fisica.
La realtà completa dell’albero ce l’abbiamo con la luce fisica che mi dà la percezione, e con la luce metafisica che mi dà il concetto. Quando metto insieme la luce fisica con la luce metafisica, spirituale del pensare il concetto dell’albero, ho tutta la realtà dell’albero, non mi manca nulla! Però se ho soltanto il concetto dell’albero ma non ho la percezione fisica, non ho l’albero: la realtà è incompleta sia se ho soltanto il concetto senza la percezione, sia se ho soltanto la percezione senza il concetto. Per avere una realtà devo averli tutti e due.
Intervento: Devono essere contemporanei?
Archiati: Come può una percezione precedere o seguire un concetto?
Replica: Qualcosa mi dice che però è possibile che uno abbia l’idea e in quel momento non sta guardando, come nel ricordo: ho il concetto, l’ho immagazzinato nel ricordo e so che è l’albero.
Archiati: No, no, riprendiamo l’esempio degli scolari laotiani che non avevano mai visto un ascensore. Noi dicevamo che la rappresentazione dell’ascensore la puoi avere soltanto se hai avuto la percezione, ma il concetto di ascensore te lo puoi formare anche senza la percezione. Però il fatto che io posso avere il concetto di ascensore senza la percezione, non significa che il concetto mi dà l’interezza dell’ascensore, perché un ascensore puramente concepito non è ancora un ascensore, è un ascensore potenziale. Per diventare reale bisogna che abbia il lato di percezione, bisogna che si renda percepibile.
Per l’uomo incarnato nel corpo di materia ogni realtà è realtà se è sia percepibile sia pensabile.
In quanto pensabile mi dà la possibilità di creare il concetto, in quanto percepibile mi dà la possibilità di creare la percezione, e la rappresentazione come risultato. Quindi, quando qualcuno mi vuol dire che qualcosa è reale, gli dico: per convincermi che è reale deve farmi vedere dove è percepibile e dove è pensabile. Dev’essere sia percepibile, sia pensabile.
Replica: Potrebbe sembrare che il mio cervello non vuol fare tanta fatica, ma visto che l’ha già fatta, la fatica, quando io ho fatto il lavoro di arrivare al concetto dell’albero, può averlo immagazzinato da qualche parte. Cioè, che bisogno ho di tirar fuori nuovamente il concetto? O forse non faccio fatica a tirar fuori il concetto?
Archiati: Attento. Tu dici: il concetto di albero è una realtà o no? È una realtà in quanto il concetto io lo percepisco e in quanto il concetto lo penso. Il concetto di albero, se io l’ho formato, lo percepisco dentro di me, nel mio spirito, e lo posso sempre ripensare. Però, che il concetto di albero sia reale in me perché lo percepisco e lo penso, non significa che l’albero è reale: stiamo parlando della realtà del concetto. Ma perché l’albero sia reale deve essere percepibile come albero, non come concetto. È una enorme differenza!
Questo è importantissimo perché gli esseri umani, in fondo, sono divisi in due categorie fondamentali: il tipo che tende ad essere spiritualista, e pensa di avere l’interezza della realtà disattendendo la percezione; e poi c’è il materialista, o realista, che privilegia, insiste, o gode maggiormente il lato di percezione e pensa di avere solo lì una realtà completa. No: i due mondi devono congiungersi per avere il reale completo. Devo portare a combaciare il concetto e la percezione.
Intervento: È un po’ complicato formulare la domanda. La realtà quindi è nello spazio/tempo per l’uomo incarnato, stiamo dicendo questo, perché l’albero è nello spazio e nel tempo e il concetto si deve incarnare nello spazio/tempo. L’uomo stesso è incarnato in un corpo nello spazio/tempo. Al momento della morte, allora, non abbiamo più la realtà, in quanto esseri umani?
Archiati: La realtà di che cosa?
Replica: La realtà è nello spazio e nel tempo, e anche come esseri umani siamo nello spazio e nel tempo, in quanto incarnati. Ma sia l’albero che il corpo umano spariscono dalla realtà spazio-temporale. Per il morto, allora, non è più reale?
Archiati: No. L’essere umano disincarnato, scorporato, è un essere umano altamente potenziale, perché per diventare reale a livello pieno deve ricongiungersi col corpo. Perciò la scienza dello spirito ti dice: quando tu muori, finché non ti reincarni non c’è evoluzione reale, c’è soltanto un bilancio conoscitivo di ciò che hai fatto e di ciò che non hai fatto, c’è una progettazione di ciò che vorrai fare o non vorrai fare, ma non compi nessun passo reale come spirito pensante nel mondo della percezione. Per fare passi evolutivi reali a livello di tutto il tuo essere, devi ritornare nel mondo della percezione: Se invece l’evoluzione dell’essere umano fosse possibile anche senza il corpo, l’incarnazione non sarebbe necessaria e allora saremmo Angeli, non esseri umani.
Intervento: Fino ad ora abbiamo parlato di percezioni e di concetti legati comunque al mondo materiale. Si può avere la percezione anche dei mondi spirituali?
Archiati: Quando io dico «bontà», bontà è un concetto ed è una percezione: ciò che io finora ho già pensato in merito a questo concetto è qualcosa che percepisco nel mio spirito, è una percezione che io faccio nel mio spirito. Poi, pensando col processo di pensiero attuale, posso aggiungere altri elementi al concetto di bontà, perché ogni concetto è passibile di ampliamento, di approfondimento all’infinito: in fondo, il concetto di bontà indirettamente abbraccia tutto il reale, perché la bontà è possibile soltanto nel contesto del mondo intero, è possibile soltanto presupponendo che ci sia un essere pieno di bontà, pieno di amore ecc., che rende possibile la bontà negli esseri umani.
Il concetto di albero è esauribile? No, perché indirettamente l’albero è possibile soltanto nel contesto di tutta l’evoluzione della Terra. Come ogni percezione è inesauribile in termini di quantità, così ogni concetto è inesauribile in termini di qualità, di intensità.
Nessun concetto può essere separato dagli altri, perché il concetto di albero è nel contesto della differenza che c’è fra il vegetale e l’animale, tra il vegetale e il minerale. Nel concetto di albero c’è indirettamente tutto il minerale, che è diverso dall’albero e quindi mi serve in negativo per formare il concetto di albero; c’è indirettamente il rapporto con tutto il mondo animale – l’albero non è un animale, quindi fa parte del concetto di albero di non essere un animale ecc. Indirettamente nel concetto di albero c’è tutto il mondo in cui viviamo, perché è un frammento di mondo.
L’arte del pensare è l’arte di creare nessi e rapporti all’infinito, ma i rapporti non sono percezioni, sono atti di pensiero. Il rapporto che c’è tra l’albero e il minerale, tra l’albero e l’animale, non è questione di percezione è questione di pensiero all’infinito.
V,5 Ad un idealista critico di questa specie l’universo appare come un sogno {ognuno è chiuso nel suo sogno, pieno di immagini, di rappresentazioni}, di fronte al quale sarebbe semplicemente assurdo ogni tentativo di conoscenza {perché non può uscire dal mondo delle sue rappresentazioni}. Non possono esserci per lui che due generi di uomini: gli ingenui, che ritengono cose reali i fantasmi dei propri sogni {gli ingenui ritengono che la rappresentazione che loro hanno dell’albero corrisponda a una cosa reale}, e i saggi che vedono la nullità di questo mondo sognato e che devono quindi, via via, perdere ogni voglia di curarsene.
Tutto il mondo è una fantasmagoria di illusioni, di rappresentazioni. E l’Oriente ti dice: più alla svelta ti tiri fuori, meglio è. Prima dicevamo che l’essere umano deve tornare sempre sulla Terra per potersi evolvere, adesso l’illusionista dice che è assurdo voler conoscere una realtà reale oltre le rappresentazioni, perché ognuno di noi è soltanto chiuso nel suo mondo di rappresentazioni.
(V,5) Da questo punto di vista, anche la propria personalità diviene una mera immagine di sogno {cosa abbiamo noi di noi stessi? Immagini sognanti}.
Intervento: Questo lo sta affermando Steiner?
Archiati: No, questa è la teoria degli idealisti critici. Loro dicono che anche di noi stessi possiamo avere soltanto immagini, rappresentazioni: come fai a dire che hai la cosa in sé, la realtà di te stessa? Cosa hai tu di te stessa? Immagini, e le immagini non sono realtà.
(V,5) Proprio come, nel sonno, fra le immagini del sogno appare anche l’immagine nostra, così nella coscienza di veglia la rappresentazione del proprio io si aggiunge alla rappresentazione del mondo esterno {ma è un’immagine come tutte le altre, un’immagine illusoria, irreale come tutte le altre, un altro fantasma}. Non abbiamo quindi nella coscienza il nostro vero io, ma solo la nostra rappresentazione dell’io. Chi nega che vi siano delle cose, o, per lo meno, che noi possiamo sapere qualcosa di esse, deve negare l’esistenza, o, per lo meno, la conoscenza anche della propria personalità {stando a questa teoria ognuno si deve dire: io di me non posso conoscere nulla, ho soltanto immagini effimere}. L’idealista critico giunge allora ad affermare: «Tutta la realtà si trasforma in un meraviglioso sogno, senza una vita di cui si sogni, e senza uno spirito che sogni: in un sogno che in sogno dipende da se stesso» (cfr. Fichte La destinazione umana).
V,6 Per colui che crede di riconoscere la vita immediata come un sogno, sia che non supponga niente altro dietro a questo sogno, sia che riferisca le sue rappresentazioni a cose reali, la vita stessa deve perdere ogni interesse scientifico. Mentre, però, per colui che crede esaurito col sogno tutto quanto è a noi accessibile ogni scienza è una chimera, per chi invece si crede autorizzato a trarre conclusioni sulle cose in base alle rappresentazioni, la scienza consiste proprio nella ricerca di queste «cose in sé». La prima concezione può essere indicata col nome di assoluto illusionismo, la seconda è chiamata, dal suo più conseguente sostenitore, Eduard von Hartmann, realismo trascendentale.
Il realismo trascendentale dice: io conosco direttamente soltanto le rappresentazioni delle cose, le immagini: però, essendo queste rappresentazioni un’immagine riflessa delle cose in sé, devono contenere qualcosa della cosa in sé. Allora, per via di illazione, posso fare delle affermazioni indirette sulla cosa in sé. Se la sua immagine riflessa è fatta così, allora la cosa in sé deve avere questa e questa e quest’altra caratteristica.
V,7 Entrambe queste concezioni hanno in comune col realismo primitivo il fatto che cercano di prendere piede nel mondo attraverso l’analisi delle percezioni. Ma entro questo campo non possono trovare in nessun luogo un punto d’appoggio.
In altre parole, che io ritenga conoscibile la cosa in sé direttamente o che la ritenga conoscibile soltanto indirettamente, questo schema di conoscenza parte dal presupposto che io conosco in base a percezione, o diretta o indiretta. Quindi concepisce il conoscere come un guardare.
Supponiamo che ci sia una cortina di separazione, e dietro ci sia la cosa in sé. In base a frammenti che la cosa in sé butta dentro la mia percezione, io dico: se la cosa in sé mi fa percepire questo e questo e questo, io posso indirettamente fare affermazioni su qualità della cosa in sé.
Qui c’è una cortina, viene giù acqua e l’acqua fa un arco, quindi l’acqua non viene giù dal cielo e io non vedo la cosa in sé per via della cortina.
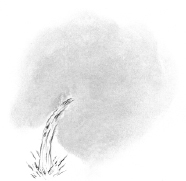
Fig.17
Ma posso fare delle affermazioni: lì ci deve essere non soltanto acqua, ma acqua messa in moto in modo tale da venir giù così…

Fig.18
Quindi delle affermazioni indirette le posso fare.
Intervento: Non c’è già pensiero in questo?
Archiati: Sì. Il punto fondamentale è che questa teoria disattende, non si rende conto di ciò che fa il pensare, e attribuisce alla percezione ciò che invece fa il pensare. Proprio questo è il punto.
V,8 Una delle questioni principali per il seguace del realismo trascendentale dovrebbe essere questa: «Come fa l’io a creare, traendolo da se stesso, il mondo delle rappresentazioni?». Un tentativo serio di conoscenza si può interessare ad un mondo a noi dato di rappresentazioni, che scompare appena chiudiamo in nostri sensi al mondo esterno, solamente in quanto tale mondo di rappresentazioni è un mezzo per indagare indirettamente il mondo dell’io per sé esistente. Se le cose della nostra esperienza fossero rappresentazioni, allora la nostra vita quotidiana assomiglierebbe a un sogno, e la conoscenza del reale stato di fatto al risveglio. Anche le nostre immagini di sogno ci interessano solamente per il tempo in cui sogniamo e, di conseguenza, non scorgiamo la loro natura di sogno. Al momento del risveglio non ci interessiamo più al nesso interno fra le nostre immagini di sogno, ma ai processi fisici, fisiologici e psicologici che ne stanno a base. Altrettanto poco il filosofo che ritiene il mondo una sua rappresentazione può interessarsi al nesso interno fra i singoli particolari del mondo.
Cioè, se è vero che io del mondo, che sia reale o no, ho in me soltanto immagini, queste immagini sono per definizione un riflesso in me delle cose, non sono le cose. Se io voglio conoscere il mondo, perdo l’interesse a queste immagini che non sono le cose, e mi chiedo: come posso risalire da queste immagini, che non sono le cose, alle cose?
Steiner paragona questo ragionamento al fatto che mentre sono nel sogno vedo le immagini, sono tutto circondato da immagini di sogno: quando mi sveglio, mi interessano le immagini di sogno? No, dico che la realtà è meglio delle immagini di sogno, perché le immagini di sogno non sono una realtà. La realtà è meglio. Cosa è meglio, un gelato sognato, l’immagine del gelato, o un gelato reale che mangio?
Noi facciamo l’esperienza dello svegliarci – e svegliarci significa venir catapultati fuori da un mondo di pure immagini nel mondo della realtà –, e le immagini non ci interessano più perché la realtà ci dà tutte e due le cose, sia la percezione che la realtà. Nella percezione del gelato ho l’immagine, però quando lo mangio ho anche la realtà.
Lo stesso processo avviene quando noi vediamo la coscienza ordinaria come uno stato sognante passibile di risvegliarsi: il risveglio a livello superiore sta nel capire che la coscienza ordinaria è sognante perché prende le percezioni, che sono immagini, come se fossero realtà. Il risveglio sta nel capire che se io entro nel pensare allora sì che ho la realtà senza perdere le immagini, perché congiungo il concetto con la percezione.
Il pensare è l’esercizio del risvegliarsi nella coscienza diurna che sogna. La coscienza ordinaria, rispetto a una coscienza più sveglia, cosciente di ciò che fa il pensiero, è una coscienza sognante, perché non siamo circondati da nessuna realtà e abbiamo soltanto immagini di sogno (stiamo parlando del sogno, non del sonno).
Che cosa ho nel sogno? Immagini. E quando mi sveglio? Cosa pensiamo, noi, di uno che si sveglia e dice: no, no, fammi tornare nel sogno, lì è più bello! Che tipo sarebbe? Uno che vive la realtà ancora più sognante del sogno.
Nel sogno ho soltanto immagini, quando mi sveglio ho la realtà. Che cosa ho in più quando mi sveglio? I due fattori della percezione e del concetto: nel sogno non ho né la percezione né il concetto, solo immagini. Non è vero che io nel sogno ho una metà della realtà, non ho nulla della realtà; quando mi sveglio ho tutti e due i lati della realtà perché percepisco e penso.
Perché, allora, questa coscienza ordinaria è sognante rispetto al tipo di coscienza più desta di cui sta parlando Steiner? Perché il pensiero che non sa di pensare è un pensiero sognante. Non è il nulla del pensiero: è un pensiero sognante, un pensiero che ancora non si è reso conto che pensando io costituisco la realtà, la creo.
Intervento: È un pensare inconscio.
Archiati: È un pensare sognante, ci manca la coscienza. La coscienza manca a un punto tale che pensatori di enorme peso hanno preso i concetti che il pensare crea come se fossero rappresentazioni, come se fossero solo immagini, e hanno detto; la cosa in sé non la raggiungi mai. Questi pensatori non si sono mai risvegliati, non hanno portato a coscienza il fatto che nel creare il concetto io non soltanto ho la cosa in sé, ma divento io, come spirito, la cosa in sé. Questo modo di portare a coscienza i fenomeni della conoscenza del mondo è, rispetto alla coscienza ordinaria, un enorme risvegliarsi, paragonabile al passaggio dal sogno alla veglia.
Intervento: Ne La poesia delle fiabe alla luce della scienza dello spirito[26], c’è un passo in cui Steiner afferma che l’anima sta sempre in uno stato di sogno, sempre.
Archiati: Sì, certo. Guarda che per i fenomeni che noi stiamo descrivendo, siccome le cose possiamo articolarle soltanto a livello di linguaggio, è anche questione di terminologia. Se io adesso uso la tua terminologia, che va bene, dico: il pensare ordinario è un pensare dell’anima, profondamente passivo e automatico.
Il pensare più sveglio, di cui parla Steiner, è un pensare dello spirito che diventa sempre più attivo, più cosciente. L’anima, che è la coscienza ordinaria, rispetto allo spirito è sognante. E stiamo dicendo che c’è modo di far assurgere il pensare ordinario a un gradino di attività molto superiore, che è paragonabile al risvegliarsi rispetto al sogno. Paragonato con questo nuovo modo di pensare, molto più attivo e più conscio di sé, il pensare ordinario animico è come un sogno, un sognare.
Per descrivere questi fenomeni, però, dobbiamo avere la capacità di usare una pluralità di termini, altrimenti facciamo un dogmatismo di terminologia: l’importante è capire i fenomeni, poi usiamo la terminologia a seconda di come ci serve. Se tu per anima intendi la coscienza ordinaria, paragonata al modo specifico di pensare dello spirito sveglio, è come un sognare.
Tanto è vero che questi filosofi paragonano la coscienza ordinaria, il pensare ordinario, all’illusionismo di un essere che resta chiuso in immagini di sogno, e non raggiunge nessuna realtà. La realtà, lo vediamo in questo studio de La filosofia della libertà, la raggiungi soltanto se, svegliandoti nel processo creatore del pensare, dello spirito che pensa, porti a coscienza che il creare concetti è creare realtà. E allora ti svegli a un livello più alto, e dici: quell’altro modo di pensare che avevo prima, paragonato a quest’altro modo, è un sognare. Avevo solo immagini delle cose, ma non creavo l’essenza delle cose.
Intervento: Stavo pensando che ogni persona praticamente è un mondo a sé. Il problema della cosa in sé, nonostante la percezione e il concetto, rimane: io non potrò mai conoscere a fondo una persona, perché ognuno è un universo. Come lo spieghi questo fatto? Non mi sembra risolto il problema della cosa in sé.
Archiati: Il pensare è l’organo di creazione di concetti, e il concetto è per natura ciò che gli scolastici chiamavano un universale, quindi il concetto di albero deve valere per tutti gli alberi. C’è un concetto che ha il carattere universale di non essere universale, di essere soltanto unico, e perciò è l’unico concetto puramente morale e non intellettuale: è il concetto dell’io.
È nel concetto dell’io che il contenuto dell’io è diverso in ogni essere umano. In quanto vale per ogni essere umano che ogni io è diverso dall’altro, il concetto vale per tutti: ma i contenuti di questo concetto sono diversi, unici in ognuno.
Che cosa hanno in comune tutti gli io umani? Che cosa è conoscibile, generalizzabile, degli io umani? Che nel contenuto sono tutti diversi. E questo vale per tutti, però! Quindi il concetto dell’uomo, in quanto io, è che tutti gli uomini sono uguali nell’essere assolutamente unici. Questa unicità, questa assoluta disuguaglianza ce l’abbiamo tutti ugualmente
Replica: Il problema della conoscenza della cosa in sé, della realtà, rimane solamente a livello superficiale. Io dovrei essere un albero per conoscere esattamente l’albero.
Archiati: Ma certo che lo puoi fare con il pensare!
Replica: Il concetto di albero e la percezione di albero non mi faranno mai entrare nei panni dell’albero. L’albero è un’altra cosa da me: io ho creato il concetto e la percezione, ma la cosa in sé non la conoscerò mai.
Archiati: Sei un bravo kantiano! Sta’ attento: il concetto mi crea l’essenza dell’albero, ciò che è essenziale all’albero. Che cos’è la cosa in sé dell’albero oltre la sua essenza? Me lo dici?
Replica: Ma per conoscere una persona devo mettermi nei suoi panni…
Archiati: No, no, no, aspetta! Tu stai passando da una cosa che vale per tutti gli alberi al concetto dell’io! Stai barando, vuoi portarmi soltanto l’unico esempio che non vale, dove l’uguaglianza è la disuguaglianza! Ma nel concetto di albero l’uguaglianza non è nella disuguaglianza, è nel fatto che l’essenza di albero è la stessa in tutti gli alberi.
Il concetto di albero è l’essenza dell’albero, è la cosa in sé dell’albero, lascia stare l’io. Io ti ho chiesto: che cosa ha l’albero come cosa in sé oltre all’essenza dell’albero? Dimmelo. Nulla! L’essenza di albero che creo nel concetto è la cosa in sé dell’albero. Che altro c’è nell’albero? Oppure mi dici che nel pensare non ho nessuna realtà, e allora sei un bravo kantiano: io ho rispetto, ma dico che è una coscienza sognante, che non si è ancora risvegliata nella realtà delle cose che il pensare crea. Il pensare crea la realtà delle cose: come è sorto l’albero, scusate? Come è nata la cosa in sé dell’albero? Con lo spirito che l’ha concepito. Il concetto è la cosa in sé, e nella misura in cui io ho il concetto di albero, divento io la cosa in sé dell’albero. Il tuo problema è che tu dici: io non posso diventare albero.
Replica: Io non sarò mai albero, invece per poter capire esattamente l’albero dovrei essere un albero.
Archiati: Tu pensi che l’albero sia ciò che noi percepiamo. Adesso ti dimostro che ciò che noi percepiamo non ha nulla a che fare con l’albero, perché oggi l’albero è così, domani è in tutt’altro modo, dopo domani è sparito: che cosa ti dà la percezione dell’albero? Nulla! È un albero sempre diverso, la percezione non ti dà la cosa in sé dell’albero. Nel pensare diventi albero, perché la cosa in sé dell’albero non è materia: la materia cambia continuamente. Il problema del materialismo è che pensa che la materia sia più reale, più sostanziale che non lo spirito, questo è il problema! Ma la materia dell’albero ti dà il nulla dell’albero, perché un giorno è così, un altro è cosà. E quando la materia dell’albero è sparita, è sparito l’albero?
Replica: No, ma si può pensare a uno spirito dell’albero? C’è il modo vivente di essere dell’albero, l’essenza?
Archiati: Se attorno all’albero ci sono spiriti della natura, allora creiamo il concetto di spiriti della natura: noi stiamo parlando del concetto dell’albero. È come se tu, per dirmi qual è l’essenza di un orologio, invece di dirmi che le lancette si muovono in base al concetto incarnato nell’orologio, dici: si muovono perché dietro c’è un diavoletto che continua a spingerle.
Adesso tu mi vuoi spiegare la realtà dell’albero con i diavoletti che continuano a farlo crescere! Tu puoi metterci tutti i diavoletti che vuoi, ma senza il concetto, senza l’idea dell’albero che l’ha concepito con le sue leggi di crescita ecc., tutti i diavoletti di questo mondo non faranno mai saltar fuori un albero!
Dài che mi vado a raffreddare con un bel gelato, via! Ogni volta che mi scaldo voi mi guardate tutti spaventati! Tu giustamente, da buon kantiano dicevi: ma io mica posso diventare la cosa in sé dell’albero! In quanto materia no, ma in quanto concetto sì.
Replica: Ma il concetto non è una cosa generica? Cioè, tu hai un’idea comune di albero: ha un tronco duro, radici, rami, foglie, che cos’è? È un albero. Ma è un albero in senso molto lato, questo non capisco io.
Archiati: Nel Milindapanha, II secolo a.C, un testo indiano del Punjab – dove c’è stato un incontro tra l’alessandrinismo e la cultura indiana antica – c’è un dialogo spesso citato da Steiner tra il re Milinda, che era un rampollo di Alessandro, con il saggio buddista Nagasena. Questo saggio buddista vuol dimostrare al re Milinda che il carro non è nulla oltre alle parti, ai pezzi. E allora gli chiede: tu, re Milinda, sei venuto sul carro: dimmi, che cosa fa parte del carro? Il timone, i mozzi delle ruote, le ruote, la cassa dove ci si siede ecc. Quando tu hai fatto la somma delle parti – vedi il pensare frammentato al livello di percezione? – che cosa ci manca?
Ci manca il carro! Perché su tutte le parti ammucchiate alla rinfusa io non posso andare a trovare il saggio Nagasena. Qual è, allora, la cosa in sé del carro? C’è una realtà o no oltre alle parti? Il concetto di carro, che è l’intuito di come queste parti possono interagire, è talmente reale che tu su questo concetto veramente cammini, e senza questo concetto non c’è il carro. Quindi questo incontro tra buddismo e alessandrinismo – Alessandro, e quindi Aristotele, precedono i misteri del Logos – è proprio questo sfociare dell’umanità nella chiamata a vedere nel Logos (che 300 anni dopo si è incarnato), nel concetto, una realtà assoluta perché senza il concetto di carro tu non avresti nessun carro!! I pezzi non sono il carro.
Replica: Esatto, ma il carro ha una funzione che si può definire: un carro formato da quattro ruote, ecc. per trasportare qualsiasi cosa. Dai una definizione in questo senso qui, allora questo è il concetto? Altrimenti quale concetto dai?
Archiati: No, no, non ci siamo, sei fuori, tu disattendi il fatto che il carro è l’evidenziare con pezzi di materia la realtà di un concetto, perché il concetto è una strutturazione di questi oggetti, e senza questa strutturazione di pensiero non è un carro. Quindi il carro reale, la cosa in sé del carro, è una strutturazione di pensiero! Quello è il carro reale! Senza questa strutturazione di pensiero che pensa i pezzi strutturati e connessi, non ci sarebbe il carro. Il concetto è la realtà delle cose, altrimenti sei un materialista.
Intervento: La percezione materiale dei pezzi del carro…
Archiati: Come fai a sapere che sono pezzi di un carro? Dicendo così ti metti già dopo che è stato creato il carro: mettiti prima del primo carro.
Replica: Sì, però io volevo dire un’altra cosa. Il concetto, in questo senso, è qualcosa staccato dalla percezione perché si parlava dell’albero, no? Da lì siamo partiti, poi tu hai tirato fuori la faccenda del carro e dei pezzi. Io dico: la materia del carro, pur strutturando i pezzi col concetto, non varia, la materia non varia, non c’è un’aggiunta.
Archiati: E allora cos’è il carro?
Replica: È la struttura dei pezzi che lo compongono.
Archiati: No, no, è ciò che li struttura, è l’attività di metterli in un certo rapporto e che opera e compie il carro.
Replica: Ma anche i pezzi non esisterebbero senza il concetto.
Archiati: No, il pezzo di legno c’era già prima dell’invenzione del carro.
Replica: Ma non strutturato per fare il carro.
Archiati: Quando una persona costruisce una casa, che cos’è la realtà operante?
Intervento: Il progetto.
Archiati: Cosa intendete dire con progetto? I pensieri formanti, quella è la realtà in assoluto. Se non sono formanti non sono pensieri, non sono concetti.
Intervento: Quindi il carro è più della somma delle sue parti, esattamente è il concetto.
Archiati: Per forza! Non è soltanto di più, ma con tutta la somma delle parti non c’è il carro.
Replica: Il più è il concetto, che è la sua realtà.
Archiati: Sì, quindi non è soltanto un di più.
Intervento: Ma il carro, se non venisse usato come carro, non sarebbe niente? Cioè, se c’è un carro e una persona non sa come usarlo, che cosa dice?
Archiati: Problemi suoi, scusa!! Impari a usarlo!
Vi auguro una buona notte in carrozza!
Domenica 24 agosto 2008, mattina
Una buona domenica a tutti!
La domenica è il giorno del Sole, le lingue al nord chiamano la domenica Sunday: il giorno del Sole, in tedesco Sontag – il giorno del sole. L’italiano è stato un pochino più inquinato dal cattolicesimo e ha preso per il giorno del Sole la parola ebraica shabbàt (sabato, in inglese Saturday, il giorno di Saturno) che vuol dire «riposare». Il buon Dio ha creato il mondo, ha cominciato con le pietre, le piante, gli animali, e fino al 5° giorno andava tutto bene: la grossa sfacchinata che l’ha costretto a riposarsi al 7° giorno è stata al 6° giorno, quando ha creato l’uomo.
Tra l’altro, pare che poi dalla costola di Adamo sia stata creata Eva – il testo è stato interpretato così, ma non è vero, non è che Dio ha creato prima il maschio, questa è un’interpretazione mascolinizzante. Adamo non era il maschio dal quale è stata creata la donna, Adamo era l’essere umano primigenio, maschile e femminile insieme: poi i due sessi si sono scissi e quindi, quando dalla costola è nata Eva, al contempo è nato il maschio. Prima erano tutti e due insieme.
Comunque, il succo del discorso è che col fattore uomo, Dio si è talmente stancato che al 7° giorno dovette riposarsi, per cui il 7° giorno in ebraico si chiama shabbàt, tBv che significa «riposare». È il giorno in cui Dio, o Javhè, o Elohim, riposa.
Questo risvolto psicologico della stanchezza, però, non c’entra nulla: il vero senso di questo riposo di Javhè è La filosofia della libertà. È semplicissima, la cosa. Intendo dire che Dio (uso la terminologia nostra, ma ognuno lo traduca come gli pare, le parole sono tutte cifre, metafore) si è detto: se Io creo non soltanto pietre inanimate – che non mi possono fare concorrenza perché non sanno né parlare né pensare –, non soltanto piante e animali, ma creo uno spirito nell’uomo, allora lo spirito è spirito.
Quindi, dice Dio, o decido di non creare l’uomo, e allora resto io padrone, oppure se creo l’uomo come spirito libero devo far posto alla sua libertà. Caro uomo, ora tocca a te, e le vie della tua libertà sono aperte. Allora questo sabato, questo riposare di Dio, ha un significato bellissimo e profondo perché, di fronte allo spirito umano libero, l’unico atteggiamento che veramente lo onora ed è degno, è quello di tirarsi indietro per lasciarlo fare. Altrimenti non può esercitare la libertà, non può essere libero.
Dio dice, al 7° giorno: essere umano, ora tocca a te, perché ti ho creato spirito libero – in erba, in potenza, però sempre spirito libero…
Come si chiama il sabato di tutti i genitori di questo mondo? La pubertà! La pubertà significa: mamma, papà, tiratevi indietro! Datevi una calmata! Il sabato è la calmata divina di fronte alla libertà dell’uomo. I figli magari devono costringere i genitori, la Divinità, invece, se l’è data da sé e volentieri la calmata, perché ha voluto la libertà dell’uomo: l’ha creata!
Come l’italiano ha preso per il sabato il termine ebraico, così ha preso per la domenica il termine latino dominica, dies dominicus: il giorno del Signore – Dominus, colui che domina, che è capace di padroneggiare. Con che cosa si domina? Con che cosa si padroneggia? L’elemento in assoluto sovrano, in nulla passivo, che non subisce nulla, in tutto e per tutto attivo è il pensare.
Più l’essere umano vive nel pensare, e più decide lui di tutto quello che avviene. Il pensare è certo passibile di infinite gradazioni, di infinite intensità, ma nel pensare si è sovrani: capire vuol dire capire, se non capisco devo essere dipendente da un altro che mi spiega, o devo credere a qualcosa perché non lo capisco. Il concetto di Dominus è l’Io, a differenza dell’anima.
Ieri e oggi abbiamo esaminato due modi di viversi dell’essere umano:
1. un modo di vivere è muoversi nel mondo delle rappresentazioni. Per far sorgere rappresentazioni non ho bisogno di essere Dominus, di essere Signore, padrone, di essere io a prendere in mano le cose: le rappresentazioni sorgono spontaneamente e passivamente in base alle percezioni. Mi basta vedere, sentire ecc., e sorgono le rappresentazioni. Vivere nel mondo della rappresentazione è un fatto di automatismo, è la coscienza normale, spontanea, è il tipo di coscienza che ci dà la natura: mentre noi viviamo nelle rappresentazioni, per esempio abbiamo la rappresentazione dell’albero, non ci rendiamo conto che il linguaggio – la parola «albero», in questo caso – può essere preso in senso passivo: io so cos’è un albero, lo so senza ulteriore sforzo. Se io prendo dell’albero ciò che già mi dà il linguaggio, che già mi dà la percezione, ho la rappresentazione dell’albero, e disattendo, non mi accorgo che c’è un secondo modo di vivere.
2. Potenzialmente ogni rappresentazione, ogni verbo del linguaggio, ogni parola è un concetto già pensato e cristallizzato nel linguaggio, che è passibile di venir afferrato da me coscientemente, attivamente, quando comincio a chiedermi: un momento, io dell’albero ho la parola che mi dà il linguaggio, però «albero» è una parola italiana, in tedesco si dice Baum. Allora cosa ho, io, quando dico «albero»? Ho una parola italiana e ho una rappresentazione più o meno a seconda degli alberi che ho visto: ho un automatismo del linguaggio italiano e un automatismo di rappresentazione. Però capisco anche che, in chi ha coniato questa parola, alla base c’è stata la creazione di un concetto: albero è un concetto. Se io prendo l’albero che vivo spontaneamente all’inizio come evento di linguaggio, come vissuto di rappresentazione, e capisco che però alla base c’è stata la creazione di un concetto, allora dico: voglio provare io a rifare tutto il cammino che ha fatto il linguaggio per ricostruire il concetto puro di albero. E lì c’è da sudare, perché bisogna rifare tutti i sei giorni della creazione!
Il pensiero alla base dice: se tu trovi la voglia di fare questo cammino, di afferrare tutte le rappresentazioni, tutte le parole del linguaggio come potenziali cammini di attivazione del tuo spirito per creare concetti sempre più nitidi, sempre più puri, ti strabilierai, ti meraviglierai di quanto la vita diventi molto più bella, perché è come un risvegliarsi superiore, un essere a un livello del tutto diverso che sta alla veglia della coscienza ordinaria come la coscienza ordinaria sta alla coscienza sognante.
Nella misura in cui si fa questo secondo cammino, ci si dice onestamente che la coscienza ordinaria è sognante rispetto alla sua potenzialità, alla sua facoltà e capacità di essere afferrata dall’attività creatrice dell’io che pensa: con la creazione pensante del proprio io può trasformare ogni rappresentazione in un concetto.
Nell’immagine rappresentativa di una rosa ho la realtà della rosa? No: la guardo il primo giorno e non ha neanche il bocciolo, il giorno dopo la percezione mi dà tutta un’altra immagine, la guardo un mese dopo e l’immagine è ancora diversa: se la percezione mi dà ogni volta una cosa diversa, non può mica essere la rosa, quella lì! La rosa è sempre rosa!
La percezione mi presenta il modo in cui la rosa, in quanto concetto, in quanto realtà spirituale, mi squaderna, mi presenta, mi rende percepibili i contenuti infiniti del suo concetto, un pezzettino dopo l’altro. Nel concetto di rosa c’è il bocciolo, c’è lo stelo, ci sono le spine, la foglia nuova e la foglia che ingiallisce e appassisce… La rosa mi dice: sta’ attento, se tu sei così passivo, così poltrone o così modesto nel pensare che non ce la fai a concentrare nel concetto l’infinità di elementi essenziali della rosa, io ti aiuto: proprio perché sei bambino nel pensare, nello spazio del tempo ti presento squadernati uno dopo l’altro i vari aspetti essenziali della rosa per renderteli visibili, in modo che tu, percependoli tutti uno dopo l’altro, tutti dispersi perché quando hai l’uno ti manca l’altro, impari nella formazione del concetto ad averli tutti insieme.
Il concetto mi dà in un lampo ciò che la percezione ci mette mesi a presentarmi – un aspetto dopo l’altro, e neanche mi presenta tutto! La rosa non è una somma di frammenti disparati, la rosa è un’unità.
Allora la percezione è un inganno, perché mi presenta aspetti uno senza l’altro, uno dopo l’altro, uno accanto all’altro, e invece il concetto è tutto insieme. La frammentazione del mondo che percepiamo nella percezione è un inganno, perché la realtà non è frammentata: questo inganno è l’esca che serve a farci venire voglia di disingannarci. La percezione è l’inganno che ci fa venire voglia, nel creare il concetto, di disingannarci.
Nella percezione viviamo il reale come se fosse spezzettato, frammentato, atomizzato all’infinito e invece nel concetto lo viviamo tutto insieme. Nella percezione la distanza tra Achille e la tartaruga è fatta di infiniti pezzettini, nel movimento è un salto solo.
Di fronte al mondo spezzettato, farraginoso, sconclusionato della percezione, se l’essere umano dicesse: no, i pezzi sono troppi, sono come un’infinità di cocci di infiniti vasi, non ce la farò mai a metterli insieme, vorrebbe dire che non ha ancora capito che ha le gambe per camminare nel pensiero. E il camminare nel pensiero non è un processo infinitesimale ma un processo integrale.
La percezione è vivere il mondo dalla parte dell’infinitesimalità, e il processo di integrazione non è un lungo raccogliere un’infinità di pezzettini, ma si fa in un attimo. Cento è un’unità, o bisogna contare fino a cento per arrivarci? Cento è cento. Ti do 100 euro: no, no, per averne davvero 100 me ne devi dare 1,2,3,4,5, fino a 100…, non si può avere 100 in una volta!
Oppure c’è un altro aspetto dell’analogia della luce, sempre usata per capire il pensare. In greco la parola idea (o concetto), viene da „de‹n (idèin) che significa vedere (da cui video, latino). Quindi pensare è un vedere. Quando noi accendiamo la luce, la luce illumina i pezzettini uno dopo l’altro? Io, per vedere Carmine, devo aspettare che la luce illumini prima un pezzettino di naso, poi un altro pezzettino e poi un altro…? No, non è un processo di sommazione di infiniti frammenti.
Accendo la luce ed è tutto lì. Ci vedo.
Attivo il pensiero ed è tutto lì. Ci vedo. Capisco.
Si tratta di accendere sempre di nuovo, sempre di più la luce.
Eravamo arrivati al paragrafo 8, con le posizioni del realismo ingenuo e dell’idealismo critico. Il realista ingenuo dice che la cosa in sé me la dà la percezione (che poi è la posizione più giusta, in fondo): quando percepisco l’albero ho l’albero, ho la realtà dell’albero. Ed è vero soltanto perché non si rende conto che l’albero è un concetto oltre ad essere una percezione: se noi all’albero togliessimo via il concetto e lasciassimo soltanto la percezione, dell’albero non ci sarebbe nulla.
La percezione pura è il nulla dell’albero e noi, nello stato di veglia, non possiamo mai, da adulti, avere una percezione pura. Una percezione senza concetto non c’è. Quindi il bambino, che non ha ancora i concetti, non ha vere e proprie percezioni: se fossimo puliti nel pensare dovremmo dire che al massimo ha percezioni a livello potenziale, che diventano percezioni reali soltanto quando ci aggiunge il concetto.
O ho tutti e due, percezione e concetto, o non ho nessuno dei due. Nell’animale la percezione non è neanche potenziale. Nel bambino è potenziale, però potenziale non vuol dire reale: diventa reale quando c’è un inizio di attivazione del pensare.
Il problema del materialismo moderno, anche di Kant, è che si è fissato sull’elemento di percezione e ha perso di vista sempre di più ciò che noi compiamo in concomitanza alla percezione, e cioè che creiamo concetti. Non ce ne accorgiamo perché questo processo di creare concetti si è appoggiato sempre di più sul suo lato comodo e automatico, sul deposito più grande che ci sia di concetti: il linguaggio.
La maggior parte delle persone hanno parole, non concetti, e la parola è un concetto potenziale, perché in colui che ha creato la parola «albero» c’è stato il concetto, naturalmente, però l’ha codificato nel linguaggio, e colui che impara il linguaggio non per forza rifà il cammino di costruire lui stesso, di generare, di creare il concetto in chiave di pensiero proprio: lo prende dal lato del linguaggio, lo prende già fatto. Lo so cos’è un albero. Ma cos’ha dell’albero? Solo la parola e la rappresentazione. Automatismi di linguaggio e passività di rappresentazione in base alla percezione.
Rileggiamo dall’inizio il paragrafo V,8 «Una delle questioni principali per il seguace del realismo trascendentale dovrebbe essere questa: come fa l’io a creare, traendolo da se stesso, il mondo delle rappresentazioni?».
Abbiamo visto, all’inizio del V capitolo, che in effetti se è vera l’affermazione che dice: io delle cose che vedo ho soltanto delle rappresentazioni, allora possiamo cominciare a chiederci come sorge in me questa immagine rappresentativa. Chi la crea?
L’albero là fuori non è l’albero che io ho dentro. Come nasce l’albero qua dentro? Questa è la domanda che si pone ora Steiner. Io sono io, lì c’è una superficie rispecchiante e vedo me stesso come immagine nello specchio. Dunque il concetto di immagine (la rappresentazione dell’albero è un’immagine) comporta che ci deve essere una realtà che proietta di sé un’immagine, perché senza una realtà non può sorgere l’immagine. Può sorgere l’immagine riflessa di me nello specchio senza di me? Assurdo.
È nel concetto di immagine, è nel concetto di rappresentazione che ci deve essere una realtà che proietta la sua immagine morta. Ci vuole l’albero reale per gettare un’ombra di sé, quindi non può essere che il mondo è fatto soltanto di rappresentazioni, perché le rappresentazioni sono immagini, e le immagini possono sorgere soltanto in base a realtà che si rispecchiano.
La mia anima è uno specchio, però le immagini in me presuppongono la realtà che si rispecchia in me, quindi l’albero è la cosa in sé, quello che percepisco è la cosa in sé. L’unica cosa da aggiungere è che l’albero reale a cui io mi riferisco non è soltanto una percezione, ma è già un concetto.
L’albero come pura percezione sarebbe un’infinità di frammenti, di ombre, di colori, di forme ecc… ma già questi sono concetti, eh? Se io avessi solo la percezione, da questa infinità frammentata, atomizzata, non potrei mai avere in me un’immagine unificata. L’immagine unificata presuppone una realtà già unificata, ed è il pensare che la unifica! – il pensare ordinario, spontaneo che tutti abbiamo, che è codificato nel linguaggio per cui la mamma dice al bambino: guarda, quello è un albero, quella è una mucca.
Praticamente, il creare concetti ordinari avviene per una specie di simbiosi tra la percezione – che tutti abbiamo, anche il bambino – e il linguaggio.
La percezione è il sedimento corporeo dei pensieri divini, e il linguaggio è il sedimento animico dei pensieri umani.
Il linguaggio, come cristallizzazione animica dei pensieri umani, si congiunge col sedimento corporeo dei pensieri divini, a livello di percezione, e la mamma dice: quello è un albero. La natura ti presenta quell’unità pensata dal divino e il linguaggio, quindi il passato dello spirito che è diventato anima, ti dice: è un albero.
Venti anni dopo questo bambino va a un seminario su La filosofia della libertà e dice: un momento, nella percezione ho una realtà corporea, nella parola del linguaggio ho un sedimento culturale, ma né l’uno né l’altro sono farina del mio sacco. La percezione me la dà la natura, la parola me la dà il linguaggio: e io?
La parola è il risultato della formazione di un concetto, il risultato di un processo pensante, perché nessun linguaggio può creare la parola «albero» senza aver compiuto un processo di unificazione, di unitarietà, rispetto a quella potenzialmente infinita frammentazione che sono le percezioni possibili rispetto all’albero – l’albero cambia continuamente, oggi è così, domani è cosà, quindi ce n’è da portare all’unità di tutto ciò che è potenzialmente percepibile di un albero.
I tre passi del diventare uomini sono:
• il corpo che si erge per avere le percezioni;
• il linguaggio che dà il passato del lavoro dello spirito;
• il pensare in proprio, dove l’essere umano diventa attivo.
Ah, ah, allora, siccome adesso io vado al seminario su La filosofia della libertà, non mi importa nulla della percezione, a quella ci pensa la natura, e nemmeno del linguaggio m’importa nulla perché tanto io sto imparando il tedesco, l’inglese, il francese, quindi che in italiano si chiami «albero» è relativo… voglio creare io il concetto puro di albero!
Aristotele ti dice una cosa molto semplice: basta che tu sai che per creare un concetto devi saper distinguere ciò che è accidentale e devi prendere soltanto ciò che è essenziale, e poi parti, parti!
Vi invito a creare il concetto puro di una parola: da questa parola tirate via tutto quello che è accidentale, e mi dite cosa resta in termini di essenzialità. Dovete tradurmi la parola in termini di concetti, come se io fossi straniero: se uno impara una lingua traducendola lessicalmente non la impara, dovrebbe risalire al livello del pensare dove è il concetto che si esprime nella parola.
La parola che volevo scrivere è:
musicista
Che cosa è accidentale e che cosa è essenziale a questo concetto? Ditemi voi il concetto di «musicista». Potremmo star qui per mesi interi ad accapigliarci a vicenda e non giungeremmo a un accordo. Ma neanche è necessario: l’importante è che ognuno rafforzi il suo processo di pensiero, lo affini sempre di più.
Ogni parola, ogni concetto, è una proposta di evoluzione del pensiero all’infinito. Questo vale per ogni concetto. Aristotele e Tommaso d’Aquino erano spiriti che per tutta una vita hanno lavorato ai concetti e si sono resi conto che non c’è fine a questa creazione bellissima, perché lavorare ai concetti significa distinguere, sottodistinguere, sotto sotto distinguere, ma soprattutto godersi il distinguere!
Pensate a un pittore che dice: mannaggia, non bastano sette colori, adesso li devo mischiare e saltano fuori un’infinità di colori, che noia! Ma è proprio lì il bello, distinguere tutte le sfumature, quel rosa lì è diverso da quell’altro rosa... e così è per le sfumature dei concetti. Allora, o le sfumature ti danno gioia, oppure invece di fare il pittore vai a fare un’altra cosa.
Allora, dimmi il concetto di musicista?
Intervento: Dal latino Muse.
Archiati: Ah, ah, lui si salva in calcio d’angolo portandoci indietro dal latino alle Muse, che è una parola greca. Allora dimmi il concetto di Musa. «Cantami o musa del pelide Achille l’ira funesta…»
Replica: Le muse ispiratrici dell’arte in genere.
Archiati: No, no, io ti ho chiesto di spiegarmi il concetto puro di musicista. Quali sono gli elementi essenziali e quali sono gli elementi accidentali? Il senso di questa domanda non è quello di pretendere da qualcuno, qui, che ci spieghi veramente il concetto di musicista, ma il senso è di renderci conto che noi, riguardo all’evoluzione del pensiero, siamo all’inizio. Tu, con le Muse, stavi andando proprio all’acqua di rose! Il centro, il nocciolo del concetto di musicista, non c’è.
Intervento: Il concetto di musicista è «misura».
Archiati: Che cosa intendi dire?
Replica: Misurare.
Archiati: Così non distingui affatto tra il musicista e il geometra. L’intento di questi esercizi è di evidenziare che l’umanità attuale così come noi la percepiamo negli altri o in noi stessi – è una percezione sincera, questa – è agli inizi di un cammino di pensiero che forma concetti, e non ha soltanto rappresentazioni date per grazia ricevuta in base al linguaggio.
La filosofia della libertà è un testo di base per farti venire la voglia di svegliarti, ti mette la pulce nell’orecchio e ti dice: se tu ti metti su questa strada è paragonabile alla gioia che hai quando ti svegli, nel sogno avevi immagini di un fuoco che ti assaliva e tu eri lì e non riuscivi a scappar via, poi ti svegli… e hai mal di gola, hai la gola tutta infiammata. Tu dici: a me non interessa il mal di gola, mi interessa il fuoco che c’era nel sogno, ritorno a dormire? No, no, il senso del fuoco nel sogno era di farmi svegliare e di far qualcosa per la gola.
La filosofia della libertà ti dice che c’è un modo di svegliarsi rispetto a questo sognare della coscienza ordinaria per cui tu puoi dire: no, quello che avevo fissandomi sulle percezioni, appoggiandomi sul linguaggio, erano immagini di sogno rispetto ai concetti quando li creo io! Uno che dica: oh, che noia creare i concetti, torno alle parole del linguaggio belle comode!, sarebbe come preferire l’immagine del fuoco al mal di gola da curare.
Se uno dice: ma questa coscienza ordinaria che tu, rispetto a una coscienza più alta, chiami coscienza sognante, a me sta bene, me la sto godendo… E se la goda! Abbiamo mai costretto qualcuno a venire a un seminario su La filosofia della libertà? No, ognuno si gode quello che gode, non si può costringere nessuno a godere di qualcosa.
C’è solo da aspettare che venga il giorno in cui dirà: non mi basta, vorrei qualcosa di più! Allora funziona! Il figliol prodigo è andato via, finché gli bastava il patrimonio del padre l’ha sperperato, alla fine aveva soltanto le ghiande che non poteva nemmeno mangiare perché doveva darle ai porci, e allora ha detto: no, no, queste ghiande scarse non mi bastano, torno dal padre.
Questa coscienza ordinaria, no, mi è troppo noiosa, è questa che mi fa depressivo, scontento ecc… non mi basta! Bene. Bevi tre litri al giorno de La filosofia della libertà e scoprirai che c’è di meglio. Stiamo aspettando che diventi sempre più numerosa la gente che dice: non mi basta, è troppo noioso quello che c’è.
Se l’essere umano fosse veramente tale che la coscienza ordinaria in tutto e per tutto gli basta, lo rende felice, lo rende pieno, sarebbe assurdo parlare di qualcosa che gli manca. Quindi partiamo dal presupposto che, prima o poi, ogni essere umano per natura arriva al punto di dire: voglio qualcosa di più. E nessuno ha il diritto di spingerlo per farlo arrivare prima, perché la natura umana sana, quando viene spinta per arrivare prima a quel punto lì, ci arriva più lentamente! Perché? Perché se mi pressano devo difendere la mia libertà, che è il valore supremo.
Quando noi cerchiamo di spingere una persona, possiamo essere sicuri di ritardare il suo cammino perché deve opporsi, se è sana. Però partiamo dal presupposto che è nella natura umana di non contentarsi, prima o poi, di ciò che dà il mondo corporeo in chiave di percezione, dove non siamo attivi e di ciò che dà il linguaggio in chiave di rappresentazione – i concetti già formati nel linguaggio e le rappresentazioni che sono una copia della percezione già creata dalla natura.
Partiamo dal concetto dell’uomo e diciamo che un tratto essenziale è che non si accontenta di ciò che riceve dalla natura e dalla cultura, perché lì non è attivo. È nella sua natura di voler fare l’esperienza della libertà, ma l’esperienza della libertà la fa soltanto in ciò che crea lui: come può dire di essere libero in ciò che gli dà la natura o la cultura? Non è cosa sua, e ognuno è libero in ciò che crea lui, perché lo crea come vuole lui.
Allora, o è nella natura dell’uomo di prendere come fondamento tutto quello che riceve e di vivere, di godere al massimo ciò che crea lui individualmente – e se è nella sua natura prima o poi lo vuole, perché non può vivere senza –, oppure, se non è nella sua natura, è inutile che parliamo di qualcosa che non esiste.
Questo è un testo fondamentale che articola l’esperienza dell’esseri liberi in quanto individualmente creatori:
• non si può essere liberi e individualmente creatori rispetto al corporeo, quello lo fa la natura;
• non si può essere liberi e individualmente creatori rispetto all’animico, al linguaggio, alla cultura, perché quelli sono fattori di comunanza;
• si può essere liberi soltanto rispetto all’elemento del pensare. Questo elemento del pensare, poi, si esprime di nuovo a livello di percezione nel quadro del pittore, nella musica del musicista, nel modo di una mamma di pulire il bambino piccolo e cambiare i pannolini... All’origine di ciò che è libero e individuale c’è sempre il pensare.
Rileggo: V,8 «Un tentativo serio di conoscenza si può interessare ad un mondo a noi dato di rappresentazioni, che scompare appena chiudiamo in nostri sensi al mondo esterno, solamente in quanto tale mondo di rappresentazioni è un mezzo per indagare indirettamente il mondo dell’io per sé esistente. Se le cose della nostra esperienza fossero rappresentazioni, allora la nostra vita quotidiana assomiglierebbe a un sogno, e la conoscenza del reale stato di fatto {assomiglierebbe} al risveglio. Anche le nostre immagini di sogno ci interessano solamente per il tempo in cui sogniamo e, di conseguenza, non scorgiamo la loro natura di sogno. Al momento del risveglio non ci interessiamo più al nesso interno fra le nostre immagini di sogno, ma ai processi fisici, fisiologici e psicologici che ne stanno a base {mi chiedo: cosa ha creato queste immagini di sogno?, qual è la realtà che ha proiettato queste immagini di sé?}. Altrettanto poco il filosofo che ritiene il mondo una sua rappresentazione può interessarsi al nesso interno fra i singoli particolari del mondo».
(V,8) Nel caso che egli ammetta ancora l’esistenza di un io {di un Io reale che proietta, che crea queste immagini sognanti che noi chiamiamo rappresentazioni}, non si domanderà come una delle proprie rappresentazioni si connetta con un’altra, ma che cosa avvenga nell’anima, che è da lui indipendente, mentre la sua coscienza contiene una determinata serie di rappresentazioni. Quando io sogno di bere del vino che mi produce bruciore in gola, e poi mi sveglio con stimolo a tossire (cfr. Weygandt Origine dei sogni, 1893), al momento del risveglio l’azione del sogno cessa di avere interesse per me. La mia attenzione resta rivolta solo ai processi fisiologici e psicologici attraverso i quali lo stimolo a tossire si esprime simbolicamente nel sogno.
Un momento: può darsi che in Germania Steiner se la passi liscia a scrivere così, ma in Italia, nel paese del Chianti... Se sogno che sto bevendo vino, mi sveglio e sento bruciore in gola, oh, scappo subito di nuovo nel sogno! È molto meglio bere vino, no?
Intervento: Non ubriaca, quel vino di sogno.
Archiati: Ma come no? Nel sogno ero ubriaco! Una cosa così bella… Perciò prima dicevo che l’essere umano ci può mettere molto tempo prima che gli venga voglia di uscire da questo sogno della coscienza ordinaria, perché se la gode! Diritti suoi. E il fatto che tu gli dica che l’altro è un godimento maggiore non serve finché lui non ha l’esperienza che è veramente un godimento maggiore: nel frattempo si tiene il Chianti della coscienza ordinaria.
Però, che la coscienza ordinaria sia un godimento maggiore rispetto alla coscienza sognante, questa esperienza la facciamo tutti, quindi è convincente che non vogliamo tornare nel sogno e restiamo volentieri nella realtà. E perché è convincente? Perché c’è l’esperienza.
L’altro passo diventa convincente nella misura in cui si fa l’esperienza, e allora non si può più tornare indietro. Però bisogna fare l’esperienza. Noi facciamo seminari su La filosofia della libertà e io mi sento dire dai partecipanti soltanto: è dura, è dura, è dura, io mi chiedo: fin quando «durerà», se è così dura? Se invece i partecipanti dicono: dài, dài, dài che andiamo sempre meglio, allora dico che sì, sì, durerà, durerà.
Se la libertà venisse regalata non sarebbe libera. Va conquistata. Ogni scalatore dice, da sotto la montagna: è dura, ma quando è sopra è una gran bella cosa! Allora vi dico: se non molliamo, non ci pentiremo. Se invece molli, spero, anzi son sicuro, che prima o poi ti pentirai perché è nella natura umana.
V,8 «…al momento del risveglio l’azione del sogno cessa di avere interesse per me»: al momento del risveglio però, quindi soltanto quando mi risveglio a livello superiore l’altro modo sognante comincia ad avere meno interesse per me. Quindi il presupposto è di essermi svegliato, per lo meno incipientemente, non soltanto di averne sentito parlare, o di averne il concetto intellettuale senza l’esperienza.
Cos’è essenziale al concetto di libertà? L’esperienza reale. Farne l’esperienza reale fa parte dell’essenza o no? Sì, perché se non ne fai l’esperienza, non è libertà. L’essenza di ogni concetto non è mai un puro fattore intellettuale, è sempre una realtà, un’esperienza. Cos’è l’albero? Un’esperienza reale dell’essere umano. In che consiste il carattere di sogno della coscienza ordinaria? Che abbiamo ridotto tutto a concetti astratti, senza spessore reale di esperienza. E qual è la realtà esperienziale di ogni esperienza? Il pensare. Il pensare è la realtà esperienziale di ogni esperienza. L’alternativa è che dormo.
Intervento: Il pensare che è il pensatore, giusto?
Archiati: Il pensatore è una potenzialità.
Replica: Perché è colui che pensa, è colui che fa l’esperienza al momento che intuisce il concetto.
Archiati: Allora devi distinguere, qui è questione di linguaggio. Secondo me Dante ti direbbe: non stai distinguendo tra «pensatore» e «pensante». Il pensatore è una pura potenzialità al pensare, il pensante è il pensatore in atto – di quello parlavi tu, chiamandolo pensatore.
Il pensante è nell’esercizio, nell’esperienza attualizzantesi del pensare. E che cosa si attualizza nel pensare? Il pensatore. Il pensatore diventa realtà in quanto pensante, ma nessun pensatore diventa automaticamente pensante, se no sparirebbe la libertà. Se non ci fosse questa distinzione fondamentale di concetti, il linguaggio non ti distinguerebbe tra pensatore e pensante.
Ve lo dicevo che l’arte del pensare è l’arte del distinguere, e se tu leggi Rosmini – lasciamo da parte Tommaso d’Aquino che ha scritto in latino – e confondi tra pensante e pensatore, ti prendi di quelle sberle e ti dicono: no no, vai a far qualcosa d’altro, lascia perdere!
L’italiano ha il concetto di musicista: c’è il musicante? È una parola desueta, nessuno sa cosa vuol dire.
Intervento: I musicanti di Brema, la fiaba.
Archiati: E già, ma perché viene dal tedesco, invece in tedesco Musikant è una parola normale del linguaggio, e l’altra è Musiker: quindi Musikant è il musicista nell’atto, nel suo attualizzarsi (in italiano non ha bisogno di essere musicante, i soldi se li piglia come musicista). C’è la differenza, si capisce?
Intervento: È di sostanza.
Archiati: È di sostanza.
(V,8) In maniera analoga il filosofo che è persuaso della natura rappresentativa del mondo deve saltare subito da questo all’anima reale che vi sta dietro. Peggio si sta certamente nel caso dell’illusionismo che nega completamente, dietro le rappresentazioni, l’io in sé, o per lo meno lo ritiene inconoscibile. Ad una simile idea può facilmente condurre l’osservazione che, se di fronte al sogno c’è lo stato di veglia nel quale abbiamo occasione di accorgerci dei sogni e di riferirli a rapporti reali, noi non abbiamo invece nessuno stato che stia in analogo rapporto con la vita cosciente e di veglia {dicono questi signori}. Ma chi segue questo modo di pensare non vede {non sa} che di fatto vi è qualcosa che si comporta, rispetto al puro percepire, come lo sperimentare allo stato di veglia si comporta rispetto al sognare: questo qualcosa è il pensare.
Vivere nel pensare è un risvegliarsi a livello superiore. A chi vive nel pensare, la coscienza ordinaria appare tanto un sognare quanto il sognare normale appare appunto un sognare alla coscienza ordinaria. Il paragone calza assolutamente, con la differenza che il passaggio dal sogno alla coscienza ordinaria ce lo dà la natura quando ci svegliamo ogni mattina, mentre l’altro salto è molto più grande, perché è conquista di libertà.
In un certo senso, da un punto di vista morale, di autorealizzazione dell’essere umano, il passaggio dal sogno alla veglia è un piccolo salto qualitativo perché tutti e due, sonno e veglia, me li dà la natura. Invece il passaggio dalla veglia alla superveglia del pensare, è un salto mortale. Moralmente, in fatto di realizzazione dell’io, non è neanche paragonabile.
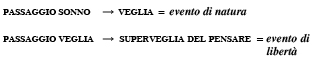
Si può dire: ma il concetto dell’albero ce l’ho già allo stato di veglia, so cos’è l’albero, il contenuto conoscitivo, intellettivo del concetto di albero in fondo ce l’ho già. Però, ciò che avviene di nuovo in questo stato di veglia non è il fattore intellettivo, ma il fattore morale del creare la libertà: l’Io libero creatore pensante viene creato dal nulla della coscienza desta ordinaria.
Da un punto di vista conoscitivo, la coscienza desta ordinaria ha già tutto nel linguaggio: allora non è che io aggiungo altri elementi al concetto di albero, è che ne faccio un frammento morale del mio Io. Il mistero della libertà è la creazione dell’Io. I contenuti conoscitivi intellettuali del mondo ci sono già tutti: li contiene il mondo della percezione, li contiene il linguaggio con le parole, perché ogni parola è un concetto
Intervento: È quello che dà gioia.
Archiati: Sì, perché uno dice: sono io, sono io, sono io. Archimede dice: ho capito! Eureka! Eureka! Ho trovato, ho afferrato! Io ho sempre detto: vi è mai capitato che mentre un altro capisce qualcosa voi giubilate? Che bello, lui ha capito! No, non succede.
Il liceale sta seduto a tavolino alle prese con un’equazione: ci ha lavorato e lavorato… Dopo una settimana c’è un buco nel soffitto perché ha trovato, ha trovato la risposta! Il fratellino di otto anni sta lì seduto accanto e vede questa gioia: anche io, anche io, anche io! E il fratello maggiore gli dice: campa cavallo che l’erba cresce. Però, cosa si manifesta nel bambino piccolo? Il desiderio della gioia, il desiderio della pienezza, che fanno parte della natura umana. Ecco la prova!
V,9 All’uomo ingenuo non si può imputare il difetto di perspicacia cui si accenna qui. Egli si abbandona alla vita e ritiene che le cose esistano realmente così come si presentano alla sua esperienza.
Eh, santa pace!, l’albero è l’albero, quando vado lì e tiro giù una mela me la mangio, non mi dirai mica che è una mia rappresentazione!! Se questo Kant vuol venire a convincermi che io del melo ho soltanto la rappresentazione, sono problemi suoi: a forza di star seduto sul seggiolino del pensatore gli ha dato di volta il cervello!
Cosa c’è di sbagliato nella posizione del realismo ingenuo? Nulla. Perché in fondo si muove sulla pienezza del corporeo – la percezione – e sulla pienezza del pensiero che ha già pensato, che sono le parole «il melo», «la mela»: tutti concetti. Quindi, anche se l’uomo ingenuo non se ne rende conto, ha la realtà piena.
Arriva il filosofo e dice: no, no, tu non hai la cosa in sé della mela, hai soltanto la rappresentazione!
Ma come?, la sto mangiando?!
Non hai la cosa in sé della bocca, hai la rappresentazione della bocca, non hai la cosa in sé del gusto. Come fai tu a sapere cos’è la cosa in sé del gusto? Hai la sensazione del gusto! Ma se la sensazione del gusto e il gusto in quanto cosa in sé siano la stessa cosa, tu non lo puoi sapere.
E il realista ingenuo dice: se il gusto della mela sia la cosa in sé del gusto della mela o no, proprio non mi importa, perché mi basta godere il gusto della mela, la sensazione mi basta.
(V,9) Il primo passo da muovere per superare questo punto di vista può però solo consistere nella domanda: «Come si comporta il pensare rispetto alla percezione?».
Il primo passo, che va oltre l’atteggiamento spontaneo del realista ingenuo, non è quello di porre un dogma che dice: io di tutte le cose ho soltanto la rappresentazione e non ho la cosa in sé. No, il primo passo è quello di chiedersi: mentre io interagisco con le cose, mentre mangio la mela e me la gusto e non manca nulla, c’è forse qualcosa che io non ho ancora portato abbastanza a coscienza? Soltanto questa domanda è legittima, perché l’esperienza è che non manca nulla! La mela è buona e non mi manca nulla.
Se qualcuno viene e mi dice: guarda che il fenomeno te lo puoi gustare ancora di più, allora il pensiero sano dice: non sarà che manca qualcosa non al fenomeno, ma alla mia coscienza? Non sarà che c’è ancora qualcosa di questo fenomeno che io posso portare di più a coscienza? Il pensiero sano non dice che al fenomeno manca qualcosa.
Questo qualcosa che c’è e che io posso portare ancor più a coscienza, e quindi goderlo e gustarlo ancora di più, è il pensare! Ma c’è! Perché senza il pensare non posso sapere che là c’è un albero di mele, che adesso colgo la mela e la mangio: sono sempre nel pensare. E siccome ci sono sempre, e siccome lo produco io a livello spontaneo, non lo porto più di tanto a coscienza.
La filosofia della libertà ti dice: più tu porti a coscienza il pensare, più diventi attivo in questo elemento e più ti dà soddisfazione – più di tutte le mele di questo mondo! La soddisfazione di gustare la mela resta, ovviamente, nessuno te la porta via, ma quell’altra soddisfazione prova a gustartela.
Insomma, diciamocelo: non c’è gusto a vivere in questo mondo complesso, nel sociale, nella globalizzazione, senza capirci nulla. Non c’è gusto! Perciò tante persone sono depresse[27].
La filosofia della libertà ti dice: c’è gusto, sempre più gusto nella misura in cui capisci sempre di più nessi e connessi – cosa ha a che fare la borsa con le speculazioni degli immobili in America, ecc. Più capisci i nessi e più c’è gusto.
Il gusto supremo della vita è il capire, però te lo devi conquistare, se no non c’è gusto[28].
C’è un limite al capire? No, no. Quindi non c’è un limite al gustare.
Tu pensi che il gusto che ti dà il tuo palato sia il gusto supremo della vita? Dài, vai all’altro mondo, datti una guardata intorno su cosa si gustano gli Angeli che capiscono un paio di cose più di noi, cosa si gustano gli Arcangeli, cosa si gustano i Troni, i Cherubini, cosa si gusta il Logos, e fatti venire la voglia di tornare sulla Terra con l’intento di gustare un po’ di più!
Per fortuna c’è la morte se no, a forza di rimbambolimenti, non gusteremmo più nulla! E cos’è la vita tra la morte e una nuova nascita? Una rispolverata data agli occhi, se no non gustiamo più nulla! Agli occhi del pensare, però, perché gli occhi fisici sono spariti.
Gli Angeli – supponiamo che ci siano, io vi assicuro che ci sono ma non posso vendervi dogmi – guardano gli esseri umani e dicono: una umanità che non si gusta più nulla non c’è mai stata. Ma come si può vivere in quel modo lì, senza gustarsi nulla? L’unica cosa che gli Angeli non si sanno spiegare è che il suicidio non aumenti all’infinito. Al che gli Angeli si dicono: se è vero che sono pochi quelli che si suicidano vuol dire che in fondo l’essere umano non molla, resta sempre col desiderio di poter gustare un po’ di più. Solo che non ha ancora capito che per gustare un po’ di più deve far lui un po’ di più.
Di fronte al materialismo c’è lo strabiliarsi degli Angeli che dicono: ma come si fa a passare una vita da uomo accontentandosi di così poco? Cari esseri umani, sbrigatevi a morire e venite a dircelo, perché noi proprio non lo capiamo. La bistecca viene gustata di più che non un concetto! È da matti! E l’Angelo dice: adesso ho capito perché il Padreterno ha inventato la morte. Per fortuna! Se non ci fosse la morte, in men che non si dica sulla Terra avremmo un dormitorio – lo dicevamo, no?, che la coscienza di veglia ordinaria è un dormire, un sognare rispetto a quello che potrebbe essere.
Io sto cercando di dire cose stratosferiche, e vedo Luciana che guarda l’orologio e dice: quand’è che finisci? Allora, siccome comanda lei, facciamo una pausa.
*******
Intervento: Dove mettiamo il fare? Abbiamo parlato di pensare, sentire, volere: e le azioni pratiche?
Archiati: Tu chiedi: dove lo mettiamo il fare? In soffitta? Nella valigia?
Ci sono tre tipi fondamentali di fare, di attività, di praticità, di prassi.
1. per un tipo fondamentale è determinante il corpo, e l’umanità di oggi conosce quasi solo questo tipo: non parla di «fare» dove non è presente il corpo fisico;
2. poi c’è un secondo tipo fondamentale di fare, dove è attiva e operante l’anima – non soltanto l’anima, ma principalmente l’anima è il fattore dominante;
3. poi c’è un terzo tipo fondamentale di fare, dove il fattore dominante è lo spirito.
Camminare, spaccare la legna è un fare – dal latino facere –, un tipo di fare per il quale il corpo è determinante: non puoi camminare o spaccare la legna senza il corpo. Guidare la macchina è un fare, cuocere un pasto è un fare che senza il corpo non esiste.
Adesso arriva il contraccolpo: amare è un fare o no?
Replica: È un’azione reale, amare.
Archiati: È un fare?
Replica: È un fare, è proprio un’azione, questa.
Archiati: Benissimo. Allora diciamo che è una caratteristica fondamentale del materialismo di ridurre il concetto di fare alla sfera corporea. Il che vuol dire che questo tipo di uomo del materialismo si sente attivo, si sente nel fare, ha l’impressione di fare qualcosa soltanto quando muove il corpo, ed è impoverito rispetto a un essere umano che si sente altrettanto facente e operante, altrettanto attivo quando ama, quando maneggia i sentimenti, senza perdere la prima accezione del termine fare. Poi c’è la terza: il pensare è un fare o no?
Replica: È un fare.
Archiati: Io dicevo: c’è pensare e pensare. C’è un tipo di pensare talmente passivo che non è un fare, è automatico perché viene dato dal linguaggio. Il pensare è passibile di diventare sempre di più un fare proprio, attivo, individuale, nella misura in cui ci metto la mia attività nel pensare: allora diventa un fare anche quello, un fare a livello dello spirito, però, dove l’elemento in cui io sono operante, sono facente è lo spirito, così come nell’amore e nei sentimenti l’elemento in cui divento attivo è l’anima. Se poi i termini spirito, anima e corpo non vi piacciono, inventatene altri: qui non si tratta di termini, ma di realtà.
Fatta questa riflessione – che ci sono tre livelli fondamentali del fare, dell’agire, dell’operare – chiediamoci: che differenza c’è tra il fare dove il corpo prende il ruolo dominante, e il fare dove lo spirito prende il ruolo dominante?
Il fare dove il corpo ha una funzione preminente è minimamente individualizzato, perché le leggi del corpo sono leggi di natura uguali per tutti. Io non potrò mai individualizzare il camminare quanto posso individualizzare il pensare, perché se per il camminare è fondamentale il corpo, io non posso avere leggi che reggono la natura del corpo del tutto individualizzate, perché il corpo è per natura uguale per tutti. Nessuno può decidere di camminare con tre gambe – voi pensate all’anziano col bastone, vero?, ma il bastone non è una gamba.
Quel tipo di fare, di agire, di operare, di essere attivi che chiamiamo il pensare è passibile di individualizzazione, di creazione artistica, di variazione all’infinito, e perciò è passibile di maggiore gioia, di maggiore godimento. Perché io dico: è la natura che cammina quando io cammino. Ma quando penso, nella misura in cui divento creatore nel pensare dico: sono io, sono io, sono io, non è la natura che pensa in me. La natura dorme in me, non pensa.
La tragedia di colui che fa, fa, fa, immerso in una prassi all’infinito, una prassi che ritiene superiore, è che a un pensatore come Aristotele dice: ma come?, hai soltanto pensato tutto il giorno?, non hai fatto nulla?! Secondo lui, se uno ha soltanto pensato, non ha fatto nulla. Dormitorio.
Invece, nella misura in cui attivo il pensatoio divento un facitore: faccio, faccio, creo, sono operante nel pensare, nello spirito. Il camminare viene accompagnato da tutt’altri pensieri. Cosa faccio quando cammino? Cosa faccio quando spacco la legna? Il mio corpo spacca la legna, io faccio i pensieri che sto pensando: quello faccio io. Perché camminare lo fa il corpo, spaccare la legna lo fanno le braccia: cosa faccio io? Se non ci metto nessun pensiero che creo io mentre spacco la legna, non faccio nulla! La natura del corpo spacca le cose, ma io non faccio nulla.
Intervento: Anche cucinando si possono mettere tanti pensieri.
Archiati: Se tu mentre cucini non ti accorgi che stai mandando al diavolo, stai dicendo peste e corna di quella persona che ti ha fatto arrabbiare, sei sognante perché non ti rendi conto di tutto il processo di pensiero che accompagna la tua attività. Oppure, se sei una mamma piena di amore, accompagni il cucinare per i bambini, per la famiglia con pensieri, sentimenti di amore, e questi sentimenti di amore sono il tuo fare.
Certo che noi facciamo anche col corpo, ma il cucinare cos’è? È un concetto, è un pensiero. Non si scappa, e l’alternativa è addormentarsi, però da addormentato non cucino nulla, perché non penso. Sono le dodici e devo cucinare: cos’è? Un pensiero. Ho fatto un pensiero.
Tu dicevi: e il fare? Un’azione è un pensiero che diventa percepibile tramite il corpo. Ci vuole il pensiero però, senza il pensiero non c’è azione, non so neanche cosa faccio. Il materialismo disattende la realtà dello spirito che pensa sempre, e che è passibile di diventare sempre più attivo, più creatore nel pensare.
Passo per strada e c’è lì un mendicante seduto: cosa faccio? Non potrei pormi questa domanda senza il concetto di mendicante, senza il concetto di aiuto, senza il concetto di «sarà per il suo bene se gli do un po’ di soldi, o sarà un contributo a che poltrisca invece di lavorare?» ecc… Cosa sto facendo? Sto pensando! E le azioni esterne evidenziano i miei pensieri.
Intervento: Quindi è bene che ogni azione che viene fatta venga accompagnata non solo dal pensiero – quello c’è sempre: stai dicendo che è sempre un pensiero che ci fa agire –, ma anche dal portare questo pensiero a coscienza.
Archiati: La percezione mi dà già un concetto cristallizzato nel linguaggio, automatico. La percezione mi dà il concetto automatico di mendicante, e mendicante mi dà il concetto automatico di aiuto: «mendicante» è un concetto, però non necessariamente recepito attivamente da me, e «aiuto» è un altro concetto. Sono tutti concetti. Nello stato di veglia l’essere umano agisce sempre in base al pensare, il pensare non può mai mancare, altrimenti si deve addormentare.
La riflessione che noi stiamo facendo è che questo pensare automatico – che mi viene in base alla percezione e in base al linguaggio che da sempre appiccica la percezione a un concetto – è passibile di venir preso in mano, di venir gestito in un modo così attivo, che questo creare i concetti in un modo individualizzato è uno stato di veglia superiore rispetto alla veglia ordinaria, ancora superiore rispetto a quanto lo stato di veglia supera il sonno.
Quindi il pensare ordinario è passibile di evoluzione, di individualizzazione, di attivazione all’infinito. Il pensare ordinario, che mi viene automaticamente dalla percezione e dal linguaggio, e che in partenza è solamente potenziale perché massimamente automatico e passivo, è passibile di evoluzione in chiave di attività, in chiave di individualizzazione, in chiave di creazione all’infinito.
Intervento: Lo scendere le scale automatico, come si inquadra in questo discorso che fai tu?
Archiati: Scendi la scala e dove vai?
Realtà: Vado giù.
Archiati: Cosa c’è giù?
Realtà: C’è qualche cosa che mi interessa.
Archiati: Allora vai a fare qualcosa che ti interessa. Cosa stai facendo?
Realtà: Un pensiero.
Archiati: Perché ti interessa?
Replica: Perché voglio andare a prendere un caffè.
Archiati: Perché ti interessa il caffè?
Replica: Sento il desiderio di prendere un caffè.
Archiati: Bene, e ti basta che ci sia il desiderio? Il caffè è un concetto, la scala è un concetto, la natura del corpo ti dà la voglia (tu l’hai chiamato desiderio, ma è voglia) del caffè, tu sei abituato ad avere piacere nel prendere il caffè, scendi la scala e bevi il caffè. Io ti sto dicendo: in questa costellazione di interazione tra percezioni – scala, gradini, caffè, piedi – e concetti che sono cristallizzati nel linguaggio (tu non stai inventando le parole «scala», «gradini» ecc.), siccome la percezione te la dà il mondo corporeo e i concetti te li dà, già pensati nel passato, il linguaggio, allora proprio i concetti sono passibili di evoluzione all’infinito se tu li prendi in mano e ci rifletti sopra a livello individuale e sempre più creativo.
Replica: Io mi riferivo al movimento dello scendere le scale che diventa automatico…
Archiati: No, non esiste il puro movimento, altrimenti devi essere un sonnambulo! Un sonnambulo scende la scala allo stesso modo di uno che è sveglio?
Intervento: Uno che è sveglio dà una direzione.
Archiati: Accompagna con pensieri, perché è sveglio. Il nostro problema è che disattendiamo il pensare, perché ci siamo sempre dentro. Tu stai pensando: vado a bere un caffè. Oh, è un pensiero! Se a metà scala ti dimentichi di cosa stai facendo torni indietro. Il pensiero «voglio bere un caffè» è una realtà che ti accompagna mentre scendi le scale. Per uscire dal pensiero dobbiamo addormentarci.
Intervento: Qual è la differenza tra il pensiero che mi conduce al bar, e il pensiero che invece mi fa creare un dipinto, mi fa realizzare artisticamente un’opera?
Archiati: Eh, che differenza c’è?
Replica: La qualità del pensiero, il grado di svegliezza del pensiero, di individualizzazione?
Archiati: Il grado di attività! Il pensare che mi accompagna mentre scendo la scala è molto meno attivo, molto meno intenso che il pensare che devo generare mentre faccio un quadro in cui devo essere più attivo.
Intervento: Uno va a prendere un caffè e il motivo che lo accompagna è che vuole rigenerarsi; invece il pensiero che accompagna l’azione del dipingere è più impegnativo, c’è più gusto, c’è una ricerca del gusto.
Archiati: Perché ci devi mettere più sforzo, più attività.
Replica: Più impegno.
Archiati: Impegno è troppo morale. Più attività: devi diventare più attivo.
Intervento: Per il caffè ci sono forse solo pensiero e corpo che inseguono quel fine; nella composizione di un’opera poetica o grafica c’è anche un apporto di emozioni e sentimenti.
Archiati: Sta’ attenta: il piacere che sento quando bevo il caffè l’ho già provato, e quindi mi riprometto di risentire questo piacere. La gioia che sento quando ho fatto un bel quadro l’ho già provata: mi riprometto di rivivere questo piacere. La differenza non è nel gusto o nel piacere, la differenza è che nel caso del caffè vado al bar, lo trovo pronto e lo bevo, il quadro lo devo creare, non c’è senza di me. Questa è la differenza di attività.
Replica: Sì, ma mi chiedevo se – in relazione a quel che abbiamo visto in questi giorni circa la partecipazione di uno o dell’altro dei nostri componenti, delle nostre dimensioni dell’umano – non ci sia anche l’intervento in più della sfera animica nel comporre qualcosa. In più rispetto al caffè già pronto. Non c’è una compartecipazione animica?
Archiati: Ci stai dando un caffè un po’ diluito adesso, eh? La sua domanda era: che tipo di gusto c’è nel bere un caffè? Che tipo di gusto c’è nel creare un quadro? Che differenza c’è?
Replica: Ma quel gusto non è legato proprio al mio sentire? È qualcosa in più rispetto all’andare a prendere il caffè.
Archiati: No, è che il caffè non l’ho creato io, il quadro l’ho creato io.
Replica: Sì, appunto, ma nel creare non c’è la partecipazione animica in più?
Archiati: Guarda che la partecipazione animica c’è anche nel bere il caffè, se no non lo posso gustare.
Replica: Ah, certo, certo. Grazie. Quindi è creazione ex novo quella del quadro o della poesia.
Archiati: Adesso ci siamo.
Intervento: Io penso che il desiderio del caffè sia un desiderio animico, mentre la creazione artistica viene dal pensiero spirituale.
Archiati: Il desiderio è un vissuto nell’animo, non importa nulla se è il desiderio di bere un caffè o il desiderio di fare un quadro: il desiderio è desiderio, è un fenomeno animico. La differenza è nel come mi esperisco, come mi vivo bevente il caffè, e come mi vivo architettante e dipingente un quadro.
Mentre bevo il caffè mi vivo del tutto passivo: basta che ci sia la bocca e la tazzina col caffè dentro che mi dà il barista. Per dipingere un quadro basta prendere il pennello col colore? No. Bisogna attivare il pensatoio. Quindi il gusto, il desiderio è nell’anima sia nell’uno che nell’altro caso; invece, per appagare il desiderio di caffè, la cosa più importante è il corpo, per appagare il desiderio di un quadro ben dipinto, la cosa più importante è lo spirito, sono i pensieri. Però i pensieri saltano fuori soltanto nella misura in cui li creo io, mentre il caffè me lo danno al bar, basta che io tiri fuori i soldi. Anzi, in questi giorni non ho tirato fuori nemmeno quelli, perché me l’hanno sempre offerto, il caffè!
Intervento: Immagino che coinvolgere sia la parte spirituale, sia la parte animica, sia la parte corporea, motoria, in un’azione sarebbe l’ideale, perché ci sarebbe l’elemento totale del nostro essere.
Archiati: Diciamo che sto scendendo le scale e non mi importa nulla di quello che il mio corpo sta facendo: mentre scendo le scale è presente al mio pensare l’intuizione complessiva di tutto il sistema solare e di tutti i nessi e connessi che creo io in questo momento! Beh, sarei lo spirito del Sole che sta scendendo le scale! Campa cavallo che l’erba cresce!
Il concetto di Logos, dello spirito del Sole che si è incarnato nel Gesù di Nazareth, è che crea continuamente il tutto, tutti i nessi e connessi e tutti i concetti, senza mai subire minimamente passività. Una prospettiva di evoluzione per noi stratosferica, strabiliante. Quindi fa’ in modo che i tuoi pensieri, sia che scendi la scala o che la sali o che bevi il caffè, siano sempre più vasti, sempre più profondi, sempre più creativi e sempre più pieni di nessi e connessi. Allora il caffè avrà un altro gusto e anche la scala, perché non vorrai scendere la scala come la scende il gatto. Il gatto la scende senza pensieri, perciò è un gatto.
Intervento: Noi adesso abbiamo fatto l’esempio del caffè: lui va a prendere il caffè, lo gusta e sente che è buono, crea un pensiero. Ultimamente sta succedendo secondo me, una cosa più pericolosa: la pubblicità ci dice che quel caffè è più buono di un altro. Non è che la pubblicità ci dà dei pensieri già pensati, già fatti che, anziché venire dalla percezione, cambiano la percezione?
Archiati: Ma guarda che la pubblicità ti dà quei pensieri lì soltanto se tu li pigli! Io non li piglio, quindi non me li dà. Devo confessarvi che io la televisione non l’ho mai avuta e mai l’avrò.
Replica: Quindi ci sono anche pensieri passivi e pensieri attivi?
Archiati: Ah, dici che ci possono essere anche dei pensieri passivi? Bello, non lo sapevo!! Il linguaggio è una somma di pensieri già pensati, no? Ogni parola del linguaggio è un concetto, però già pensato, cristallizzato, bello morto. Il linguaggio è la sepoltura dello spirito, che però dà la possibilità all’individuo singolo di far risorgere questo spirito, perché se non è sepolto non lo puoi far risorgere. Anche il povero Cristo ha potuto risorgere soltanto facendosi seppellire.
Ah, Luciana mi sta dicendo che abbiamo tempo solo per un’altra domanda, il che significa che non c’è tempo per la mia risposta. Quindi, per favore, si presenti qualcuno che ha una domanda che non chiede risposta.
Luciana: Come sei spiritoso!
Archiati: Beh, alla fine di un seminario, almeno un po’ di spirito me lo concedi?
Intervento: Se una persona è in grado di rifare un quadro identico a un Van Gogh, per esempio, dal punto di vista tecnico può essere identico, però l’uomo ha la capacità di distinguere un originale da una buona imitazione, di capire dove c’è dietro al quadro un pensiero creativo e dove invece un pensiero che scimmiotta.
Archiati: L’esperienza della maggiore o minore attività nessuno la può fare guardando un altro. Ognuno la può fare soltanto su se stesso e, se siamo sinceri, ognuno sa quando si vive maggiormente attivo, maggiormente sveglio e quando si vive maggiormente recepente o passivo.
Per fare una camminata quand’è che ci vuole più attività, più forza di volontà e quando di meno? Per quanto riguarda te lo puoi dire soltanto tu, e non hai voce in capitolo su un altro, perché un percorso che per te può essere automatico, senza bisogno di sforzo volitivo, non lo è per un altro che ha ottant’anni e arranca: per lui è un sacco di attività.
• Il conoscere universalizza l’uomo, lo spersonalizza, perché il conoscere è oggettivo, uguale per tutti.
• L’agire, il lato morale della volontà, lo individualizza. Il carattere di più impegno o meno impegno, di maggiore o minore sforzo, di maggiore o minore creatività e individualizzazione lo posso vivere soltanto io su di me, non posso riferirlo a un altro.
Quindi nel campo della conoscenza c’è il monismo di pensieri, che è la prima parte de La filosofia della libertà. Nel campo dell’agire, del fare c’è l’individualismo etico – seconda parte de La filosofia della libertà –, e ciò che vale per una persona non può valere per un’altra, ciò che per uno è impegno per l’altro è poltroneria.
Arrivederci alla prossima volta!
Appendice
(dall’incontro del venerdì mattina, come segnalato nella nota 7)
Archiati: Ho la grande gioia di presentarvi Maria Nieddu, nata in Sardegna e abitante in Piemonte, che adesso si trova a un punto della sua vita in cui ha la possibilità di dedicare tutto il suo tempo, le sue energie e i suoi talenti all’attività editoriale. Siccome noi, in Germania, siamo rimasti soltanto in due nella casa editrice, abbiamo deciso di non occuparci più delle edizioni in italiano: che gli italiani facciano in Italia quello che vogliono! Dicevamo prima che nei linguaggi ci sono sfumature molto diverse, e pensate quando si tratta di scegliere copertine e titoli dei libri (cosa importantissima). Perciò vi raccomando questi libri, soprattutto i testi di Steiner, perché quelli di Pietro Archiati servono soltanto a portare fino a Steiner. Incendiate tutta l’Italia di questo entusiasmo per il pensare che suscita gioia, luce, attività.
Allora, io adesso faccio un’eccezione, sto zitto, e do la parola a Maria Nieddu.
Maria Nieddu: Buongiorno a tutti. Io voglio dedicare le mie forze a questa iniziativa delle casa editrice in Italia, che non è proprio una prima iniziativa: ci sono state esperienze precedenti. Negli ultimi anni è stata Monika Grimm, che ringrazio tantissimo, a portare avanti questa attività per l’Italia, e l’ha fatto benissimo, in modo egregio. Penso però che la stampa dei testi in italiano debba essere presa in mano da persone che sono presenti sul territorio italiano. Io ho delle persone che collaborano con me perché sono convinte, come me, che questi contenuti siano un bene per l’umanità.
Questa attività richiede moltissime forze, soprattutto dal punto di vista della diffusione. Sappiamo tutti che sono contenuti che non si venderanno a milioni, però qualche centinaio, magari anche qualche migliaio, nel territorio italiano speriamo di riuscire a portarlo.
È importante soprattutto che questi libri divengano percepibili per il maggior numero possibile di persone, su tutto il territorio italiano. Ad esempio il sud è quasi inesplorato e io chiedo fortissimamente la collaborazione di chi, come me, sente la spinta a diffonderli, questi contenuti. Chiedo di offrire col cuore l’aiuto per portare questi contenuti su tutto il territorio: scusate se mi ripeto, ma le cose da dire son poche e son sempre quelle.
Continueremo a rimanere legati all’Archiati Verlag e infatti abbiamo deciso di chiamarci Archiati Edizioni, continueremo a produrre i libri di Pietro Archiati, che sono fondamentali – lui li sminuisce, ma sono importantissimi perché danno una chiave di accesso ai libri di Steiner –, e continueremo a tradurre Steiner dal tedesco. Pensavamo anche di fare le trascrizioni dei Convegni.
Comunque, piano piano, come programma di attività ci adatteremo alle esigenze della gente, a ciò che il pubblico ci chiederà.
Mi sembra di aver detto tutto: la cosa più importante è che ci sia una partecipazione del cuore alla diffusione di questi libri. Io sono disponibile perché voglio dedicare me stessa a questa attività 24 ore su 24, anche di notte! Chi vuole chiedere informazioni, chi si vuole offrire come collaboratore, può rivolgersi a:
A proposito di Pietro Archiati
Pietro Archiati è nato nel 1944 a Capriano del Colle (Brescia). Ha studiato teologia e filosofia alla Gregoriana di Roma e più tardi all’Università statale di Monaco di Baviera. È stato insegnante nel Laos durante gli anni più duri della guerra del Vietnam (1968-70).
Dal 1974 al 1976 ha vissuto a New York nell’ambito dell’ordine missionario nel quale era entrato all’età di dieci anni.
Nel 1977, durante un periodo di eremitaggio sul lago di Como, ha scoperto gli scritti di Rudolf Steiner la cui scienza dello spirito – destinata a diventare la grande passione della sua vita – indaga non solo il mondo sensibile ma anche quello invisibile, e permette così sia alla scienza sia alla religione di fare un bel passo in avanti.
Dal 1981 al 1985 ha insegnato in un seminario in Sudafrica durante gli ultimi anni della segregazione razziale.
Dal 1987 vive in Germania come libero professionista, indipendente da qualsiasi tipo di istituzione, e tiene conferenze, seminari e convegni in vari Paesi. I suoi libri sono dedicati allo spirito libero di ogni essere umano, alle sue inesauribili risorse intellettive e morali.

Gli autori difendono la gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l’accesso alla cultura.
Gli autori e l’editore rinunciano a riscuotere eventuali royalties derivanti dal prestito bibliotecario di quest’opera. Tale opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons, che recita: si consente la riproduzione parziale o totale dell’opera e la sua diffusione per via telematica, pubblicazione su diversi formati, esecuzione o modifica, purché non a scopi commerciali o di lucro e a condizione che vengano indicati gli autori e che questa dicitura sia riprodotta.
Ogni licenza relativa a un’opera deve essere identica alla licenza relativa all’opera originaria.


[1]Pietro Archiati Il pensare, una creazione dal nulla (FdL 3) pag. 168 – Archiati Edizioni.
[2]Rudolf Steiner Introduzione alla scienza dello spirito – Archiati Edizioni
Pietro Archiati Creare e vivere una nuova vita. L’impulso scientifico-spirituale – Archiati Edizioni
[3]Rudolf Steiner Verso un’etica della libertà – Archiati Edizioni
[4]Rudolf Steiner Il pensiero nell’uomo e nel mondo. Dodici modi di pensare, sette modi di vivere – Archiati Edizioni
[5]Dante Alighieri, Divina Commedia. Paradiso Canto IV v.28.
[6] Rudolf Steiner Riscatto dai poteri, tra Est e Ovest l’enigma dell’Europa centrale – Archiati Edizioni
[7]Solo 2 conf.: 21 dic. 1916 Natale – Rivista Antroposofica Genmar 1978 25 dic. 1916 Per una rinascita del Natale – Archiati Edizioni (solo la seconda parte della conferenza)
[8]Nel testo tedesco qui comincia il paragrafo 8 perché il precedente paragrafo 3 di questo IV capitolo, sempre nel testo tedesco, diventa par. 4 dopo tre righe: «Se camminando attraverso i campi…», mentre in italiano continua come paragrafo 3 (vedi: Pietro Archiati Il pensare, una creazione dal nulla (FdL 3) pag. 214 – Archiati Edizioni). Non avendo Pietro Archiati rilevato questa discrepanza nel precedente incontro, continuiamo con la sequenza corretta solo da questo paragrafo in poi, e quindi qui risulterà mancante il paragrafo 8.
[9]Dante Alighieri Divina Commedia. Inferno Canto XXVI vv.119-120
[10]Pietro Archiati presenta la proprietaria della nuova Archiati Edizioni italiana. Per gli interessati rimandiamo all’Appendice.
[11] Pietro Archiati intende dire che in questo vangelo compare la parola «Cristo» soltanto quando Giovanni riporta frasi o racconti di altri che usano questa parola, mentre quando è lui stesso ad esprimersi parla sempre del «Logos». Nel caso del v. 20,31 (dove non sembrerebbe riportato un pensiero altrui), si tratta in realtà di una postilla dei discepoli che a seguire scrissero l’intero capitolo 21.
[12] Gv 16,7 – vedi per completezza anche Gv 14,26 e 15,26
[13] Dante Alighieri, Divina Commedia. Purgatorio Canto XXVII v.142.
[14]In tre libretti sono raccolte tre conferenze tenute da Pietro Archiati sul tema delle fiabe:
Il mondo delle fiabe – Archiati Edizioni
Rosaspina – Archiati Edizioni
La Signora Holle – Archiati Edizioni
[15]Rudolf Steiner Il fenomeno uomo. Da Gesù a Cristo – Archiati Edizioni
Rudolf Steiner Il bello di essere uomini. Per una convivenza giusta e libera – Archiati Edizioni
Pietro Archiati Guarire ogni giorno – Archiati Edizioni
[16]Pietro Archiati Il pensiero, via maestra alla felicità – Archiati Edizioni
Pietro Archiati Equilibrio interiore. L’arte di mediare fra gli estremi – Archiati Edizioni
[17]Pietro Archiati Il mistero del male – Archiati Edizioni
[18]Pietro Archiati Pensare sul pensare. Un’esperienza straordinaria (FdL 2) pag.163-164 – Archiati Edizioni
Pietro Archiati Il pensare, una creazione dal nulla (FdL 3) pag. 231 – Archiati Edizioni
[19] Sull’argomento vedi ancora gli esperimenti di Libet già citati in nota1: Pietro Archiati Il pensare, una creazione dal nulla (FdL 3) pag. 168 – Archiati Edizioni.
[20]Rudolf Steiner Tra destino e libertà – Archiati Edizioni
Pietro Archiati L’arte dell’incontro – Archiati Edizioni
Pietro Archiati Il mistero dell’amore – Archiati Edizioni
Pietro Archiati Arrivederci alla prossima vita – Archiati Edizioni
[21]Pietro Archiati Dalla mia vita. La mia esperienza con la Chiesa e l’Antroposofia – Archiati Edizioni
[22]Pietro Archiati Nati per diventare liberi. Ereditarietà e libertà nel destino di un uomo – Archiati Edizioni
[23] Rudolf Steiner Il bene c’è per tutti. La redenzione vista in chiave moderna – Archiati Edizioni
[24] Pietro Archiati Il pensare, una creazione dal nulla (FdL 3) pag. 191 – Archiati Edizioni.
[25] Per un approfondimento del significato della malattia come occasione di guarigione vedi: Pietro Archiati Guarire ogni giorno – Archiati Edizioni
[26] Rudolf Steiner La poesia delle fiabe alla luce della scienza dello spirito Editrice Antroposofica – Milano.
[27]Pietro Archiati La forza della positività. In tempi di sfide a misura d’uomo – Archiati Edizioni
[28]Pietro Archiati Il grande gioco della vita – Archiati Edizioni