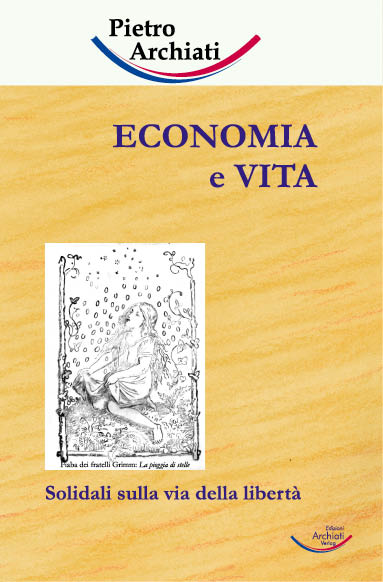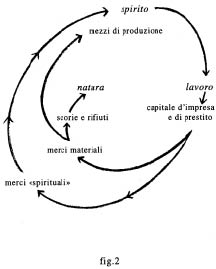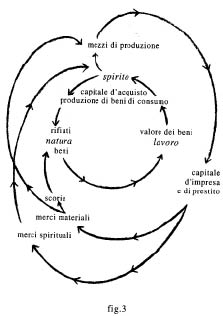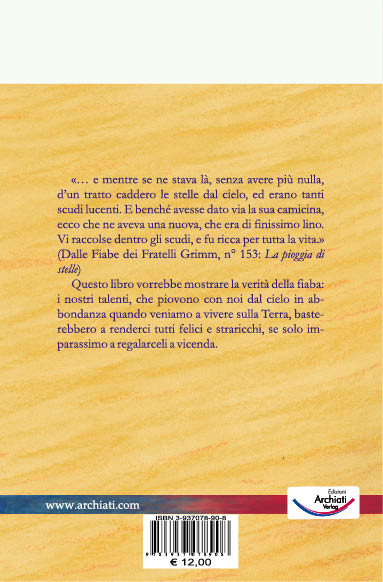Indice
Prefazione
Primo capitolo
leggi dell’economia e scelte libere
dello spirito
• Il cammino umano dallo spirito al denaro
• Un’economia secondo leggi ineluttabili o secondo libertà?
• I tre usi del denaro: pagare, prestare, donare
• Il denaro è come il sangue: deve circolare
• La legge del capitale e la legge del lavoro
• Che cos’è la «triarticolazione» dell’organismo sociale
• Il vero volto del «plusvalore»
• Evoluzione o progresso?
• Le tre grandi fasi del materialismo
Secondo capitolo
da un’economia di denaro a un’economia di fiducia nell’umano
• Capitalismo, comunismo e la terza via
• Chi regge le sorti dell’economia e del sociale?
• Per il denaro è tempo di un’inversione di marcia
• L’ossessione assicurativa dell’uomo insicuro
• Come si genera la fiducia nell’umano?
• Lo spirito di libertà nella vita culturale
• Lo spirito di donazione quale dinamismo specifico dell’economia
• Le tre grandi fasi evolutive dell’economia
• Egoismo e altruismo in economia
• Spirito di donazione quale spirito associativo
Terzo capitolo
lavorare per sé o per gli altri? liberazione del lavoro dalla tirannia dell’economia
• L’uomo e il suo lavoro
• La redenzione del lavoro dalla tirannia dell’economia
• Il lavoro si divide e si specializza: l’uomo si universalizza
• La mentalità autarchica si fa sempre più anacronistica
• Le due grandi missioni dell’uomo lavoratore
• Lavoro utile, lavoro inutile, lavoro nocivo
• L’evoluzione dell’idea di giustizia: da Tommaso d’Aquino a oggi
• La lavanda dei piedi: fenomeno archetipico del «lavoro» umano
• L’opus magnum dell’evoluzione
Quarto capitolo
lo spirito associativo in economia e il superamento del parassitismo
• «Essere se stessi» quale vera salute dell’organismo economico
• Conoscere i propri talenti per individuare i propri bisogni reali
• Dirigismo statale e dinamismo associativo
• Che cosa comporta la «triarticolazione» per l’economia?
• Come si giunge ad attribuire un valore alle merci?
• I tre compiti fondamentali dell’associazione
• È veramente un vantaggio guadagnare più del necessario?
• «Il diritto all’uso esclusivo» quale evoluzione e sintesi dei concetti di proprietà privata e collettiva
• Differenza tra utopia e salute
• L’eredità e i beni immobili: possedere o essere posseduti?
• La legge economica del profitto per tutti
• Il contratto di coproduzione e di distribuzione dei profitti
Quinto capitolo
il nostro pane quotidiano materiale e spirituale
• Il dinamismo intrinseco alla triarticolazione sociale quale «nutrimento» quotidiano
• L’arte della mediazione nel pareggiare diritti e doveri
• Il duplice nutrimento dell’uomo: libertà e amore
• Bisogni e talenti: fame e sazietà
• Uomo bisognoso o uomo che elargisce?
• Il talento del lustrascarpe e della lavandaia
• C’è un pane vero che discende dal cielo?
• Denaro che invecchia, deperisce, muore. E rinasce
• La nuova missione di un cristianesimo rinnovato
• La missione individuale sostiene e sostenta l’uomo
A proposito di Pietro Archiati
Prefazione di Pietro Archiati
Un detto popolare afferma: in cielo regna il Dio trino, in terra il dio quattrino. Un detto forse non proprio saggio, ma di certo realistico. Chi di noi può dire che il denaro non giochi un ruolo fondamentale nella sua vita?
Il denaro sta però facendo la fine della macchina: da strumento di benessere per l’uomo che dovrebbe essere ne diviene sempre di più il tiranno. Fa sorgere brama (di denaro): prima forma di tirannia. Fa sorgere paura (di restare squattrinati): seconda forma di tirannia. Fa sorgere concorrenza (per i posti ben pagati): terza forma di tirannia. Fa sorgere sfruttamento (col vivere di eredità, per esempio): quarta forma di tirannia. Fa sorgere a livello mondiale la cosiddetta «globalizzazione» del potere e dello sfruttamento economico a vastissimo raggio (con l’egemonia spietata dell’Occidente): quinta forma, anzi quintessenza mondiale della tirannia.
Ma c’è anche un riscatto del denaro, che fa parte della liberazione dell’uomo stesso. È possibile, se si vuole, cominciare a vivere per l’uomo e per l’umanità anziché per il denaro. A questo punto lo spirito umano termina di essere schiavo del denaro e fa di esso il proprio preziosissimo servitore. In questo modo avremo spirito e denaro a servizio dell’uomo. Mostrare come ciò sia realmente e concretamente possibile è l’intento di questo libro.
Queste pagine devono la loro origine a un Convegno tenuto a Bologna nel settembre del 1997. A più riprese nel testo viene fatto riferimento a R. Steiner, colui che ha inaugurato una scienza moderna che indaga non solo il mondo visibile ma anche quello spirituale. I pensieri qui espressi devono moltissimo a lui. Per quanto riguarda il tema specifico di questo scritto, il lettore interessato ne troverà i fondamenti soprattutto nei libri di R. Steiner I capisaldi dell’economia e I punti essenziali della questione sociale.
Primo capitolo
LEGGI DELL’ECONOMIA
E SCELTE LIBERE DELLO SPIRITO
Il cammino umano dallo spirito al denaro
«Spirito e denaro»: un tema ardito e al contempo arduo, il nostro. Si propone infatti di raffrontare due realtà del vivere quotidiano che si presentano in tensione, in opposizione fra di loro, in un rapporto di polarità.
Da un lato abbiamo lo spirito che rappresenta, in modi diversissimi e spesso inafferrabili, tutto ciò che dentro e fuori di noi è impalpabile e pur tuttavia reale. Pensiamo all’amicizia, alla gioia e alla gratitudine, alla tolleranza che ci sforziamo di esercitare gli uni con gli altri nella vita quotidiana: si possono vedere o toccare? No, ma sappiamo bene che ci sono. Sono realtà cosiddette «spirituali».
Quando un profondo rapporto d’amicizia all’improvviso viene meno, la vita non è più la stessa. Si può avere l’impressione di un finimondo, di un rivolgimento radicale delle cose: da lieti che eravamo, con le ali che ci facevano volare, diventiamo tristi, frastornati. Ugualmente, quando avviene una riconciliazione, ritroviamo la gioia di vivere e il senso positivo dell’esistenza. Sono soltanto alcuni esempi tra i più semplici e comuni dell’esperienza di ciò che chiamiamo «spirito».
All’altro estremo troviamo il denaro e qui non abbiamo nessuna difficoltà a sapere di che si tratta: basta mettere le mani in tasca e, se non siamo proprio del tutto squattrinati, troviamo lì biglietti e monete a noi ben noti. Quando ne vengono coniati di nuovi, nel giro di pochi giorni impariamo a riconoscere la loro figura, i colori e il corrispettivo valore. Una delle qualità più importanti del denaro è proprio la sua estrema concretezza. Una banconota deve essere immediatamente riconoscibile per tutti, altrimenti in ogni transazione si perderebbe tempo prezioso.
Il denaro rappresenta tutto ciò che è visibile e tangibile ed è, lo sappiamo bene, lo strumento più incarnato e incarnante che ci sia: è il correlativo, infatti, di tutte le cose materiali che con esso possiamo comprare. Vedremo che rappresenta non meno le cose spirituali, ma nella psicologia normale dell’uomo d’oggi i soldi rimandano immediatamente a ciò che materialmente si acquista per mangiare, per bere, per vestirsi, per abitare, per spostarsi, per divertirsi, ecc.
Tra lo spirito e il denaro si pone l’essere umano stesso a far da mediatore e da ponte tra l’invisibile e il visibile. L’uomo contemporaneo è chiamato a penetrare sempre maggiormente tutto il mondo fisico con forze di pensiero sempre più intrise di consapevolezza, per trasformarlo e umanizzarlo. La cosiddetta materia non esiste di per sé, ma è intrisa di spirito: lo spirito ne costituisce la realtà vera.
Si può dire che nelle due parole «spirito» e «denaro» sia riassunta l’intera evoluzione dell’umanità dai primordi fino a oggi.
Lo spirito si riferisce agli albori del nostro divenire: le grandi immagini archetipiche e collettive del paradiso terrestre – quelle della Bibbia e quelle ad esse analoghe di tutte le grandi cosmogonie e mitologie dei popoli – parlano di uno stadio evolutivo primigenio dell’umanità, di natura puramente spirituale. È questo un assunto fondamentale che colloca l’inizio del cammino umano nello spirito, un assunto certo da non prendere come un dogma, ma come un continuo stimolo al pensare.
Sopraggiungono poi le immagini della cosiddetta caduta, del «peccato originale» e della «cacciata dal paradiso», tramite cui l’essere umano discende dalle regioni celesti sempre più giù nel mondo della materia: egli lascia dietro di sé il regno del puro sovrasensibile per immergersi sempre più nel mondo fisico. In questa seconda grande fase dell’evoluzione ci troviamo noi oggi, sentendoci completamente a casa nostra nella realtà sensibile, tanto è vero che viviamo nell’oblio quasi assoluto della realtà dello spirito
Mentre dunque la parola «spirito» evoca i primordi storici del nostro divenire nel tempo e la capacità di viverne e riconoscerne la realtà, la parola «denaro» indica l’immersione attuale nel mondo del visibile, di tutto ciò che si tocca o si possiede o di cui si è certi, di tutto ciò che col denaro si può comprare e possedere.
L’umanità moderna ha codificato il carattere fondamentale di questa situazione dicendo: esiste la scienza, fondata su oggettiva certezza, che è in grado di sceverare e penetrare la realtà visibile secondo le forze di una conoscenza rigorosa; ed esiste la fede, per ciò che riguarda l’invisibile, nei confronti del quale – così è stato decretato – non ci può essere conoscenza certa e oggettiva, valida per tutti. Essendo la fede una faccenda personale, essa deve limitarsi alla sfera privata: non le è concesso di incidere più di tanto sulla vita pubblica, che è poi vista e vissuta come la vita vera.
Questa dicotomia è una vera schizofrenia culturale che ha stabilito un rapporto di reciproca esclusione tra la scienza e la fede. E così l’uomo moderno si contenta di una conoscenza limitata a ciò che è materiale. Il denaro, a sua volta, sta a rappresentare la circolazione, la quantificazione e l’acquisizione di tutte le cose visibili.
Al contempo si dichiara – non meno dogmaticamente! – che non è possibile una conoscenza davvero scientifica del mondo spirituale, ammesso che esista, e perciò se ne fa una questione puramente affettiva o consolatoria: anzi, per molti esseri umani d’oggi il dubbio e anche la negazione della realtà dello spirito appaiono sensati e auspicabili proprio in ragione della presunta impossibilità dell’esistenza di una scienza spirituale, altrettanto oggettiva rispetto a quella che indaga la materia.
In questa prospettiva di un’evoluzione umana che si muove dai mondi spirituali per immergersi sempre più nella materia viene alla mente una bella parola greca che riassume in sé tutto questo umano cammino: è la parola ταλαντον (tàlanton), talento. Questo vocabolo ha due significati ben diversi che corrispondono proprio ai due grandi momenti evolutivi or ora indicati: talento è da un lato la moneta di metallo, il denaro, ma indica d’altro lato ogni capacità e dote spirituale dell’essere umano, ogni «talento» interiore, appunto.
La parola talanton, nel suo duplice significato, sintetizza così il mistero del divenire dell’umanità: il talento come denaro è il simbolo dell’operare umano dentro al mondo della materia; il talento come facoltà interiore, come ingegno umano, indica il dinamismo della creatività dell’uomo in quanto essere spirituale.
Nel periodo di cultura dei greci e dei romani circa i nove decimi della popolazione doveva svolgere lavori manuali per procurare la base materiale dell’esistenza di tutti, e soltanto circa un decimo aveva la possibilità e anche la capacità di dedicarsi alla σχολη (scolè); questa parola, da cui deriva la nostra «scuola», significa tempo libero, il tempo per dedicarsi alla cultura, all’arte, alla scienza, alla religione, in una parola: allo spirito.
Nell’epoca moderna, iniziata nel quindicesimo secolo, questa proporzione ha cominciato a invertirsi. Col passare del tempo ci sarà sempre meno bisogno di lavoro materiale (del resto già vediamo come le macchine sostituiscano sempre di più il lavoro umano) e nel corso dei prossimi secoli arriveremo prima o poi al punto in cui basterà un decimo dell’iniziale lavoro materiale e gli altri nove decimi saranno tempo libero, tempo per lo spirito.
Il denaro rappresenterà perciò in futuro sempre di meno il lavoro destinato al mantenimento dell’esistenza corporea e verrà a significare sempre di più ciò che noi possiamo fare per coltivare il nostro spirito. Nell’evoluzione prima di Cristo si pagava la decima – un decimo!– per rendere possibile la vita culturale-spirituale; nella seconda parte dell’evoluzione si arriverà a dedicare un decimo delle energie al fondamento materiale dell’esistenza, per riservare tutto il resto all’evoluzione dello spirito umano.
Un’economia secondo leggi ineluttabili o secondo libertà?
Se questi mutamenti sono realmente prevedibili, la domanda fondamentale allora è: in economia noi abbiamo a che fare con leggi deterministiche e ineluttabili, per esempio di mercato, che si possono solo conoscere e rispettare nella loro inesorabile oggettività, oppure è possibile anche in campo economico, o forse soprattutto in campo economico, che sia lo spirito umano a reggere secondo libertà le sorti della vita?
In altre parole, la scienza economica è una scienza teorica o pratica?
Le scienze teoriche, per esempio la fisica, studiano le leggi di funzionamento della natura non con l’intento di mutarle, cosa impossibile all’uomo, ma per conoscerne con precisione la processualità. La fisica teorica diventa poi fisica applicata (e non pratica!) quando utilizza, sfrutta direttamente o riproduce i fenomeni di natura, governati dalle loro leggi ineluttabili, per trarre vantaggio dai loro prevedibili e misurabili effetti. Una centrale idroelettrica è, per esempio, il frutto della fisica applicata.
Le scienze pratiche (dal greco πραξις, pràxis: opera, azione) riguardano invece l’uomo in quanto è libero nel suo operare sociale e privato: vanno dalla giurisprudenza alla morale e sono passibili di tutte le modificazioni che l’uomo stesso vi apporta nel corso del tempo.
La scienza economica è una scienza sia teorica sia pratica (come la medicina o la pedagogia): se la ritenessimo una scienza puramente teorica, una scienza che tratti unicamente leggi inesorabili di funzionamento della natura sulle quali è impossibile intervenire, lasceremmo entrare in tutto e per tutto il determinismo di natura anche nell’area vera e propria delle azioni umane.
Eppure ci sono molti uomini che vedono nell’economia unicamente l’espressione di leggi immutabili di natura: basti pensare al classico Adam Smith e alla sua «legge» fondamentale del mercato che si regola da sé, secondo il meccanismo ferreo della domanda e dell’offerta, un meccanismo che si può conoscere, per regolarsi di conseguenza, ma che non si può mutare. I seguaci di Adam Smith sono oggi più numerosi che mai, spesso senza saperlo.
È importante allora distinguere tra ciò che è fattore di natura e ciò che è fattore di libertà: questa è una distinzione fondamentale, che l’umanità moderna tende però a disconoscere.
Nella natura regnano leggi generalizzabili e prevedibili cosicché Galileo, per esempio, poté calcolare che un sasso con una certa massa, e quindi con un certo peso, cadendo da una certa altezza avrebbe avuto una ben precisa velocità e durata di caduta. Nel regno umano, invece, il fatto sociale si manifesta in modo polarmente opposto, perché in esso entra il fattore evolutivo «uomo» che è solo in parte un fattore di natura e per il resto è fattore di libertà. Ciò che è specifico dell’essere umano è proprio la capacità di libera scelta del suo spirito che interagisce in modi sempre più nuovi con il determinismo di natura.
Qual è la prima cosa da dire sulla libertà? È che la libertà non esiste necessariamente. Altrimenti non sarebbe libera! È assurdo pretendere di dimostrane l’esistenza come se fosse un dato di natura. Ciò vorrebbe dire che la libertà c’è di necessità, e dunque non è libera di non esserci. Questo è il punto fondamentale: la libertà è per natura preteribile, deve poter essere omessa. E quando si omette di esercitarla e in noi restano solo meccanismi di natura è un sofisma poco intelligente l’estrapolare da ciò una teoria a dimostrazione dell’inesistenza della libertà, se non addirittura della sua metafisica impossibilità! Il mistero della libertà risiede invece proprio nella sua possibilità da un lato e nella sua omissibilità dall’altro.
Nel campo dell’economia – per quanto complessi siano i fattori e per quanto in essi giochino anche elementi di natura, e quindi elementi di inesorabilità – l’essere umano può tuttavia immettere la sua libertà; è evidente, però, che, se non lo fa, anche nell’economia restano soltanto i dati deterministici della natura. Quando l’essere umano tralascia di prendere in mano le cose in campo economico, le cose decidono da sé come e dove andare. Ma ciò non dimostra che la libertà non ci sia, bensì che non è stata esercitata. Oppure che è stata esercitata da qualcuno a danno di qualcun altro, che non è stato sufficientemente sveglio.
Il nostro intento vuol essere allora quello di mostrare in quali modi sia possibile inserire nella gestione del denaro, nella produzione delle merci, nella loro circolazione e nel loro consumo l’elemento creativo e specificamente umano della libertà.
Abbiamo detto che la scienza economica è sia teorica sia pratica. Vediamo più concretamente in quali modi essa lo sia:
– è teorica quando ricerca giudizi conoscitivi sul dato di natura con il quale interagisce: se noi vogliamo stabilire il prezzo di una merce dobbiamo riferirci, per esempio, ai dati oggettivi di produzione che dipendono dalle materie prime. La produzione del pane è di tutt’altra natura che la produzione delle automobili o delle scarpe. I processi di produzione sono di volta in volta oggettivamente diversi e vanno analizzati non secondo il criterio della libertà umana ma secondo l’oggettività della natura. La scienza economica è teorica anche rispetto alla prassi passata dell’economia umana perché questa è, di necessità, così com’è stata: ogniqualvolta, perciò, l’economia fa la sua storia entra nelle realtà oggettive e immutabili del già operato, del già prodotto – anche se ai suoi tempi liberamente deciso e operato –, e dunque tratta un materiale sistematizzabile a posteriori;
– l’economia è una scienza pratica, cioè rimessa alla libertà umana, per quanto riguarda il presente e il futuro: lì noi possiamo intervenire in tanti modi ed è allora nostra responsabilità edificare l’avvenire economico o esclusivamente sui determinismi della natura e del passato oppure sulla saggezza della conoscenza e della libera creatività dello spirito umano.
I tre usi del denaro: pagare, prestare, donare
In chiave di economia pratica un primo approccio alla realtà economica può essere quello di considerare i tre grandi usi del denaro che tutti ben conosciamo e che sono: il pagare, il prestare e il donare.
1. Muovo denaro di acquisto ogniqualvolta compro una merce o remunero una prestazione. Desidero qualcosa, ne ho bisogno, qualcuno me la mette a disposizione, io la prendo e la pago. È questo il campo dell’uso e del consumo delle merci vere e proprie. Qui risalta il carattere specificamente economico del denaro.
2. Muovo denaro di prestito quando non desidero avere in cambio una merce, ma voglio che il denaro stesso mi torni indietro maggiorato dagli interessi. Il modo tradizionale per immettere il denaro in questo particolare circolo è quello dei nostri depositi bancari: la banca stessa provvede, poi, a prestarlo e ad accreditarci i corrispondenti interessi.
Nel rapporto di prestito il denaro mostra il suo carattere maggiormente giuridico, di interazione umana in base a diritti e doveri. Quando io presto, stipulo una sorta di contratto sociale: ti concedo il diritto d’uso di questa quantità di denaro a patto che tu accetti il dovere di ridarmela con un preciso interesse al quale io ho diritto alla scadenza fissata. Noi stabiliamo insieme che sarai tu ad utilizzare questo denaro al posto mio a condizione che, nel tempo, tu divida con me i vantaggi dell’uso.
3. Il terzo tipo di impiego del denaro è il denaro di donazione. È un terzo uso oggi purtroppo molto poco in uso! Io dono il denaro quando non ne ho bisogno io stesso e quando mi rendo conto che è nocivo per me e per gli altri non farlo circolare, cioè non metterlo a disposizione di altri. Vedremo come una delle disfunzioni più deleterie dell’economia mondiale attuale non sia il far sorgere il capitale ma sia proprio l’opposto: una enorme quantità di capitali non trova la possibilità di circolare, cioè di venire sempre nuovamente donata, e perciò innesca un micidiale meccanismo di autosfruttamento dell’umanità intera.
Questo è un pensiero cui ora accenno soltanto e sul quale dovremo ritornare: la vera sfida del denaro non consiste nell’accumularlo ma nella capacità di farlo sempre di nuovo circolare. Il denaro esiste per venire usato grazie a un massimo di circolazione reale – come il sangue nell’organismo – e se si accumula è destinato a tiranneggiare l’umanità in modi non sempre chiaramente visibili: anzi, è proprio ai livelli dell’eccessivo concentramento che il denaro esercita più che mai il suo potere di occultarsi, di non mostrare chiaramente il suo volto. Vedremo in seguito che le speculazioni e le transazioni moderne di borsa creano l’inganno di una massima circolazione del denaro, mentre sono nella realtà proprio l’opposto.
La donazione è dunque la libera decisione di non sottrarre il denaro agli altri, di non trattenerlo per sé, di non accumularlo. Vedremo anche come mai questo gesto sia così poco popolare nell’umanità attuale. Io cercherò di mostrare la necessità assoluta del donare il denaro non secondo i canoni della pia esortazione o del comandamento morale, ma argomentando in chiave puramente economica. Deve cioè divenire convincente in senso economico il pensiero che dice: dove manca lo spirito di donazione il denaro ristagna e ingenera malattie sempre più gravi per l’organismo economico e sociale e dunque per noi tutti.
Soltanto se riusciremo a convincerci del fatto che dall’accumulo del denaro risultano gravi danni sociali in base ai quali tutti siamo svantaggiati, ci convinceremo al contempo che è necessario, per ragioni squisitamente economiche, non soltanto usare il denaro per pagare e per prestare ma che occorre anche trovare sempre nuovamente il coraggio di cederlo senza nessuna ipoteca, senza nessuna aspettativa.
La donazione è allora la libera decisione di mettere a disposizione dell’altro il denaro che non mi serve, perché ne faccia ciò che vuole. La mia volontà si compie in questo gesto e non va oltre, altrimenti si tratterebbe di nuovo di un prestito. Quando io dono il denaro l’unica cosa che desidero e ritengo per me importante è di metterlo a disposizione d’altri perché non ne ho bisogno. E voglio al contempo che sia l’altro a decidere sul modo di disporne.
Il concetto che sta ancora più a monte è questo: se ho del denaro e lo trattengo pur non avendone veramente bisogno posso essere sicuro che lo sottraggo ai talenti e ai progetti di altri che ne hanno bisogno. La mancata donazione è sempre il rifiuto di favorire il talento altrui che necessita di capitale per esercitarsi e così immettersi nell’organismo dell’umanità, a vantaggio anche mio.
Se col pagare io esperisco l’umano dal lato dei bisogni e intervengo nella circolazione delle merci comprandole, col donare faccio invece un uso spirituale e culturale del denaro perché favorisco direttamente la vita scientifica, artistica e religiosa: esperisco, alimento e fecondo la qualità dell’umano dal lato dei talenti. Comprando appago i miei bisogni come condizione dell’esercizio dei miei propri talenti; donando appago i bisogni degli altri come condizione dell’esercizio dei loro talenti.
Nella polarità del pagare una merce, perché ne ho bisogno io, e del donare, promuovendo i talenti altrui perché si esprimano e possano così vivificare e arricchire l’umanità, quali sono le scelte libere dello spirito e quali sono le leggi di natura dell’economia?
I determinismi ineluttabili si trovano indubbiamente dal lato dei bisogni: lì non si scappa, quando si deve mangiare si deve mangiare, quando ci si deve vestire ci si deve vestire… L’essere umano sperimenta il suo lato di natura là dove vive i suoi bisogni che esigono di essere appagati secondo una legge di soddisfacimento loro propria: e qui l’economia non è libera, deve rispettare leggi di natura ben precise, che sono anche le leggi della natura umana.
Nello stesso campo economico, però, l’uso del denaro in chiave di donazione crea subito aree di libertà: la scelta stessa del donare è libera, perché nessuno è obbligato a donare. Ognuno di noi «deve» appagare i propri bisogni, ma nessuno «deve» favorire, col donare, i talenti altrui, se non per una decisione libera del suo spirito. Ecco perché la donazione viene spesso omessa: essa non si compie di necessità.
Il riferimento del denaro ai bisogni non può dunque essere libero: i bisogni ci sono sempre, e sono oggettivi, si riaffacciano giorno dopo giorno per pura legge di natura. Il riferimento del denaro ai talenti, invece, essendo un fattore di eminente libertà, può anche essere disatteso. Una delle più grandi malattie dell’economia mondiale attuale è perciò proprio la vistosa assenza dell’uso di donazione del denaro: questa omissione produce ingenti accumuli di denaro paragonabili a una situazione in cui il sangue, invece di circolare, si ingorghi ristagnando in pochi punti dell’organismo.
Il denaro è come il sangue: deve circolare…
Mi limito per ora a fare un breve cenno al paragone tra la circolazione del sangue e la circolazione del denaro, ma è molto interessante approfondire i vari aspetti di questa similitudine: si rimane stupiti di quanto sia feconda! Naturalmente ogni paragone zoppica se non si ravvisano i veri elementi di paragonabilità: perché comunque il denaro non è sangue e il sangue non è denaro. Però, dal punto di vista delle funzioni, nella vita economica il denaro svolge un compito del tutto analogo a quello del sangue nell’organismo fisico.
La caratteristica fondamentale del sangue è che deve circolare sempre senza arrestarsi mai. Il sangue è l’organo di tutti gli organi, è la quintessenza del vitale dentro all’organismo umano: il ritmo respiratorio lo rigenera in continuazione ed esso, a sua volta, opera in tutte le cellule una rivivificazione ininterrotta, costante. Tutti i cibi si trasformano in sangue ed è il sangue ad alimentare tutti gli organi grazie alla sua circolazione incessante, che lo fa arrivare dappertutto. Se il sangue ristagna, l’organismo si ammala.
Se il sangue rappresenta tutte le cose che noi mangiamo perché le sublima tutte, rendendole tutte consone all’organismo umano, qual è, nel mondo economico, l’elemento che rappresenta tutte le cose, l’elemento nel quale noi possiamo trasformare tutte le cose? È il denaro. Tutto si può trasformare in denaro, e il denaro si può ritrasformare in tutte le cose. In questo modo il denaro è il sangue vitale dell’organismo sociale economico e la sua legge fondamentale è la circolazione.
La legge della circolazione del sangue ci indica subito una sua seconda caratteristica fondamentale: l’operare capillare. Ciò vale anche per il denaro: l’intento di farlo circolare al massimo, evitando ogni tipo di accumulo centralizzatore, ha proprio lo scopo di ridargli la sua funzione vivificante a livello del tutto capillare. In altre parole: l’uso sano del denaro si instaura quando ogni singolo individuo – ogni cellula dell’organismo sociale – ne riceve e ne ridà il più possibile. L’opposto di ciò è la tendenza attuale dei grandi poteri monetari di togliere all’individuo ogni possibilità di transazione in contanti.
Argomentazioni teoriche se ne possono trovare a iosa per giustificare tutto ciò che si vuole: in questo caso si dice che tutto diventa più facile, più veloce, più comodo se si abolisce l’uso della moneta reale. Ciò equivarrebbe a dire: sarebbe meglio se tutto il sangue restasse nel cuore, perché così si eviterebbe la macchinosa complessità di tutto ciò che il sangue deve fare in ogni minima cellula dell’organismo. Ma proprio in questo sta la salute dell’organismo! E in questo sta anche la salute dell’economia: nel fatto che ogni cellula, cioè ogni singolo individuo umano, possa esercitare direttamente e in grado sommo la sua libertà nei confronti del denaro. Ciò avviene nelle ripetute scelte libere e quotidiane che si possono esprimere soltanto potendo disporre sempre e immediatamente del denaro liquido.
Stando così le cose, ogni essere umano è libero di assumere l’uno o l’altro dei due possibili atteggiamenti fondamentali nei confronti del denaro e influire così su tutta la vita economica:
– La prima tendenza, possente e atavica tendenza, è quella già accennata ad accumulare il denaro senza ben riflettere che per ammassarlo bisogna sottrarlo agli altri: proprio come fa un organo quando aggruma in sé il sangue privandone gli altri organi. Quando questa tendenza diventa eccessiva, il denaro si trasforma in strumento di potere, di manipolazione e di sfruttamento dell’organismo economico mondiale.
– L’altro atteggiamento fondamentale è la libera decisione di farlo circolare il più possibile: se ognuno di noi fa parte dell’organismo unitario dell’umanità e quindi dell’organismo economico, il denaro deve passare continuamente attraverso di me e attraverso ognuno. L’importante è che nessuno lo fermi mai presso di sé, trattenendolo unicamente per sé. Pensando e agendo così mi libero dalla grande illusione che sia un vantaggio per me possedere il più denaro possibile. È questo un inganno specificamente economico, ma come tutti gli inganni ha il suo risvolto reale, crea oggettivi guasti, anche se spesso a lunga scadenza. Ne dovremo riparlare più a lungo in seguito.
Ciò che massimamente conta in campo economico è dunque l’uno o l’altro atteggiamento interiore di fondo con il quale ognuno di noi si pone di fronte al denaro: esso determina poi la qualità reale di ogni suo uso concreto. La vita economica moderna è infatti molto complessa e potremmo anche chiederci, per esempio, se il cosiddetto denaro di prestito non possa a sua volta diventare una forma di accumulo o se può considerarsi ancora prestito il denaro investito in speculazioni di borsa. Oppure potremmo chiederci se è sempre un sano circolare della liquidità quello che ci induce all’eccessivo consumismo, al comprare, comprare e comprare, che a sua volta è ingenerato dalla produzione illimitata di merci, sorte per soddisfare non certo solo i bisogni veri ma anche una straordinaria varietà di bisogni indotti.
La chiave umana per orientarci in questi meandri della seduzione del denaro è quella dell’atteggiamento fondamentale dell’animo, della mentalità secondo la quale agiamo. Si tratta addirittura, volendoci esprimere in modo spregiudicato, della scelta fondamentale di vita che ogni essere umano deve compiere e difatti compie: o dedicare le proprie energie ad accumulare il più denaro possibile oppure impegnarsi ad accumularne il meno possibile. Infatti vedremo che il non accumulare denaro richiede non meno impegno ed inventiva dell’accumularlo: non stiamo perciò qui perorando la causa della mera povertà o della rinuncia ascetica nei confronti del denaro bensì della necessità e del coraggio di metterlo il più possibile e nel miglior modo possibile a disposizione di tutti.
Questa duplice possibilità di atteggiamento interiore e di scelta fondamentale di vita nei confronti del denaro è a sua volta il risultato di un’altra duplice scelta che ognuno di noi fa, più o meno consapevolmente, e che non investe soltanto l’economia, ma tutta l’esistenza: la scelta tra l’essere per avere oppure l’avere per essere.
Questa formula non vuole essere solo un’astratta generalizzazione. Il modo di vivere di ciascuno di noi si può ricondurre a una posizione di fondo, a un atteggiamento del cuore e della mente, a una struttura interiore grazie alla quale o si è ipnotizzati dal visibile e dal materiale e si interpreta la vita secondo l’avere, secondo una felicità misurata in termini di beni materiali, oppure si ravvisa il senso della vita nel coltivare la qualità interiore dell’umano, cioè l’essere stesso.
Nel secondo caso l’avere è lo strumento preziosissimo e indispensabile dell’essere, ma non è né il senso né il fine della vita. Quando io posseggo le cose perché mi consentono di coltivare la qualità interiore dell’essere – la sua qualità conoscitiva, artistica, religiosa – allora ho in mano un criterio fondamentale per sapere come gestire l’avere stesso. Ho il criterio del sufficiente, del troppo e del troppo poco. Solo colui che coltiva la qualità dell’essere sa in che modo servirsi degli strumenti materiali, perché sa a che cosa servono. L’avere per essere ci dà il criterio giusto dell’avere; l’essere per avere ci dà la morte dell’essere.
La legge del capitale e la legge del lavoro
I due cardini dell’economia moderna sono il capitale e il lavoro. Secondo il comune capitalista la legge basilare del capitale è il profitto. Il capitale ha senso unicamente se è in grado di produrre profitti sempre maggiori. La legge specifica del lavoro, secondo il normale lavoratore, è quella di ottenere un salario sempre più alto. Tutto ciò può apparire evidente e anche sensato: un capitale che frutti sempre di meno e un lavoro che venga pagato sempre peggio sono senza dubbio investimenti di energie umane poco intelligenti.
Ci troviamo qui, allora, di fronte a leggi ferree e deterministiche di natura? Il capitale esiste per incrementare inesorabilmente se stesso e il lavoro per ottenere ad ogni costo salari sempre più alti? Sì e no.
C’è stato nel passato un periodo in cui erano in pieno svolgimento sia il dinamismo del capitale – pensiamo all’ingegno creativo e alle invenzioni dei primi imprenditori – sia il dinamismo del lavoro – pensiamo al ruolo storico dei sindacati –, ambedue spinti da una forza primigenia da pionieri che non era solo di natura economica ma che proveniva da valori tradizionali ben più profondi e da grandi impulsi culturali. Oggi questo slancio interiore viene sempre più a mancare e l’essere umano si fissa sempre maggiormente sul denaro in quanto rappresentante di beni puramente materiali, oppure di benessere astratto o di potere ingenerati dall’accumulo del denaro stesso.
Consideriamo a questo proposito due grandi affermazioni di Karl Marx, che la cosiddetta classe proletaria e operaia dell’ultimo secolo ha fatto proprie, plasmando in base ad esse fino ad oggi la vita sociale:
– la prima dice che lo spirito è ideologia: i valori ideali, culturali e religiosi non sono che futile teoria, mentre la vera realtà è quella dei processi economici veri e propri, cioè della produzione, della distribuzione e del consumo di merci;
– la seconda dice che il lavoro è merce: come tale viene trattato e come tale pagato da quelle classi potenti e privilegiate che credono di poter sfruttare impunemente il sudore dei lavoratori, in nome del loro profitto.
Noi faremmo un grande torto all’umanità moderna se ci limitassimo a considerare queste due affermazioni come l’espressione di verità oggettive. Il loro vero significato è un altro: esse sono l’inconscia accusa morale, carica di profondissima e sofferta delusione, con cui la classe operaia ha sferzato la classe dirigente per aver ridotto lo spirito e gli ideali ad astrazioni avulse dalla vita, senza più nessuna capacità di incidere sulla qualità dell’esistenza, e per aver ridotto il lavoro a merce asservendo l’essere umano che lo compie.
In base a questa duplice disumanità era diventato per esempio possibile parlare di civiltà cristiana e di amore per tutti gli esseri umani in stanze ben riscaldate con il carbone estratto nelle miniere da bambini che vi entravano ancor prima del sorgere del sole e ne uscivano dopo il tramonto. Avendo ridotto lo spirito a ideologia, si è poi ridotto il lavoro a merce, ignorando il lavoratore stesso in quanto spirito umano.
In questa duplice accusa morale vibrano l’amarezza e la ribellione viscerali dell’essere umano che lavora materialmente dalla mattina alla sera e vede gli alti ideali e la cultura di chi detiene il potere ridotti a una alienante astrazione, a una sfacciata ipocrisia di sfruttamento. L’adesione del cuore della classe operaia al marxismo non proveniva dalla volontà di degradare e vanificare lo spirito riducendolo a vuota ideologia. Essa sgorgava invece dal profondissimo se pur inconscio dolore per il fatto che proprio questo fosse accaduto, e che insieme allo spirito fosse stato svilito l’uomo stesso.
Analogamente, la rivendicazione del giusto salario come adeguato pagamento della merce-lavoro gridava nell’interiorità ferita dei lavoratori proprio l’esatto opposto: che cioè la vita sociale mai avrebbe dovuto arrivare a questo, e che il lavoro è così intimamente congiunto con la dignità della persona umana che lo compie da non poter mai e poi mai essere degradato a merce. Il lavoro è sacro come lo è l’uomo che lo compie, e se l’operare umano viene inserito come una merce nel processo economico è l’uomo stesso a ricadere nella schiavitù, nella mercificazione di se stesso.
In questa ribellione tanto più intima e squassante quanto meno conscia, e che sottende alle accuse coscienti e esplicite della classe operaia, ravvisiamo l’aspirazione profonda e tutta umana a che il cosiddetto imprenditore e il cosiddetto lavoratore si riconoscano l’uno accanto all’altro come esseri umani nella loro qualità di coproduttori, con pari dignità e con pari diritti. E lo sono di fatto, perché lavorano insieme in quanto uomini alla stessa produzione. Nella realtà, nella verità delle cose, non esiste un datore di lavoro di fronte a un lavoratore: ci sono due esseri umani che insieme si ingegnano a produrre qualcosa da offrire agli altri.
È vero, d’altra parte, che il compito della vita economica in quanto tale è proprio quello di rendere tutto merce: nel circolo economico sano ogni cosa deve venir trattata come merce, in quanto viene prodotta, messa in circolazione e consumata. Ne consegue che se ci sono delle cose che non devono diventare merce bisogna estrarle dalla sfera economica.
In questo passaggio prima conoscitivo e poi operativo vediamo la fondazione, a partire da un ragionare di natura prettamente economica, della necessità odierna di un profondo e vasto rinnovamento della vita sociale. Si tratta infatti da un lato di liberare il capitale dal suo potere di sfruttamento e dall’altro di liberare il lavoro umano dalla calamità di venire sfruttato dall’economia.
Che cos’è la «triarticolazione» dell’organismo sociale
Con la denominazione di triarticolazione dell’organismo sociale Rudolf Steiner – colui che ha inaugurato una moderna scienza che abbraccia anche l’invisibile – intende una proposta razionale e pratica per un ampio rinnovamento della vita sociale che prende le mosse dal fatto fondamentale che, pur essendo la convivenza umana unitaria e organica, essa si esprime e si articola tuttavia in tre diverse sfere che sono, nelle loro leggi di sano funzionamento, per natura indipendenti l’una dall’altra:
1. la sfera economico-commerciale,
2. la sfera giuridico-statale,
3. la sfera culturale-spirituale.
Queste tre espressioni dell’umano si regolano secondo atteggiamenti interiori e modi di essere del tutto diversi l’uno dall’altro e, pur comunicando fra di loro, esse possono godere buona salute soltanto se vengono evitati snaturamenti che provengono da ingerenze indebite dell’una nei confronti dell’altra. Ognuna di esse deve avere perciò la possibilità di un’autogestione autonoma e indipendente. Ce ne occuperemo più approfonditamente in seguito. Per ora ci basti osservare ciò che segue:
1. ogni realtà, e dunque anche il lavoro, quando viene gestita all’interno della sfera economica non può far altro che diventare una merce, perché l’economia si occupa sempre ed esclusivamente della produzione, del commercio e del consumo di tutti i prodotti (materiali o spirituali) che concorrono al soddisfacimento dei bisogni umani. Se non vogliamo che il lavoro venga trattato come merce dobbiamo inserirlo in una sfera che non abbia a che fare con i parametri dell’economia e non decida secondo leggi economiche.
L’atteggiamento interiore consono a tutti i processi economici è quello della solidarietà e della fratellanza. Ciò non va inteso come comandamento morale – proveniente da una vita culturale ridotta ad alienante ed esangue ideologia – bensì come criterio di salute dell’economia in quanto tale. La divisione del lavoro è il carattere fondamentale dell’economia moderna, e ciò significa al livello dei fatti oggettivi: nessuno può lavorare per se stesso, ognuno deve lavorare per gli altri. L’economia moderna è possibile solo se ognuno lavora per gli altri, cioè grazie a un vero e oggettivo spirito di reciproco aiuto e servizio.
2. La sfera giuridica è la sfera dei diritti e dei doveri inerenti alla persona umana in quanto tale. La giustizia è l’ambito della vita sociale nel quale ci si occupa della pari dignità umana, senza distinzioni tra l’uno e l’altro uomo (di ordine né economico né culturale). Soltanto in questa sede, dove vige assoluta parità di dignità, cioè di diritti e di doveri di tutti verso tutti, possono decidersi in maniera equa le modalità del lavoro, i tempi, le condizioni, le misure di sicurezza e tutela dei lavoratori: e lavoratori siamo noi tutti, l’imprenditore non meno del cosiddetto operaio.
In una sana vita dello Stato non vigono dunque leggi di mercato e non ci si occupa dei fattori di produzione, distribuzione e consumo delle merci. L’attenzione è qui rivolta esclusivamente alla persona umana in quanto tale, qui devono valere unicamente leggi «umane». L’ambito giuridico statale deve allora essere indipendente in modo assoluto dalla sfera economica, deve avere un’amministrazione sua, una competenza deliberativa sua propria, un sistema parlamentare tutto suo.
3. La vita culturale-spirituale, infine, si regge su un terzo principio regolatore fondamentale che differisce essenzialmente sia da quello economico sia da quello giuridico. Nella vita culturale, che abbraccia la scienza, l’arte, la religione, ogni essere umano si esprime diversamente dall’altro, è sovrano e decide per proprio conto: di qui, vedremo, l’importanza dell’indipendenza sia dallo Stato sia dall’economia di ogni pedagogia, di ogni medicina o arte o religione. Una vita spirituale asservita allo Stato oppure alle leggi dell’economia si snatura, perde ogni valore per l’uomo, perché da una parte cade nel livellamento e dall’altra nella corruzione.
Il principio regolatore, l’atteggiamento interiore necessario alla vita spirituale e culturale è quello della libertà individuale. L’atteggiamento della solidarietà in economia e quello della libertà in fatto di autoespressione individuale sono per natura opposti l’uno all’altro: proprio questa sana e necessaria tensione – in base alla quale essi devono tendere a contrastarsi a vicenda – permette la ricerca quotidiana di equilibri sempre nuovi tra la libertà individuale e la solidarietà sociale, tra l’amore di sé e l’amore per gli altri.
Il vero volto del «plusvalore»
Torniamo ora al capitale e al lavoro e consideriamo un’altra affermazione di Karl Marx che tutti conosciamo perché è divenuta storica. Essa dice che nella vita economica è sorto a torto il plusvalore. Il datore di lavoro paga il meno possibile il lavoro dell’operaio, lo compra a basso costo come una merce, e il valore di esubero, cioè il profitto, se lo tiene tutto per sé.
A questo proposito dobbiamo però chiederci: è vero che il plusvalore va tutto a guadagno del capitalista? E per che cosa viene usato? Se lasciamo da parte l’acquisto di beni immobili e di fondi terrieri dei quali ci occuperemo in seguito, il plusvalore viene sostanzialmente investito nella vita culturale, nella ricerca, nell’educazione, nell’assistenza, nella scienza, nell’arte. Tutta la sfera della cultura trae il suo sostentamento economico da ciò che sopravanza dal puro soddisfacimento dei bisogni materiali.
Allora la domanda da porre è un’altra: se è vero che il «plusvalore» rende possibile la vita culturale, l’operaio è in grado di accedervi e di farla sua, oppure gli rimane del tutto estranea? È la vita culturale una realtà che egli sente veramente sua, che davvero gli appartiene? Può realmente il non-capitalista andare a scuola, a teatro, all’università, ai concerti, e sentirsi del tutto a casa sua? Partecipa l’operaio intimamente di quella vita artistica e religiosa alla cui esistenza contribuisce col «plusvalore» prodotto dal suo lavoro? Si sente egli inserito in una cultura sociale consona e corrispondente al suo spirito?
Questi sono interrogativi che valgono anche oggi, sebbene le parole «proletario» o «classe operaia» abbiano modificato il loro significato. Anche nel mondo odierno il normale «salariato» che impiega la sua giornata ad appagare i bisogni primari per poter «campare», vive spesso una certa animosità nei confronti dei «ricchi» che si permettono il lusso della cultura, e ciò perché la vita culturale e artistica gli rimane estranea.
Viene così riconfermato ciò che dicevamo prima sulla vita spirituale diventata ideologia. La cultura moderna è diventata per molti così avulsa dalla vita da far sì che, per esempio, l’esercizio dell’arte sia concepito dai più come un lusso frivolo e inutile, come una specie di superficiale distrazione e di divertimento che non hanno nulla a che fare con la vita reale. Solo chi non ha nulla di meglio da fare va a teatro, e dunque andare a teatro è una divagazione dalla vita reale, non un evento della vita e capace di trasformare la vita. Se ne può fare benissimo a meno.
Molti esseri umani considerano tutt’oggi l’arte e l’insieme della vita culturale e spirituale come una specie di menzogna dell’esistenza, come un privilegio dei ricchi e dei fannulloni a spese di chi lavora. Soltanto chi fa lavorare gli altri per sé, dicono costoro, può pascersi di ideologie e godersi un’arte artificiosa che non incide sulla vita reale. Essi dicono: questo «plusvalore» non è per me. Questa cultura non è mia, non mi interessa perché è staccata dalla vita.
Una cultura che sia davvero per l’essere umano in quanto tale, per tutti gli esseri umani, deve essere dunque un’espressione della vita stessa: deve esserne parte integrante senza instaurare una dicotomia alienante tra l’arte e la vita, tra la scienza e la vita, tra la religione e la vita.
È vero che la vita culturale è passata nell’epoca moderna dalle mani della Chiesa – che l’ha detenuta per tutto il Medioevo – a quelle dello Stato, e dunque ciò dovrebbe garantirne a tutti l’accesso: eppure tante persone pensano che le cose non siano affatto migliorate. Perché? Perché una dirigistica gestione delle faccende culturali da parte dello Stato – basti pensare all’educazione statale – risente inevitabilmente degli scopi dello Stato stesso e dunque è di nuovo avulsa dalla sovranità umana e individuale; quella sovranità che, in un sano organismo sociale, dovrebbe essere l’esperienza primigenia dell’essere umano.
Allo Stato compete di garantire a tutti l’accesso alla cultura, perché la dignità umana non può farne a meno; ma non compete allo Stato la creazione, l’amministrazione e l’esercizio della cultura stessa. Sono gli uomini, il lavoratore in prima linea, che vogliono non solo godere l’arte e la cultura ma plasmarle a immagine del proprio essere e come espressione della propria vita.
Gli insegnanti, che pur nella loro qualità di impiegati statali oggi possiamo ben considerare semplici lavoratori e non certo privilegiati al potere, sono paradossalmente i primi a vivere l’amarezza di una cultura estranea al loro essere ed estraniata dalla loro stessa vita. Il modello educativo è infatti questo: il bambino, il ragazzo, deve essere educato in modo tale da andare bene allo Stato. Come se l’essere umano si incarnasse per adeguarsi allo Stato!
Come si può pensare che l’essere umano scenda sulla Terra per conformarsi allo Stato, per modellarsi su una cultura livellante uguale per tutti e condotta secondo i criteri dell’utile sociale già preordinato? Un utile che risente anche dei fini dell’economia la quale, a sua volta, tracimando nella sfera dello Stato, deve tendere a mercificare anche gli educatori e gli allievi…
Come potranno il bambino e poi il giovane sentire la gioia dell’esistenza, dell’espletamento della loro individuale missione di vita, se questa viene loro tarpata proprio dalla scuola di Stato? E come potranno gli insegnanti muoversi veramente nella sfera libera della cultura se in essa non vigono i talenti e la responsabilità individuale del singolo docente ma le leggi del diritto e dell’economia?
Evoluzione o progresso?
Un elemento importante nel rapporto tra spirito e denaro riguarda la tendenza dell’umanità moderna a confondere fra di loro due concetti che indicano realtà quanto mai diverse: quello di evoluzione e quello di progresso.
La parola «evoluzione» sta a significare che la realtà è sempre in cangiamento, che il cammino umano e cosmico non conosce arresti, ma vive di un incessante dinamismo. Il concetto di evoluzione è perciò neutro, non si occupa di stabilire se le cose vadano meglio o peggio. Dice semplicemente che le cose sono in continuo cambiamento.
Il concetto di «progresso», che indica invece l’andare sempre in avanti, il procedere verso il meglio, è venuto ad indicare un’interpretazione impropria dell’evoluzione: dalla constatazione oggettiva dell’incessante dinamismo evolutivo si è voluto evincere che l’evoluzione come tale debba volgere sempre nella direzione del meglio. Il continuo cambiamento è stato identificato con un cambiamento sempre in meglio.
Nonostante si siano da tempo levate molte voci (anche, e forse soprattutto, in campo scientifico) a dichiarare che l’umanità moderna sta per molti versi evolvendo piuttosto verso il peggio, la mentalità che interpreta l’evoluzione in chiave di progresso è ancora molto diffusa. Ciò dipende dal fatto che noi tutti siamo inseriti profondamente dentro ai meccanismi della tecnologia moderna che diventano sempre più complessi e in un certo senso davvero sempre più «perfezionati»: questa dimensione di «progresso» reale viene allora inconsciamente riferita a tutto l’umano mentre, in onestà conoscitiva, dovrebbe limitarsi tutt’al più all’ambito della tecnica vera e propria. Considerando per esempio il campo dell’ingegneria medica e genetica possiamo dire: le possibilità aperte alla libertà umana «progrediscono» in continuazione; l’uso di questa libertà può però essere sia a favore sia anche a danno dell’essere umano.
Se guardiamo alla totalità dell’essere umano nel suo evolversi, che cos’è che ci impedisce di interpretare a priori l’evoluzione nella prospettiva a senso unico di un progressivo miglioramento? È proprio il fattore della libertà. Se l’evoluzione fosse da intendersi necessariamente come progresso non sarebbe un’evoluzione libera: sarebbe costretta a migliorare sempre. Invece, nella libertà, l’evoluzione umana deve poter andare sia in meglio sia in peggio.
È questo un motivo per diventare pessimisti? No, è l’apprezzamento positivo e ottimistico dell’essere umano libero, è il renderci conto che il buono o il cattivo esercizio della libertà comportano la possibilità di volgere la nostra stessa evoluzione sia in chiave positiva sia in chiave negativa. Di fronte al frenetico «progresso» della scienza e della tecnica l’essere umano deve allora stare sempre più attento per riuscire a individuare quali fattori rappresentino un progresso reale del suo essere in quanto tale e quali fattori, invece, ne rappresentino un regresso.
Per nostra «fortuna» ci sono fenomeni davvero macroscopici – la degradazione dell’ecosistema, per esempio – che cominciano a bussare alle porte della coscienza umana perché essa si renda conto dei limiti dello sfruttamento dei beni della natura e rifletta e capisca che non tutto ciò che è fattibile rappresenta un passo in avanti. Nella libertà esistono anche i passi indietro, e perciò se è possibile il deterioramento della qualità esteriore della vita è possibile, altrettanto, l’involuzione interiore dell’essere umano.
Le tre grandi fasi del materialismo
In questo contesto di evoluzione umana aperta sia al progresso sia al regresso veniamo indotti a riflettere su tre grandi fasi del cosiddetto materialismo, che rappresenta il registro culturale fondamentale del tempo in cui viviamo.
1. La prima fase è stata quella del materialismo teorico, che si è svolta a partire dal secolo diciottesimo e che si è estesa anche all’intero diciannovesimo. Nell’epoca dell’Illuminismo sono state scritte per la prima volta opere in chiave materialistica. Pensiamo a Lamettrie (L’homme machine, L’uomo macchina, 1748) che interpreta l’uomo addirittura come una mera se pur complessissima macchina. Il tratto fondamentale del materialismo teorico è quello di non essere ancora «pratico»: la testa mette in moto una teoria che nega lo spirito, ma il cuore, i sentimenti, le abitudini di vita, le istituzioni sociali, sono ancora intrisi di tanti altri elementi culturali che la contraddicono e le fanno da contrappeso. Fin verso la fine del diciannovesimo secolo soltanto i pensieri erano imbevuti di materialismo: la vita reale era ancora piena di religione, di arte, di valori morali tradizionali, di riferimento istintivo al non materiale.
2. Nella sua seconda fase il materialismo diventa più radicale, proprio perché i pensieri non sono aria fritta e nel tempo modificano la realtà: abbiamo perciò nel ventesimo secolo, come inevitabile conseguenza del materialismo teorico, il materialismo pratico. La vita stessa diventa ora materialistica: il cuore quasi si svuota di ogni realtà che non sia materiale e l’essere umano si ritrova a sperimentare ed amare quasi esclusivamente ciò che è visibile, fino a coincidere con esso. L’esperienza del corpo diventa sempre più preponderante e l’uomo comincia a chiedersi: che cosa possono mai essere quest’anima e questo spirito, dei quali si è sempre parlato, se ciò che nasce, vive e muore è il mio corpo e nient’altro? Come può un’anima essere immortale se è in tutto e per tutto dipendente da un corpo che perisce?
Il materialismo teorico decretava che la materia è la sola vera realtà e che lo spirito e l’anima non esistono, se non come funzioni della materia: al contempo però il sentimento degli uomini parlava un altro linguaggio. Il materialismo pratico si instaura invece quando l’animo stesso perde la capacità di esperire tutto ciò che non è materiale. Non si tratta più di una teoria che nega in linea di principio lo spirito: ora è l’uomo a perderne davvero l’esperienza reale.
Questo materialismo pratico ci ha portato il parallelismo classico che tutti conosciamo, e che è sorto soprattutto nel ventesimo secolo: la schizofrenia culturale cui ho accennato, che pone da una parte la prassi, la vita reale senza spirito e senza anima, e dall’altra pone lo spirito, per chi ci vuole ancora credere, senza alcuna realtà di vita e di prassi sociale.
3. Quale dovrà essere, allora, la terza grande fase del materialismo, nel ventunesimo secolo? Molti forse penseranno che la terza fase debba consistere nel superamento del materialismo. Ciò è giusto, ma non va inteso nel senso di una pura e semplice abolizione del materialismo. La terza fase dovrà essere, e vogliamo che sia, paradossalmente, un materialismo spiritualizzato.
La spiritualità riconquistata, per essere a misura d’uomo, non deve perdere di vista il mondo della materia, non deve abbandonarlo o rifiutarlo. Deve restare in un sano materialismo; che sarà allora un materialismo spiritualizzato! Parlare di un semplice superamento del materialismo potrebbe infatti indurre a fraintendimenti, potrebbe trarci in inganno come se si trattasse di abbandonare il mondo della materia per volarcene in mondi puramente spirituali. La terza fase dev’essere invece quella in cui l’incontro con l’elemento materiale diviene al contempo l’esperienza diretta dello spirito. Uno spirito dunque non più disincarnato, ma incarnato, capace di esperire sé in tutte le condizioni materiali della Terra.
Per questo tipo di «materialismo spirituale», nel senso di spiritualità incarnata, vedremo che la vita economica e l’uso del denaro assumono una decisiva importanza: in questa prospettiva essi diventano lo strumento di incarnazione dello spirito umano dentro alla realtà della materia e vengono così a rappresentare tutto ciò che noi possiamo compiere in questo mondo nel quale siamo entrati con la nostra nascita.
Secondo capitolo
DA UN’ECONOMIA DI DENARO
A UN’ECONOMIA DI FIDUCIA NELL’UMANO
Capitalismo, comunismo e la terza via
Il denaro è come una spada a doppio taglio: quale strumento della libertà umana esso può venire usato in due direzioni diverse. Da un lato esso rappresenta tutte le cose materiali che si possono acquistare e dall’altro rappresenta anche tutto ciò che fa parte del nostro essere interiore: il capitale umano in quanto patrimonio dei talenti dell’umanità intera, l’immensa riserva di potenzialità e di ideali evolutivi che gli individui umani albergano dentro di sé.
Consideriamo i due modelli fondamentali di economia invalsi nell’umanità moderna e che tutti conosciamo: il modello capitalista e il modello comunista. Ognuno di noi li vive sotto i più diversi aspetti, ma qui è importante considerarli nella loro dimensione prettamente economica per vedere se questi due modi di affrontare l’esistenza sappiano cogliere l’interezza delle esigenze economiche nel contesto globale della vita sociale.
Ambedue i modelli si riferiscono indubbiamente a valori insindacabili dell’umano: in questo senso sia il capitalismo sia il comunismo intendono favorire, anche se in modo polare e unilaterale, aspetti sostanzialmente buoni e positivi del cammino economico moderno.
L’attenzione va rivolta, allora, piuttosto alle rispettive unilateralità e alla vicendevole esclusione che essi operano l’uno nei confronti dell’altro, divenendo, così, due ideologie nonché due «strategie» sociali. E le strategie, si sa, procedono in negativo perché implicano sempre una volontà di agonismo, di lotta, nei confronti di tutte le altre metodiche che appaiano come soluzioni tattiche opposte.
C’è da chiedersi, allora, se esista una terza via, una via di mediazione, dove le due posizioni del capitalismo e del comunismo non riverberino più antagonisticamente l’una sull’altra eliminandosi a vicenda, ma possano mettere a disposizione dell’umanità tutti i valori positivi di entrambe.
Qualora si miri a una sintesi che armonizzi il positivo di tutte e due le parti, le cose diventano più difficili, e la difficoltà spesso scoraggia l’essere umano. È molto più facile, infatti, considerare soltanto i valori della libertà individuale, dell’intraprendenza e dell’ingegno dei singoli, come fa il capitalismo, trascurando i valori della fratellanza e della solidarietà – che sono visti come un impaccio, un elemento di ritardo che favorisce l’inettitudine –; ed è altresì, all’opposto, più facile avere di mira esclusivamente l’intreccio solidale della comunità umana, come fa il comunismo, disattendendo la forza primigenia dei talenti individuali e tarpando le ali all’intraprendenza dei singoli – che è vista come una fonte pericolosa di sopruso sociale e di prepotenza.
In altre parole essere unilaterali è più facile perché è più comodo: basta lasciarsi andare sempre in una sola direzione e si diventa unilaterali, si abbandonano, cioè, i propri pensieri, le proprie azioni e i propri sentimenti all’inerzia fatta degli automatismi e dei risucchi che si generano da qualsiasi prospettiva a cuneo. Per non essere unilaterali bisogna invece attivare la sempre aperta disamina conoscitiva e fare appello alle forze volitive della libertà che spazia nel vasto e complicato panorama dell’umano, perché lo ama tutto. Se l’unilateralità procede a senso unico e diviene presto monotona e automatica, la versatilità tiene svegli e non consente automatismi.
La sintesi degli opposti, la coincidentia oppositorum, non viene dunque mai da sé e non è nemmeno il risultato di una cucitura che si limiti ad affiancare le polarità lasciandole immutate, perché allora il cozzo sarebbe ancora più disumano della dicotomia. La forza della vera mediazione, la ricerca di sempre nuovi equilibri, è tutta nell’esercizio umano della libertà, il solo gesto di pienezza capace di ritrovare e di ricostruire l’Umano che è stato smembrato e disperso nelle profondità della Natura e nelle vastità del Cosmo.
In chiave di enunciazione programmatica, e non di ingenua semplificazione, si potrebbe allora dire che il grande compito della libertà è quello di operare sintesi sempre nuove tra il valore positivo del capitalismo, che rappresenta l’imprescindibile emergenza creatrice e audace dell’individuo – e che da solo porta però a una sorta di libertarismo egoistico, senza amore –, e il valore positivo del comunismo, che rappresenta la necessaria solidarietà dell’essere gli uni per gli altri – ma che da solo fa sorgere una sorta di totalitarismo collettivo, senza libertà individuale.
Creare e ricreare sempre nuovamente una sintesi armonica tra questi due poli dell’esistenza, grazie alla quale la libertà individuale non si volga contro la fratellanza, ma anzi la favorisca, la approfondisca e la renda sempre più salda, e grazie alla quale la fratellanza e la solidarietà non si volgano contro la libertà individuale, ma anzi la promuovano, la approfondiscano e la rendano sempre più calda: questo è il grande compito conoscitivo e operativo della libertà umana moderna anche in campo economico. Se noi omettiamo questo squisito e vasto esercizio dell’umano, le leggi ferree dell’economia, quelle che si muovono da sole come forze di natura e senza una vera impronta umana, continueranno a portarci inesorabilmente o verso il capitalismo o verso il comunismo nella loro disumana unilateralità.
Sotto questa luce è importante considerare il fatto che, dopo il cosiddetto crollo del comunismo e la conseguente caduta del muro di Berlino e della cortina di ferro, è improprio dire che il capitalismo abbia vinto: dovremo ancora vedere se non si tratti piuttosto di una vittoria di Pirro.
Che il comunismo abbia in parte palesato la rovina e l’insostenibilità dei suoi limiti, certo lo possiamo affermare: ma il crollo del comunismo non è di per sé la vittoria del capitalismo. Non perché abbiamo visto le deleterie conseguenze dell’unilateralità dell’uno possiamo illuderci di aver dimostrato la bontà assoluta dell’altro. E forse il grande risveglio che attende la nostra umanità, all’inizio del nuovo millennio, sarà proprio quello di rendersi conto a ben più largo raggio dei difetti intrinseci, non meno gravi, del capitalismo.
Chi regge le sorti dell’economia e del sociale?
Poiché per la migliore comprensione di ogni singolo fenomeno umano è importante sempre considerare il contesto più ampio dell’evoluzione storica, chiediamoci quali siano stati lungo la storia i fattori guida in campo economico. Ciò sarà utile per approfondire ulteriormente il dinamismo insito nelle due grandi proposte di convivenza umana, il capitalismo e il comunismo, di cui ci stiamo occupando.
Possiamo individuare, a questo proposito, cinque fasi caratteristiche:
1. Fino al periodo della Riforma protestante, cioè fino al quattordicesimo-quindicesimo secolo, l’elemento conduttore dell’economia veniva ricercato nella vita spirituale: il sacerdote, oltre che il re, quale rappresentante del divino nell’umanità, decideva anche delle sorti dell’economia comunicando dall’alto gli orientamenti e la prassi per affrontare ogni esigenza legata ai bisogni della popolazione.
2. A partire dalla Riforma e fino al diciannovesimo secolo, divenne l’economo il reggitore dei fattori economici. La gestione specificamente economica delle faccende sociali ebbe modo di affrancarsi dalla vita spirituale: l’economo era ora un essere umano che non si rifaceva più ai precetti divini per l’attuazione della giustizia distributiva e commutativa fra gli uomini, ma cominciava a prendere decisioni attenendosi alle leggi proprie della vita economica e ad agire in base ad esse.
3. Nel diciannovesimo secolo è subentrato alla guida dell’economia il banchiere: in particolare tutta la storia dell’Ottocento è segnata dal sorgere dei grandi centri bancari. Il banchiere è in fondo un vero e proprio usuraio, nel senso neutro della parola: è colui che si fa ripagare l’uso del denaro. Un banchiere senza usura non potrebbe essere un banchiere.
In questo processo di progressiva emergenza del denaro, che viene ad occupare un posto sempre più centrale nell’economia, non siamo ancora alla realtà vera e propria del deposito bancario moderno, dove i rapporti interpersonali sono pressoché scomparsi: storicamente siamo ancora in una fase che pone in primo piano l’individualità concreta del banchiere stesso e le sue doti personali specifiche nel decidere sugli orientamenti del denaro.
Pensiamo al gustoso episodio di Rothschild, banchiere a Parigi, che, durante un’interessante trattativa con un commerciante di pellami, riceve un giorno la visita del ministro delle finanze del re di Francia. Il ministro crede di essere così importante da dover immediatamente entrare nella stanza di Rothschild, senza fare anticamera. Si fa quindi annunciare dall’usciere più volte, senza però ottenere successo. Alle insistenze dell’allibito ministro, Rothschild manda a dire, sempre tramite l’usciere, che il nobiluomo prenda una sedia come tutti gli altri e si accomodi nell’attesa. A questo punto il ministro irrompe nella stanza ed esclama: «Ma io sono il ministro del re di Francia!»; e Rothschild: «Allora prenda pure due sedie!».
4. Già pochi decenni più tardi non è più il banchiere la figura di spicco in grado di avere uno sguardo d’insieme e di decidere sul giro del denaro, ma è il denaro stesso, il denaro impersonale, a operare. Soprattutto con il sorgere delle società per azioni, il banchiere viene ridotto a un puro osservatore, a un registratore dei fenomeni di transazione. L’essere umano in quanto tale perde sempre di più la sua possibilità reale di gestire e seguire direttamente le dinamiche del denaro. Un denaro che si sposta senza nomi di riferimento comincia a diventare il signore dell’uomo, il reggitore occulto dell’economia. Nasce qui la reale biforcazione tra il modello comunista e quello capitalista.
5. Oggi siamo a un altro livello ancora: il denaro stesso è diventato sempre più paurosamente astratto. Così come prima era diventato aleatorio il riferimento all’essere umano reale, negli ultimi decenni si è fatto sempre più aleatorio e volatile il riferimento al denaro reale, alla valuta reale – che a sua volta dovrebbe riferirsi a beni reali, cioè di natura – soprattutto in base alle speculazioni di borsa, alle transazioni di tipo derivato, alle operazioni a rischio tramite i calcoli di probabilità e di previsione statistica sui guadagni o le perdite, tramite la fiducia o la sfiducia nelle ipotetiche direzioni di investimento degli esseri umani, dei governi, delle alleanze: tutto al livello della scommessa. Non è più il denaro concreto che si sposta da una parte all’altra del globo, ma una specie di registrazione computerizzata di fantomatiche e possibilistiche decisioni o intese, di reali o possibili decennali intrighi, sui quali è solo possibile «speculare». Il denaro è divenuto il puro strumento astratto della speculazione pura operata dallo spirito umano.
Sono sempre più numerosi gli Stati che fino a ieri – come nel caso del Sud-Est asiatico – si ritenevano sovrani in fatto di economia «nazionale» e che fanno dall’oggi al domani l’esperienza agghiacciante di essere in tutto e per tutto alla mercé del fantomatico FMI (Fondo Monetario Internazionale) le cui decisioni sono dettate da poteri talmente «occulti» da restare proprio del tutto invisibili, non meno dello spirituale puro!
Per il denaro è tempo di un’inversione di marcia
Se dunque il denaro col sorgere di una economia globale ha raggiunto un livello di astrazione tale che il suo riferimento diretto non è più la realtà oggettiva esterna, bensì unicamente i reali o possibili pensieri – le «speculazioni» – degli esseri umani stessi, diviene necessario invertire questa marcia: proprio perché il denaro non rappresenta più nulla di oggettivo e reale, è ora compito dell’uomo riprenderlo in mano e condurlo secondo realtà e libertà. E proprio perché il modo di operare del denaro diviene sempre di più «irreale» e irrazionale, indipendente da ogni realtà oggettiva tangibile, l’essere umano acquista paradossalmente il massimo di possibilità di afferrarlo con il suo spirito.
L’opportunità di orientare il denaro a partire dallo spirito umano non è mai stata così reale come nel nostro tempo, appunto perché il denaro ha perso quasi ogni possibilità di riferimento al dato naturale di ordine oggettivo, e dunque non libero. Soltanto con questo sforzo conoscitivo, rimesso totalmente all’uomo, è possibile invertire la direzione deterministica delle sorti del denaro, che se non viene padroneggiato dallo spirito umano ne diviene sempre di più il disumano e arbitrario padrone.
Così possiamo dire: il tempo della tirannia del denaro è compiuto. Il denaro si è del tutto svincolato dal riferimento coatto alla natura, si è distaccato da ogni processo normativo che sia cogente rispetto all’uso che se ne fa, e perciò diviene sempre più afferrabile e gestibile da parte dello spirito umano in quanto tale. Di fronte a processi di borsa che divengono sempre più impersonali e astratti – sempre più disumani – il singolo individuo è chiamato a riscoprire la sua possibilità reale, diretta e personalissima, di intervenire e di incidere. Viene rimesso infatti del tutto e per tutto alla sua decisione libera e individuale se investire il suo poco o il suo molto denaro in azioni – sfruttando così il suo proprio organismo umano – o se farlo circolare capillarmente grazie soprattutto allo spirito di donazione.
Il padrone dell’economia mondiale non è più il denaro, ma la speculazione, cioè lo spirito umano. Questo spirito è libero: può esprimersi in chiave di egoismo – quando la speculazione tende solo a sfruttare gli altri – e può esprimersi in chiave di amore – quando si comprende che chi danneggia gli altri danneggia prima o poi anche se stesso.
L’ossessione assicurativa dell’uomo insicuro
Sul retroscena di queste brevi considerazioni di tipo storico evolutivo, vorrei fare alcune osservazioni su ciò che chiamerei «l’ossessione assicurativa » dell’uomo d’oggi, cioè sulla mentalità di assicurazione e del cosiddetto «risparmio».
Conosciamo bene il tipo di ragionamento che sottostà a queste scelte: devo assicurarmi la pensione per la vecchiaia – non so nemmeno se diventerò vecchio, ma non importa! –; devo assicurarmi la vita – così, se vado all’altro mondo, che almeno paghino qualcosa! –; poi devo assicurarmi contro le malattie, l’incendio, il furto, gli incidenti, la grandine, la peronospora… Così vivo al sicuro!
Che cosa denota questa mentalità del programmarsi un futuro in tutto e per tutto protetto e sicuro? Denota un’insicurezza interiore assoluta. Una persona che sia già interiormente sicura non ha bisogno di mettersi al sicuro! Il progetto assicurativo che va sempre più consolidandosi nella società moderna è quanto mai sintomatico e fa il paio col raccomandarsi l’anima a Dio osservando i comandamenti: infatti, mentre papà Stato, o chi per lui, ci assicura in vita fino alla morte, mamma Chiesa provvede ad «assicurarci» l’anima dopo la morte. Il bravo cittadino così può dire: io sono assicurato in vita e in morte, non mi manca nulla e allora mi siedo e mi godo la vita – sicura!
Questo atteggiamento interiore è però del tutto passivo. In esso manca il dinamismo, manca la gioia della creatività. Esso palesa la profonda paura dell’uomo moderno, la sua totale sfiducia nei confronti dell’esistenza stessa. Dobbiamo allora comprendere quali meccanismi lavorino oltre la nostra coscienza, fin dove arrivi realmente la ragionevolezza delle nostre preoccupazioni e dove si inneschi, invece, una mortificazione dell’umano in noi. Del tutto irrazionale e astratto è divenuto, abbiamo detto, l’operare del denaro: non meno irrazionale e astratta è divenuta la paura e l’insicurezza che vuol tutto «assicurare».
L’ossessione di assicurarsi il futuro comporta infatti il proibirsi di vivere pienamente nel presente. Abbiamo paura di quello che ci aspetta e così omettiamo l’esperienza della pienezza nel presente, la sola in grado di costruire un futuro non alienato, non affidato al caso.
Non intendo certo dire che si debba cadere nell’altro estremo della leggerezza, del vivere alla giornata senza minimamente occuparci del domani, senza sapere se avremo o no un paio di Euro in tasca per comprarci da mangiare. Intendo dire che il modo migliore per garantirci il futuro è vivere a piene mani il presente, perché il futuro lo potremo vivere solo quando sarà presente. L’unica realtà del futuro è sempre il presente: l’essere umano lo tocca e lo vive soltanto nella dimensione presente del tempo.
Per nessuno di noi, inoltre, il futuro potrà mai essere sostanzialmente migliore del presente, né possiamo pensare noi stessi (se non fantasticando) migliori nel futuro se non lo diventiamo adesso, nell’oggi. In altre parole, io mi posso ripromettere di essere migliore nel futuro soltanto divenendolo nel presente, cioè cominciando ad esserlo qui ed ora. Il presente è a mia diretta disposizione in tutta la sua pienezza e concretezza, non il futuro.
Ritornando alle riflessioni sull’assicurazione dell’anima grazie alla Chiesa: può accadere che qualcuno viva tutta una vita da povero diavolo per poi guadagnarsi il paradiso. Immaginiamo una persona che trascorra magari i suoi giorni castigandosi e mortificandosi: vive un «inferno» in questa vita nella speranza di ritrovarsi in paradiso nell’altra.
Costui vive in una grossa illusione. Se egli non fa l’esperienza del paradiso ora, su questa Terra, è e rimane un essere strutturalmente «incapace di paradiso» anche dopo la morte. Il «paradiso» può essere unicamente uno stato o stadio di coscienza: la realtà vera in senso più profondo, quella che ognuno di noi realmente vive, è sempre e soltanto il suo stato di coscienza. Se io passo tutta una vita nelle «privazioni dell’inferno» sono capace soltanto di inferno, perché non ho esercitato e vissuto altro. L’unico modo di vivere un paradiso dopo la morte è di essere io stesso paradiso nella vita. O lo esperisco io stesso, adesso, il paradiso, oppure come farò all’improvviso a ritrovarmi affine a una realtà paradisiaca che mi è stata sempre del tutto estranea?
Paradiso e inferno sono dunque due modi fondamentali di autoesperienza umana. Che cosa ha, l’essere umano, oltre all’autoesperienza? Nulla. In essa è compreso tutto, anche il modo di porsi in relazione con il mondo: il mondo viene recepito dentro all’essere umano soltanto nella misura in cui egli riesce a trasformarlo in autoesperienza, assimilandolo a sé in quanto spirito.
Il coraggio e la gioia del vivere quotidiano, allora, scalzano le radici psicologiche più profonde della mentalità assicurativa, tutte innestate nella paura. E proprio occupandoci di denaro non dobbiamo sottovalutare il ruolo che gioca la paura nell’economia mondiale di oggi.
Come si genera la fiducia nell’umano?
Eppure la paura non è un fenomeno primigenio nell’interiorità umana; essa trae alimento da un atteggiamento dell’anima ancora più profondo: la mancanza di fiducia nell’umano. Questa è la vera malattia originaria – il vero peccato originale – che impedisce all’uomo di cogliere e vivere la positività assoluta del proprio essere. Di qui la paura generale nei confronti della vita e come conseguenza l’ossessione dell’assicurarsi che fa del denaro accumulato uno scudo, un appiglio, uno baluardo di roccia che deve stare lì ben fermo ad attenderci, sostenerci e difenderci.
C’è un nesso diretto come di causa e effetto tra il sorgere della mentalità assicurativa e l’immobilizzazione dei capitali a livello mondiale: ognuno di noi, a grado a grado e giorno dopo giorno, tende a portar via all’altro sempre più sicurezza per assicurare se stesso, e così diventiamo tutti sempre più insicuri. Siamo immersi tutti in un progetto globale di precarietà generata e alimentata vicendevolmente che depaupera e fa degenerare fino alla paralisi tutte le forze positive dell’organismo sociale e del metabolismo economico.
Paragoniamo questa mentalità di sfiducia che conosciamo bene – e che è anche molto comprensibile – con alcune frasi del Vangelo che risuonano nell’umanità cristiana occidentale, bene o male, da duemila anni: «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il vostro Padre dei cieli li nutre. Or non valete voi più di loro? […] Guardate come crescono i gigli del campo: non lavorano né filano, eppure vi assicuro che nemmeno Salomone, in tutta la sua gloria, fu mai vestito come uno di loro. […] Non vogliate dunque angustiarvi dicendo: che cosa mangeremo? che cosa berremo? di che ci vestiremo? Di tutte queste cose, infatti, si danno premura i pagani; ora, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutto questo. Cercate allora prima di tutto il regno dei cieli e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù» (Mt 6, 26-33).
C’è chi ha commentato questo passo ravvisandovi l’espressione di una mentalità ingenua e irresponsabile. Ma queste parole vanno capite nel modo giusto. Il Cristo non afferma che non ci debba essere nessuno a curarsi degli uccelli del cielo e dei gigli del campo: dice invece che esiste un Padre dei cieli e che è lui a ben occuparsene. Se a quegli uccelli del cielo venisse meno l’aria, per esempio, non potrebbero più volare, e se ai gigli venisse meno la terra non potrebbero più crescere. Perciò il Padre dei cieli dà loro sia l’aria sia la terra.
Il Cristo intende allora dire che come il regno animale e il regno vegetale vivono della fiducia cosmica nel Padre dei cieli – che è ben fondata perché questo Padre c’è –, anche se in loro è inconscia e istintiva, così l’essere umano è chiamato ad avere questa stessa fiducia in modo consapevole ma non meno fondato.
E su che cosa può fondarsi una fiducia che spazzi via la paura e l’eccessiva preoccupazione per il domani? Sulla consapevolezza non ingenua, non utopica, ma fondata sul reale, che ciascuno di noi è un essere spirituale reale che alberga in sé un mondo di talenti, di energie positive, di capacità vere, di intenti e ideali evolutivi che sono proprio come la terra che sostiene i gigli e come l’aria che trasporta gli uccelli. Essi parlano il linguaggio delle messi rigogliose e non della carestia, della sovrabbondanza e non della privazione, della creatività e non dell’abbandono. Questo è il «regno» dei cieli: la ricchezza «regale» dell’essere umano sulla Terra!
Se guardiamo a tutte le risorse positive dell’umanità, alla ricchezza insita in ogni Io umano, non abbiamo ragione alcuna di aver paura e non abbiamo bisogno di assicurarci il futuro trascurando o rovinando il presente. Un essere umano che riesca a vivere la pienezza del presente, non la esperirà come effimera, ma come sostanziata di eternità. Un uomo che eserciti oggi la capacità di pensare, di orientarsi, di prendere decisioni, di afferrare le sorti della sua vita e di amare tutte le creature, potrà mai domani veder sparire tanta dovizia? No: domani essa sarà ancora più vasta e bella e vera. Chi ha creato l’essere umano lo ha creato in modo tale da assicurargli in partenza un futuro tutto positivo senza fine. Basta che ogni giorno egli trasformi la paura in fiducia.
Il grande futuro economico dell’umanità può essere allora unicamente la vittoria sulla paura e sulla mentalità assicurativa, che è una specie di surrogato fittizio, preso dal di fuori, per ciò che manca ancora dentro. Quando la saldezza reale dell’individuo e la sovrabbondanza di positività dell’umano vengono realmente vissuti, non c’è più alcun bisogno di succedanei fallaci. Ci si libera dall’illusione di mettere al sicuro sé togliendo la sicurezza agli altri.
Dal punto di vista spirituale potremmo esprimere questo cammino con un’altra immagine ancora: il sorgere della fiducia nel karma, nel destino vero e proprio dell’uomo. Posta in termini prettamente economici la grande domanda è questa: come si fa a generare in campo economico la fiducia nell’umano? Qui non basta dire: tu devi aver fiducia nella positività dell’essere umano. Se ci fermassimo a questa enunciazione avremmo fatto una bella predica, avremmo formulato un altro comandamento morale. E ciò non servirebbe a nulla.
Dire «devi aver fiducia» è come dire a una stufa: «cara stufa, è tuo dovere scaldare questa stanza», senza provvedere a mettervi dentro il carbone o la legna! Si tratta qui di mettere in atto processi economici concreti che siano in grado di generare in modo reale le forze della fiducia, una volta che il nostro sforzo conoscitivo sia giunto a riconoscerne l’importanza sociale.
Se smettiamo di predicare la fiducia e ci occupiamo invece delle opere da compiere per farla realmente sorgere appare subito evidente che la fiducia reale nell’umano non si crea dall’oggi al domani e che, anzi, proprio in ciò consiste l’illusione del predicare. Chi predica ritiene implicitamente che tra il dire e il fare non ci sia di mezzo il mare, ma che basti dire per fare. E invece non è così.
La fiducia nell’umano è un atteggiamento che risulta dalla decisione ferma e amante di coltivare quotidianamente tutto ciò che è umano. Si tratta di una lunga gestazione che si compie giorno dopo giorno. È una questione di esercizio e di impegno continui. È un quotidiano lavoro su di sé, che solo ciascuno può compiere e ciascuno solo su se stesso.
L’educazione, per esempio, è in questo contesto di fondamentale importanza. La parola «educare» è bellissima: e-ducere vuol dire «tirare fuori». E che cosa si può trar fuori se non ciò che è già dentro?! Così faceva anche Socrate, che si riteneva né più e né meno di una levatrice. I bambini anelano a una scuola che si fondi proprio sulla fiducia nell’umano; cercano maestri consapevoli del fatto che ogni facoltà reale è già immanente nell’essere, è già potenzialmente presente nel bambino stesso e attende soltanto di sprigionarsi e di tradursi in atto tramite la cura pedagogica di adulti che conoscono questa verità. Se i bambini non trovano un maestro che li sappia educare e condurre alla propria piena fioritura, alla libera espansione del proprio essere stesso, se tutto questo non accade sarà difficile che da adulti essi possano conquistare quella fiducia nell’umano, e cioè in se stessi e negli altri, alla quale non sono stati educati.
La fiducia nell’umano è il progetto educativo per eccellenza. Ogni essere umano porta in sé, anche se ancora inconscia o inespressa, la pienezza della sua natura del tutto unica e individuale, e in essa ripone un’immensa fiducia nel momento in ci si incarna, lasciando i mondi spirituali. Se l’educatore non ha coscienza di questa premessa dell’esistenza, non avrà motivo di entusiasmarsi di fronte al compito di coltivare e lasciare germogliare e fiorire quella fiducia nell’umano, che il suo allievo porta già in sé come un seme.
E se in età adulta non si ha più fiducia nell’umano di quanta ne sia stata non «inculcata» ma «evocata» grazie all’educazione, come si potrà porre rimedio alle carenze di una pedagogia inadeguata? Ricorrendo all’autoeducazione! L’autoeducazione è il lavoro che giorno dopo giorno si fa su se stessi, è un cammino interiore, un esercizio quotidiano di iniziazione individuale. Per il bambino occorre l’educazione, per l’età matura l’autoeducazione: libera, costante e autocondotta. L’autoeducazione è il quotidiano e beatificante esercizio della fiducia nell’umano. È la terapia più vasta ed efficace che vi sia, e perciò non è la più facile.
Per l’adulto che voglia sempre nuovamente riconquistare e coltivare la fiducia nell’umano esistono due strumenti fondamentali:
1. il primo è il cammino del pensiero che comprende non solo lo studio del mondo visibile, ma anche l’approfondimento conoscitivo dei mondi spirituali. Questo cammino è un continuo esercizio della facoltà vivente e creativa del pensare stesso, atto più di ogni cosa a darci fiducia nello spirito umano. L’umanità moderna ha vissuto la positività dello spirito umano nella sua capacità di esplorare il mondo visibile. L’umanità postmoderna vuole scoprire la seconda grande positività dello spirito umano: la sua capacità di scandagliare sempre più a fondo i regni dell’invisibile. L’esercizio di questa «positività» è in grado di ingenerare una fiducia nell’umano che non conosce limiti;
2. il secondo straordinario strumento dell’autoeducazione consta di esercizi di purificazione interiore, soprattutto quelli che curano la qualità del pensiero o dell’attenzione, l’esercizio della volontà o dell’intenzione, l’esercizio del sentimento o della distensione e dell’equanimità; gli esercizi della positività, dell’apertura o della spregiudicatezza, dell’armonia e della calma interiore. Questi esercizi, calati metodicamente nel quotidiano e rimessi alla libera volontà individuale di praticarli, sono la via più diretta per riedificare sempre nuovamente la fiducia nell’umano.
La fiducia è perciò l’intimo convincimento, acquisito a ragion veduta e sempre di nuovo riconquistato, che la persona umana dà oggettivamente affidamento in senso assoluto. E io chiedo: se non è la persona umana, intesa quale luogo di convergenza microcosmico di infinite energie evolutive, a darci affidamento, chi o che cosa mai ce lo potrà veramente dare? L’essere umano è davvero uno scrigno di positività assoluta, di potenzialità evolutive senza fine. Il vivere gli uni per gli altri ci riempie di fiducia e ci fa vincere la paura.
Lo spirito di libertà nella vita culturale
Abbiamo già accennato allo spirito di uguaglianza, di parità, che deve informare la vita giuridica, e allo spirito di fratellanza o solidarietà che vuol fare della vita economica un ambito di rapporti umani tutti fondati sul reciproco aiuto.
Consideriamo ora più da vicino lo spirito di libertà che rende autenticamente umana la vita culturale, artistica e religiosa. Cercherò in seguito di mettere in relazione lo spirito di libertà con lo spirito di donazione – che è il suo riverbero in chiave di economia –, tutto ciò nel contesto di quanto abbiamo detto circa l’importanza del riconquistare la fiducia nell’umano per superare la mentalità mortificante dell’assicurazione.
Ci siamo detti che non basta chiedere che cosa debba imparare o saper fare l’uomo a servizio dell’ordine sociale già esistente, bensì che cosa egli porti in sé come seme per il futuro e che cosa possa venire sviluppato a partire dal suo stesso essere. L’uomo non nasce solo per servire l’ordine già esistente ma per arricchirlo e fecondarlo di tutte le cose nuove che egli alberga nel proprio essere.
L’ordine costituito è la base, il fondamento per ciò che di nuovo ogni essere umano viene a portare sulla Terra. La mentalità oggi comune pensa invece il contrario: che l’essere umano debba essere educato a servire l’esistente. È una mentalità del tutto unilaterale e conservatrice, questa, e spunta fuori anche quando chi parla si definisce «progressista»: infatti molti sedicenti progressisti vorrebbero scalzare il conservatore per instaurare un altro modello di vita sociale che il singolo poi, ovviamente, dovrebbe prodigarsi a consolidare e conservare!
Ciò che nasce, invece, da una convivenza umana fondata sulla fiducia nell’uomo singolo, nella sua unicità e positività, dovrà, per natura sua, essere sempre aperto agli elementi innovatori che racchiude in sé ogni nuovo essere umano che si incarna. Le nuove generazioni, allora, non dovrebbero essere viste come quelle che «disturbano» quando scalpitano di fronte a una società che sta loro stretta, ma si dovrebbe capire che esse fanno appello proprio a quelle capacità di rinnovamento che distinguono l’uomo dai regni di natura. I giovani portano impulsi evolutivi nuovi, vita nuova, sangue nuovo, mete e ideali nuovi per tutto l’organismo sociale.
Riconoscere questo dinamismo inarrestabile e riporre fiducia nelle forze che creano, portano a maturazione e poi fanno decadere intere civiltà perché ne possano sorgere delle nuove è nell’economia proprio l’elemento più vitale, è la molla di tutto ciò che è produttivo e innovativo in campo economico. È infatti la fiducia nei talenti e nelle capacità innovatrici che fa progredire l’economia. Tutte le invenzioni, le scoperte, i perfezionamenti della tecnica chi li ha portati sulla Terra? Le forze di pensiero e di volontà delle generazioni che si sono succedute a fecondare l’umanità, le intuizioni conoscitive e la fantasia morale di volta in volta del tutto nuove dei singoli individui umani che sono venuti nella loro «casa» terrestre e vi si sono sentiti, appunto, a casa propria: la parola «economia» viene da οικος (oikos), che vuol dire casa! Il Vangelo di Giovanni comincia proprio così: il Verbo umano-divino venne nella sua casa, venne sulla Terra per farne la sua dimora!
Il sentimento di speranza nei figli «mandati dal cielo», che ancora fino a qualche secolo fa animava la vita sociale e faceva sì che si riponesse in loro la vera garanzia del futuro, oggi è stato mortificato dall’apprensione degli adulti per il domani dei figli, dalla preoccupazione per l’avvenire che li aspetta, dalla paura che addirittura non trovino un avvenire, dalla conseguente dannosa tutela assicurativa che in ogni campo si vorrebbe offrire. I genitori vivono nell’assillo di trovare una «sistemazione» ai figli, come se essi venissero al mondo per venire sistemati! La sistemazione sociale è parente stretta del «sistema» – non solo quello hegeliano di matrice puramente speculativa, ma anche quello sociale ed economico che vuol costringere l’individuo a «darsi una sistemata»…
Però, voglio ripeterlo, non basta ribadire in astratti assunti che il cosmo umano custodisce in sé infinite potenzialità: quest’esuberanza bisogna viverla concretamente per poter sentire le ali della speranza. Soltanto grazie alla gioia che tocca con mano l’inesauribile fecondità dell’umano può la generazione precedente liberamente proibirsi di dire alla nuova che cosa essa deve fare. L’una generazione ascolterà con interesse e con spirito di accoglienza e di gratitudine ciò che l’altra, la nuova, ha da dire riguardo al compito evolutivo che è venuta ad attuare.
Com’è paralizzante e povera un’evoluzione nel registro del dovere e com’è invece dinamica e rigogliosa un’evoluzione in chiave di creativo e libero volere! I giovani scendono sulla Terra con una volontà propria e non vogliono lasciarsi ricattare dalle volontà passate e non proprie. Non sono lo Stato, l’economia o la tradizione ad avere il diritto di dire: così deve essere l’uomo. È l’uomo che sempre nuovamente ha da dire allo Stato, all’economia e alla storia come essi debbono evolversi per tenere il suo passo.
Riflettiamo, per esempio, sulle tante cose che nella vita culturale – intesa come luogo di espressione dei talenti umani – strumentalizzano e asserviscono l’essere umano tramite un’impropria reverenza al dirigismo statale: vengono emanati decreti e decreti e si pretende che ad essi si uniformino le aspirazioni e le azioni di tutti. Ciò è assurdo e del tutto disumano!
Il cosiddetto popolo ha solo bisogno che la sfera giuridica garantisca in chiave di legge uguale per tutti le condizioni, degne dell’umano, necessarie all’espressione libera di sé: il diritto alla scuola, all’assistenza sanitaria, all’appagamento dei bisogni primari; mai, però, nell’offerta di queste garanzie il legislatore dovrebbe intervenire in merito a ciò che l’insegnante o il medico o il fornaio o l’architetto o l’ingegnere debbono fare quando sono nell’esercizio dei loro talenti.
Lo spirito di donazione
quale dinamismo specifico dell’economia
Chiediamoci ora in che modo una libera vita culturale e spirituale abbia a che fare con lo spirito di donazione in campo economico. Ho già accennato al fatto che l’uso di donazione del denaro è necessario perché è il più dinamizzante che ci sia: colui che dona il denaro non pone nessun vincolo rispetto alla direzione che il denaro donato prenderà. Infatti, quando io muovo il denaro d’acquisto pongo un’ipoteca massima: quella di ricevere subito in cambio la merce corrispondente. Quando muovo il denaro di prestito pongo un’ipoteca media: quella di riavere dopo un dato tempo denaro maggiorato. Quando muovo denaro di donazione non pongo nessuna ipoteca: lo metto incondizionatamente e per sempre a disposizione della libertà altrui.
A questo proposito dobbiamo chiederci: quali sono i modi concreti per far sorgere e coltivare lo spirito di donazione, visto che anche in questo caso il semplice predicare non serve a nulla? A me sembra che uno dei modi più belli ed efficaci per invogliarci realmente a donare sia quello di porre attenzione e di riflettere sul nostro modo di vivere il ricevere.
Pensiamo a quando eravamo bambini: tutto ci è stato regalato. Non eravamo in grado di ripagare nulla. Quando giacevamo nella culla, piccoli piccoli, non potevamo nemmeno ringraziare con un sorriso. Che cosa ci è stato donato, nella nostra infanzia? Tutto. E ancora: paghiamo noi il sole, l’aria, i fiori, gli uccelli, il mare, le montagne? Nella natura tutto è pura gratuità. È economica, pragmatica, coi piedi a terra, questa gestione della natura che ci offre da millenni grano e mele in sovrabbondanza senza chiedere nulla? La scienza dell’ecologia è sorta proprio per comprendere, rispettare e tutelare questa straordinaria «metodologia» della salute naturale.
Inoltre, che cosa abbiamo pagato, noi, per avere le doti che abbiamo? Essere un ricettacolo di capacità infinite è proprio la definizione dell’Io. Ogni Io è un centro di coesione cosmica dei più svariati talenti che ci vengono messi a disposizione da infiniti Esseri spirituali che donano e donano senza nulla «esigere» in contraccambio.
Colui che ritiene di conoscere la realtà del destino umano o del karma e di sapere che nessun talento ci è dato per caso, ma è il frutto dei nostri sforzi in ere o vite precedenti, costui deve sapere a maggior ragione che il nostro passato lo dobbiamo anche e soprattutto all’amorevole «grazia» cosmica che di volta in volta ci ha messo a disposizione tutte le condizioni necessarie per il nostro divenire in chiave di libertà.
Se guardiamo a noi stessi come «ricevitori», dunque, ci rendiamo conto del fatto che tutti noi viviamo in un mondo di esuberante magnanimità, che la legge fondamentale dell’evoluzione è la gioia del donare, è una munificenza amante che dispensa senza calcolo di ricompensa. Chi ha mai calcolato e contato i fiori delle nostre primavere per far sì che non ve ne sia neppure uno in più dello stretto necessario? Se l’universo e gli Esseri spirituali che lo abitano ci ricolmassero di doni solo in vista di una resa, come avrebbero potuto darci tanto, sapendo che avrebbero da noi ricevuto in cambio infinitamente di meno? Nello spirito di donazione i conti delle uscite e delle entrate non sono mai messi in partita doppia: la controparte del donare è la pura gioia del donare stesso. L’amore vero non ha bisogno di essere ricambiato, perché non è bisognoso, bensì straricco e straripante.
La donazione è allora il sangue arterioso dell’economia, immette forze e dinamismi sempre nuovi nell’organismo economico, mentre il suo sangue venoso è il pur necessario denaro di acquisto per il consumo.
Queste riflessioni ci inducono a un altro esercizio in grado di suscitare concretamente nella nostra interiorità la gioia del donare: è l’esercizio del vivere i talenti altrui come se fossero miei. Il paradosso di questo esercizio è che la sua positività si evidenzia soltanto se riesco a contraddire l’enunciato stesso dell’esercizio e mi convinco che i talenti altrui sono realmente miei. Finché li considero come se fossero miei, continuo a pensare che in realtà non lo siano e l’esercizio mi appare capzioso e fittizio.
Ma chiediamoci ora: il concerto di un pianista di chi è? È soltanto suo? No, se sono presente e lo gusto è anche mio. Il talento del suonare bene chi se lo gode? Soltanto colui che suona? No, anch’io che ascolto. Così è per il talento di chi sa far pizze gustose: esso appartiene non meno a chi le mangia! E così è per ogni talento…
Il fare questa esperienza di reale condivisione e l’esercitarla sempre più spesso ci fa capire che il sentirci separati gli uni dagli altri è una pura illusione. I nostri pezzi di materia, i nostri corpi, sono separati gli uni dagli altri, non noi. Noi non siamo dei pezzi di materia, ma degli esseri spirituali fatti di pensieri, di ideali, di forze d’amore che non conoscono separazioni. Al livello più profondo della realtà noi siamo veramente membri gli uni degli altri, siamo un organismo unico e in esso viviamo in interdipendenza, come gli organi dell’organismo fisico. I talenti degli altri sono allora altrettanto miei in modo verissimo e realissimo. Vivere sempre più coscientemente in questo modo è il compito complessivo dell’evoluzione umana.
Questa ripetuta esperienza porta a un profondo cambiamento non solo del nostro sentimento sociale, ma anche delle nostre decisioni economiche: scopriamo che la gioia più grande nella vita sta nel dare, non nell’avere o nel difendere a denti stretti, perché il significato umano del sano ricevere è proprio quello di renderci capaci a nostra volta di donare. Il significato del dare invece è il dare: esso vive della sua beatitudine intrinseca.
In altre parole, se io miro al solo ricevere mi esperisco sempre come bisognoso e dipendente. L’esperienza interiore del ricevere è quella del bisogno, della carenza; quando invece do, l’auto-esperienza è quella della munificenza, dell’esuberanza. Chi dà è sovrano e perciò sa anche ricevere, perché ciò gli consente di ridare ciò che ha ricevuto, dopo averlo fatto fruttare al massimo grazie al suo talento. Il cosmo in cui viviamo ci ha colmato di doni non per far di noi degli eterni e bisognosi «ricevitori», ma perché impariamo a nostra volta sempre meglio l’arte e la gioia del donare.
Queste riflessioni ci riportano al nostro punto di partenza: chi trattiene ciò che ha ricevuto, senza ridarlo, lo fa perché ha paura. Il mistero della paura è tutto racchiuso nel compito di trasformare l’illusione della povertà umana in una esperienza reale della prodigalità infinita dell’umano.
Le tre grandi fasi evolutive dell’economia
Nella storia dell’economia possiamo ravvisare tre grandi fasi evolutive, lo studio delle quali ci consente di comprendere meglio la situazione attuale dell’umanità e i compiti che le spettano soprattutto riguardo all’economia.
1. La prima forma di economia fu l’economia di scambio, di baratto: fu un’economia di tipo agrario, domestico, quindi territorialmente circoscritta e non complessa. Io ti do le pere e la farina e tu mi dai il latte e la lana. Se fossimo rimasti a questo iniziale tipo di economia non avrebbe potuto sorgere, per esempio, la multiforme attività culturale specifica dei nostri tempi.
2. La seconda grande fase dell’economia, nella quale ci troviamo tuttora, è l’economia di denaro. L’economia di scambio è incentrata preminentemente sui bisogni, sul consumo: io do all’altro qualcosa perché ne ha bisogno e prendo a mia volta da lui ciò di cui io ho bisogno. Quando subentra il denaro a rappresentare tutte le cose, si avvia il processo di astrazione di cui abbiamo già parlato: non devo più avere in mano un prodotto da scambiare con un altro prodotto, mi basta avere il denaro. Non ho bisogno di nulla in modo specifico e concreto, e perciò ricevo l’astratto denaro.
A questo punto sorge un nuovo e interessante fenomeno: con l’avvento del denaro subentrano le brame indistinte e astratte. Io non mi regolo più secondo necessità di natura che sono vincolanti, ben concrete e primarie, ma comincio a desiderare tutto e niente, perché il denaro rappresenta tutto e nulla. L’essere umano va ora in cerca della felicità senza sapere più in che cosa essa consista.
Nell’economia di denaro anche la felicità diventa allora del tutto astratta. Al tempo del baratto la felicità era avere le patate quando si aveva bisogno di patate: felicità e brame erano concrete e si corrispondevano a vicenda. Col sorgere dell’intermediazione del denaro, che ondeggia nel mare indistinto delle infinite possibilità, la brama della felicità perde sempre di più il suo oggetto concreto e succede che tutti cercano la felicità e nessuno sa con che cosa identificarla.
Uno dei tratti fondamentali dell’economia nella quale siamo oggi immersi è che, siccome tutti desidererebbero essere felici grazie al denaro, nessuno di fatto lo è proprio a causa di esso. Un uomo felice infatti non desidera essere felice: lo è già! Qualcuno dirà: chi è felice vuole essere, però, più felice ancora. Ma ciò non è vero: chi è felice desidera continuare a essere felice. Se desidera essere più felice di quanto sia, ciò vuol dire che non è felice. Torniamo allora all’intuizione fondamentale che si può essere felici soltanto nella concretezza. Perciò il desiderare e cercare «la» felicità di cui tanto oggi si parla caratterizza lo stato di massima infelicità. In altre parole, un essere umano che vuole essere felice in realtà non vuole nulla di concreto, vuole solo liberarsi dalla sua infelicità reale. Non ha la minima idea di ciò che positivamente e concretamente vuole. E non sapendo ciò che vuole, vuole essere felice! Tanto per volere qualcosa!
Nel momento, invece, in cui io voglio qualcosa di concreto, qui e ora, come autoespressione e realizzazione del mio essere, non ho tempo da dedicare a una felicità campata in aria e che non significa nulla. Essendo veramente me stesso sono del tutto felice.
3. L’economia attuale di denaro richiede allora di venir superata da una terza forma di economia: quella dei talenti, quella fondata sulle doti, sulle capacità reali e individuali di ogni essere umano attraverso le quali si innesca sempre nuovamente il dinamismo dell’evoluzione. Il soldo non cerca allora più la felicità astratta, ma si volge alla promozione e alla fecondazione delle capacità individuali concrete. Un’economia di talenti è un’economia di credito – non più di denaro – in senso vero e proprio. Si fa credito, si fa affidamento sulle qualità durature e positive dell’essere umano. Credito viene da «credere», che vuol dire avere fede, aver fiducia nell’umano vero e proprio come degno di massimo affidamento.
Noi viviamo storicamente nel grande travaglio di transizione da un’economia di denaro, fondata sulla paura e sulla mentalità assicurativa dell’accumulo, a un’economia di credito e di fiducia nei talenti umani, nella quale il denaro viene sempre di nuovo messo a disposizione e consumato per coltivarli.
Non è allora più il denaro che si vuole avere, ma la gioia dell’esercizio dei talenti. Gli economisti più sagaci cominciano oggi a rendersi conto che è proprio questa la grande via d’uscita prettamente economica per risolvere i grandi problemi attuali della globalizzazione. Cominciano a capire che possedere denaro in sé e per sé non serve di fatto a nulla. L’unica cosa importante, l’unica cosa che dà affidamento e sulla quale veramente vale la pena di investire, sono i talenti reali e le risorse durature degli esseri umani.
Il denaro che possediamo oggi, al fine di conservarlo e accrescerlo, in base a manipolazioni speculative che si fanno sempre più irrazionali e macrocosmiche, diventerà sempre meno affidabile: se io oggi ho cento, nessuno può garantirmi che domani non precipiterò a trenta, o a venti. Invece un talento che c’è oggi ci sarà anche domani e dopodomani, e se lo coltivo bene sarà di sicuro ulteriormente rafforzato. Il talento è dunque sommamente affidabile, non il denaro.
Comprendere questi capisaldi – in quanto capisaldi specifici dell’economia, quindi non sull’onda di vaghi moraleggiamenti spirituali – significa capire la cosa più importante per la vita economica moderna e futura: dovrà sorgere un’economia di credito riferito ai talenti. Questa economia non sarà più fissata sui bisogni come quella di scambio, o sull’ansia e la paura, come quella di denaro. Essa presuppone un’impostazione dell’economia mondiale in grado di considerare il soddisfacimento dei bisogni materiali come un problema del tutto risolvibile, che consente sempre più di occuparsi dell’esercizio delle dimensioni interiori e culturali dell’uomo e dei destini del suo spirito.
Denaro e risorse naturali ce ne sono in abbondanza – se non li snaturiamo – per soddisfare i bisogni dell’intero pianeta. Dobbiamo cominciare a dedicarci alla qualità vera della vita secondo lo spirito, che è infinitamente variabile e quindi infinitamente passibile di evoluzione. L’economia dei talenti è puro esercizio di libertà, quando si tratta di esprimere i talenti propri, ed è puro esercizio di amore, quando si tratta di favorire i talenti altrui. Vivere nella libertà significa fare l’esperienza dei talenti propri, vivere nell’amore significa permettere all’altro l’esperienza dei talenti suoi, gioendo nel vedere gli uni e gli altri contribuire all’esperienza del viversi come membri viventi di un unico organismo.
Se consideriamo la dinamica intrinseca di queste tre grandi fasi evolutive dell’economia, le potremmo anche chiamare l’economia specifica del corporeo (i bisogni), dell’animico (le brame) e dello spirituale (l’amore per la libertà).
Il denaro, abbiamo visto, sta al centro tra l’economia di scambio e l’economia di credito o dei talenti: esso ha dunque la possibilità di orientarsi sia verso i bisogni sia verso i talenti. Ciò vuol dire che io già oggi posso scegliere di orientare il denaro esclusivamente verso la compravendita, verso il possesso delle cose e il consumismo, insomma verso la realtà corporea; oppure posso volgerlo sempre di più verso i talenti, verso l’umano vero e proprio, verso ciò che aspetta di venire all’essere grazie alla promozione delle forze dello spirito. Il denaro diventa allora strumento dell’esercizio della libertà e dell’amore, veramente capaci di futuro e sommamente degni di affidamento e di credito.
Un tale mutamento di direzione nell’uso del denaro non presuppone, naturalmente, che venga soppresso l’altro suo uso, quello della compravendita volta a soddisfare i bisogni. I bisogni, certo, non scompaiono. L’errore, o la menzogna, del nostro agire in campo economico subentra quando esso si adagia sulla presunta irrisolvibilità e illimitatezza delle questioni primarie legate alla sopravvivenza – fame e guerre nel mondo, catastrofi climatiche, tragedie di popoli con tassi di mortalità infantile ancora spaventosi, ecc. – facendo di questi spettri una giustificazione per rimanere abbarbicati all’unica direzione dell’«avere» e rimarcarla sempre di più, magari ringraziando il buon Dio che non sia toccata a noi la malasorte.
La differenza fondamentale tra la sfera corporea dei bisogni e la sfera spirituale dei talenti consiste proprio nel fatto che i bisogni veri e propri sono per natura limitati in quanto hanno carattere di strumento, sono ripetitivi, bene individuabili perché in gran parte comuni a tutti e perciò in larga misura prevedibili, mentre i talenti sono del tutto illimitati poiché hanno una natura individuale fondata sull’inesauribile creatività di ogni spirito umano.
Dunque non è dalla parte della materia che è più sensato investire: la realtà ci sta dicendo già da un pezzo che solo gli ingorghi di capitale impediscono un sano circolare delle merci per il sostentamento di tutti. I cosiddetti poveri ci sono soltanto perché esistono i cosiddetti ricchi, e il cibo manca in Africa o in Asia perché in Europa e in America si butta. Di «cose», mal distribuite, il mondo è vuoto qui perché è strapieno là.
Un’espansione «economica» realmente illimitata, senza ingorghi e fruibile da tutti, è possibile soltanto nel campo dello spirito. E per espansione economica non si intende dire che investendo nei talenti avremo più soldi a disposizione: il progresso non sarà quantitativo ma qualitativo e riguarderà il benessere dell’umanità intera, sia corporeo che, soprattutto, spirituale.
Egoismo e altruismo in economia
Chiediamoci allora: in che cosa consiste l’incriminato «egoismo» nella vita economica? Questa parola, messa qui fra virgolette perché sono invalsi troppi preconcetti moraleggianti nei suoi confronti, significa a tutta prima l’amore di sé. Il pregiudizio comune rispetto all’egoismo è quello di ritenerlo, tout court, un atteggiamento riprovevole. Perciò chiediamoci con tutta chiarezza e onestà: che cosa c’è che non va nell’amore di sé? Nulla!
La religione considera l’amore di sé così pulito e bello che lo propone come modello assoluto per l’amore verso gli altri: «Ama il prossimo tuo come te stesso». Uno dei più grandi fraintendimenti del cristianesimo tradizionale è stato proprio la condanna sommaria dell’egoismo in quanto amore di sé. Ciò ha fatto sorgere intere generazioni di cristiani che hanno passato tutta una vita nell’intento di amare gli altri più di se stessi, credendolo un atteggiamento più nobile!
E come giunge un essere umano a ritenere che non basti amare gli altri come se stesso? Ci giunge soltanto se ama se stesso troppo poco. Al contempo, però, colui che pensa di non amarsi, non si conosce: perché esseri umani che non amino se stessi in realtà non esistono. Esistono soltanto uomini che non sanno di amare incondizionatamente se stessi, o vogliono credere di non amarsi in base a un narcisistico autocompiacimento. Resta vero che l’intento di amare l’altro più di me è un’assoluta illusione: non posso mai amare l’altro più di me.
Il vero bene morale sta allora nel proporsi di amare l’altro come si ama sé. L’amore di sé è la forza propulsiva più sana che ci sia. Il male dell’egoismo, allora, non consiste nella presenza dell’amore di sé, ma nella più o meno marcata assenza dell’amore per l’altro. Sono due cose ben diverse! L’assenza dell’amore per gli altri non è lo stesso che la presenza dell’amore di sé!
Il fatto che ci sia l’amore di sé è allora proprio il lato positivo e da conservare dell’egoismo: si tratta sempre di aggiungervi l’amore per l’altro. L’amore di sé è infatti un dato di natura, non è un fattore di libertà. Nessuno è libero di amare o non amare se stesso: ognuno deve amare se stesso, non può farne a meno. Perfino il suicida si uccide nell’illusione di proteggere sé dall’insostenibilità della vita e il più grande benefattore vuol confermare se stesso grazie alla sua generosità. Invece l’amore per l’altro è un fattore di libertà e può perciò venire in maggiore o minore misura omesso, non essendo un fatto di necessità.
Non va estinto dunque l’amore di sé e neanche sarebbe possibile farlo: potrei estirpare l’amore che ho per me stesso unicamente scomparendo, dissolvendomi nel nulla. E che cosa ci guadagnerebbe l’umanità se tutti lo facessero? L’evoluzione ha compiuto tutto il necessario per far sorgere questa bella umanità e noi in questo modo la cancelleremmo!
In altre parole, l’egoista è colui che vive nell’illusione che l’esclusione dell’amore altrui costituisca un aumento dell’amore di sé. E così facendo ama se stesso troppo poco. Questo è il paradosso. L’egoista non è ancora in grado di ravvisare nell’amore altrui un aumento dell’amore di sé. Non ha ancora compreso che rivolgere amore all’altro è il solo modo di amare anche se stessi in modo sommo e perfetto. L’egoista è colui che ama se stesso troppo poco!
L’altro appare solo esteriormente come «altro», ma nella realtà più profonda, lo abbiamo già detto a più riprese, non lo è: è parte di me stesso. O io amo tutto l’organismo umano – e l’umanità è un unico organismo –, e allora il modo migliore di amare me, come organo di questo organismo, è di amare anche tutti gli altri organi; oppure non amo l’organismo intero, e allora amo di meno anche me stesso, come organo singolo, poiché mi proibisco di partecipare alla salute generale e mi danneggio. L’essere umano che non vive l’amore del prossimo sottrae amore anche a se stesso.
Qual è, allora, il volto specificamente economico dell’egoismo? In italiano c’è una parola non molto bella, ma calzante, che esprime bene ciò di cui stiamo trattando: il menefreghismo. Il menefreghismo, che spesso regna sovrano nella nostra vita quotidiana, è un’assenza di dinamismo interiore, conseguenza primaria e molto grave del materialismo. Fissandoci sulle cose materiali, noi trascuriamo la vitalità reale dell’Io e diventiamo ignavi, abulici, interiormente pigri. Non conosciamo più la perfetta letizia di un Francesco d’Assisi che consisteva nella sua capacità di prendere tutto e tutti a cuore come suoi fratelli e sorelle. «Prendere a cuore»: una bellissima espressione per dire l’opposto di «menefreghismo». L’avvenire dell’economia mondiale dipende tutto da una cultura che sia in grado di coltivare le forze del cuore.
Il disinteresse interiore provoca, in campo economico, l’inerzia: appunto perché all’Io manca la forza interiore di quel dinamismo che si sprigiona dall’interessamento. E come può l’Io prendere a cuore tutto e tutti? Non certo nell’isolamento «egoistico», ma nell’interazione vivace e vivente con gli altri, nel fare quotidianamente l’esperienza corroborante della reciproca appartenenza. Il disinteresse nei confronti degli altri innesca invece la paralisi economica, frena e mortifica la produttività dell’ingegno umano.
Dobbiamo allora escogitare modi concreti di superare l’inerzia interiore causata dal materialismo! E per far ciò dobbiamo procedere con la stessa metodica conoscitiva che abbiamo applicato per l’egoismo, evitando anche qui ogni falso moralismo. Se è vero che il materialismo è l’amore per il mondo visibile, che cosa c’è di male in questo? Nulla!
Come l’amore di sé è la parte positiva dell’egoismo e la carenza dell’amore per l’altro ne è l’aspetto negativo, così l’amore per la materia è la parte buona del materialismo e la sua parte non buona è la carenza, l’omissione, dell’amore per lo spirito. In un’evoluzione in chiave di libertà i grandi peccati sono quelli di omissione! Anche qui, allora, non si tratta di togliere ciò che c’è di buono, ma di aggiungere il buono che manca. Se il materialismo consiste nell’apprezzamento della vita visibile, nella gioia che nasce dal sentirsi inseriti nella fisicità, va benissimo. Non togliamocela, allora, questa gioia, ma completiamola con un’altra esperienza che ci rende ancora più felici: l’amore per lo spirito! Come l’egoista ama sé troppo poco, così il materialista ama la materia troppo poco, perché ancora non ama lo spirito che la compenetra e che, solo, rende il mondo materiale degno di infinito amore.
Queste considerazioni ci riportano al pensiero di fondo che in ultima istanza non si tratta mai di abolire qualcosa di negativo, ma di creare qualcosa di positivo che ancora manca. Non basta predicare che il materialismo fine a se stesso costituisce una prigione per l’essere umano: troveremo sempre qualcuno che ci risponderà che lui sta benissimo così. Si tratta di mostrare che c’è qualcosa di molto meglio. Il vero superamento dell’unilateralità del materialismo è allora il godimento, la beatitudine contagiosa dello spirito. Chi preferisce essere povero – di spirito! – ne ha in fondo il «diritto», ma non ha il diritto di dar la colpa ad altri.
Ciò può suonare a tutta prima astratto. Il godimento dello spirito diventa invece del tutto concreto quando il cosiddetto spirito viene vissuto nella sua vera realtà di creatività di pensiero e di sovrabbondanza di amore, che sono ancora più reali della cosiddetta materia.
Cosa succede, allora, nel mondo dell’economia, quando un essere umano non vive più nell’ipnosi univoca del puro materiale, ma, nell’esercizio quotidiano della conoscenza, dell’arte, della religiosità, fa sempre di più l’esperienza dello spirito che illumina di sé tutto il mondo materiale? E cosa succede nell’economia quando si unisce all’amore di sé l’amore per l’altro?
Nasce lo spirito associativo.
Spirito di donazione quale spirito associativo
Lo spirito associativo, in economia, è l’esercizio concreto della fratellanza, dell’aiuto reciproco, della solidarietà: le tre componenti della vita economica – i processi di produzione, di commercio e di consumo – vengono rappresentati nell’associazione economica dal produttore, dal commerciante e dal consumatore, che sempre nuovamente si riuniscono nell’intento della collaborazione e del reciproco sostegno.
È importante rilevare che nella vita economica contemporanea stanno sorgendo molte «associazioni tra consumatori», e poi «associazioni tra commercianti», e poi «associazioni tra produttori»: i tre protagonisti dell’economia, cioè, non sentono l’esigenza di incontrarsi insieme, ma per categoria. Ciò inasprisce spesso ancora di più le polarità e conferma la mentalità illusoria del potersi avvantaggiare l’uno a svantaggio dell’altro.
La sussidiarietà è la legge fondamentale dell’economia moderna fondata sulla divisione del lavoro. Essa evidenzia la dipendenza reale di tutti da tutti e la responsabilità di tutti verso tutti. Ogni solidarietà di tipo settoriale che operi a danno di un altro settore è una solidarietà di «autodistruzione». Se veramente compresa nella sua intima natura, l’economia mondiale moderna richiede una solidarietà onnicomprensiva, e ciò significa: solidarietà reciproca fra tutti e tre i settori economici, quello della produzione, quello del commercio e quello del consumo. Un’associazione economica consona ai tempi moderni può essere perciò solo quella che abbraccia tutti e tre. La sfida moderna della fratellanza economica risiede nell’intesa e nell’accordo che produttore, commerciante e consumatore raggiungono sempre nuovamente fra di loro.
Produttore, commerciante e consumatore mettono innanzitutto a disposizione l’uno dell’altro le proprie percezioni ed esperienze, si comunicano i problemi e le difficoltà, le esigenze e i desideri, i vantaggi e gli svantaggi reciproci. Scoprono, ben presto, che è nel loro interesse comune prendersi sul serio a vicenda. Può nascere così una genuina e non filtrata attenzione, una comprensione attiva e diretta delle situazioni concrete, visto che ognuno di noi, nella vita, per molti aspetti è consumatore, per altri produttore, per altri ancora distributore.
Sapere dalla bocca di chi se ne occupa in prima persona cosa voglia dire, per esempio, trasportare frutta per migliaia di chilometri in inverno, con le strade gelate, o d’estate, quando non soltanto si suda, ma le merci rischiano di deperire, è molto importante sia per il produttore che per il consumatore. È altrettanto importante, sia per il consumatore sia per il commerciante, comprendere le istanze del produttore (in questo caso della frutta) che, estate o inverno, non può mai abbandonare i campi e in una stagione è alle prese col maltempo, in un’altra con i parassiti delle piante o con la siccità. E ancora è di grande importanza, per avere un quadro esauriente e dinamico delle cose, che possa dire la sua soprattutto il consumatore, che magari si ritrova a pagare come oro l’uva o le pesche o le fragole e deve pure chiedersi se non siano state trattate con sostanze velenose.
Le associazioni devono esistere a livello generale, medio e capillare. Solo in un’associazione piccola, però, è possibile la partecipazione diretta di tutti gli interessati. Questa forma è dunque quella più importante e vitale di tutte. Le altre devono avvenire per delega, e dovrebbero perciò limitarsi a raccogliere informazioni e a formulare orientamenti generali. Decisioni veramente concrete, tali da generare le forze necessarie per la loro realizzazione, sono possibili solo nell’associazione a partecipazione diretta, dove anche l’esecuzione reale degli accordi presi viene direttamente operata dalle stesse persone che li hanno comunemente concordati. Qui non c’è nessuno che decida per un altro ciò che egli deve fare, ma ci sono solo persone che dicono a se stesse che cosa esse stesse vogliono fare insieme per venire incontro ai bisogni comuni da esse direttamente espressi e da esse direttamente percepiti e presi a cuore. Quando si decreta o si delega si può esser certi che non viene fatto nulla.
L’associazione diviene allora il nuovo modo «concertato» di prendere decisioni in campo economico. Essa vive della solidarietà delle forze migliori dei tre cardini dell’economia. Essa è carica di umanità perché tutte le istanze e i desideri espressi sono istanze e desideri di esseri umani in carne e ossa, non delle necessità cieche o astratte del mercato. L’associazione rappresenta così il vero esercizio della fratellanza, dell’essere gli uni per gli altri. Questo spirito associativo è del tutto necessario per passare da un’economia di reciproco sfruttamento a un’economia di collaborazione, da un’economia di denaro a un’economia di fiducia nei talenti umani.
Noi viviamo ormai da lungo tempo in un’economia mondiale unica e unitaria: è improprio e fuorviante parlare di economia statunitense, o tedesca, o giapponese, quando non solo il commercio dei prodotti ma soprattutto gli stessi processi di produzione hanno ormai valicato ogni tipo di frontiera. I processi produttivi stessi sono diventati ormai internazionali, quindi del tutto unitari nell’umanità. In un’economia mondiale globalizzata a tutti i livelli non ci sono più interessi di settore o di nazione a danno di altri settori o di altre nazioni: o guadagniamo tutti o perdiamo tutti. Da ogni nuova serie di riflessioni ritorna lo stesso ritornello!
La realtà dell’economia ha dunque già fatto dell’umanità una reale unità, ma la coscienza umana è rimasta indietro. L’economia ha creato una tale interdipendenza tra i popoli che non è più possibile pensare che il danno di una nazione possa costituire il vantaggio di un’altra, per quanto grande e potente essa possa essere. Questa è la grande sfida della realtà economica mondiale per la coscienza umana moderna: quella di creare una struttura di pensiero che sia veramente universale e tenga il passo con un’economia sempre più globale e unitaria.
Terzo capitolo
LAVORARE PER SÈ
O PER GLI ALTRI?
LIBERAZIONE DEL LAVORO
DALLA TIRANNIA DELL’ECONOMIA
L’uomo e il suo lavoro
Nelle riflessioni precedenti ho sottolineato quanto sia importante per la vita economica che la sfera culturale-spirituale sia resa libera e sia fatta oggetto di profonda fiducia da parte degli esseri umani. Vorrei ora rivolgere i pensieri alla grande realtà del lavoro in relazione alla vita giuridica, politica e statale, secondo il principio della pari dignità di ogni persona umana, cioè dell’uguaglianza di tutti gli uomini in fatto di diritti e di doveri. Nel quarto capitolo ci occuperemo poi direttamente del funzionamento delle associazioni, destinate a diventare il cuore della sfera economica propriamente detta, qualora essa voglia rinnovarsi ed evolvere in modo positivo.
Riprendiamo il concetto fondamentale della «triarticolazione dell’organismo sociale»: affinché l’essere umano possa regnare sovrano nei confronti del cosiddetto «sociale», è necessario:
– che la libertà della vita spirituale e culturale non venga asservita alle ideologie politiche o agli interessi economici;
– che la parità di dignità di tutti gli esseri umani non venga stravolta dai privilegi aristocratici della cultura tradizionale o dalle strettoie dell’economia;
– che lo spirito di fratellanza, fondamento ancora tutto da costruire per una sana vita economica, non venga minato dall’egoismo del libertarismo individuale o dalla macchinosità livellatrice e avvilente dell’economia di Stato.
Ciò vuol dire: devono venire instaurate tre sfere distinte della vita sociale – quella culturale, quella giuridica e quella economica – in modo tale da conferire a ciascuna una vera autonomia amministrativa rispetto alle altre due, così da poter sempre nuovamente respingere ogni loro tentativo di indebita ingerenza.
Ci siamo già posti la domanda se il lavoro umano rientri o no nella sfera economica. A tutta prima verrebbe di rispondere di sì. Questo è invece, abbiamo visto, un grave errore di pensiero che si è poi realizzato nella vita e contro il quale, con l’amarezza e con la forza della disperazione, si sono scagliate proprio le rivendicazioni della classe operaia già dai tempi di Karl Marx.
La sana vita economica genera un dinamismo tutto suo grazie al fatto che tutto ciò che vi entra a far parte deve diventare necessariamente merce. Se l’attività lavorativa non si può dissociare dalla persona umana, e se vogliamo evitare che l’uomo stesso diventi merce, consegue che l’attività lavorativa stessa dovrà essere strappata alla sfera economica e riconsegnata a quella giuridica, che ha proprio il compito specifico di salvaguardare la parità di dignità di tutti gli esseri umani in quanto tali.
Se noi continuiamo a lasciare al produttore, al commerciante e al consumatore in quanto tali, cioè in quanto attori diretti nel campo dell’economia, il compito di decidere sulle modalità del lavoro – su questioni che vanno dall’orario delle prestazioni alla salubrità dell’ambiente di lavoro, dai limiti di rischio e di sicurezza a quelli di età e di salute, dalla base minima di retribuzione al congedo temporaneo per maternità e paternità ecc. –, essi non potranno che usare i parametri dei rispettivi bisogni, che non possono essere che di natura prettamente economica. Dovranno cioè esigere l’uno dall’altro una solidarietà tutta specificamente economica, che però non ha nulla a che fare con la loro uguaglianza di dignità in quanto esseri umani.
Il produttore (in questo caso l’imprenditore) spingerà al massimo per allungare gli orari di prestazione e retribuirli il meno possibile, e tenderà a considerare ogni richiesta dell’operaio come un tentativo di lavorare di meno. Il commerciante tenderà a ignorare ogni imposizione di norme e pretenderà soltanto merci ben prodotte e regolarmente consegnate. Il consumatore, da parte sua, con il potente strumento della domanda allargherà il suo influsso non solo sul mercato delle merci ma anche su quello del lavoro. Il cottimo, per esempio, nacque per soddisfare la pressante domanda di questo o quel prodotto.
Se è vero che il lavoro è inscindibile dall’essere umano che lo compie e che è per sua natura non mercificabile, consegue che il lavoro in quanto tale non si può pagare, perché non è una merce. In effetti, a guardar bene la realtà, il cosiddetto datore di lavoro paga il risultato del lavoro, mai il lavoro in quanto tale. Paga ciò che il lavoro produce, il cosiddetto prodotto, perché il lavoro – in quanto attività, esercizio e fatica umani – di per se stesso non ha nessun valore economico. Chi lavora molto e produce poco vale economicamente poco; chi lavora poco e produce molto vale economicamente molto. Anche l’attività sportiva e ludica del tutto private comportano operatività, sudore e «lavoro»: ma non per questo le valutiamo in denaro.
È importante, allora, distinguere bene tra «lavoro» e «risultati del lavoro» (merci, beni di consumo, prodotti tangibili e anche prestazioni non tangibili – come l’insegnamento per esempio, ecc.). Il prodotto del lavoro lo abbiamo in forma pura solo dopo che il lavoro è finito: nel momento in cui l’essere umano che ha lavorato esce di scena resta il prodotto puro. Le affermazioni di apprezzamento o dispregio che vengono fatte sul prodotto non hanno allora nulla a che fare col lavoro stesso né, tanto meno, con l’uomo che l’ha compiuto. Il valore del prodotto viene stabilito in base ai bisogni reali di chi acquista, non in base ai «meriti» lavorativi del produttore.
Sappiamo bene che c’è chi, per proprio individuale talento, lavora poco e produce molto e bene, mentre un’altra persona lavora cinque volte di più ma salta fuori di meno, soprattutto riguardo alla qualità. Proprio qui si vede bene l’importanza del distinguere chiaramente tra lavoro e prodotto del lavoro. È evidente che per colui che compra una merce non ha alcuna importanza il lavoro che c’è dietro: non gli interessa se il lavoratore ha sudato poco o molto o quante ore ha impiegato per la sua formazione, se si tratta di una prestazione spirituale. Da un punto di vista economico gli interessa unicamente la qualità del prodotto.
Immaginiamo una famiglia che, non avendo altro, per varie settimane abbia dovuto mangiare quasi esclusivamente pere. Un bel giorno spunta un fruttivendolo con tanti tipi di frutta, tra i quali ci sono anche delle pere che, oggettivamente parlando, sono della migliore qualità che si possa trovare. Che valore hanno quelle pere per i componenti della nostra famiglia? Un valore assolutamente nullo, perché non vedono l’ora di mangiare qualcos’altro. E questo non riguarda né il produttore né il suo lavoro, ma si riferisce esclusivamente al bisogno reale del consumatore. Ciò resterebbe vero anche se il nostro fruttivendolo avesse da vendere soltanto pere!
Proprio da ciò si evince la necessità assoluta di rendere indipendenti l’una dall’altra la sfera giuridica e quella economica: la sfera economica, per natura sua, non può occuparsi di giustizia e di uguaglianza perché i bisogni sono sempre del tutto «impari» da essere umano ad essere umano. La sfera economica, perciò, non potrà che apparire «ingiusta» se non procederemo a una reale triarticolazione dell’organismo sociale che affranchi la sfera giuridica da quella economica.
Sarà allora la sfera giuridica in quanto tale, indipendentemente da ogni istanza economica, che dovrà stabilire in che modo vadano tutelate le figure «deboli» nell’ambito sociale: i bambini, i malati, gli anziani, gli inabili al lavoro, le famiglie numerose ecc. Ciò vale anche per ogni contesto di lavoro e di «collaborazione», dove il datore di lavoro è solito far la parte del leone. E dove andranno attinte le risorse economiche per far fronte a tutto ciò? Da quel sovrappiù che esubera nella sfera economica proprio grazie alle capacità dei più abili!
Quando parliamo qui della sfera giuridica propria dello Stato non intendiamo riferirci ad autorità costituite che decidono delle sorti degli altri esseri umani. Meglio sarebbe non parlare affatto di «Stato» e riferirci a quel tipo di interazione fra esseri umani grazie alla quale essi non si considerano né come più o meno dotati spiritualmente, né come più o meno bisognosi materialmente, bensì unicamente in base alla pari dignità in quanto esseri umani.
È questo tipo di rapporto e di interazione umana che deve stabilire a livello di legge valida per tutti quali siano i diritti e i doveri reciproci di tutti gli esseri umani appartenenti alla stessa giurisdizione, compresi i diritti e i doveri della situazione lavorativa. Dovendo il cittadino delegare per una legislazione ad ampio raggio, è importante che egli possa scegliere ed eleggere coloro che vengono percepiti come dotati di un sentimento particolarmente spiccato e sano della dignità della persona umana e dell’uguaglianza assoluta di questa dignità in tutti gli esseri umani.
La redenzione del lavoro dalla tirannia dell’economia
L’importante distinzione fra lavoro e risultato del lavoro ci induce a ulteriori distinzioni: per esempio a quella pure importantissima che esiste tra un lavoro veramente produttivo per la comunità umana e un lavoro che non produce nulla. In un tempo di disoccupazione di massa com’è il nostro, se non si sa fare questa distinzione si cade nell’inganno di creare posti di lavoro per tante persone (che poi ovviamente vengono da tutti noi pagate) senza chiedersi se esse producano qualcosa di oggettivamente utile per l’organismo sociale. In questo modo possono venir creati milioni di parassiti, che guastano l’organismo sociale non meno dei milioni di disoccupati.
Supponiamo che in un Paese, per creare nuovi posti di lavoro nel settore postale e tipografico, si invoglino i cittadini a triplicare il numero di cartoline che solitamente scrivono. Verrebbe così creata all’interno della sua economia anche una nuova e vantaggiosa produzione? No. La comunità non pagherebbe un arricchimento reale dell’organismo economico e sociale in termini di prodotti e servizi, ma pagherebbe un lusso, se vogliamo chiamarlo così. E rimane da vedere se se lo può permettere e se è veramente ciò che la popolazione desidera. Il salario dei neonati postini andrebbe comunque a pagare un lavoro, non il risultato di un lavoro. Infatti, per far fronte alla disoccupazione, si parla sempre di creare «posti di lavoro», non posti dove il lavoro produca davvero qualcosa di utile per tutti. Non ogni «posto di lavoro» è un posto di reale e proficua produzione! Un posto di lavoro in sé e per sé è un puro costo per la società – il costo delle paghe corrispondenti ai «posti» – non automaticamente un profitto!
Spesso nella società contemporanea, e soprattutto là dove il consumismo è diventato più accanito e incallito, vengono inventati lavori improduttivi. C’è addirittura una teoria famosa che ben conosce chi si occupa di economia: J. M. Keynes, ai tempi della ricostruzione economica americana dopo la crisi del 1929, propugnava la necessità di promuovere al massimo l’occupazione di tutti per favorire l’industria e, conseguentemente, la ricchezza e il consumismo. Là dove l’occupazione veniva a mancare egli sosteneva che fosse comunque meglio occupare centomila persone a scavare buche e altrettante persone a riempirle di nuovo piuttosto che influire negativamente sul senso di fiducia popolare riguardo alla ripresa economica della nazione. Inoltre questa procedura sarebbe stata un buon deterrente contro i disordini sociali…
Vedremo in seguito che il problema della disoccupazione risiede molto di meno nella mancanza di lavoro produttivo e molto di più nella sua non equa distribuzione e remunerazione. Se ciò non fosse, dovremmo dire (cosa che del resto è stata affermata da molti studi demografici) che nell’umanità siamo in troppi! Ciò è invece assurdo se si considera l’umanità come un organismo vivente unitario: in un vero organismo gli organi non sono mai troppi, né troppo pochi.
Nel corpo fisico sano non succede che un migliaio di alveoli polmonari rimangano improvvisamente disoccupati perché sono diventati di troppo. Addirittura potremmo paragonare il lavoro fittizio e nocivo del nostro vivere sociale all’accumulo di grasso corporeo: impropriamente nell’organismo viene promossa un’attività lavorativa inutile che non produce nulla di positivo, anzi appesantisce, debilita e squilibra le altre funzioni veramente essenziali, sottraendo forze a tutto l’organismo.
Esistono, dunque, lavori il cui valore risiede nel risultato utile per tutti e altri lavori che sono fine a se stessi e hanno solo lo scopo di venire pagati. Pensiamo al gioco o allo sport: se chiamiamo lavoro tutto ciò che ci fa stancare, anch’essi sono un lavoro. Il concetto di lavoro è uno dei più difficili proprio perché non si lascia definire: è possibile coglierlo solo in immagini viventi ed esse stesse in movimento.
I nostri calciatori noi li paghiamo. Paghiamo in questo caso lavoro o prodotto del lavoro? Se lo sport viene vissuto nella sua natura di puro gioco dovrebbe essere puro esercizio di umanità: si giocherebbe per il gusto di giocare e dunque sarebbe un controsenso svolgerlo in vista di una paga. Schiller, nell’opera Lettere sull’educazione estetica del genere umano, ha espresso pensieri bellissimi su questo puro esercizio di umanità dove l’adulto riscopre in sé il bambino e vive nel gioco, nel puro amore all’azione che non rende schiavi del risultato o del successo. In questa qualità ludica Schiller individuava l’espressione più alta dell’umano, in tutti i campi: l’uomo è veramente umano, egli diceva, quando ama ciò che fa, nel momento in cui lo fa e senza altri fini, quando è appagato e si diverte per la pienezza stessa dell’azione che compie.
Negli ultimi tempi, invece, lo sport è diventato sempre di più una guerra, una palestra di competizione accanita: il godimento si è spostato dal puro giocare al giocare contro, dal puro giocare per il gusto di giocare al giocare per vincere. Ma il vincere è il risultato, cioè «il prodotto» che va all’esterno. La parola «successo» ce lo dice così eloquentemente! Il successo è ciò che «succede» (dal latino subcedere = [ac] cadere dopo): è ciò che viene dopo, alla fine del gioco, appunto. Chi fa qualcosa per il «successo» non vive nel presente, non può sentire amore per l’azione, ma solo per ciò che consegue ad azione terminata. La mentalità del successo è perciò l’alienazione più totale che ci sia: non si è mai nel presente, ma sempre in un astratto ed estrinseco futuro.
Il consumatore, dicevamo, non è interessato al lavoro, ma, giustamente, al risultato del lavoro; il produttore, cioè colui che lavora a produrre qualcosa, deve vivere invece nell’amore per il produrre in quanto tale, perché solo in questo modo otterrà il miglior risultato per l’altro. La mentalità del «successo» consiste nel voler conseguire, a conti fatti, il miglior risultato per sé. Ciò non è amore al produrre (per l’altro), ma amore al compenso (per sé). Ciò vale anche per l’odierna partita di calcio.
Lo sport, il gioco, sono stati sempre di più fagocitati dalla sfera economica. Vengono pagati a suon di quattrini. Qualcuno dirà: ma va bene così, il calciatore o il pugile o il pilota di Formula 1 possono benissimo divertirsi mentre giocano, a prescindere dal risultato, mentre lo spettatore fruisce della loro prestazione, così come può godersi un buon concerto alla Filarmonica o un’opera teatrale. C’è qualcosa che non va in questo ragionamento? Io rispondo: c’è molto che non va!.
In un’orchestra o in una compagnia teatrale non ci sono vincitori e sconfitti: si suona e si recita non per debellare e vincere, ma per il gusto stesso del bello. L’elemento artistico è fine a se stesso e solo così è in grado di essere puro esercizio della creatività umana. I moderni tifosi del calcio (nonché i giocatori in azione) portano invece nello stadio un intento non ludico ma bellico. Se la propria squadra ha vinto si tripudia, se ha perso si passa una brutta settimana. Se l’altra squadra vince la si odia, se perde la si denigra. Se il senso della partita fosse il godimento del bello artistico in quanto tale, lo spettatore dovrebbe essere del tutto indifferente rispetto a chi vince o a chi perde, perché gli dovrebbe interessare soltanto il gioco in sé, goduto nella sua intrinseca bellezza, non meno della musica in sede di concerto. A me è capitato, vivendo in Germania, di essere evitato per qualche tempo da un amico tedesco che dava per scontato che io fossi «infuriato» perché la Germania aveva vinto la finale dei mondiali di calcio contro l’Italia!
In un organismo non c’è nessun membro che perde in base alla vittoria di altri membri. La legge della divisione del lavoro, della solidarietà in campo economico, consiste nel fatto che tutti devono vincere e che non ci devono essere sconfitti.
Liberare il lavoro dalla tirannia dell’economia significa dunque svincolarlo dal suo prodotto, dal suo risultato, che costituisce invece, e giustamente, l’oggetto di interesse specifico dell’economia vera e propria. Si tratta, perciò, di una redenzione del lavoro in vista di una redenzione del lavoratore in quanto essere umano. Essa urge nelle profondità più sane dell’essere umano stesso: bisogna ritrovare un modo di lavorare che sia puro gioco, pura gioia per l’azione in se stessa e non sia ricattato dall’assillo per il risultato dell’azione.
Il prodotto, il risultato del lavoro, sarà tanto più bello, buono e proficuo per l’organismo sociale quanto più sarà stato vivo e pieno di amore l’operare stesso dell’essere umano che l’ha prodotto, quanto più egli, lavorando, avrà sentito la gioia dell’espressione migliore di sé a servizio degli altri e non l’ingombro del risultato voluto unicamente per sé.
Non solo: la tirannia economica del lavoro ha fatto anche sì che per «risultato del lavoro» milioni di esseri umani oggi intendano unicamente la paga, il salario. Non si tratta dunque più soltanto del fatto che gli impiegati e gli operai dovrebbero riconquistare la gioia del lavorare; si tratta anche di correggere l’errore di prospettiva che li ha messi in condizione di credersi «produttori di buste paga». Lavorare per i soldi ingenera disinteresse e disaffezione rispetto al prodotto del lavoro. È questa la malattia endemica più micidiale dell’organismo sociale e del processo economico invalso nel nostro tempo.
L’umanità si trova oggi a una soglia del divenire dove i veri problemi dell’economia non sono più risolvibili a tavolino, tramite gli espedienti tecnici dei cosiddetti esperti. I grandi quesiti dell’economia attuale sono il riverbero degli atteggiamenti interiori più profondi degli esseri umani stessi. La grande resa dei conti, a questo inizio di millennio, richiede un forte scossone interiore che in ognuno si traduca nel coraggio di interrogarsi, con spregiudicatezza e sincerità, su quale sia il proprio modo di porsi di fronte al denaro, allo stipendio, al lavoro e all’organismo sociale in quanto tale.
Il lavoro si divide e si specializza: l’uomo si universalizza
Un importante aspetto della tirannia dell’economia sul lavoro e perciò sul lavoratore in quanto essere umano consiste, paradossalmente, nella contraddizione profonda che è sorta nell’umanità moderna tra la divisione reale del lavoro e la mentalità del tutto anacronistica secondo la quale tante persone continuano a credere di lavorare per sé.
L’economia mondiale odierna si caratterizza per la divisione del lavoro, ciò è innegabile: più avanza la specializzazione tecnica e industriale e più diventa necessaria una sempre ulteriore divisione e specializzazione del lavoro stesso. Ciò significa che oggi l’economia oggettiva ci fa di fatto lavorare in tutto e per tutto gli uni per gli altri. L’autarchia non è più possibile a nessun livello. Ciononostante, nella struttura interiore della maggior parte degli esseri umani, nel modo intimo di pensare e sentire, è rimasta la mentalità vecchia e illusoria del lavorare ognuno per sé.
Possiamo dire che, anche in questo caso, lo stadio di coscienza dell’umanità non è stato capace di tenere il passo con l’economia oggettiva, non si è adeguato alla realtà. A questo proposito sono interessanti due affermazioni di Rudolf Steiner: il salariato è un autarca camuffato e il capitalista è un commerciante camuffato.
Colui che lavora per il salario è una specie di cripto-autarca, di autarca travestito: ha la struttura mentale di chi lavora per sé, di chi vuol essere autonomo e autosufficiente senza rendersi conto che oggi dipendiamo oggettivamente tutti in modo assoluto gli uni dagli altri. Lo stipendiato continua a dirsi: lavoro, guadagno una paga, dunque sono in grado di mantenermi da solo.
Il capitalista, l’imprenditore, il cosiddetto «datore di lavoro» è in realtà, da parte sua, un cripto-commerciante, un commerciante travestito, perché compra e poi rivende a prezzo maggiorato, grazie a fattori di congiuntura vari, le prestazioni del lavoratore.
Se togliamo di mezzo l’elemento di illusione, di ingannevole apparenza, che cosa sono, nella realtà oggettiva, il cosiddetto salariato e il cosiddetto datore di lavoro? Sono entrambi coproduttori, l’abbiamo già detto. Essi producono insieme. È insito in un’evoluzione sana della vita sociale il pervenire alla consapevolezza che in ogni settore economico esistono unicamente persone che lavorano insieme per produrre qualcosa.
Che poi una persona abbia il compito di prendere decisioni direttive e un’altra abbia la mansione di pulire i locali dove si lavora, ciò non ha nulla a che fare con la dignità dell’essere umano in quanto tale. L’uno e l’altro lavorano insieme dando il meglio di sé per rendere un servizio alla comunità. Le decisioni del direttore non sono più importanti del far le pulizie: in economia non si fa ciò che è più o meno «importante», ma ciò che è necessario. E le pulizie non sono meno necessarie delle decisioni del direttore.
La divisione del lavoro in un’economia mondiale unitaria è dunque il superamento oggettivo dell’egoismo. È dunque l’economia e non la religione ad offrirci l’aiuto più convincente e efficace per uscire dalle ristrettezze di un egoismo malinteso che cerca il vantaggio dell’uno a svantaggio dell’altro.
Grazie alla realtà dei fatti economici improntati sulla divisione del lavoro già attuata dappertutto, nessuno è più in grado di essere un indipendente o piccolo «autonomo», oppure un patriarcale «padrone». È nella natura del processo economico moderno che esso tenda a generare in noi un atteggiamento interiore che, comprendendo rettamente lo stato delle cose, lo voglia nella sua oggettività e se ne rallegri in libertà. L’economia mondiale globale ci porta a superare la limitatezza del famoso detto: chi fa da sé, fa per tre. In economia ciò non è vero né possibile: chi fa da sé (ovvero si illude di fare solo per sé) non fa né per sé, né per tre, né per nessun altro.
Il fatto che i processi lavorativi diventino sempre più specializzati, non comporta che all’essere umano in quanto tale debba accadere la stessa cosa: che debba ridursi, cioè, a saper fare soltanto una cosa. Anzi. La parcellizzazione del lavoro, che va cesellandosi in dinamiche sempre più specifiche e settoriali, richiede, come necessario contrappeso, proprio uomini sempre più versatili, malleabili, capaci di spostarsi e intervenire in settori diversi.
Più l’economia mondiale specializza il lavoro, più l’educazione dell’essere umano deve renderlo universale. Abbiamo tutti davanti agli occhi i licenziamenti di massa ai quali spesso procedono i settori produttivi più grossi, quello automobilistico per esempio.
La domanda importante è: dove andranno a parare tutti questi lavoratori? Cosa faranno? Avranno la formazione necessaria per accedere ad altri lavori, oppure dovranno accontentarsi della cassa integrazione, quando c’è? Vedremo in seguito che l’adattabilità interiore dei lavoratori è uno degli strumenti più importanti per sanare il problema dei costi di produzione e dei prezzi di acquisto. Si renderà sempre più necessaria una vera formazione permanente dell’essere umano volta a promuoverne la flessibilità, la polivalenza, in una parola l’universalità di cui ogni uomo, proprio perché è uomo, è capace.
Uno dei risultati fondamentali e positivi della divisione del lavoro è che rende tutte le merci infinitamente meno costose: infatti, più il lavoro si distribuisce e meno caro diventa, a monte, il processo di produzione.
Da ciò otteniamo un altro risultato positivo, che spesso non viene valutato a sufficienza: grazie a questa globale ripartizione del lavoro che rende sempre più efficiente ed efficace il lavoro stesso, rimane un esubero sempre maggiore di tempo e di energie per le tante altre attività che promuovono la pienezza delle dimensioni specificamente umane. Una grande questione sociale degli anni a venire sarà perciò l’impiego del cosiddetto tempo libero.
Noi siamo già a un punto dell’evoluzione in cui, se distribuissimo bene il lavoro e sapessimo avvalerci in modo saggio di tutto ciò che le macchine fanno al nostro posto, avremmo necessità di lavorare non più di tre o quattro ore al giorno, in media, per assolvere le richieste della sfera dei bisogni. Questo nuovo rapporto con il tempo sarebbe del tutto giovevole se avessimo la capacità di farne buon uso, ma sarebbe un immane disastro se ci cogliesse impreparati.
La cosiddetta lotta contro la disoccupazione infatti nasce anche dal fatto che fa più comodo, e meno paura, affibbiare agli esseri umani più ore di lavoro di quelle che sarebbero necessarie, pagandone lo scotto in termini economici, piuttosto che affrontare i guai e i disastri che sorgono dall’incapacità di «occupare» in modo positivo il tempo libero. Ancora più terrificante – per sé e per gli altri – è la situazione di chi il tempo libero ce l’ha ma non lo sa affatto «occupare», bensì solo «ammazzare»! L’alcolismo e la violenza che spesso si uniscono alla tragedia della disoccupazione sono anch’essi un risvolto di questa realtà.
La mentalità autarchica si fa sempre più anacronistica
Se la divisione del lavoro ha reso impossibile l’esistenza di economie-stagno, indipendenti le une dalle altre riguardo ai processi di produzione, che cosa provoca, in questo contesto, colui che lavora per sé? Rende le merci più care. Chiunque abbia ancora la mentalità autarchica tende realmente, anche se non se ne accorge, a rincarare i prodotti.
Un discorso a parte va fatto per l’agricoltura che, svolgendo un lavoro diretto alla terra, ha per natura una tendenza autarchica, perché nessun contadino può in effetti immettere tutti i suoi prodotti sul mercato. Né ciò sarebbe auspicabile o giovevole: basti pensare al letame, che è più efficace se usato per la stessa terra della quale si nutrono gli animali che lo producono. La tendenza conservatrice a consumare ciò che si produce è dunque parzialmente ingenita nel lavoro agricolo: da ciò consegue anche il rialzo continuo dei beni fondiari, rafforzato dal fatto che noi trattiamo la terra come fosse una merce che è giusto possedere, mentre la terra, il fondo, è in realtà un mezzo di produzione che va usato ma non posseduto.
In realtà i terreni, come tutti i mezzi di produzione e come il denaro, non hanno nessun valore intrinseco: un pezzo di terra, una fabbrica o centomila lire passando da una persona a un’altra mutano valore. Facendo invece della terra una proprietà noi ci illudiamo di conferirle un valore economico oggettivo e questa menzogna realizzata si ripercuote sulla vita sociale generando squilibri e sperequazioni.
L’attività industriale, invece, non può permettersi, neanche se lo volesse, di lavorare «per sé»: sarebbe una contraddizione intrinseca al processo produttivo stesso. Tra i due poli dell’industria e dell’agricoltura, a metà strada, si pone l’artigianato: per evidenziare anche in questo settore l’illusione del lavorare per sé Rudolf Steiner portò più volte l’esempio del sarto che trova ovvio confezionare lui stesso il proprio abito, senza comprarlo, e crede, così, di risparmiare. Invece questo artigiano contribuisce, anche se in leggera misura, al rincaro generale dei prezzi degli abiti, compreso il suo, nonché dei fili, degli aghi, delle forbici, dei bottoni, delle stoffe ecc. Unito al medesimo agire di altri diecimila sarti, il rincaro del costo degli abiti diventerebbe sensibile per tutti.
Non è però facile capire perché il vestiario si venderebbe meno caro sul mercato se tutti i sarti comprassero i loro propri vestiti dai commercianti! Eppure le cose stanno proprio così. Il commercio, e non l’autarchia, favorisce la massima accessibilità a tutti gli oggetti e a lungo andare l’artigiano stesso, il sarto nel nostro caso, si rende conto che non gli costa di meno l’abito che ha confezionato da sé, perché nei fatti si ritrova a pagare di più tutti i materiali che gli occorrono per produrre anche gli abiti degli altri. Non stiamo qui dicendo che non se lo debba permettere, stiamo dicendo che gli viene a costare di più.
Le due grandi missioni dell’uomo lavoratore
A questo punto vorrei accennare a ciò che chiamerei le due grandi missioni storiche degli uomini lavoratori. Con il termine generale «lavoratori » non intendo riferirmi solo al concetto di «classe lavoratrice» o operaia, che a partire dal secolo scorso si usava per indicare il proletariato. Oggi il lavoratore si trova in tutte le classi sociali, perché ogni essere umano è per più versi un lavoratore. L’unica vera distinzione oggi importante in campo economico non è più quella tra capitalisti e operai, ma tra esseri umani che vivono nel dinamismo del produrre, del fare qualcosa di positivo per gli altri, ed esseri umani che hanno la tendenza a cavar fuori il più possibile dagli altri, facendo il meno possibile.
Questa distinzione ci palesa la sua importanza fondamentale nel momento in cui ognuno di noi sia sincero e spregiudicato con se stesso: la vera linea divisoria tra gli esseri umani è oggi quella che corre tra chi tende maggiormente al farsi servire, al vivere una vita comoda, e chi ricerca maggiormente la gioia del produrre e del prodigarsi per gli altri.
Questi due atteggiamenti interiori fondamentali non hanno in sé nulla a che fare con le classi sociali o con la ricchezza o la povertà: ci possono essere persone senza alcun problema economico che non sanno vivere senza immettere nell’organismo sociale l’apporto produttivo dei propri talenti, e non meno ci sono persone che sfacchinano dalla mattina alla sera controvoglia, solo per campare, e agognano ad uno stato di vita comodo, farcito senza alcuno sforzo di tutto quello che non possiedono.
Le due grandi missioni storiche dell’uomo lavoratore si riferiscono all’interazione dell’essere umano con la macchina. Anch’essa si è svolta in due fasi, entrambe decisive per il rapporto dell’uomo con il suo lavoro:
1. nel diciannovesimo secolo, in seguito alla rivoluzione industriale, milioni e milioni di esseri umani vennero strappati dal contesto culturale tradizionale del loro lavoro, vecchio di secoli e millenni, e proiettati verso l’anonimia ammaliante delle città: con l’ideale della produzione tramite strumenti meccanici, con l’ideale della libertà che li affrancava dalla servitù della gleba e dall’artigianato tradizionale. La macchina era sorta per dare lavoro e libertà a tutti. La macchina fu vista come una grande benedizione…;
2. oggi, agli albori del terzo millennio, siamo all’inizio della seconda grande fase del rapporto umano con la macchina: essa porta via sempre più inesorabilmente il lavoro all’uomo.
Tutti noi abbiamo riferimenti di esperienza diretta per comprendere le dinamiche se pur incipienti di questa seconda fase, ma ci è più difficile ricostruire ciò che è avvenuto interiormente nella prima: l’intensità della trasformazione delle consuetudini di vita; l’improvviso ampliamento del contesto di lavoro a spazi non più controllati dai parenti, dai vicini, dai compaesani; la straordinaria fioritura delle speranze in un avvenire lavorativo tutto da scoprire e da inventare.
Quali sono allora le due grandi missioni dell’uomo lavoratore nel suo rapporto con la macchina?
1. Gli operai che lavoravano alla macchina durante il primo periodo ebbero la missione sociale di lasciare da parte l’arte, la cultura, la religione tradizionali (considerandole «ideologie» e «oppio del popolo») per fondare tutta l’esistenza su una visione scientifica e oggettiva delle leggi economiche. Le altre classi – borghesia, nobiltà e clero – conservavano invece retaggi di arte, di cultura e di religione che, pur vivendo nella sfera del sentimento, costituivano orientamenti e sostegni per la vita quotidiana.
La classe operaia rigettò della tradizione tutto ciò che appariva ai suoi occhi una menzogna, un lusso, e fu capace, accanto al duro lavoro quotidiano, di dedicare il cosiddetto tempo libero a una visione tutta scientifica della vita: e poco importa, a questo proposito, che l’impulso a un tale sforzo venisse, originariamente, da chi aveva una formazione culturale cosiddetta borghese.
Il marxismo è stato uno dei fenomeni più strabilianti della storia: operai le cui forze venivano succhiate da orari di lavoro disumani, trovavano la forza di dedicare il poco tempo libero a lunghe riunioni dove si appropriavano di una scienza materialistica rigorosa e complessa, depurata da ogni tradizione ritenuta non scientifica e alienante, da ogni prepotenza di una cultura che addormenta i più deboli. L’operaio moderno fu così il primo essere umano a fondare l’esistenza esclusivamente su una visione scientifica del mondo.
2. Coloro che nell’umanità odierna sono i più attivi e operosi, coloro che senza distinzione di classi sociali subiscono la disoccupazione di massa per via di quelle stesse macchine che al loro comparire avevano moltiplicato le occasioni di lavoro, costoro hanno ora una seconda, grande missione da compiere: quella di creare e coltivare un nuovo tipo di scienza, non materialistica, ma dello spirito.
Di fronte al fenomeno contemporaneo della disoccupazione di massa, può sorgere proprio nei lavoratori più desti e dinamici la consapevolezza tutta nuova che non si tratta di retrocedere a un ideale di piena occupazione lavorativa in senso tradizionale, ma che l’esubero delle forze attive dovrà essere destinato alla costruzione non meno impegnativa di una moderna scienza dei mondi spirituali, non meno oggettiva e rigorosa della scienza che indaga il mondo visibile.
Solo chi vive un profondo desiderio di lavorare, desiderio che non può più trovare immediata risposta negli spazi ormai saturi del materialismo unilaterale, solo questo essere umano può sentire il profondo bisogno di una nuova scienza capace di trasformare la vita aprendola a dimensioni di operatività umana tutte nuove.
Solo chi abbonda di forze volitive perché gioisce del lavoro o sente la pena dell’inattività forzata sarà in grado di contrapporre all’antica esigenza dell’occupazione piena, l’aspirazione alla vita piena. È la vita che vuol essere piena, non l’occupazione. Il rimpianto di quei sindacati che vorrebbero ritornare alla garanzia di ore e ore di occupazione giornaliera è un triste anacronismo: dobbiamo avere il coraggio di andare avanti e affrontare la realtà oggettiva. Non più l’occupazione deve essere piena: è l’essere umano che vuol vivere nella sua vera «pienezza» in quanto essere non solo materiale ma anche e soprattutto spirituale.
Una piena occupazione che intenda impegnare tutti in otto ore di lavoro quotidiano non è più possibile: dissangueremmo l’organismo sociale pagando salari per lavori inutili se non addirittura nocivi. Ancora una volta pagheremmo il lavoro e non il prodotto del lavoro. Si tratta invece di distribuire in modo umano ciò che compete all’uomo. Non è un evento arbitrario o casuale che la macchina sia stata creata per svolgere lavori meccanici: li fa meglio di noi, proprio perché l’attività meccanica non è specifica dell’uomo. Quanto più la macchina prende su di sé, favorendo l’uomo, il lavoro meccanizzato, tanto più restano all’uomo il tempo e le energie per ciò che non è meccanico, per l’esercizio di ciò che è libero e più umano.
Qual è allora la differenza fondamentale fra la macchina e l’essere umano? È proprio la libertà. Io non credo che sia giustificato il risentimento nei confronti del computer, capace di calcoli e operazioni imponenti: per quanto possa sfornare ed elaborare una quantità ingente di dati, un computer non può tuttavia mai scegliere liberamente. Anche se Deep Blue vince la partita a scacchi, non lo sa neppure. Invece in ogni minimo atto di pensiero, in ogni sua più piccola decisione l’essere umano manifesta la sua sovranità nei confronti della macchina: tutto sta a vedere se egli sarà capace di innamorarsi di questa libertà e di esercitarla sempre di più, oppure se cederà alla seduzione della logica inorganica, mineralizzata e inerte della macchina da lui costruita.
Una macchina può avere miliardi di funzioni ma si limita, appunto, a funzionare: non può avere una sola vera intuizione pensante, non può creare, non può godere del bello, non può amare. Essa esegue o al massimo assembla, giustappone, classifica. L’essere umano è una miniera inesauribile di talenti perché può vivere nella creatività assoluta della libertà, se vuole. Egli soltanto intuisce davvero il vero, egli soltanto può godere con intimo gaudio il bello, egli soltanto sa amare con forza soave tutto ciò che è buono.
Lavoro utile, lavoro inutile, lavoro nocivo
In tempi di disoccupazione di massa dobbiamo distinguere, come già accennavo, almeno tre tipi fondamentali di lavoro: il lavoro utile, il lavoro inutile, il lavoro nocivo. Il lavoro utile e vero, l’abbiamo detto più volte, è quello che produce qualcosa di giovevole per la comunità umana; il lavoro inutile o fittizio non produce nulla e crea l’illusione dell’occupazione mentre genera salari parassiti; infine il lavoro nocivo immette nell’organismo sociale prodotti deleteri e danneggia direttamente la comunità umana.
Prendiamo il classico esempio della produzione di armamenti: alle proteste di chi chiede la chiusura e la riconversione delle fabbriche di armi si risponde sempre (oltre al ritornello della necessità di difendersi) che si perderebbero al contempo molti posti di lavoro e che la riconversione non è cosa semplice. Ma che cosa immette nell’umanità una fabbrica di mitragliatrici? Prodotti che favoriscono il disumano e dunque l’involuzione. Non è lo stesso, in fondo, per il traffico di droghe, per la produzione di sigarette e per tante altre cose?
Questa questione va lasciata per molti versi aperta, naturalmente: non è possibile fare un ingenuo elenco dei prodotti «buoni» e dei prodotti «cattivi»; la realtà non è mai tutta semplice e di immediata collocazione in comodi schemi conoscitivi. Ma proprio per questo è importante acquisire orientamenti di fondo e sapere che esistono veramente lavori per natura umanizzanti e lavori per natura disumanizzanti.
Pensiamo, cambiando registro, a tutto il lavoro quotidiano che c’è dietro alla stampa: un impegno ciclopico! Ma subissare la società di giornali e di riviste è un lavoro senz’altro tutto positivo? Anche gli effetti della televisione sono tutti positivi? Per non parlare dei problemi terribili che comincia a creare il fantomatico Internet, soprattutto nei confronti dei bambini… E come se le guerre non bastassero ora si aggiungono le sofisticate guerre dell’informatica, a base di irruzioni nelle banche-dati più segrete e nevralgiche per le istituzioni di un Paese (info-war).
Positivo è ciò che ci pone nella condizione di avere informazioni oggettive su ciò che succede nel mondo; è nocivo ciò che diventa strumento di manipolazione, di mezza o di falsa informazione.
Si tratta allora di distinguere due atteggiamenti di fondo ben diversi: il primo mira coscientemente al servizio dell’uomo; l’altro intende raggiungere non meno coscientemente ben altri scopi. Diventa allora sempre più importante non considerare il lavoro umano in modo generale e astratto, ma discernere guardando concretamente all’uomo che lo compie. Il lavoro non è mai neutro o reso comunque positivo dal semplice fatto che serve per la pagnotta. È necessario osservare ciò che viene oggettivamente immesso nell’umanità in base a ogni lavoro che viene compiuto.
Un lavoro che diventerà sempre più importante è quello della cosiddetta assistenza sociale. È il lavoro dell’attenzione e dell’interesse diretto degli uni verso gli altri. È la pura gioia dell’interazione umana, la gioia dell’incontro. Accanto all’educazione dei bambini diventerà sempre più importante la cura dei malati e degli anziani: non soltanto perché avremo uomini sempre più longevi, ma anche perché disporremo sempre più di tempo libero da dedicare alla qualità specificamente umana della vita e dei rapporti tra le persone.
È altrettanto evidente, però, che l’organismo sociale avrà bisogno di persone che facciano bene e con gioia questo tipo di lavoro! Se infatti è ancora comprensibile che in un’industria qualcuno lavori soltanto per la paga, è una contraddizione intrinseca ed è disumano assistere un anziano o un malato unicamente per la paga. È inerente all’assistenza sociale che la motivazione di scelta lavorativa sia la benevolenza, l’amore per l’umano che vive in noi e nell’altro. Siamo qui di fronte a un lavoro la cui qualità è eminentemente libera, del tutto opposta a quella meccanica e di necessità svolta dalle macchine.
Ciò infine ci porta a capire che il lavoro più bello e terapeutico è quello che svolgiamo su noi stessi. Ma qui arriviamo al limite del concetto stesso di lavoro, che da fatica diventa pura beatitudine, pura realizzazione di sé, coltivazione gioiosa del regno umano.
L’evoluzione dell’idea di giustizia:
da Tommaso d’Aquino a oggi
Abbiamo detto che per liberare la legislazione sul lavoro dalla servitù dell’economia bisogna riconsegnarla alla sua giusta sfera, quella giuridica. Da ciò consegue che nella sfera economica non dovranno più esserci «contratti di lavoro», ma solo «contratti di produzione», cioè accordi di natura prettamente economica riguardo a ciò che il cosiddetto imprenditore e il cosiddetto lavoratore intendono produrre insieme. Il contratto di lavoro in quanto tale non è stipulabile in campo economico perché riguarda la sfera giuridica dei diritti e dei doveri da far valere in base alla pari dignità di tutte le persone umane.
Può essere utile, per approfondire questo argomento, seguire Tommaso d’Aquino nella sua elaborazione del concetto di giustizia, che riprende Aristotele aggiungendo però elementi nuovi che al tempo dei Greci erano prematuri nell’evoluzione dell’umanità.
La giustizia è vista come una virtù, dunque una capacità umana, un habitus che permane costante nel tempo. Tommaso chiama giustizia «la perpetua e costante volontà di attribuire a ciascuno il suo». È questa la più alta formulazione medievale di ciò che noi oggi chiamiamo il riconoscimento di pari diritti e pari doveri a tutti gli esseri umani, in quanto esseri umani.
Ma come si fa a dare a ciascuno il suo? Non è una cosa semplice: richiede a monte un criterio per discernere che cosa appartenga a ciascuno per poi attribuirglielo. Tommaso distingue a questo scopo tre forme fondamentali di giustizia:
1. justitia commutativa,
2. justitia distributiva,
3. justitia legalis o generalis.
1. La giustizia commutativa è l’ordo partium ad partes, cioè il giusto rapporto delle parti con le parti. Essa ordina le modalità di scambio fra gli esseri umani singoli: mi dai tanto, tanto ti do. Qui vige e viene tutelato il rapporto di parità tra membro e membro nell’organismo umano. È un tipo di giustizia che si esprime particolarmente nell’economia di scambio.
2. La giustizia distributiva è l’ordo totius ad partes, cioè il rapporto di armonia che va dalla totalità unitaria dell’organismo alle parti singole. È l’operare dell’organismo nella sua unità, in grado di attribuire ad ogni organo il suo giusto posto e la sua giusta funzione.
Tommaso dà per scontato che vi sia un Essere unitario dell’umanità in quanto organismo unico il quale distribuisce fra gli uomini, membri viventi dell’organismo, i talenti, conferendo a ciascuno il suo compito specifico. Il rappresentante e l’esecutore terreno di questa giustizia unitaria e armonica che attribuisce a ogni essere umano «il suo» era a quei tempi il papa o l’imperatore.
In fondo, ogni essere umano viene al mondo in chiave di giustizia distributiva. Ciascuno di noi è il ricettacolo e porta il sigillo di questa giustizia che è l’effetto del rapporto del tutto, cioè dell’organismo intero, con le sue parti. Ognuno di noi ha ricevuto la sua giusta e individuale porzione d’umano, la sua missione specifica di vita, il compito terreno in seno all’umanità che porta in sé nascendo. Come la giustizia commutativa ha il carattere di equo scambio fra le parti, così la giustizia distributiva ripartisce imparzialmente le funzioni fra tutti i singoli membri. Li fa tutti ugualmente partecipi dell’unico organismo, conferendo loro, così, pari dignità.
3. Tommaso lascia il terzo tipo di giustizia, quella «generale» o «legale», un po’ in secondo piano: è l’ordo partium ad totum, l’ordine, il rapporto delle singole parti verso il tutto. La prospettiva è qui l’inverso della precedente. Siccome ai tempi di Tommaso la capacità dei singoli esseri umani di cogliere la realtà complessiva e unitaria dell’organismo di una comunità o addirittura dell’Umanità intera era appena incipiente, si concedeva soltanto al re o al papa il privilegio di accogliere e interpretare l’ordine divino, di avere un reale sguardo d’insieme sul tutto e di assumerne vicariamente la responsabilità.
La grande novità delle forze della coscienza morale dell’uomo moderno consiste nella sua capacità sempre crescente di porre in primo piano proprio il terzo tipo di giustizia. Egli viene posto sempre maggiormente in grado di cogliere conoscitivamente la realtà unitaria dell’Umanità. Sorge così in lui sempre di più la capacità di individuare il proprio posto e la propria funzione in relazione al tutto. L’amore del singolo per l’umanità intera diviene in questo modo sempre più cosciente e concreto: il singolo vive il giusto rapporto con l’intero organismo donando tutto a tutti nella consapevolezza che ognuno di noi nel corso dell’evoluzione ha ricevuto tutto da tutti.
Un esempio fondamentale di questa concertata reciprocità, di questa volontà associativa in campo giuridico di giustizia, dove il singolo assume sempre più la responsabilità nei confronti della totalità della comunità umana – non più vista come un gruppo anonimo e omogeneo, ma in quanto complessamente articolantesi in membri viventi del tutto individuali –, risiede nella capacità di prendere coscienza del fatto che ogni essere umano in quanto tale ha diritto a tutto il necessario per vivere con dignità umana. Questo diritto è per sua natura del tutto indipendente dal fatto che egli sia o no «produttivo» per la collettività.
Siccome il fondamento necessario per un’esistenza degna dell’uomo riguarda soprattutto i bisogni legati alla sfera corporea (un tetto sulla testa in un ambiente salubre, il cibo, il sostentamento e le cure in caso di malattia, ecc.), una società si mostrerà tanto più moralmente matura quanto più in ogni singolo vivrà la coscienza che è cosa giusta conferire a tutti una base materiale sempre più «umana». Ciò potrà poi anche essere realizzato perché coloro che vogliono ben di più che non il necessario per vivere cercheranno questo di più non in un ulteriore accumulo di beni materiali – che così verrebbero a mancare per gli altri – ma nella qualità specificamente umana della vita.
Possiamo allora dire che il minimo a cui ognuno ha diritto per legge, al fine di vivere degnamente in quanto essere umano, consiste in ciò che una data società è in grado di distribuire a tutti in modo uguale, indipendentemente dalla produttività del singolo in campo economico.
Ciò significa che il singolo è chiamato, nel corso della sua evoluzione, a una comprensione sempre più profonda di ciò che il cristianesimo chiama il «Corpo mistico del Cristo». L’essere umano singolo è chiamato a rendersi sempre più personalmente responsabile dei destini dell’umanità intera nonché dell’evoluzione della Terra.
La lavanda dei piedi:
fenomeno archetipico del «lavoro» umano
Nel vangelo di Giovanni il Cristo lava i piedi ai dodici apostoli, Giuda compreso. Che cos’è la lavanda dei piedi? È un lavoro? È una prestazione di servizio? È una produzione di merce? È una espressione creativa di talenti?
Questo gesto porta in sé il carattere di fenomeno primigenio, come direbbe Goethe: mostra la qualità che acquisisce il cosiddetto lavoro quando diventa espressione di pura umanità. Esso è ad un tempo utile prestazione di servizio, puro esercizio di talento, somma espressione d’amore per la pari dignità di ogni persona umana (Giuda compreso!).
L’essere umano umanizza se stesso massimamente quando compie tutto ciò che compie con l’atteggiamento interiore della lavanda dei piedi. Essa è l’immagine sacramentale, il risvolto religioso della divisione del lavoro: ciascuno lavora per gli altri e, con l’offerta del proprio lavoro, pone l’altro in grado di camminare coi suoi propri piedi, di progredire lungo il cammino della propria evoluzione individuale, aiutando a sua volta gli altri.
La lavanda dei piedi è un fenomeno di puro amore all’azione, quale più alta autorealizzazione della persona umana. È questo il nuovo modo di lavorare – che vince la mentalità dell’arraffare per sé e dell’egoismo esclusivo – quale ci viene richiesto in modo pressante dall’economia moderna.
Che cosa significa allora permanere nell’illusione che sia possibile lavorare solo per sé a svantaggio altrui? Significa votarsi alla scontentezza e alla solitudine. Infatti, se fosse vero che l’essere umano è stato creato per lavorare solo per sé, dovremmo, facendolo, essere tutti felici. Come mai, allora, c’è nel mondo tanta rassegnazione, tanta tristezza, tanta infelicità?
Non sarà forse che l’essere umano, nella sua più alta natura spirituale, è volto proprio a lavorare per gli altri, e quando lavora solo per sé deve necessariamente creare una somma infinita di dolore e di mancanza di senso? Deve essere questa la conseguenza del voler lavorare solo per sé, se è vero che l’essere umano non è fatto per lavorare unicamente per sé, ma per tutti. Il cosiddetto amore per il denaro, che è l’espressione più comune del lavorare per sé, è l’origine profonda della rinuncia all’umano, del rinnegamento delle forze di solidarietà, della mortificazione evolutiva, della solitudine endemica.
I dodici apostoli, che rappresentano i dodici segni dello Zodiaco, rappresentano al contempo tutta l’umanità. L’Essere pieno di amore – ogni essere umano che davvero ama – lava i piedi a tutti, rende capace di ulteriore cammino evolutivo l’umanità intera. Questo è il senso più profondo di ogni lavorare, di ogni operare davvero umano.
L’opus magnum dell’evoluzione
Esisteva, nel passato, la mentalità del lavorare solo per sé, per la propria paga? Molto meno di oggi. Nel Medioevo, per esempio, una delle gioie più comuni era la soddisfazione artigianale, la consapevolezza di produrre qualcosa di così bello e ben fatto che avrebbe costituito soddisfacimento anche per il committente. Un buon artigiano non misurava le sue capacità solo in base al guadagno, ma anche in base al pieno adempimento delle richieste del cliente: e preferiva spesso rifare daccapo e gratis il lavoro, piuttosto che mandare via qualcuno insoddisfatto. È stata questa la forza sociale che ha fatto sorgere non solo maestose cattedrali e incantevoli dipinti, ma anche tavoli, sedie, cassapanche, letti, finestre, porte, chiavi e chiavistelli che noi oggi neanche ci sogniamo con quella funzionalità, robustezza e perfezione di progetto, per non parlare della bellezza artistica!
Più d’uno di noi avrà fatto l’esperienza, almeno nel passato, di quel tipo di barbiere che taglia i capelli esclamando ad ogni piè sospinto: uhmm, che taglio perfetto! Ad ogni incrocio di lame è contento: ahhh, che bella sforbiciata! Si loda da solo! E non mira mica a sminuire gli altri barbieri, no! Esprime solo la gioia tutta umana e schietta di fare bene ciò che fa e di far contento l’altro.
La gioia artigianale che consentiva di essere presenti a tutte le fasi di lavorazione di un oggetto è stata pressoché cancellata dalla divisione del lavoro e dalla produzione industriale a catena di montaggio. È inutile rimpiangere l’antica salute del lavoro, intimamente legata alla soddisfazione del fare bene qualcosa per far contento l’altro. Dobbiamo trovare per il futuro motivazioni al lavoro tutte nuove e di tutt’altra natura.
Tramontato l’antico lavorare per la gioia condivisa del buon prodotto, superato il moderno ed egoistico lavorare per la paga, cosa potrà motivarci nel lavoro futuro? L’unica realtà che può validamente sostituire il riferimento diretto al prodotto – che consentiva fierezza e soddisfazione in un certo senso ancora estrinseche, perché evocate dalle cose – dovrà essere la gioia stessa di esercitare i propri talenti a servizio dell’umanità in quanto tale. La forza propulsiva del lavoro nel futuro dovrà essere l’amore verso l’essere umano, per il solo motivo che è un essere umano, cioè per l’umanità che tutti ci accomuna.
Anche se io, operaio della FIAT, non potrò mai partecipare all’intera costruzione di un’automobile e non potrò mai godere della gioia di colui che l’acquisterà e sarò perciò privo di qualunque soddisfazione personale diretta, tuttavia potrò riconquistare lo slancio del produrre quando sentirò di essere inserito nell’organismo vivente dell’umanità intera e avrò la certezza interiore di contribuire col mio lavoro al meglio della sua evoluzione. L’essere umano moderno, mentre lavora, è chiamato a rinunciare a ogni riferimento ancora egoistico all’oggetto materiale del suo impegno e a coltivare sempre di più la dedizione del cuore alla costruzione dell’umano.
Il fruitore del suo lavoro, che egli non incontra più esteriormente, deve rinascergli dentro grazie all’amore per quell’umanità che è anche la sua. La forma moderna dell’amore per il prossimo è l’amore all’umanità. Da lontana dal nostro cuore che è, l’umanità va resa «prossima» nella decisione quotidiana di prenderla a cuore.
Chi pensa che queste considerazioni non siano rilevanti in campo economico, chi le ritiene astratte o avulse dalla vita, non comprende il grande avvenire dell’economia. L’uomo non potrà reggere a lungo la condizione di triste burattino in mano a pochi burattinai, e se vorrà uscirne dovrà far leva sulle sue forze interiori e profonde di essere umano, le sole che potranno aiutarlo a distinguere tra ciò che lo promuove e ciò che lo distrugge.
L’amore per l’Umanità che vive in ogni singolo uomo porta con sé l’amore per tutta la Terra e per tutte le creature. Come ci è stata tolta la possibilità di gioire con un residuo di egoismo per la cura relativa a un prodotto singolo tutto opera nostra, così ci viene data la possibilità di sostituirla con l’amore per tutte le creature e per tutte le cose, sul cui sacro fondamento l’Umanità intera cammina. L’opus magnum, l’opera grande dell’evoluzione umana, il lavoro di tutti i lavori, sarà allora la trasformazione e la «transustanziazione» della Terra nel corpo risorto di un’Umanità intrisa di amore e di libertà, che si accinge a mete evolutive sempre nuove.
Quarto capitolo
LO SPIRITO ASSOCIATIVO
IN ECONOMIA E IL SUPERAMENTO DEL PARASSITISMO
«Essere se stessi» quale vera salute
dell’organismo economico
Per un sano funzionamento della vita economica nell’intento di vincere la tendenza all’inerzia interiore, al parassitismo e all’apatia, è di particolare efficacia il sorgere e la diffusione di ciò che ho chiamato lo spirito associativo: esso permette di riaccendere quel dinamismo sociale che non può mai essere automatico, né acquisito senza sforzo, visto che la sua essenza vera e propria è la libertà. Le riflessioni che ora seguono intendono ulteriormente approfondire lo spirito associativo in campo economico.
Uno dei quesiti più importanti del convivere sociale moderno è questo: come si può impostare la vita economica così da aiutare tutti a sentire la gioia dell’essere produttivi? Abbiamo detto che non basta predicare la necessità del dinamismo interiore o mostrare solo in teoria che è indispensabile l’apporto creativo di ogni singolo individuo nella sfera economica: bisogna mettere in atto ciò che realmente è in grado di promuovere e favorire la creatività individuale in campo economico.
L’aiuto morale più efficace è sempre stato il sano contagio. Il contagio al positivo, il contagio morale, è un fondamentale fenomeno psicologico e sociale che ha valore in ogni contesto e non meno in quello economico: sostituisce nell’epoca nostra il vecchio, fastidioso e spesso moraleggiante concetto del «buon esempio» che tutt’al più, previa sottile mortificazione, induceva a una rigorosa e spesso alienante emulazione.
Nell’economia divenuta globale, dove o ci salviamo tutti o non si salva nessuno, è sommamente auspicabile l’essere esposti al contagio, privo di contrizioni e sensi di colpa, che può sopravvenire in presenza di esseri umani che sono schiettamente contenti di operare creativamente e irradiano una letizia impagabile nell’esercizio a volte anche faticoso dei propri talenti. Ciò è molto più efficace che arrabattarsi da soli per cercare di capire in linea teorica e astratta chi ce lo fa fare a lavorare. Ma dove sono, oggi, questi sani contagiatori? – ci si chiederà.
Ritorniamo al concetto di organismo: uno degli assunti fondamentali delle nostre riflessioni è che l’Umanità è in realtà un organismo unico e che di questa verità è testimone e portavoce in modo palese proprio l’economia: essa, per prima e per la prima volta nella storia, si esprime ed opera realmente a livello mondiale, sovranazionale e unitario.
In un organismo la somma complessiva delle capacità funzionali di tutti gli organi corrisponde perfettamente alla somma totale dei bisogni degli organi medesimi, e cioè dell’intero corpo. E che cos’è la salute? È quel modo di funzionare ideale grazie al quale i reni, i polmoni, il cuore, il fegato, il cervello ecc. si esprimono nella purezza del proprio essere: fanno bene ciò che sanno fare, ciò che sono preposti a fare. Sono in tutto e per tutto se stessi.
Se è vero che l’Umanità è stata concepita come un organismo vivente e unitario, la sua legge di sano funzionamento dovrebbe essere che i bisogni di tutti vengono adeguatamente appagati dall’espressione dei talenti di tutti. L’alternativa sarebbe che l’umanità non sia per natura un organismo unitario e che perciò non sia affatto possibile conseguire un’armonia, perché certe parti o porzioni sono per natura in opposizione ad altre. In questo caso sarebbe assurdo, cioè impossibile, l’anelito profondo all’armonia, che invece fa parte proprio della sana natura umana.
L’appagamento dei bisogni di tutti i membri di un organismo è allora proprio la diretta conseguenza dell’espressione dei talenti e delle funzioni specifiche dei membri stessi. Per ogni singolo membro si tratta, più che di «fare» qualcosa, di «essere» veramente e genuinamente se stesso. Anche in campo economico, analogamente, la responsabilità produttiva e operativa del singolo nei confronti della comunità umana si traduce in un atteggiamento di fondo che è l’essere se stesso.
Dove ognuno è veramente se stesso, l’umanità è sana; è malata quando alcuni o molti esseri umani non sono autentici. La salute dell’organismo economico non comporta tanto qualcosa di speciale da fare, ma si incrementa grazie allo sforzo continuo da parte di tutti di essere sempre più autenticamente se stessi. La chiave di funzionamento dell’economia umana è dunque che ognuno diventi sempre di più la manifestazione pura, semplice e piena dell’essere suo: avremo così sempre di più un’umanità dove ogni membro compie, proprio perché gli si confanno, le funzioni che meglio servono all’intero organismo. L’organismo è sano non quando ognuno fa senza volerlo ciò che deve, ma quando ognuno liberamente vuole ciò che deve agli altri, in quanto è insito nel suo essere.
È importante allora considerare l’appagamento dei nostri bisogni come una conseguenza dell’esserci almeno sforzati di conoscere ed esercitare i nostri propri talenti! Se noi miriamo direttamente e unicamente al soddisfacimento dei bisogni trascurando i talenti, i conti non torneranno perché non riusciremo mai a stabilire quali siano i nostri reali bisogni. Non dimentichiamo, infatti, la trappola dei tanti bisogni indotti. Di che cosa ha veramente bisogno ciascuno di noi? In chiave di organismo dobbiamo rispondere: dei talenti di tutti gli altri.
Ponendo in primo piano i talenti, cioè le potenzialità intrinseche e positive dell’essere di ognuno, cerchiamo e privilegiamo per tutti lo sforzo di conoscere sempre più intuitivamente ciò che ognuno si è preposto di immettere dentro all’organismo dell’umanità. Questa dimensione propositiva e fattiva della vita apre le porte alla comprensione del fatto che la fedeltà al proprio essere, alle proprie capacità più vere e profonde, è al contempo il modo migliore di servire e aiutare gli altri e di appagare volentieri i loro veri bisogni.
È perciò un requisito fondamentale dell’economia che nessuno di noi si lasci ricattare direttamente da bisogni, reali o presunti, per i quali egli non ha talenti. Ognuno di noi ha il dovere e il diritto di prendere sul serio i bisogni altrui soltanto quando trova in sé una corrispondenza ben precisa di talenti propri. Chi ha bisogni che non si riferiscono oggettivamente a capacità che io ho dentro di me, occorre che si rivolga, per l’appagamento, ad altri esseri umani. Allo stesso modo l’organismo non pretende dal cervello ciò che deve fare lo stomaco.
Conoscere i propri talenti
per individuare i propri bisogni reali
Abbiamo visto che è povera un’umanità che si fissi sui bisogni: è una umanità eternamente «bisognosa», che rimane al livello naturale dell’animale, poiché la sfera dei bisogni è quella che abbiamo in comune con gli animali. L’animale è infatti una somma di bisogni e di istinti. Gli istinti sono in lui non solo l’elemento di natura, iscritto nella sua specie e utile all’appagamento dei bisogni, ma sono anch’essi un bisogno: l’animale non può fare a meno di sfogare tutti i suoi istinti. Quando l’animale appaga i suoi bisogni-istinti è soddisfatto: sta bene, non chiede altro, manifesta completamente il suo essere attraverso le caratteristiche propulsive (istintuali) della sua specie di appartenenza. Potremmo metaforicamente dire che la sua specie è «felice» così: non le manca nulla.
L’uomo è invece una somma di talenti individuali oltre che di bisogni di specie. Le libere potenzialità artistiche, creative e conoscitive fanno di lui un essere per il quale l’appagamento dei bisogni è solo il presupposto e la condizione necessaria per espletare i suoi talenti individuali. Ogni uomo, infatti, è specie a se stesso. La felicità umana, allora, non può risiedere nel mero appagamento dei bisogni condivisi da altri o da tutti gli uomini (fame, sete, sonno ecc.) perché, a seconda dei suoi specifici talenti, ognuno dovrà specificare ulteriormente anche i suoi bisogni.
È un’astrazione allora pensare che esista un modello di felicità e di appagamento che vada bene per tutti. È un’illusione cercare soluzioni per il benessere sociale in base all’osservazione della sfera dei bisogni generalizzati. Solo promuovendo l’esperienza concreta dei miei talenti individuali avrò la percezione reale di ciò di cui ho bisogno per poterli esplicare.
Se io ho attitudine per la geologia, ad esempio, posso vivere felice unicamente da buon geologo. Scoprirò di avere desiderio e necessità di viaggiare per luoghi particolari della Terra, di visitare qua e là centri di raccolta di minerali, di avere a disposizione testi scientifici di meteorologia piuttosto che altri, di partecipare a convegni dove sia possibile confrontare le mie esperienze con quelle dei colleghi, di passare un mese in qualche miniera, di sorvolare in elicottero zone particolarmente interessanti per avere una visione d’insieme dei corrugamenti della litosfera… e avrò bisogno di una certa disponibilità di denaro, che sarà per me non vaga e indistinta, ma ben specifica. E magari non me ne importerà niente se la mia abitazione sarà piccola e situata in un quartiere rumoroso e «trafficato» della città.
Se, invece, io porto in me il talento del pianista, la musica cambia! Diventerà forse per me imprescindibile l’esigenza di vivere in una casa silenziosa, con stanze ampie dove i suoni non rimbombino, possibilmente un po’ fuori dalla città, ma non tanto da impedirmi di dare lezioni private; e poi avrò bisogno di conoscere e studiare col tale e talaltro maestro per perfezionarmi, avrò bisogno di riferirmi a qualche struttura che si occupi di organizzare concerti, avrò bisogno di stabilire rapporti con case discografiche… e tutto questo mi parlerà anche di costi economici reali.
E il talento, l’arte, di essere un buon impiegato all’Ufficio Postale (visto che il vocabolo «talenti» si riferisce a tutte le capacità umane, non solo a quelle ritenute straordinarie) quali bisogni reali susciterà? È chiaro che non esistono risposte generali e che soltanto i singoli impiegati potrebbero rispondere: ma forse un bisogno primario, cioè condiviso da tutti i lavoratori delle Poste, potrebbe essere quello di non dover sottostare a un’asfissiante burocrazia e di poter esprimere individualmente e liberamente le proprie qualità organizzative non solo esecutive. L’impaccio burocratico di base, che è uno dei risvolti più tipici del dirigismo statale, impedisce infatti all’impiegato stesso di individuare quali siano i propri veri talenti nonché di sceverare i propri reali bisogni.
Inoltre, proprio chi svolge lavori di tipo impiegatizio potrebbe forse meglio di altri comprendere la natura del tempo libero e dell’affacciarsi dell’impegno di tipo spirituale e creativo: già oggi infatti la categoria degli impiegati è quella che più d’ogni altra si dedica ai cosiddetti hobby, surrogato spesso materialistico e spurio dell’esigenza umana di cimentarsi con ciò che va oltre la pura sopravvivenza materiale.
Dirigismo statale e dinamismo associativo
L’associazione in campo economico è il luogo della più pura interazione tra bisogni e talenti. Lo spirito associativo ha, nella vita economica, il compito di mantenere sano l’intero processo economico di produzione, di distribuzione e di consumo riconsegnandolo sempre di nuovo agli esseri umani e ai loro infiniti talenti. Esso si contrappone in tutto e per tutto al centralismo e al dirigismo di tipo statale, perché il suo modo di operare tende per natura a liberare l’economia da ogni assoggettamento alla sfera politica.
C’è un abisso tra le legiferazioni e i decreti dello Stato, che intendono imporsi all’economia considerandola uno strumento del proprio potere, e lo spirito di solidarietà associativa che si instaura grazie alla cooperazione umanissima e diretta del produttore, del consumatore e del commerciante fra di loro, vissuta nell’amore sia per i talenti (e per la produzione) sia per i bisogni (e per il consumo) di tutti.
La vita economica viene del tutto stravolta, paralizzata e avvelenata qualora le si impongano modi di funzionare, regolamenti di gestione e mete operative secondo scopi modellati su ciò che lo Stato si propone di raggiungere attraverso l’economia.
L’embargo, per esempio, uno degli strumenti politici che spesso oggi bloccano e guastano l’economia di intere nazioni (Cuba, Iraq ecc.) col pretesto di tutelare la pace nel mondo, è una follia micidiale e anacronistica che deriva dall’ingerenza della sfera giuridica in quella economica. Analogamente vanno considerati tutti i tipi di finanziamento o di sovvenzione statale. In altre parole, l’economia di Stato è oggi in contraddizione assoluta col fatto reale – e che non ammette alternative – di un’economia divenuta mondiale. Ciò per il fatto che l’economia mondiale è una sola – come anche l’umanità –, mentre gli Stati sono molti e tradizionalmente con mire per natura antagonistiche gli uni nei confronti degli altri. Nulla è più disumano e fuori tempo nell’umanità attuale che il parlare di «interessi nazionali» o statali.
Si ottiene un velenoso ibrido tra la sfera economica e quella giuridica qualora siano le leggi dello Stato a decidere ciò che si deve produrre e in quale quantità, quando e come vanno cambiati i prezzi, quali programmi televisivi bisogna mandare in onda ecc. Ma perché mai è così?
Il carattere fondamentale di una legge è il suo valore generale. Una legge è legge quando vale per tutti e in tutti i casi che essa comprende. Le stesse eccezioni devono servire a confermare la regola, cioè la legge. Per questo motivo l’iter per cambiare una legge dello Stato è lungo e macchinoso, legato alla storia stessa di un popolo. Una legge che valga una volta sola o per un caso solo non è una legge.
È compito specifico della sfera giuridica, dello Stato, al suo interno e nel dialogo con altre unità giuridiche, stabilire diritti e doveri validi per tutti, emanare norme generali per ordinare, a vantaggio di tutti, ciò che la civiltà umana via via conquista e propone nella vita sociale.
Prendiamo il fenomeno dell’immigrazione di massa dai Paesi cosiddetti sottosviluppati, o dilaniati dalla guerra cosiddetta civile, verso i Paesi più industrializzati: sorgono serie responsabilità giuridiche nei confronti di chi viene dall’America Latina, dall’Africa, dall’Asia, dall’Albania, dalla Russia...
Le improvvise difficoltà sociali in cui vengono a trovarsi i Paesi ricettori (stabilire i controlli, i modi e i tempi di accesso in sintonia con la capacità di ricezione; tutelare gli immigrati dallo sfruttamento e i cittadini dalla disperazione a volte violenta degli immigrati, ecc.) inducono a pensare che esse siano risolvibili esclusivamente in termini di legge: a ben vedere esse sono, invece, proprio il risultato di un’attività politica internazionale (e quindi di natura giuridica) che ha snaturato lo svolgimento dei suoi compiti specifici intorbidandoli con prepotenze e imperialismi di stampo economico e culturale.
Gli Stati dovrebbero comprendere che è necessario affidare da un lato alla solidarietà della sfera economica e dall’altro alla libertà della sfera culturale (perché sono le sole ad averne gli strumenti) l’onere di fronteggiare, ognuna nel suo campo, le inevitabili modificazioni del concetto e della prassi di vita sociale internazionale alle quali i tempi moderni già da un bel pezzo ci stanno richiamando.
Solo in base a questi nuovi pensieri dello spirito umano e a queste nuove interazioni di stampo economico potranno le comunità giuridiche più agevolmente capire quali nuovi diritti e quali nuovi doveri debba sancire oggi l’umanità.
Lo Stato conosce dunque unicamente leggi generali da applicare in tutti i casi; nell’economia, invece, non c’è nulla di generalizzabile: i processi sono sempre concreti e nuovi, ogni situazione singola comporta azioni e decisioni niente affatto generalizzabili. Unicamente la mentalità e la prassi associativa sono in grado di affrontare nel concreto i problemi sociali che di volta in volta e di caso in caso sorgono nel campo dell’economia.
Prendiamo un qualsiasi settore di produzione: quello automobilistico, per esempio. Il produttore, il consumatore e il commerciante di automobili si incontrano periodicamente per comunicarsi le esperienze fatte. Quali leggi generali potranno essi mai comunicarsi? Nessuna! Saranno tutte percezioni e esperienze di tipo singolo e concreto, limitate nel tempo, da ascoltare e comunicare una per una e di volta in volta. Se l’economia avesse leggi generali le potremmo tutti imparare una volta per tutte e ogni problema si risolverebbe applicandole; ma non è questa la realtà dell’economia: tutto ciò che ha valore generale la contraddice, perché essa è una realtà in continuo cambiamento e di situazione in situazione del tutto diversa.
E perché scoppiano le guerre? Perché gli interessi di potere degli Stati vogliono servirsi dell’economia per raggiungere i propri scopi: lo Stato si invaghisce della velocità e dell’incisività immediata dei processi economici che producono, subito e qui, risultati ben tangibili. L’economia asservita, a sua volta, produce per lo Stato i mezzi bellici per soddisfare la sete di potere che mira a difendere o ad ampliare i confini – non necessariamente quelli geografici, ma comunque quelli della propria egemonia.
In questo modo i singoli Stati sorti nell’epoca moderna hanno da sempre falsamente interpretato il loro potere come un diritto sacro e inviolabile. Nella logica del sano organismo, invece, ogni esercizio di potere è un sopruso contro natura. In un organismo vivente nessun organo ha «potere» su altri organi: là vige la «legge» del tutti per uno e uno per tutti. Quando sorge opposizione si ha la malattia.
Anche nel caso di un popolo intero minacciato dall’invasore nella sua esistenza, questo popolo avrà il diritto di difendersi fino all’ultimo sangue solo nella misura in cui coglie questo diritto al contempo come un assoluto dovere nei confronti dell’umanità intera, il cui organismo culturale e morale si guasterebbe se perdesse un membro di vitale importanza. Solo il convincimento di avere questa responsabilità morale nei confronti di tutta l’umanità in quanto tale darà il coraggio di affrontare anche la morte per amore non solo del proprio popolo, ma dell’umanità intera che non può vivere sanamente senza il contributo specifico di questo singolo popolo. Il combattere fino alla morte per amore all’umanità intera è l’opposto del combattere nazionalistico che vuole il potere del proprio popolo contro altri popoli, la propria libertà tramite l’asservimento di altri, che vuole cioè la salute di un organo dell’organismo tramite la malattia di altri.
Si potrebbe obiettare che, se anche fosse tolto agli Stati lo strumentario dell’economia, le conflittualità resterebbero. Ma è del tutto diverso un conflitto che si svolge in campo puramente economico, sia pure a suon di scioperi e serrate, da quello gestito dagli Stati a suon di carri armati e di bombe. Tutta l’economia bellica convenzionale ci offre un’immagine terrificante di ciò che succede quando la sfera giuridica si appropria di quella economica e quella economica accetta di mutuare la logica di potere dello Stato. Lo stesso vale per tutti gli integralismi e le guerre sante: lì lo Stato si appropria non solo della sfera economica, ma anche della sfera culturale, artistica e religiosa. La differenza tra Chiesa e Stato allora scompare: la Chiesa si comporta da Stato e lo Stato da Chiesa.
È necessario che gli esseri umani comprendano che l’economia va del tutto affrancata dall’asservimento agli scopi dello Stato. Lo Stato non deve avere nessuno «scopo»: il senso del legiferare sta nel reciproco accordo dei cittadini sui diritti e sui doveri validi per tutti gli esseri umani. La legge è per natura sua stabile, costante, a lungo termine; le decisioni in campo economico fanno fronte a situazioni sempre cangianti e hanno spesso il carattere dell’urgenza o dell’inversione di marcia.
Se in un settore di produzione sono state prese misure concrete e specifiche per alzare i prezzi, prima troppo bassi, può darsi che essi diventino in poco tempo troppo alti. Bene: si prenderanno misure opposte per farli calare di nuovo. Basta restare nell’economico.
Anche nel corpo umano vediamo che esistono sia leggi costanti di funzionamento, che valgono sempre – basti pensare al respirare o alle «leggi» di circolazione del sangue –, sia modificazioni continue e da riequilibrare sempre nuovamente, che affiancano e intersecano, con modalità proprie, l’organizzazione più fissa. Dopo aver mangiato, per esempio, nello stomaco c’è troppo cibo: prima di mangiare ce n’era troppo poco. Il mangiare risolve il fatto dello stomaco vuoto; il digerire quello dello stomaco pieno. Quando lo stomaco è vuoto, lo riempiamo; quando è pieno, lo svuotiamo smaltendo il cibo. Proprio in questa processualità inarrestabile consiste la salute. Bisogna intervenire continuamente a dare cibo perché sempre di nuovo rispunta la fame, e lo stesso vale per la digestione. Non esiste una pienezza dello stomaco ideale e statica che vada bene una volta per sempre. Così è per l’economia: il suo metabolismo, per essere sano, necessita di un incessante dinamismo, che non consente stasi.
Che cosa comporta la «triarticolazione» per l’economia?
La proposta moderna della triarticolazione dell’organismo sociale, cui più volte ho accennato, tiene conto proprio del fatto che la salute della convivenza umana è tutta basata sulla necessaria autonomia amministrativa di ciascuna delle tre sfere d’espressione dell’umano: quella culturale, quella giuridica e quella economica. Ciò è dovuto al fatto che la qualità del rapporto tra uomo e uomo dev’essere ogni volta di natura diversa:
1. l’atteggiamento interiore fondamentale per vivere lo spirito insito alla sfera culturale è la libertà individuale, lo svincolamento assoluto da ogni percorso preordinato, per permettere la piena espressione della diversità e unicità dei talenti personali di ognuno;
2. l’atteggiamento interiore necessario per instaurare e praticare vera giustizia è il pari rispetto, sempre e comunque, della pari dignità insita in ogni uomo proprio perché è uomo e quindi l’accordo in spirito democratico su diritti e doveri uguali per tutti;
3. l’atteggiamento interiore che instaura una sana vita economica è quello della fratellanza che riconosce l’interdipendenza reale degli uomini di tutto il mondo e la conseguente solidarietà volta a promuovere, in chiave associativa, il comune vantaggio tramite interventi concreti sempre diversi e mai codificabili.
Solo se ognuna delle tre sfere viene amministrata indipendentemente dalle altre ha la possibilità reale di intervenire a correggere le altre in caso di bisogno. Pur nella loro indipendenza reciproca, le tre sfere del sociale non possono fare a meno l’una dell’altra: rafforzandosi nell’autonomia delle loro specifiche funzioni potranno meglio proteggersi dalla tendenza reciproca a invadersi indebitamente.
Anche l’unità dell’organismo corporeo non è indistinta, ma è l’espressione unitaria di tre sistemi fondamentali del tutto diversi nei loro principi di funzionamento: il sistema neuro-sensoriale, il sistema ritmico della respirazione e della circolazione, e il sistema del movimento e del ricambio. Anche nell’organismo fisico ogni malattia nasce dall’interferenza indebita di un sistema in un altro.
Se la grande proposta evolutiva di una moderna triarticolazione dell’organismo sociale cominciasse ad essere compresa e attuata, essa renderebbe ben presto indipendente l’economia da ogni indebita ingerenza dello Stato e della cultura. A questo punto si obietterà: ma allora cosa conta, in campo economico, se non contano le leggi dello Stato e la vita culturale deve restarne fuori? Nell’economia hanno valore:
1. la conoscenza specifica dei processi e delle istanze di produzione;
2. l’apprezzamento del prodotto fatto da chi lo consuma in base ai propri bisogni reali;
3. l’esperienza e le istanze del commercio che cura la circolazione e la distribuzione dei prodotti.
In campo economico contano, insomma, le capacità, le esperienze e il soddisfacimento concreti degli esseri umani in quanto produttori, commercianti e consumatori di merci.
Ricordiamo come il banchiere Rothschild ritenesse molto più interessante ciò che aveva da proporgli il commerciante di pellami piuttosto che le esigenze politiche del ministro del re di Francia. Così come, per un produttore di biscotti, il parere dei premi Nobel per la fisica e la letteratura sul suo prodotto sarà molto meno importante di quello dei bambini di una bella scolaresca elementare e delle loro mamme.
Il giudizio di una persona in campo economico ha peso solo nella misura in cui è intriso dell’esperienza concreta e diretta di settore: come produttore, come consumatore o come commerciante.
Come si giunge ad attribuire un valore alle merci?
Le deliberazioni in sede di associazione economica tendono tutte a raggiungere un accordo sul giusto prezzo da conferire alle varie merci. Prima però di affrontare direttamente questa questione e di mostrare come essa sia risolvibile in modo sano unicamente in ambito di associazione, dobbiamo considerare il processo economico più in generale per vedere in che modo comunemente si giunga ad attribuire un valore, un prezzo, un costo ad una data merce (a prescindere, per ora, dal fatto che questo prezzo sia quello giusto o no).
La designazione stessa di processo economico vuole indicare che in economia, come dicevamo, non possiamo dare definizioni statiche su cosa siano il lavoro, il capitale, i beni di consumo, la merce, il valore ecc. Le definizioni fisse non servono in questo campo, perché la parola «definire» significa proprio «tracciare confini»: finis, in latino, vuol dire confine. Invece nell’incessante dinamismo del processo economico non ci sono mai limiti fissi: le cose trapassano continuamente l’una nell’altra e quindi bisogna creare concetti che siano essi stessi viventi, in grado di metamorfosarsi seguendo la realtà nella sua continua mutabilità.
Il processo economico nella sua totalità si muove in due direzioni fondamentali e opposte:
1. Il primo andamento – che, visualizzato su un cerchio nella fig.1, possiamo considerare antiorario – esprime l’incontro e l’interazione dinamici fra il dato di natura e il lavoro umano.
Il dato di natura non è una realtà economica fino a che il lavoro umano non lo tocchi e non lo elabori. Un dato di natura non lavorato dall’uomo non ha ancora alcun valore economico vero e proprio. Prima che i diamanti fossero diamanti, per esempio, chissà quante volte saranno capitati fra i piedi di persone che camminavano in Sudafrica, senza destare alcun interesse! Allo stato grezzo sembrano sassi qualunque: dunque al dato di natura non basta essere esposto alla presenza ignara di un uomo, per assumere valore economico in senso vero e proprio.
Quando però, per la prima volta, qualcuno si rese conto che dentro quell’apparente superficie terrosa si celava una pietra straordinaria, il pensiero umano cominciò a pensare quale tipo di lavorazione, quale intervento operativo le si potesse applicare. Nel mettersi in moto di questi pensieri «laboriosi» ha inizio l’interazione tra l’operatività umana (della quale fanno parte anche i pensieri!) e il dato di natura che, per questo motivo, comincia ad acquisire valore economico. In questo modo i diamanti diventarono diamanti. E ancora oggi il valore di un diamante dipende dal grado di perfezione del taglio e della sfaccettatura. È sempre la qualità del lavoro umano a decidere il valore conferito al dato di natura.

Le mele, in se stesse, non hanno alcun valore: ciò appare più chiaro se retrocediamo al tempo in cui era ancora possibile passare accanto a un albero non posseduto da nessuno, allungare la mano e mangiarsi una mela. Nel momento, però, in cui questo albero di mele ha incontrato un uomo che ha cominciato a potarlo, a curarlo e poi a raccoglierne i frutti maturi, le mele hanno assunto un valore economico.
Il valore economico del dato di natura non risiede dunque né nella natura in sé e per sé, né nell’uomo in sé e per sé, ma nel tipo di interazione operativa e dinamica che si stabilisce tra il dato di natura e il lavoro umano. Il valore economico sorge là dove l’uomo elabora la natura.
Il processo non si ferma qui, ma continua. Tralasciando la fase del baratto – dove il valore di dieci mele, per esempio, poteva corrispondere a un orcio di latte – trasferiamoci al tempo in cui il dato di natura elaborato dal lavoro ha già acquisito un valore in termini di denaro. Che cosa è accaduto?
Come la natura ha incontrato il lavoro umano, e ne è stata, appunto, elaborata, così il lavoro umano, a sua volta, ha incontrato lo spirito umano che è intervenuto su di esso e lo ha organizzato. In altre parole, quando il lavoro in quanto tale entra nel raggio di osservazione dello spirito umano, quest’ultimo, per così dire, comincia a «lavorare sul lavoro»: sorge così la razionalizzazione del lavoro.
Noi viviamo ormai da lungo tempo in un’economia che non si incentra più tanto sul lavoro da compiere direttamente sulla natura, quanto sull’organizzazione sempre più complessa, «laboriosa» ed «elaborata», del lavoro stesso.
L’esempio più macroscopico del processo immane di intervento dell’ingegno, cioè dello spirito umano, nell’organizzare e nel razionalizzare il lavoro è proprio la moderna divisione del lavoro, della quale abbiamo già parlato a più riprese. In campo economico risultano valori (e quindi prezzi) del tutto diversi a seconda che l’organizzazione del lavoro sia intelligente o poco funzionale: un lavoro bene organizzato e ben suddiviso aumenta e perfeziona la produzione e abbatte enormemente i costi; un lavoro che proceda in modo caotico, incongruo e irrazionale causa dispendio di denaro e prodotti più costosi, oltre che di qualità inferiore.
Osserviamo ora, però, più concretamente questo processo. Immaginiamo che, in una società ancora molto arretrata, venti persone si debbano recare ogni giorno a lavorare nei campi situati a tre chilometri di distanza. Un giorno a qualcuno viene in mente di costruire un carretto, di attaccarvi due cavalli e di trasportare così i venti lavoratori in cambio di pane, frutta, olio ecc.
A quale importante fenomeno ci troviamo qui di fronte? Lo spirito, l’intelligenza umana ha organizzato il lavoro e l’ha diviso: ciò che prima competeva ai singoli lavoratori (farsi cioè tre chilometri a piedi) diventa adesso occupazione di un altro. Non solo: nasce ora il capitale. Il carrettiere entra nella categoria dei capitalisti: il carretto è il suo capitale.
Egli potrà in seguito offrire il suo servizio non solo a quei venti contadini, ma anche ai minatori, ai boscaioli, ai cacciatori, e potrà farlo più volte al giorno; potrà costruire altri carretti, allargando così la sua impresa sorta per organizzare e razionalizzare i lavori altrui, che affiderà in seguito ad altri lavoratori-carrettieri ai quali chiederà una parte del loro guadagno. E, soprattutto, l’ingegno di questo primo carrettiere si sarà a mano a mano emancipato sia dalla natura sia dalle forme specifiche del lavoro sulla natura e avrà avviato l’economia di denaro.
Il suo servizio, infatti, comincerà ben presto a non essere più facilmente remunerabile in termini di baratto: in breve tempo la sua casa rigurgiterebbe di beni di consumo che la sua intera famiglia non potrebbe smaltire. Deve allora prima o poi ricorrere al denaro. Il nostro esemplare carrettiere – imitato magari dal figlio del contadino che comincerà a offrire il servizio di consegnare le mele casa per casa e dal pescatore che userà la sua barca per traghettare i viandanti, e così via – avrà posto il seme per l’invenzione del denaro e il suo capitale sarà costituito dai carretti in quanto mezzi di produzione veri e propri e dal denaro.
Riassumendo, in questa prima direzione del processo economico si parte dalla natura sulla quale interviene il lavoro umano che la trasforma conferendole un valore. Sul lavoro interviene poi l’ingegno umano che lo organizza e lo razionalizza generando, da una parte, un sempre crescente aumento della produzione di beni di consumo e, dall’altra, capitale neutro, cioè non più legato né alla natura né a un tipo specifico di lavoro.
Giunti al capitale in quanto tale, soprattutto nella sua forma astratta di denaro, che cosa succede? Succede che esso diviene il rappresentante dell’ingegno umano stesso, cioè dello spirito umano. Il capitale è, in economia, spirito attuato, realizzato, svincolato dalla natura e messo dallo spirito a disposizione di se stesso. Lo spirito ha creato per il proprio uso il denaro e può farne qualsiasi impiego. Lo spirito ha elaborato nella sfera economica lo strumento corrispondente alla sua propria libertà.
Occupiamoci ora del destino di questi beni di consumo e del capitale.
Finora abbiamo considerato il processo economico dal punto di vista della produzione, cioè della generazione di valori: osserviamo ora il polo opposto, cioè il consumo. La legge fondamentale per il sano funzionamento degli organismi viventi è che tutto ciò che viene ingerito e si accumula al loro interno deve venire consumato o estromesso di nuovo: se noi continuiamo ad ingerire, giorno dopo giorno, etti ed etti di cibo in più rispetto a quelli che riusciamo a smaltire, nel migliore dei casi cadremo nell’obesità, nel peggiore ci piglierà una congestione o andremo all’altro mondo.
I beni di consumo e il capitale, perciò, una volta immessi nell’organismo sociale economico devono altrettanto venire o consumati o «estromessi». E come avviene ciò? La fig.1 ci mostra che ciò che non viene «consumato» dall’organismo economico è costretto a tornare alla natura: in che modo? I beni vi tornano sotto forma di montagne di rifiuti. Il capitale, invece, quando è anch’esso una grossa montagna (capitale di esubero), non è possibile smaltirlo tutto acquistando prodotti deperibili della natura (capitale di consumo o d’acquisto). Il capitale di esubero ha allora due possibilità di impiego: o viene «consumato» mediante una sistematica svalutazione che lo riporta con l’andare del tempo a valore zero, oppure viene costretto a fissarsi nei beni immobiliari e fondiari, gli unici che la natura può stabilmente offrire. In questo caso il cerchio si chiude in un circolo vizioso e il processo economico subisce un dannoso arresto, una fatale congestione. Ne tratteremo più avanti in modo specifico.
Lo spirito umano, a questo punto, deve intervenire a «decongestionare» l’organismo economico invertendo la direzione di marcia del processo economico stesso dal senso antiorario a quello orario: non più soltanto dalla parte della natura, ma anche dalla parte del lavoro. Lo stesso compie sempre l’organismo fisiologico invertendo ogni acquisizione di cibo nel suo annientamento. Ciò avviene nel modo seguente:
2. Anziché continuare a organizzare il lavoro per aumentare senza limiti la produzione di beni di consumo, lo spirito umano prende a elaborare le risorse della natura (materie prime) nella direzione del lavoro. Riferendoci ancora una volta ai carretti, pur avendoli noi chiamati «capitale», sono pur sempre natura (pezzi di legno) trasformata dal lavoro intelligente (in congegni di legno): è chiaro, allora, che questo tipo di capitale non potrebbe ritornare alla natura (e quindi consumarsi) se non divenendo legna da ardere, il che sarebbe una bella asinata.
Ecco allora che i carretti, nelle mani dello spirito, divengono mezzi di produzione (in questo caso producono un servizio) e si orientano di nuovo verso il lavoro, ora però in direzione opposta, in senso orario, come mostra la fig. 2 che andremo via via analizzando.
Oggi sono infiniti i mezzi di produzione che l’umanità si è messa a disposizione nel corso del tempo: dai più complessi (macchinari di fabbrica, impianti industriali), ai più semplici (la penna, per esempio, che è il mezzo di produzione dello scrittore).
Unendosi con il lavoro i mezzi di produzione vanno a costituire il cosiddetto capitale di investimento (o d’impresa), viene cioè ad essi riconosciuto un valore economico: il capitale d’impresa materialmente visibile della FIAT o della BMW, per esempio, è costituito da tutti i mezzi di produzione di cui si avvale il lavoro degli operai: cioè da tutte le officine, gli stabilimenti, i macchinari, i magazzini di stoccaggio, i circuiti di prova ecc.
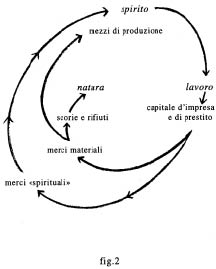
Ritorniamo al nostro carrettiere, anzi ai suoi pronipoti che vogliamo supporre altrettanto ingegnosi e volenterosi. Abbiamo visto che essi possiedono dopo un certo tempo anche capitale in denaro: pur impiegandone una parte per la manutenzione dei carretti vecchi, per l’allestimento dei nuovi, per lo stipendio dei carrettieri alle loro dipendenze e per le spese di famiglia (tutto capitale di consumo e d’investimento o d’impresa), ne rimane loro ancora molto (capitale di esubero).
Guardandosi intorno, essi notano che ci sono molte altre persone alle quali non basta il capitale d’investimento che possiedono (sia sotto forma di mezzi di produzione, sia sotto forma di liquidità); vedono anche altre persone, sveglie e piene di inventiva, che potrebbero apportare molte interessanti innovazioni in vari settori della vita sociale, con vantaggio di tutti, le quali però hanno a disposizione un solo mezzo di produzione: il talento.
I pronipoti del nostro carrettiere, insomma, volendo investire il loro capitale di esubero si rivolgono a esseri umani degni di fiducia sia perché già posseggono beni personali, sia perché hanno capacità individuali che li rendono idonei a ricevere credito personale. Essi decidono, allora, di mettere a disposizione di costoro il proprio capitale di esubero ripromettendosi di fruire essi stessi della positiva ricaduta del buon lavoro altrui: nasce, così, il capitale di prestito a tasso d’interesse. I pronipoti del carrettiere sono diventati anche banchieri!
Il processo economico prosegue così il suo movimento naturale perché coloro che hanno ricevuto un prestito dispongono, ora, del loro capitale d’impresa: vediamo allora che il denaro al servizio dello spirito, sia esso mezzo di produzione sia esso denaro puro, in questa invertita direzione di marcia fluisce sempre, dal tempo dei carrettieri fino ad oggi, verso l’intelligenza e l’ingegno umani.
E che cosa produrrà, a questo punto, l’intelligenza umana grazie al capitale d’impresa e ai mezzi di produzione? Produrrà merci. Merci della più svariata natura, ma sempre merci: dagli aeroplani alla musica, dai bulloni all’educazione dei bambini, dai servizi di trasporto alle cure mediche. In economia anche i vari servizi devono assumere il carattere di merce e devono venir trattati dal «consumatore» come merci.
Pur essendo in campo economico tutto «merce», è importante distinguere tra i beni di consumo e le merci propriamente dette: i beni di consumo sono fatti appunto per essere consumati (le torte, gli spaghetti, la benzina, i farmaci ecc.) e si riferiscono principalmente alla sfera dei bisogni corporali; mentre le merci sono fatte per l’uso (automobili, radio, televisione, libri, parchi, musei ecc.) che può essere più o meno protratto nel tempo, e si riferiscono principalmente ad attività proprie dell’anima. Un litro di latte può sparire in men che non si dica, un libro di solito no. Il corpo consuma velocemente i beni, l’anima usa più a lungo le merci. Ma anche ciò che si usa, in quanto materiale, prima o poi si consuma e deperisce. Poiché tutto il consumabile ha per natura un limite, non è possibile produrre e usare merci in quantità illimitata. Altrimenti raddoppieremmo, anzi moltiplicheremmo, anche in questo movimento orario dell’economia il bel pasticcio delle scorie, dei rifiuti.
I beni di consumo (per i bisogni ricorrenti del corpo) e le merci d’uso (per le abitudini costanti dell’anima) devono allora costituire la base per l’attività della terza dimensione, quella specificamente inventiva dell’essere umano: lo spirito. Lo spirito (l’ingegno umano) – che si avvale del corpo e dell’anima per il consumo e per l’uso – produce sempre: e può produrre nella direzione sia del corporeo (i già visti beni di consumo), sia dell’animico (le già viste merci d’uso), sia soprattutto dello spirituale stesso (merci e prestazioni spirituali). Soffermiamoci ora su quest’ultimo aspetto.
L’esercizio della produzione spirituale, a differenza dei beni di consumo e delle merci d’uso, ha carattere intrinseco di illimitatezza: non c’è infatti limite ai pensieri ai quali possiamo dar vita, non c’è limite agli atti d’amore che possiamo compiere, non c’è limite all’espressione delle dimensioni conoscitive, artistiche, morali e religiose dell’essere umano. Non solo: qui non esistono affatto rifiuti ma ci sono solo «tesori immarcescibili», per dirla col Vangelo. L’umanità attuale deve però ancora arrivare a capire che il produrre pensieri non è meno incentivante ed economicamente redditizio del produrre vestiti, aerei o pagnotte. Non riflette ancora a sufficienza sul fatto che anche una macchina viene prodotta grazie al pensiero!
Là dove si tratta davvero di produzione (merce) spirituale non avremo problemi di scorie: vedremo, anzi, che proprio il finanziamento della produzione spirituale favorisce, in ogni campo, lo smaltimento di tutto ciò che deve venire consumato dall’organismo economico e sociale sano, nonché, già a monte, l’eliminazione di tutti quei falsi bisogni che inondano di beni e merci inutili o nocive la nostra attuale economia di esasperato e folle consumismo.
Va ricordato, come sintesi finale di quanto abbiamo fin qui descritto ed elaborato, che i due movimenti fondamentali del processo economico (antiorario e orario) sono sempre compresenti nell’economia e sempre in molteplice interazione fra di loro. Possiamo perciò graficamente raffigurarli entrambi nella fig. 3, alla pagina seguente:
Sulla base di queste riflessioni – per quanto generali e tutt’altro che esaurienti – che riguardano la produzione e il consumo di beni e di merci ai quali si attribuisce un valore, possiamo ritornare a considerare le associazioni, quali palestre viventi di collaborazione incessante tra produttore, commerciante e consumatore. Non dimentichiamo che siamo partiti dal quesito del prezzo giusto da attribuire alle varie merci in sede di associazione.
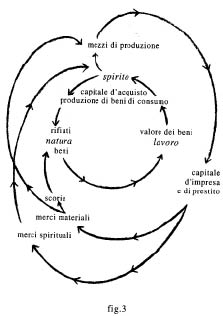
I tre compiti fondamentali dell’associazione
Possiamo distinguere tre compiti fondamentali che l’associazione economica deve svolgere:
1. un primo compito è riverberare indirettamente sulla sfera giuridica respingendone i poteri impropri e cedendole i suoi compiti specifici;
2. il secondo compito è agire, anche qui indirettamente e senza tracimazioni indebite, a sostegno della libera sfera culturale, conferendole le condizioni necessarie di esistenza;
3. il terzo compito, quello economico vero e proprio, è occuparsi direttamente del giusto prezzo delle merci e dei beni di consumo, quali sono anche le prestazioni e i servizi vari. Tutto ciò che l’associazione compie, dicevamo, mira a stabilire il prezzo giusto delle varie merci. Quando nell’associazione si è fatto tutto il possibile in questa direzione, si è fatto anche tutto il necessario.
Le reciproche consultazioni e le comuni deliberazioni che avvengono tra il produttore, il consumatore e il commerciante, tutto ciò che essi fanno insieme mira ad assegnare a ogni merce il prezzo giusto. Essendo, però, il processo economico eminentemente dinamico, non dobbiamo illuderci che il prezzo equo di una merce possa essere statico: lo sforzo costante, per quanto riguarda i prezzi, sarà allora quello di avvicinarsi di volta in volta il più possibile al giusto, attraverso correzioni sempre nuovamente da ripetere. Ciò soprattutto in base al fatto che i prezzi influiscono continuamente gli uni sugli altri. Il prezzo dell’acciaio, per esempio, non può che dipendere da quello del carbone e viceversa.
Consideriamo ora più da vicino ognuna di queste tre funzioni principali dell’associazione economica:
1. Qual è l’apporto indiretto dell’associazione economica in campo giuridico? Essa è in grado di mostrare che gli interventi di legge sul rincaro o il deprezzamento delle merci sono non solo illusori ma dannosi, perché non si orientano secondo la realtà economica stessa nella sua oggettività.
Il prezzo corrente di una merce è come la temperatura in una stanza indicata dal termometro: se io sento freddo e vedo che il termometro segna 8 gradi, comincio forse a soffiare fiato caldo sulla colonnina del mercurio per farla salire? No di certo, perché la temperatura reale della stanza in questo modo non cambierebbe. Io uso il termometro in modo saggio se lo considero soltanto come un evidenziatore di temperatura; se poi voglio più calore provvederò a riempire di legna la stufa o di gasolio la caldaia, oppure chiuderò la finestra.
Analogamente, quando il prezzo di una merce è troppo alto o troppo basso, devo sapere che esso mi sta evidenziando una realtà ben precisa: il troppo basso o troppo alto numero di lavoratori operanti in quel settore di produzione. Il termometro del prezzo mi dice: ci sono troppi lavoratori! Oppure: ce ne sono troppo pochi! Non altrimenti la colonnina del mercurio mi dice: c’è poca legna nella stufa! Ce n’è troppa! Cambiare il prezzo – con un decreto di legge – senza cambiare il numero di operai è come cambiare la temperatura del termometro senza cambiare quella della stanza!
Poniamo che il costo dei telefonini cellulari sia talmente alto che tutti se ne lamentino: vuol dire che nel settore della telefonia il numero dei lavoratori è troppo basso, dunque i costi di produzione (per via della insufficiente divisione del lavoro) sono troppo alti. E i telefonini sul mercato sono troppo pochi.
Viceversa, può accadere che gli editori dei quotidiani si lamentino perché il prezzo dei giornali è troppo basso e quindi non ce la fanno nemmeno a far fronte alle spese di gestione dell’azienda: vuol dire che nel settore della stampa ci sono troppi lavoratori. L’eccessiva divisione del lavoro ha sì abbassato i prezzi di produzione, ma la quantità di stipendi da pagare è troppo alta e troppo alta è la quantità di giornali immessa sul mercato.
L’associazione economica, in un sistema sociale sano, dovrebbe allora avere per legge il diritto e quindi la possibilità reale di intervenire sul numero dei lavoratori presenti in un settore. I compiti sociali che ci attendono sono veramente immani! Però non c’è bisogno di essere «economisti» per capirli: sono accessibili al pensare sano di ognuno. E si possono compiere subito e ovunque i primi passi nella giusta direzione.
Il concetto tradizionale stesso di «competenza tecnica» e specifica in campo economico va profondamente mutato. Ci sono solo tre tipi di competenti possibili: colui che è competente in fatto di produzione di una data merce, colui che è competente in fatto di distribuzione e colui che è competente in fatto di consumo. La qualità e l’autorevolezza della «competenza» dipendono da un lato dall’esperienza di vita, che è fatta di tutte le percezioni concrete del passato compiute nel proprio campo, e dall’altro dalla capacità più o meno penetrante del pensiero che interpreta la somma delle percezioni e delle esperienze fatte.
È tutt’altra cosa se noi diamo vita, in campo economico, ad associazioni che abbiano la possibilità reale di spostare dieci, venti, cinquantamila lavoratori dal settore automobilistico a quello farmaceutico, per esempio, o se questa possibilità non c’è.
Oggi lo Stato interviene in vari modi per cambiare direttamente i prezzi, ma in realtà non cambia nulla: è come se decidesse di emettere milioni di nuove banconote da cinquanta Euro. Cosa cambierebbe? Nulla. Già Goethe nel suo Faust lo mostra in modo poeticamente sublime. La realtà rimarrebbe la stessa e l’intervento sarebbe non solo fittizio, ma, se limitato a ciò, molto nocivo.
Potremmo a questo punto chiederci: ammesso che questa metodica dello spostamento dei lavoratori da settore a settore sia giusta, perché non potrebbe gestirla lo Stato stesso? Perché ci vogliono proprio le associazioni?
Il diritto di spostare i lavoratori può averlo soltanto il bisogno reale dell’organismo sociale umano. L’associazione è fatta per cogliere proprio questi bisogni reali mantenendo in costante, attivo e diretto contatto fra loro il produttore, il consumatore e il commerciante, cioè tutti gli esponenti dell’organismo economico. Ogni associazione sarà, nella sua dimensione medio-piccola, ma anche nella grande, uno spaccato vivente e attento della realtà vivente e organica alla quale partecipa giorno dopo giorno. Solo i diretti fruitori, produttori e distributori delle merci possono avere il polso della situazione. L’impiegato (o il funzionario) statale tradizionale è proprio l’essere umano che è più di ogni altro avulso dai processi specificamente economici di produzione, di commercio e di consumo. È quindi strutturalmente la persona meno «competente» che si possa immaginare.
2. Come interviene l’associazione, indirettamente, sulla sfera culturale-spirituale? Questa funzione potrà essere assolta dall’associazione, in un futuro che purtroppo sembra ancora lontano, tramite la possibilità di assegnare le donazioni. Il modo perfetto di donare, il più coerente, è quello di mettere il denaro in mano a un’associazione che, per reale competenza sulle varie situazioni, sarà in grado di trovare, spesso meglio del donatore stesso, il destinatario giusto, cioè quello con i talenti adatti a farne l’uso migliore per il bene di tutti.
In che modo avviene ciò? Ricercando, sempre in base a esperienza diretta e non per sentito dire o per decreto, chi abbia i talenti corrispondenti necessari per usare bene il capitale donato. Certo, non è una responsabilità da poco, questa, e si possono fare sbagli, ma finché non si avrà il coraggio di dar vita a queste nuove dinamiche economiche non si risolveranno i grandi problemi sociali. Il capitale di donazione deve avere la possibilità di andare là dove ci sono i talenti adatti a farlo fruttare nel modo migliore per tutti.
In un certo senso l’assegnazione delle donazioni rappresenta la vita spirituale in seno a quella economica. Si tratta infatti da un lato di valutare i talenti veri dei singoli individui umani e dall’altro di stabilire una scala di priorità circa i talenti che è più o meno urgente favorire per il bene complessivo del processo economico e, di riflesso, dell’organismo sociale stesso. In ognuna delle sfere dell’organismo sociale sono sempre presenti indirettamente anche le altre due, grazie all’essere umano stesso che è sempre in modi svariati presente in tutte e tre e che nella sfera economica è sempre in qualche modo sia produttore, sia consumatore, sia commerciante. La produzione è la sfera spirituale dentro all’economia; il commercio è la sua vita giuridica; il consumo ne è il fattore economico puro.
3. Stabilito che spetta alle associazioni economiche (che, naturalmente, sono sempre pensate in costante relazione fra di loro) e non allo Stato giuridico di equilibrare il numero dei lavoratori operanti in ogni settore e così agire indirettamente ma sanamente sui prezzi, non abbiamo ancora indicato il modo concreto che consente di stabilire il prezzo giusto di una data merce. Rudolf Steiner dà a questo proposito una specie di formula, sconcertante per la sua semplicità: il prezzo giusto da pagare per una merce è quello che consente a colui che l’ha prodotta di continuare a produrla, dopo aver appagato i bisogni suoi e delle persone che ha a carico.
Se ho a che fare con un calzolaio che produce quindici paia di scarpe al mese, il loro prezzo giusto è dato dal denaro a lui occorrente per produrne altre quindici il mese successivo. In questo prezzo complessivo è compreso il denaro necessario per i bisogni famigliari.
È una formula, questa, tutt’altro che facile nella sua applicazione concreta, ma in quanto orientamento fondamentale in campo economico essa è importantissima perché è tutta rivolta verso l’avvenire, conta sul dinamismo della vita e si occupa di rendere possibile al produttore la continua fecondazione dell’organismo sociale col ripetere il servizio già compiuto.
Questa formula sottolinea infatti che va consentito a ogni essere umano di esprimere sempre di nuovo i suoi talenti producendo «merci», sia materiali sia spirituali, che vanno incontro ai bisogni altrui. Si tende in questo modo verso una mentalità lavorativa in grado di promuovere in tutti la gioia e il dinamismo propri dell’essere umano.
Dicevo che non è semplice l’applicazione di questa «definizione» del prezzo giusto. Tante sono infatti le domande che sorgono: rimanendo all’esempio del calzolaio, quanto mai ci costeranno le sue scarpe se ha cinque figli da mantenere? E se cinquecento metri più in là c’è un bravo calzolaio scapolo, andremo tutti da lui? Nella pratica si vedrà qui l’effetto della sfera giuridica in campo economico, così come l’abbiamo già tratteggiata nella distinzione fra lavoro e prodotto del lavoro. Se un calzolaio ha cinque figli a carico non saranno le sue scarpe a costare di più a tutti noi, bensì i figli, che però non ci costeranno né più né meno di tutti gli altri bambini da mantenere.
Oltre a ciò bisogna anche riflettere sul fatto che di artigiani che fanno le scarpe, oggi, ce ne sono pochissimi: perciò, stando a quanto abbiamo detto, le scarpe su misura sono molto care (pochi lavoratori nel settore = prezzi alti); in Italia un paio di scarpe su misura può oggi costare dai quattrocento Euro in su. Significa, allora, che devono per forza aumentare gli artigiani? O significa che sono per i più un lusso superfluo, le scarpe su misura, mentre corrispondono a un vero bisogno reale solo per chi ha difficoltà a camminare e dunque ha problemi di salute? E allora, nello spirito di giustizia, dovremo o no chiederci se è sempre scontato che sia l’acquirente singolo a dover pagare direttamente l’intero prezzo o se in alcuni casi occorra invece provvedere, in via giuridica, ad integrarlo in modi nuovi, agili e intelligenti?
Resta il fatto che, con la divisione del lavoro e l’ausilio delle macchine, tutti possiamo comprare le scarpe, oggi, anche a cinquanta, cento Euro o giù di lì, perché un’industria calzaturiera di media grandezza, con cinquanta operai, che produca trentamila paia di scarpe al mese, pur rivendendole ai distributori a prezzi d’ingrosso potrà provvedere al salario degli operai, al guadagno necessario per produrne altre trentamila il mese successivo e a sostenere al contempo le spese di gestione. E con congrui avanzi che vanno a incrementare il capitale.
È veramente un vantaggio
guadagnare più del necessario?
Soffermiamoci ora un poco sul denaro che «avanza» oltre il necessario previsto dalla formula citata: a che cosa serve? Allo stato attuale delle cose esso costituisce, per l’imprenditore, un capitale: e del capitale, in termini di nocivi accumuli, abbiamo già parlato. Osserviamo, invece, il lavoratore in senso lato: qual è, per lui, la conseguenza economicamente più importante di un guadagno che vada molto al di là dei parametri che abbiamo indicati? È la pigrizia interiore.
La vita economica ha invece lo scopo opposto: quello di invogliare ognuno ad essere il più solerte possibile per il bene proprio e della comunità, ad essere sempre e soprattutto produttore, oltre che consumatore. Il consumatore appaga bisogni, il produttore invece esplica talenti: solo in quanto produttore l’uomo può fare l’esperienza della pienezza e della positività del proprio essere. Se è solo consumatore senza esservi costretto per natura egli è un parassita, un elemento morto dentro a un organismo vivente.
Pensare che il vivere di rendita da parte di tutti sia l’ideale a cui mirare è in realtà quanto di più antieconomico si possa immaginare: il risultato sarà la non produttività generale. Alla fine, non solo nessuno potrà più vivere di rendita, ma nessuno potrà più vivere! Forse l’Estremo Occidente – «estremo» rispetto a noi! – capirà questo solo dopo brutte esperienze fatte nel voler vivere di rendita alle spalle dell’Estremo Oriente (Cina compresa, naturalmente…).
Colui che riceve il necessario per continuare a esercitare, finché ne è in grado, le proprie capacità può vivere nella pienezza, realmente non gli manca nulla. È questa la bellezza strabiliante della formula del prezzo giusto: aiuta concretamente a sciogliere molte illusioni su ciò che è «il meglio» per l’uomo. Quando riceviamo più di ciò che è necessario per essere in tutto e per tutto creativi, noi estorciamo denaro alla comunità, la sottoponiamo ad una sorta di donazione coatta. Costringiamo gli altri a soddisfare bisogni che non abbiamo, impedendo in questo modo l’appagamento dei bisogni veri degli altri.
Ciò vale anche per le tasse eccessive o arbitrarie che sono il risultato di un tipo di Stato che si arroga responsabilità improprie (la sfera educativa è l’esempio più clamoroso) e sottopone il cittadino a ingiuste donazioni obbligatorie, che sono quindi estorsioni vere e proprie. Nell’assunto fondamentale che lo Stato non dovrebbe affatto interferire nell’economia è detto implicitamente che una ferrovia statale è un controsenso economico, così come lo sono le poste statali, le strade statali, le pensioni statali, la televisione statale, l’elettricità statale e così via. Vediamo, perciò, come su di noi incombano compiti veramente grandi, perché quando noi diciamo «Stato» diciamo anche milioni di persone che lavorano – o non lavorano – al suo interno e vivono in gran parte di donazioni estorte, estorte a tutti i cittadini. Una remunerazione fatta secondo criteri economici è per natura tale da stimolare al dinamismo interiore colui che la riceve; la remunerazione del classico impiegato statale, invece, tendendo a diventare sempre più indipendente dalla sua produttività economica effettiva, tende altrettanto per natura a generare un atteggiamento crescente di letargia e di parassitismo sociale.
Lo Stato non può che promettere ai suoi dipendenti ciò che preleva dalla tasca di altri, con conseguenze molto gravi per la vita economica. Proprio da questo sfruttamento endemico reciproco sorgono le grandi paralizzazioni nepotistiche, le pigrizie ereditarie, le corse e gli attaccamenti ai posti fissi, alle poltrone comode. Milioni di persone pensano così di poter vivere alle spalle degli altri: è come se alcuni organi dell’organismo procedessero tranquillamente al dissanguamento di altri organi, senza sospettare che il danno non potrà che ricadere su tutti, e quindi anche su di loro. L’abbiamo già detto: o si ha la salute di tutto l’organismo o tutto l’organismo è ammalato. Non esistono alternative.
«Il diritto all’uso esclusivo» quale evoluzione e sintesi
dei concetti di proprietà privata e collettiva
Veniamo ora a un altro quesito fondamentale della vita economica: all’annoso problema della proprietà privata e della proprietà pubblica, all’eterna lotta tra capitalismo e comunismo. Il capitalismo difende a spada tratta la proprietà privata e il comunismo difende (o almeno difendeva!) con altrettanta veemenza la proprietà collettiva non solo dei beni immobiliari e fondiari, ma anche dei mezzi di produzione.
La proprietà «privata» è tale perché di fatto priva gli altri di qualcosa. Ora chiediamoci: in un organismo sano esistono proprietà private? I polmoni potrebbero mai appropriarsi non dico del cuore, visto che ce n’è uno solo, ma di qualche milioncino di cellule o di mezzolitro di sangue in esclusiva? No, assolutamente no.
D’altra parte, dobbiamo anche dirci francamente che non è facile capire cosa mai ci sia da obiettare nei confronti di un atteggiamento interiore che, in fondo, dice semplicemente: questo è mio, e ho il diritto di farne ciò che voglio. Non è forse questo un aspetto della libertà? Perché non va bene? Sono interrogativi ai quali dobbiamo cercare di rispondere.
La proprietà collettiva, al contrario, affermando che tutto è di tutti dice al contempo che tutto è di nessuno. La difficoltà di una gestione responsabile delle cose è stato il tormento perenne delle società comuniste: demotivazione, trascuratezza e inefficienza sono state le sue piaghe sempre aperte.
Il contributo specifico della scienza dello spirito di Rudolf Steiner mi pare, proprio su questo argomento, di decisiva importanza perché apre all’economia orizzonti del tutto nuovi. La proposta nuova è quella di un rapporto economico con le cose che non sia né solo privato né solo pubblico, ma si incentri sul concetto del diritto temporaneo all’uso esclusivo.
Dal punto di vista degli strumenti di vita e di lavoro, quando noi conferiamo a una persona o a un gruppo di persone il diritto all’uso esclusivo di dati mezzi di produzione (macchinari, strumenti di ricerca, edifici, un pezzo di terra, uno stanziamento finanziario, ecc.) dei quali hanno bisogno per produrre ciò che sanno produrre, che cos’altro manca a queste persone? Nulla.
Quando io ho il diritto esclusivo all’uso di qualcosa, che cosa mi si aggiunge se questo qualcosa è mio, nel senso che lo «possiedo», che è mia proprietà privata? In realtà soltanto grane e preoccupazioni: nulla di più. Agli effetti dell’uso il possesso legale è superfluo, mai necessario. La proprietà in quanto tale è come la quinta ruota del carro rotta: quindi nemmeno di scorta. Pesa e ingombra, soltanto.
A chi obietta che il vantaggio reale del possedere consiste nel diritto a disporre a piacere dei propri beni facendone ciò che si vuole senza renderne conto a nessuno, dobbiamo rispondere che proprio l’atteggiamento interiore che non vuole rendere conto del modo d’uso è non solo il più irresponsabile, ma, nel nostro contesto, il più antieconomico che vi sia.
Il conferire il diritto esclusivo d’uso è allora il modo migliore per attuare il lato positivo sia del capitalismo sia del comunismo, evitando al contempo il lato negativo e l’unilateralità di entrambi. Infatti la possibilità sia di conferire sia di revocare il diritto all’uso salva la responsabilità nei confronti della collettività; l’esercizio reale dell’uso esclusivo salvaguarda la libertà dell’individuo singolo quando opera con i suoi talenti per il bene di tutti. La possibilità di conferire e revocare il diritto all’uso ci mostra l’importanza della comunità e del bene comune. Il diritto e l’esercizio stesso dell’uso esclusivo mettono in risalto la preziosità imprescindibile dell’individualità libera e intraprendente.
Nella mentalità ordinaria oggi invalsa, spesso si vuol possedere per mostrare agli altri ciò che si ha. Ci si identifica con l’avere anziché con l’essere. E si vuol avere sempre di più per valere sempre di più, si vuol avere più degli altri per valere più degli altri. Eppure non ci vuol molto a comprendere che colui che «possiede» di più è colui che più ha sottratto – diciamo pure sinceramente rubato – agli altri.
Sia il capitale sia i mezzi di produzione sia gli immobili sia la Terra sono fatti per venire assegnati di volta in volta a colui o a coloro che si ritiene abbiano i talenti giusti per usarli per il bene di tutti, cioè per farli fruttare al massimo nell’organismo sociale. Il dovere che corrisponde a questo diritto all’uso esclusivo è dunque quello della parabola evangelica dei talenti: ridare più di quanto si è ricevuto.
Soltanto se accogliamo questo dovere – che è un graditissimo e amato dovere per chiunque viva in profondità il suo essere uomo libero e creativo – possiamo assumerci il diritto e la responsabilità morali di escludere ogni altro essere umano dall’uso dei mezzi di produzione a noi affidati.
La mentalità del possesso garantisce al proprietario l’uso non solo esclusivo ma anche irrevocabile e arbitrario di ciò che ha: nessuno glielo può più togliere, nemmeno se egli palesemente lo usa male, senza talento e senza alcun sentimento di responsabilità di fronte al bene comune, danneggiando tutti.
Il diritto all’uso esclusivo è invece per natura limitato nel tempo e revocabile. Ciò perché soggiace alla precisa condizione dell’uso a favore di tutti.
Differenza fra utopia e salute
Qui va accennato anche a un aspetto fondamentale dell’obiezione classica che dice che tutto ciò è una bella utopia, e come tale irrealizzabile. Il meccanismo psicologico – che è un meccanismo di autodifesa – funziona qui così: io penso negativamente prima di tutto agli altri, in particolare ai grandi possidenti di capitali o di proprietà private, per convincermi subito che è strutturalmente impossibile «convertirli». Per due motivi: il primo è che non lo vogliono affatto, il secondo è che hanno il potere necessario per costringere tutti gli altri a stare al loro gioco.
Questo meccanismo psicologico è fatto però apposta per nasconderci la cosa più importante – quella per noi più pericolosa! Esso ci fa dimenticare che l’umanità non si cambia mai grazie a coloro che non possono perché non vogliono cambiare se stessi, bensì grazie a coloro che lo possono perché lo vogliono! Il superamento interiore della mentalità del possesso è per principio possibile a ogni essere umano che lo voglia.
La trasformazione dell’«utopia» in una tangibile realtà dipende tutta dal numero reale di persone singole che decidono di farlo. Ma questa decisione la può prendere unicamente ognuno per sé, perché ognuno deve personalmente volere tutte le conseguenze concrete che ricadono e ricadranno su di lui. Ciò vuol dire: la cosiddetta utopia diviene subito realtà nel momento in cui io – io, non gli altri – decido di attuarla qui e ora. Colui che chiama ciò idealismo utopico è colui che ha bisogno di proteggersi psicologicamente contro la sua stessa profonda aspirazione a vivere in modo più umano.
La salute dell’organismo fisiologico non è un’utopia: perché lo deve essere allora quella dell’organismo sociale? La salute non è, in entrambi i casi, uno stato o stadio ideale o perfetto da conseguire e da mantenere immutato una volta per sempre. È piuttosto l’opposto: è l’intervento continuo per respingere tutte le pur minime tendenze alla malattia che devono in continuazione ripresentarsi. Un organismo non più capace di ammalarsi è morto, è un cadavere.
Il carattere fondamentale di una vera utopia – cioè di ciò che è per natura impossibile – è proprio quello di prospettare un assetto ideale delle cose da raggiungere e da conservare: ciò che qui viene escluso è proprio il continuo dinamismo di cui abbiamo parlato finora. Tutto ciò che ci siamo detti è l’opposto di ogni utopia, perché ci indica i passi concreti e possibili che ognuno di noi può compiere sempre e in ogni luogo, qui e subito.
L’utopia parla di uno stato ideale delle istituzioni esteriori, la non-utopia si occupa innanzitutto della trasformazione interiore dell’individuo umano, che ha come conseguenza inevitabile la trasformazione delle istituzioni esterne.
L’utopia parla di un paradiso che verrà realizzato in un lontano futuro, il sano realismo prende a cuore il modo di essere dell’uomo nel presente. L’utopia ha in mente una felicità astratta da conseguire in base a programmi di riforma che intende imporre dall’esterno, il realismo vuole quella pienezza concreta che solo nel presente nasce dall’interiorità del singolo e subito diventa fatto sociale.
L’utopista cerca ciò che per natura è irrealizzabile per giustificare la propria inerzia; il sano idealismo guarda a ciò che è realmente attuabile già da oggi, anche se incipientemente, per goderselo. L’utopista vuole la felicità di tutti, e sposta così l’accento, senza accorgersene, su ciò che devono fare gli altri per conseguirla; l’idealista realistico vuole non meno la felicità di tutti – perché per lui è davvero possibile –, ma fa di tutto per essere felice lui stesso e perciò non perde mai di vista ciò che può decidere di fare in prima persona.
L’eredità e i beni immobili: possedere o essere posseduti?
Consideriamo ora le due realtà sociali che per loro stessa natura sono quanto di più ostile esista a questa proposta di risanamento economico: i beni immobili (edifici e terreni) e l’eredità.
L’eredità è una forma massimamente antisociale di donazione coatta. È una donazione fatta all’erede, ma estorta alla comunità. Si caratterizza per il fatto di essere un processo automatico e dunque non libero. Non è infatti un’associazione che a nome della comunità sceglie di affidare patrimoni e mezzi di produzione a chi ritiene li sappia usare bene per tutti, ma essi passano di padre in figlio per pura forza di inerzia o di sangue e grazie a una legislazione che tollera l’arbitrio e lo sfruttamento endemico dell’organismo sociale.
Il concetto di successione ereditaria è la versione borghese e laica della successione al trono per diritto divino. Là come qui è il sangue fisico a decidere chi sarà l’erede, non i talenti individuali. La comunità umana, poste queste premesse, non può intervenire in alcun modo se l’azienda X, florida e benefica per tutti quando la dirigeva il vecchio proprietario, va in malora nelle mani del figlio incapace o irresponsabile, a danno di tutti. Una sana legislazione deve invece conferire all’associazione economica il diritto, alla morte di colui che aveva i talenti per usare i mezzi di produzione a beneficio della comunità, di decidere a chi riassegnarli.
Va da sé che, come già accennavamo, la scelta del successivo fruitore è, in quanto tale, un atto che fa parte della sfera spirituale, trattandosi di sceverare la natura dei talenti individuali idonei, cosa che si può fare, a sua volta, solo in base a talenti individuali. Si potrebbe perciò dire che, dovendo assegnare il «diritto» «esclusivo» all’ «uso», il consesso di persone che prendono queste decisioni deve rappresentare tutte e tre le sfere sociali: trattandosi di un diritto va interpellata la competenza giuridica; trattandosi di uso bisogna ascoltare le priorità economiche; trattandosi di talenti individuali ed esclusivi va data voce in capitolo anche all’istanza spirituale-culturale.
Non è escluso, naturalmente, che sia proprio l’erede fisico a possedere i requisiti necessari: l’associazione non dev’essere un tribunale di sadici o di imbecilli! È ben possibile che proprio i figli del vecchio «gestore responsabile», vissuti per anni accanto al padre, abbiano acquisito meglio di altri l’esperienza, l’entusiasmo e la dedizione necessari a mantenere l’azienda nelle migliori condizioni!
L’importante e il nuovo stanno nel fatto che l’eventuale riassegnazione ai figli non sarà più un fatto di automatismo affidato inesorabilmente al puro arbitrio aleatorio. Magari si potrebbero prevedere periodi di prova o quant’altro si ideerà per poter valutare nel modo migliore ogni aspetto del passaggio di gestione; ma di certo non accadrebbe più che miliardi e miliardi di capitale possano improvvisamente rivolgersi contro la salute dell’organismo sociale per l’inettitudine o addirittura l’irresponsabilità degli eredi.
Consideriamo ora l’altro grande ostacolo alla salute dell’economia, un ostacolo che sta a monte del concetto d’eredità e contribuisce più d’ogni altro fattore a mantenerlo in vita: il possesso di beni immobili e fondiari, cioè la proprietà privata per antonomasia.
Dobbiamo comprendere che la mentalità del possedere cose (anche le meno preziose) con l’atteggiamento interiore che ritiene di poterne disporre a piacimento, senza dover rispondere a nessuno dell’uso che se ne fa, non è una conquista della libertà, ma ne è l’esatto opposto.
La libertà è infatti la grande dissolvitrice di ogni automatismo: come può dunque corrisponderle l’ossessione del possesso irrevocabile o l’acquiescenza ad esso, se il possedere è l’espressione massima dell’imprigionarsi da parte dell’uomo? Colui che possiede qualcosa, prima o poi, ne diventa posseduto. In molte lingue, «possesso» e «possessione» hanno la stessa radice.
La proprietà privata diventa nel corso del tempo un’ossessione reale: ciò perché il possedere non fa parte delle aspirazioni sane dell’essere umano. Nessuno di noi ha veramente bisogno di considerare qualcosa tutta e solo sua per sentirsi uomo! Dalle cose non riverbera su di noi nessuna qualità: siamo noi che infondiamo qualità alle cose e per far questo non abbiamo bisogno di possederle! La brama di possesso non ha dunque il significato positivo di poter disporre liberamente di qualcosa, bensì solo quello negativo di escludere gli altri – non solo ora, ma per sempre – dalla possibilità di servirsene, e di respingere ogni dovere di rendere conto dell’uso, dovendo esso essere di giovamento, e non di danno, alla comunità.
Queste riflessioni ci aiutano a meglio comprendere una legge fondamentale dell’economia: la proprietà in quanto tale ci possiede e ci uccide interiormente. Non siamo allora noi a possedere le cose, ma sono le cose a possedere noi. Come? Osserviamoci nella veste di proprietari di appartamenti: possediamo la casa dove abitiamo e forse abbiamo investito i soldi di una vita comprandocene una seconda. Cominciamo a difenderla, ad assicurarla, a rintuzzare le invidie, a soffrire per le spese condominiali e di mantenimento, a mentire minimizzando il valore della casa quando è ora di pagare le tasse e portandolo alle stelle quando la vogliamo affittare…: e questo tanto per rimanere in una fascia di modesta proprietà.
Immaginiamoci, ora, possidenti veramente sostanziosi, con tanto di rendite e beni al sole: qui anche le possessioni si fanno più ossessionanti. Se siamo completamente presi dalla voracità, il tipo di schiavitù è evidente e non è nemmeno necessario dilungarci a descriverlo. Se siamo ancora capaci di sensibilità sociale, invece, cominciamo a fare acrobazie per giustificare ai nostri stessi occhi tanta ricchezza, che è tutta povertà interiore.
Oscilliamo tra l’orgoglio dei nostri o degli aviti talenti, che siamo costretti sempre a sottolineare (come se gli altri non li avessero, i talenti, e come se l’appello ai propri non dovesse implicitamente ingenerare la voglia di metterli a disposizione per il bene di tutti), e la frustrazione continua nel vedere la povertà e la miseria che dilagano nel mondo e non ci fanno godere in pace le nostre proprietà… Per non parlare poi della paura che l’«invidia criminale» altrui ci ricatti di brutto con rapimenti di persona o con altre terribili insidie…
Per dare un po’ di pace alla coscienza ricadiamo, a questo punto, nella trappola classica del mecenatismo o della beneficenza. Ma queste due forme di falsa donazione sono oggi anacronistiche e dannose per l’organismo sociale; nulla di sano può più nascere da esse, per un duplice motivo. Da una parte esse creano in noi che «doniamo» la paternalistica idea che sia molto importante mantenere e anzi incrementare la nostra ricchezza, perché da essa dipendono anche i nostri beneficiati; dall’altra parte i cosiddetti beneficiati, poveretti, sono nel disagio di dover accettare, pure umilmente ringraziando, la nostra ala protettrice e non trovano il coraggio e la saggezza necessari per chiederci: a chi avete sottratto tutto quello che possedete?
In altre parole: il mecenatismo e la beneficenza sono forme di dipendenza a senso unico – non di interdipendenza – che andavano bene per i tempi in cui il singolo si identificava ancora con l’anima di gruppo, perché non era ancora capace di quell’autonomia del tutto individuale che costituisce la dignità dell’uomo moderno.
Un altro nefasto effetto della proprietà privata è il credito fondiario e immobiliare – verso il quale confluisce il capitale di prestito, al quale abbiamo già accennato – che si basa sulla garanzia privilegiata e duratura che le terre e gli immobili offrono alla mentalità del possesso. Si genera, così, un circolo vizioso: sulla proprietà si investe, in nome della proprietà si fa credito e la proprietà stessa si sopravvaluta in continuazione.
Detto in altri termini ciò significa: se io ho beni immobili e mi serve denaro liquido, non vendo la seconda casa o il terreno ma vado in banca e me lo faccio prestare sulla garanzia del mio passato «mineralizzato». Non solo: il prestito che mi viene senz’altro concesso prescinde del tutto dal fatto che il denaro venga usato da me per un progetto socialmente fecondo, proiettato verso il futuro, oppure per acquistare altra terra o un’altra casa che domani varranno, automaticamente, il doppio di quello che mi sono costate. Come dire: i soldi non vanno ai talenti ma vanno a chi i soldi già li ha.
Ora chiediamoci: qual è il valore reale dei beni immobili, cioè della terra e degli edifici? È oggettivamente nullo! Il loro valore, come abbiamo già visto per il dato di natura, viene deciso in tutto e per tutto dall’interazione operativa dell’essere umano con essi. Se sono in mano a una persona che li farà ben fruttare per tutti, questa conferirà ad essi un valore X; in mano a un’altra che non li sa usare, o che li usa a danno degli altri, assumeranno il disvalore Y.
Attribuire agli immobili un valore oggettivo di compravendita è contro la natura della circolazione dei beni economici. Dal punto di vista di una sana economia i beni immobili sono puri mezzi di produzione e andrebbero consegnati, come tutti gli altri mezzi di produzione, a valore zero. Ma ciò che cosa significa? Che un terreno, una casa, i macchinari per la produzione della carta o della seta ecc., non si possono né comprare né vendere. Si può solo conferire il diritto esclusivo al loro uso. Nel momento in cui incominciano ad essere adoperati, riverberano il valore dei talenti di chi li usa, profondamente diverso da persona a persona.
La legge economica del profitto per tutti
Ciò che abbiamo detto ci porta dritti a una riflessione su un’altra legge fondamentale dell’economia: la legge del massimo profitto per tutti. Quando si argomenta contro la mentalità del profitto, si fa spesso ricorso a moralismi non fondati. E ciò perché il profitto è la legge fondamentale dell’economia! Fare qualcosa senza che ci sia un vantaggio o un guadagno è, in campo economico, l’antieconomico per eccellenza!
Tutto sta allora nel capire correttamente il concetto di guadagno e di profitto. Dobbiamo qui ricordarci di ciò che abbiamo detto sull’egoismo. Abbiamo constatato che l’egoista, paradossalmente, è colui che ama se stesso troppo poco, perché cerca solo il proprio vantaggio a danno altrui, senza rendersi conto che ciò è in fin dei conti a scapito anche suo. Lo stesso vale per colui che cerca un profitto economico per sé a danno altrui: avrà un profitto di tanto inferiore di quanto ne avrà privato gli altri, dai quali in realtà dipende in tutto e per tutto. Il massimo profitto per sé lo può trarre solo colui che mira al contempo al massimo profitto per tutti. Volere un guadagno per sé a scapito altrui è allora nient’altro che una pura illusione. Ricordiamo l’analogia con l’organismo fisico!
Consideriamo ora da questo punto di vista le tre forme di uso del denaro: il comprare, il prestare e il donare.
Nella compravendita, chi ha un profitto? Tutti e due i protagonisti della transazione. Chi dà la merce vuole avere i soldi. Perché? Perché ne trae vantaggio: altrimenti si terrebbe la merce. Chi compra e dà soldi in cambio della merce, perché lo fa? Lo fa perché ha un vantaggio ad avere quella merce anziché i soldi. La compravendita è dunque sensata grazie al fatto che entrambi i contraenti ne traggono un vantaggio. Abbiamo qualcosa in contrario a che venditore e compratore siano ambedue favoriti dalla loro azione? No, è la cosa più ovvia e più bella che vi sia. Anche l’organismo è sano quando tutti gli organi traggono vantaggio dai reciproci scambi, dalle reciproche interazioni.
Veniamo ora al prestare: chi si ripromette un tornaconto nel prestare o nel ricevere in prestito del denaro? Colui che riceve il capitale in prestito è avvantaggiato perché evidentemente ne ha bisogno, e chi presta sa di trarne profitto in forma di interessi. È nella legge del prestito che entrambe le parti si avvantaggino. E va benissimo!
Vediamo infine la donazione: colui che dona veramente, senza secondi fini ricattatori o di controllo, sa che il vantaggio anche economico che ne avrà consiste nel liberarsi di quel denaro eccedente che rischia di ingorgarsi nelle sue tasche e di renderlo pigro e perciò non libero. Certo è un vantaggio, questo, poco conosciuto nell’umanità attuale, perché non si vedono ancora con sufficiente chiarezza tutti gli svantaggi – per la salute fisica, psichica e spirituale – del possedere! Colui che dona, se comprende bene il suo gesto, dona contento; e sa bene che, favorendo i talenti altrui col capitale che non serve ai suoi, ne trarrà doppio beneficio: rifluirà infatti anche su di lui l’esplicazione di quei talenti che egli rende possibile all’altro mediante la sua donazione.
La comprensione di questa legge squisitamente economica del vantaggio e del profitto reale per tutti implica uno stato di coscienza che va sempre nuovamente riconquistato. Esso comporta che nel profondo della nostra interiorità noi siamo capaci di meravigliarci e di gioire di fronte alla realtà sacra della solidarietà umana. Il percepirsi membri gli uni degli altri è un vero salto qualitativo di coscienza perché, quasi senza passi intermedi, la prospettiva all’improvviso si capovolge: ci accorgiamo di essere dentro l’Umanità, non fuori!
Come se un organo, immaginandocelo dotato di autocoscienza, si rendesse conto all’improvviso che, pur nella sua unicità di conformazione e di funzione, è inserito in un corpo unitario, e che è questo corpo a dar senso al suo vivere e a quello di tutti gli altri organi.
Lo spirito oggettivo di solidarietà si esprime in campo economico nel modo migliore tramite l’associazione. Essa è il luogo dove si impara a lavorare per il vantaggio di tutti e di ognuno e dove non c’è riposo finché questo vantaggio comune non venga attuato.
Procedendo di un altro passo, scopriamo un’altra grande verità dell’economia, quella del massimo rendimento col minimo sforzo. Il massimo rendimento, l’abbiamo visto or ora, è il vantaggio di tutti. Il minimo sforzo non è qui una rivalutazione della pigrizia, ma sta a indicare tutto il lavoro materiale che si può risparmiare nell’appagamento dei bisogni della sfera corporea per avere sempre più energie e tempo da dedicare allo specifico umano.
Entriamo così ancora più a fondo nel grande mistero dell’economia moderna e futura che prepara per l’uomo spazi e tempi liberi dall’assillo del materiale sempre più vasti, cosicché egli possa rivolgere sempre di più i suoi sforzi nella direzione dello spirito.
È il grande compito dell’economia l’operare in modo da alleviare per tutti le fatiche della pura sopravvivenza materiale (per esempio mettendo a disposizione di tutti mezzi tecnici sempre più perfetti) e favorire il cammino di evoluzione della conoscenza, dell’arte, della religione. Il risparmio del lavoro materiale rende possibile, a livelli sempre più vasti e profondi, l’esercizio dell’umano.
Il contratto di coproduzione e di distribuzione dei profitti
In un’economia associativa l’accordo che si instaura tra il produttore, il consumatore e il commerciante non è più un contratto di lavoro, l’abbiamo detto, ma di produzione: ciò è importantissimo. Mentre la legislazione sul lavoro, che riguarda la dignità della persona umana, viene lasciata alla sfera giuridica che tratta tutti in modo uguale, nell’associazione economica ci si accorda su ciò che ciascuno dovrà produrre: quanto lavoro ciascuno debba fare per arrivare al prodotto concordato è poi cosa sua. Se per una data prestazione egli prevede di dover lavorare più di quanto oggettivamente può, basterà che non prometta di darla. La legge è fatta apposta per concedergli il diritto a vivere con dignità umana indipendentemente da ogni produttività o prestazione.
In sede associativa viene dunque stipulato un contratto di coproduzione, di produzione concertata, associata. È un accordo sui servizi e le prestazioni reciproci, su ciò che ognuno dovrà poi produrre e ricevere. Nel contratto di coproduzione viene stabilito non soltanto ciò che si richiede a ognuno come prestazione, ma si decide anche della distribuzione del profitto: dunque vi si aggiunge un contratto di distribuzione. Bisogna accordarsi sia su ciò che ognuno si impegna a dare, sia su ciò che ognuno dovrà ricevere.
Da un improprio e nocivo pagamento del lavoro si passa così a una sana condivisione dei profitti: i coproduttori si accordano sul modo di distribuirsi a vicenda il ricavato che tornerà loro indietro tramite quel prezzo giusto che i fruitori pagheranno per i prodotti e che consentirà loro di rinnovare la produzione o il servizio. Il sovrappiù andrà reinvestito nelle migliorie necessarie al settore o donato.
Questo spirito di associazione, con tutte le diverse funzioni che lo caratterizzano, è infine l’arma più efficace per difendersi contro l’arbitrio micidiale del mercato. L’economia di oggi lascia troppe cose all’alea inesorabile e spesso disumana del mercato: e dietro al mercato ci sono le manipolazioni del più scaltro e del più forte. Non è vero che il mercato è cieco. Sono ciechi gli uomini, purtroppo.
Dietro alle cosiddette leggi della domanda e dell’offerta, che sembrerebbero leggi di natura, ci sono giochi di potere che orientano l’acquirente verso l’uno o l’altro prodotto: essi vanno vanificati dando alle associazioni la possibilità di coniugare sul campo le istanze reali di produzione, di consumo e di commercio.
Quinto capitolo
IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO MATERIALE E SPIRITUALE
Il dinamismo intrinseco alla triarticolazione sociale
quale «nutrimento» quotidiano
Una delle cose più belle della vita sono i problemi che sorgono per venire di volta in volta risolti. La cosa più brutta sarebbe il non aver più problemi o il pensare di averli già risolti tutti! Quando gli interrogativi, i dubbi, le tensioni ci sono, il bello dell’esistenza è di lavorarci sopra: vivere con tante domande è più bello che non averne e quando troviamo una risposta essa è convincente nella misura in cui fa sorgere nuove domande.
La gioia del vivere è nel riuscire ad accordarsi col dinamismo incessante dell’esistenza, riconoscendo che devono sorgere sempre nuovi compiti da svolgere, mai con l’intento di arrestarci: è un’illusione credere che sia auspicabile uno stato ideale e stabile delle cose, da mantenere immutato per sempre.
Ci siamo detti a più riprese che la sfera sociale dell’economia è un mondo complesso e sempre in cambiamento, fatto di interazioni infinitamente sfumate fra esseri umani che si esprimono in processi estremamente dinamici di produzione, di distribuzione e di consumo. Essa non ci permette mai uno stato d’animo di assoluto riposo. Ci mantiene sempre vivaci, sempre in divenire, per fortuna.
Abbiamo insistito sul fatto che il contesto privilegiato per far l’esperienza di questo dinamismo è l’associazione, che si fonda sull’attenzione reciproca fra gli esseri umani e sulla consapevolezza che non esistono interessi veri che non siano comuni.
L’utopia che propone e cerca uno stato economico ideale è, in fondo, una variazione del comodismo interiore, dell’ignavia spirituale che vuole finalmente sedersi e godere. Ma chi si ferma, nella vita, non lo fa mai perché è arrivato, bensì perché ha perso la voglia di vivere e di camminare. La vita se la gode veramente soltanto colui che non si ferma mai, riconoscendo nel movimento umano a tutti i livelli – del pensiero, del cuore, dell’operatività – l’essenza stessa e la bellezza del vivere.
È importante allora rivincere ogni giorno la tentazione di credere che il paradiso in terra assomigli, a seconda dei gusti, o a una specie di eterna vacanza hawaiana o a una fruizione indisturbata di beni accumulati una volta per tutte.
Non vi è alcun dubbio: la triarticolazione dell’organismo sociale, quale la propone Rudolf Steiner, è una metodica del movimento continuo, dell’essere sempre in cammino. Una metodica nel senso che, individuando i tre campi reali del sociale – quello della libertà individuale e dei talenti, che abbiamo chiamato sfera culturale; quello della pari dignità umana, dei diritti e dei doveri reciproci, che abbiamo chiamato sfera giuridico-statale; e quello della fratellanza nella produzione, nel consumo e nella distribuzione delle merci, che abbiamo chiamato sfera economica –, ci mette in grado di trapassare in modi sempre nuovi dall’uno all’altro, vivendo e attuando così l’umano. La vita reale consiste negli infiniti modi di interazione dinamica e vivente tra queste tre sfere. L’essere umano si realizza come artista sovrano del vivere facendo sprigionare da questo tricordio sociale melodie sempre nuove.
Nel momento in cui ognuno di noi si pone interiormente in chiave di libertà individuale esprimendosi come portatore di talenti, deve contemporaneamente riconoscere quali tipi di interazione richiedano invece di essere vissuti secondo solidarietà o uguaglianza. Sappiamo come sia facile vedere tutto alla luce della libertà individuale, della totale autonomia di ognuno, dimenticando la fratellanza; oppure tirare dritto per la fratellanza, perdendo di vista la libertà individuale; oppure farsi paladini di una salomonica uguaglianza, dimenticando la diversità reale e sfumata dei bisogni e dei talenti, che sono sempre disuguali da persona a persona.
La grande tentazione è qui di nuovo quella di privilegiare uno di questi atteggiamenti a scapito degli altri. L’essere «umani» sta nell’averli invece tutti e tre compresenti, interconnessi e sanamente interagenti. La complessità, del resto, ha tutto a che fare con la bellezza: il bello non è mai caratterizzato dalla monotonia o dalla riduzione. Il bello è nella ricchezza, nella possibilità di variazioni e sfumature infinite, quali ce le mostrano i tramonti del sole e i fiori a primavera.
La bellezza dei giochi di colori sta nel fatto che essi consentono variazioni e gradazioni infinite, e il pittore ama le sorprese degli incontri: ma insieme rispetta il linguaggio peculiare dei tre colori fondamentali, da cui tutti gli altri nascono, perché sa che il blu ha le sue leggi, il giallo ne ha altre e il rosso altre ancora. Solo in questo rispetto i colori possono incontrarsi davvero, possono sfumarsi all’infinito.
Per essere desti alle infinite variazioni sui temi fondamentali della sinfonia della vita bisogna essere interiormente malleabili, multiformi e capaci di giocare. Insomma, per vivere da uomini bisogna diventare artisti.
La vita è come una sinfonia, l’evoluzione umana è come un grandioso concerto, la loro legge è la ricchezza senza fine, l’esuberanza che non conosce arresti. Un pensiero che voglia attingere alla realtà dev’essere anch’esso un’opera d’arte, deve poter procedere ed esprimersi come un’armonia.
Solo a questa qualità vivente e artistica dell’umano noi possiamo affidare l’idea che lo spirito associativo, in campo economico, sia come il pane quotidiano che ci nutre in modo vero e sostanziale.
L’arte della mediazione nel pareggiare diritti e doveri
Consideriamo un po’ più da vicino la natura dell’associazione. A chi ci chiedesse: è una specie di parlamento o di corporazione? è un supertribunale? possiamo rispondere: lo spirito associativo è uno dei tre modi fondamentali di interagire degli esseri umani che, dappertutto e in ogni momento, hanno a che fare gli uni con gli altri. Questi tre modi si possono esprimere così:
1. Lasciarsi in pace a vicenda è il modo di convivere giusto quando si tratta dell’esercizio della libertà individuale attraverso l’espressione dei talenti di ognuno;
2. rispettarsi reciprocamente, riconoscendosi pari diritti e pari doveri, è il modo di interagire in tutte le questioni che riguardano la pura dignità umana;
3. associarsi nella solidarietà dell’aiuto reciproco è infine la forma di interazione più idonea là dove si tratta di produrre, di commerciare e di consumare.
Lasciarsi liberi, rispettarsi reciprocamente, aiutarsi a vicenda: queste sono le tre grandi forme del convivere sociale delle quali gli uomini hanno quotidianamente «fame» e grazie alle quali vogliono «saziarsi».
In campo economico associativo ognuno di noi si espone alla circolazione del sangue comune e ne trae vero sostentamento: come consumatori, come produttori e come distributori noi ci offriamo a vicenda in mille modi reali il nutrimento quotidiano, poiché la nostra esperienza operativa individuale (sia nel dare sia nel ricevere) è l’autentico frammento d’umanità che manca all’altro.
Prendiamo l’esempio associativo di una scuola, una piccola scuola magari. In ogni parte del mondo la scuola, intesa ora nel senso ampio di servizio educativo, presenta (o meglio dovrebbe presentare) tutti e tre i modi d’incontro fra gli esseri umani, come del resto accade in ogni altra realtà sociale umana: c’è l’interazione al livello della vita spirituale e culturale, cioè l’esercizio del tutto libero e individuale soprattutto dei talenti di ogni insegnante; c’è il livello giuridico che va dagli orari di lavoro al diritto all’educazione che ha ogni bambino; e c’è il livello economico: qui, in una corretta triarticolazione sociale, entra in scena l’associazione specificamente pedagogica, che ogni scuola dovrebbe avere.
Chiediamoci ora: come funziona un’associazione pedagogica? Essa vive dell’interazione fra gli esseri umani in quanto essi producono, fruiscono e distribuiscono il prodotto spirituale chiamato «educazione». Il numero delle persone che si incontrano regolarmente in sede associativa dovrebbe essere tale da consentire la partecipazione diretta di ognuno. Abbiamo già detto che uno dei compiti primari dell’associazione è quello di stabilire il giusto prezzo delle merci. Il compito primario di un’associazione pedagogica sarà dunque quello di trovare la giusta retta scolastica.
Nell’associazione di una scuola si incontrano allora fra di loro:
1. gli insegnanti, che sono i produttori veri e propri della merce «educazione»;
2. i consumatori: nel nostro caso i consumatori diretti sarebbero i bambini ma, non essendo essi in grado di assumere un ruolo libero e autonomo, subentrano in loro vece i genitori;
3. i «commercianti», che fanno da «mediatori» tra consumatori e produttori facendo circolare la «merce educazione», salvaguardando la pari dignità umana degli uni e degli altri e attribuendo sia agli uni sia agli altri parità di diritti e di doveri.
È molto importante soffermarci sull’ultimo punto. Coloro che hanno esperienza diretta in questo campo sanno bene che se in un’associazione pedagogica ci fossero soltanto insegnanti e genitori, scoccherebbero scintille continue: si troverebbero di fronte interessi e problemi per natura opposti, desideri e intenti spesso inconciliabili. Dunque ci vuole veramente una mediazione, anche nel caso di un’associazione pedagogica, e ciò proprio per il fatto che la tensione continua tra genitori e maestri – tensione, non guerra! – è sana e necessaria e favorisce la salute della scuola.
La mediazione, infatti, non è soltanto quella del negoziante che compra all’ingrosso e rivende al minuto o quella del commerciante che trasporta le mele dal Trentino ad Amburgo: nel contesto di un’associazione pedagogica il mediatore deve avere la prerogativa fondamentale di non essere direttamente coinvolto né nella produzione né nel consumo – non dev’essere, cioè, né insegnante né genitore – e perciò la sua sfera di osservazione imparziale è il rapporto stesso di corrispondenza tra la domanda (bisogni e aspettative legittime dei genitori) e l’offerta (prestazione dei maestri in base alle loro capacità reali).
Non avendo interessi né di qua né di là egli non è di parte e può prestare pari attenzione e dare pari peso a entrambi considerandoli unicamente come esseri umani con pari dignità. Può così veramente mediare, vagliando oggettivamente le istanze e le esperienze positive e negative di tutti. Questa mediazione è necessaria proprio perché è insito nella vita economica a tutti i livelli che i problemi del consumatore debbano essere opposti a quelli del produttore: in una scuola senza tensioni tra genitori e maestri la qualità dell’educazione non migliorerebbe ma peggiorerebbe di certo.
Il dinamismo vero dell’economia sorge infatti sempre da questa benefica tensione ed è un’arte gestirla senza rimpiangere mai uno stato ottimale di riposo, bensì inventando soluzioni e correzioni sempre nuove. Tradotto in una bella immagine: la vita è l’arte del giocare all’altalena, la capacità geniale dell’essere umano di bilanciarsi come un artista con slanci ed equilibri sempre diversi tra le varie polarità dell’esistenza. Anche nell’organismo è così: guai se il sistema neuro-sensoriale e quello del ricambio non fossero in continua «lotta» fra loro!
Come nella vita sociale, intesa in senso generale, la sfera giuridica fa da arbitro tra la libertà individuale dei talenti e la solidarietà comunitaria dei bisogni, così all’interno dell’associazione (che è la forma specifica di gestione delle faccende economiche) il concetto di giustizia trapassa in quello di mediazione equilibrante fra gli interessi dei consumatori e quelli dei produttori.
Inoltre anche la pedagogia, se non la pensiamo come un prodotto stereotipato e imposto dallo Stato, ha bisogno di modi sempre nuovi di «distribuzione» per arrivare sempre meglio al consumatore: ha bisogno di qualcuno, insomma, che si occupi di mettere e tenere in rapporto reciproco il produttore e il consumatore.
La mediazione, in campo economico, non è infatti l’invasione impropria della sfera giuridica in quella economica. Il mediatore non deve qui dettare legge né ai consumatori né ai produttori. A lui deve stare a cuore da un lato che la «merce educazione» corrisponda ai bisogni veri del consumatore che la compra e la paga, e dall’altro che le esigenze dei genitori non facciano torto alla legittima libertà individuale dell’insegnante che, come «produttore», sa bene il fatto suo in campo di pedagogia. È un po’ come l’arbitro di una partita di tennis: egli sa che non c’è gusto per nessuno se non c’è una sana tensione fra i due giocatori che permetta sorprese infinite di squilibri e di riconquistati bilanciamenti di forze. Ma ciò è possibile unicamente se le forze non sono troppo impari: altrimenti si ha la sopraffazione dell’un polo nei confronti dell’altro e non l’«emozione» del sano confronto.
Il duplice nutrimento dell’uomo: libertà e amore
Il nutrimento quotidiano più vero e sostanziale che vi sia è l’attenzione continua che io rivolgo all’altro e l’attenzione che l’altro porge a me. Quando l’altro dedica attenzione a me, mi ricarica, mi «ricostituisce» nella mia dignità e nella mia importanza. Io ricevo forza, nutrimento e conferma del mio valore grazie all’interesse che l’altro mi porta incontro; io nutro, a mia volta, confermo e rafforzo realmente l’altro nel suo essere quando gli dedico la mia attenzione. L’amore e la libertà sono davvero i due più efficaci «ricostituenti» della vita.
Rendersi importanti gli uni per gli altri è l’esercizio fondamentale del rafforzamento interiore, del nutrimento spirituale. Che cos’è, infatti, che ci sostiene davvero nella vita? Qual è il nostro vero sostentamento? È il saperci importanti, anzi necessari per gli altri. E, viceversa, ognuno di noi può dire all’altro: io ti sostengo e ti sostento riconoscendo quanto tu sei importante per me. Non di solo pane materiale vive l’uomo! Il pane materiale è la premessa per poterci cibare di un altro tipo di pane che è ancora più buono e fragrante.
Due sono allora le fonti del nostro vivere quotidiano: una è materiale, l’altra è spirituale. L’essere umano è da un lato la somma di tutto ciò che è fisico – nella sua corporeità egli è l’apice e la sintesi di tutti i regni della natura – e dall’altro è non meno la somma di tutto ciò che è spirito. Lo specifico dell’umano è proprio l’incontro, l’abbraccio vicendevole tra lo spirito e la materia. Specifico dell’uomo è di far sempre da ponte, di essere un pontefice, il fulcro cosmico di equilibrio fra l’invisibile e il visibile. Anche il pane adatto all’uomo deve essere allora duplice: deve poter venire sia dal mondo della materia sia dal mondo dello spirito. E l’anima gioisce in questa concordanza amorevole fra il suo corpo e il suo spirito.
Il pane d’acqua e farina da mangiare nutre il nostro corpo; il pane spirituale dei talenti da esplicare in libertà amando gli altri nutre il nostro spirito.
Ciò che veramente ci nutre e ci sostenta in quanto esseri spirituali sono i pensieri e i sentimenti che da essi promanano. Per l’essere umano non c’è nulla di più sostanziale e sostanzioso dei pensieri! Il motivo per cui egli disattende e sottovaluta i pensieri è proprio la sua abitudine al pensare: lo fa così spontaneamente e così volentieri che non se ne accorge neppure. Poiché egli pensa in ogni momento della giornata, si è abituato a pensare che il pensare sia di poca importanza! E questo è un grave inganno del pensiero.
È lo spirito, sempre, che informa e plasma la vita. Lo spirito è la realtà più concreta e più vissuta che vi sia, lo spirito decide della realtà intima di ogni essere umano, in chiave sia positiva che negativa. Colui che è in grado di trasformare quotidianamente le sue idee in ideali e i suoi ideali in azioni gusta la forza inarrestabile dello spirito umano. Gli ideali sono il nutrimento vero della vita: essi ci danno slancio, ci danno forza, ci fanno ridiventare giovani ogni giorno, ci danno le ali per volare.
Che cosa avviene quando sorgono in noi pensieri positivi, impulsi volitivi carichi di significato? Noi siamo commossi e mossi all’agire! Ognuno di noi fa sempre, pur senza badarci, l’esperienza della positività ricaricante e ricostituente dei pensieri. Quando si fa qualcosa perché si è innamorati, per esempio: la giornata è tutta diversa. Che cosa non si fa per la persona che si ama! E questo amore in che cosa consiste? In pensieri, che si tingono di sentimento. Si ama quando si è addormentati? No. E che cosa manca quando si dorme? La coscienza, il pensiero. L’amore è intriso di pensieri viventi e i pensieri veri sono sempre intrisi d’amore. Se all’amore togliamo i pensieri non resta nulla.
Anche in chiave negativa, e questo è importante, ci viene confermata la sostanzialità «nutriente» del pensare. Quando io nego la forza del pensiero, che cosa faccio? Esprimo un pensiero. Quando io dico che i pensieri sono una realtà di poco conto, sottovaluto il pensiero grazie al pensiero. E lo scoraggiamento che cos’è? Siamo noi stessi intrisi di pensieri negativi. Comprendendo che lo scoraggiamento viene vissuto quando mancano i pensieri positivi e belli, con questo pensiero non facciamo che riconfermare l’importanza fondamentale del pensiero. E la volontà che cos’è? È un pensiero così bello e irresistibile che non possiamo non aderire alla gioia di tradurlo in azione.
Ogni imprenditore sa che cosa vuol dire collaborare con degli operai che vengono a lavorare demoralizzati o avviliti. Lo scoraggiamento è un insieme di pensieri negativi, un vuoto spirituale che incide in modo decisivo sulla vita: uccide forze reali e se ne fa un’esperienza reale. A colui che è depressivo mancano i pensieri positivi. Ma la mancanza di pensieri positivi è povertà di pensiero: è dunque sempre il pensiero a decidere della qualità e delle sorti della vita. Anche la paura e la gioia sono fatte di pensieri, o di pensieri che mancano. I motivi che ci spingono ad agire sono pensieri, sono moventi e molle reali.
Ogni uomo è ciò che pensa. Tutto il resto egli lo ha, è estrinseco al suo essere. Ognuno di noi è ciò che di volta in volta è in grado di pensare: è questa la realtà sostanziale del suo essere che decide di tutte le sue manifestazioni, in modo assoluto.
Dobbiamo dunque occuparci delle faccende del pensiero se vogliamo nutrirci del pane che dà sapore alla vita. Quando un essere umano attribuisce ai meccanismi della materia la causalità esclusiva di ciò che avviene nel suo spirito, esprime un pensiero. È un pensiero di abdicazione tramite il quale il pensare stesso rinnega la propria forza causante: ma non può farlo che esprimendo un pensiero. Perfino i peccati più gravi di omissione avvengono nel nostro pensiero.
Anche in economia sono i motivi, gli ideali, le mete che ci prefiggiamo a decidere tutto: e sono tutti pensieri. In un essere umano scoraggiato è la povertà di pensiero a decidere del suo modo di porsi nel contesto economico. Colui che produce in base al dinamismo interiore della sua libertà produce in base a pensieri che sgorgano come intuizioni luminose e vivificanti dalla sorgente cristallina del suo spirito.
Qui si pone allora la domanda: che cosa si può fare per generare e coltivare pensieri sempre freschi e buoni, tali da costituire vero pane quotidiano che ci dia forza, che ogni giorno ci nutra e ci ricostituisca? Non basta, infatti, indicare teoricamente l’importanza assoluta dei pensieri per generarne concretamente di positivi e di belli.
Far sprigionare dal proprio essere pensieri intuitivi e fantasiosi è beatitudine, è l’arte stessa della vita. Per quest’arte non c’è una comoda ricetta, non esiste una breve formuletta: i pensieri positivi che ci nutrono e ci ricostituiscono ogni giorno possono unicamente sorgere da un’attività quotidiana analoga al mangiare. Come ogni giorno noi ci procuriamo il pane materiale che poi mangiamo per vivere, così è necessario procurarci ogni giorno anche il nutrimento per lo spirito. I «pasti» quotidiani dello spirito sono i momenti privilegiati durante i quali mettiamo ordine nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti, ristabilendo l’armonia interiore che ci dà nuova forza; il resto della giornata serve alla lenta «digestione».
Nutrire quotidianamente lo spirito è il quotidiano lavoro su di sé. I pensieri negativi vanno sempre di nuovo cancellati rendendoci conto che sono errori e illusioni. La negatività è sempre un’illusione, una miopia. Si vede il negativo soltanto perché non si vede ancora il positivo. La purificazione interiore avviene sempre grazie al nutrimento spirituale dei pensieri sani e positivi.
Bisogni e talenti: fame e sazietà
La polarità che vige tra il pane materiale e il pane spirituale ci rimanda all’altra già ricordata dei bisogni e dei talenti. I nostri bisogni sono la nostra fame quotidiana, i talenti la nostra sazietà. Il bisogno è sempre una fame in cerca di appagamento, il talento è una pienezza esuberante in grado di sfamare gli altri. Quando io vivo nei miei bisogni sono affamato, ho bisogno io di mangiare; quando vivo l’avveramento dei miei talenti non sono un affamato, sono uno straricco che vuole dare e arricchire gli altri.
E il denaro sta per entrambi! Esso può essere sia lo strumento per l’appagamento dei bisogni sia lo strumento per l’esercizio dei talenti. L’uso duplice del denaro indica proprio il dinamismo intrinseco dell’economia. Noi siamo liberi di orientare il denaro nella direzione unica dei bisogni: nasce allora un’umanità posseduta dalle brame, condannata a vivere se stessa eternamente in chiave di bisogni. Ma possiamo anche valerci del denaro sempre di più per coltivare l’inesauribile creatività spirituale e artistica degli esseri umani.
L’economia attuale è ancora in gran parte un’economia delle brame: i bisogni vengono moltiplicati all’infinito perché si conosce troppo poco la beatitudine indicibile dell’espressione dei talenti. Essendo un’economia delle brame, la nostra è altresì un’economia della fame: si dedica quasi esclusivamente all’appagamento dei bisogni. In altre parole, noi oggi viviamo in un’economia di affamati che ancora non conoscono l’umana pienezza.
Ma è possibile anche un’altra economia: quella dei sazi! Un’economia di esseri umani che vivono nella pienezza, anzi nella sovrabbondanza straripante che si comunica e contagia, come dice una delle più belle frasi del Vangelo: ex abundantia cordis os loquitur (la bocca parla dalla sovrabbondanza del cuore). Il grande travaglio, il grande varco di soglia dell’economia mondiale attuale consiste nella trasformazione interiore degli esseri umani che anelano a vivere sempre di più nella pienezza dell’umano colmando quella povertà che conosce solo la fame ossessiva delle brame e dei bisogni.
Un’economia veramente umana produce, distribuisce e consuma talenti, umana autorealizzazione, sovrana gioia del vivere. L’espressione di sé – delle proprie intuizioni, dei propri sentimenti più cari e dei propri voleri più veri e autentici – è al contempo il miglior modo per venire incontro ai bisogni altrui. Più è pura l’espressione dei talenti e più è appagante la soddisfazione dei bisogni.
Dicendo questo veniamo riportati alla domanda già prima formulata: come riconosco i miei veri bisogni? Ancora una volta non ci viene dato in mano un comodo prontuario, ma l’indicazione di un orientamento fondamentale, di un interminabile cammino da percorrere.
Un mio bisogno è vero e genuino se il suo soddisfacimento mi mette in condizione di meglio esercitare i miei talenti. Per conoscere bene i miei bisogni reali devo allora conoscere i miei talenti: solo il criterio dei talenti può sciogliere di volta in volta e in modi sempre nuovi l’enigma sfingeo dei bisogni.
Ciò che mi consente di esercitare meglio i miei talenti è un bisogno vero e va appagato; ciò che non serve a questo fine non è un bisogno vero e va scartato. Esso mi complica la vita inutilmente perché mi impedisce di esercitare i talenti nel modo più idoneo.
La prima cosa da fare è dunque di porre al centro la gioia della creatività della libera esplicazione delle proprie capacità. In questo modo sarò anche in grado di gioire di tutto ciò di cui non ho bisogno. Una volta alla settimana posso per esempio fare la bella esperienza di percorrere tutto un supermercato per godermi tutte le cose di cui posso e voglio fare a meno e uscire senza aver comprato nulla! (ammesso che mi lascino uscire senza aver comprato nulla!).
Può essere un esercizio salutare. Se io non mi metto mai nella condizione di dire: no, questa cosa non mi serve affatto, resterò sempre nell’atteggiamento interiore delle brame infinite e indefinite di colui che pensa che sarebbe bello avere tutto. No! Se io avessi tutto sarebbe per me una catastrofe totale! Per mia fortuna la stragrande maggioranza delle cose del mondo non ho bisogno di averle e non voglio averle. Ciò che veramente ci appartiene, come il Sole e la Terra, lo condividiamo col resto dell’umanità. Ognuno di noi possiede veramente soltanto ciò che ha in comune con gli altri.
Noi viviamo nell’illusione quando pensiamo che più cose possediamo e meglio è. No, più cose si posseggono e più problemi inutili si hanno! C’è qualcosa di infinitamente migliore dell’avere: l’essere. Colui che si innamora dell’essere finisce per avere tutto, perché non possiede più nulla. Nostro è solo ciò che abbiamo rinunciato a possedere, affinché ci venga dato in dono.
Se i miei veri bisogni sono quelli che mi consentono di esercitare pienamente i miei talenti, come controprova negativa non sono veri bisogni quelli il cui appagamento mi rende la vita più comoda. Perché il rendermi la vita comoda è proprio l’opposto del mettermi in condizione di esercitare dinamicamente i talenti. Il senso della vita è di essere bella, non comoda. La vita comoda non è una vita bella e la vita bella non è mai comoda. Chi vive comodamente è interiormente morto.
Uomo bisognoso o uomo che elargisce?
Però c’è un altro importante quesito che va affrontato quando si parla di bisogni e di talenti: è la difficoltà che si incontra nel distinguere che cosa sia un bisogno e che cosa sia un talento. Prendiamo un esempio concreto: un pittore che dipinge un quadro lo fa in base a un bisogno (di essere pagato bene, perché ha un gran bisogno di soldi) oppure si orienta secondo il suo talento, fatto di pura gioia creatrice (che manda a farsi benedire il bisogno di soldi)? E se poi domani – o oggi – egli stesso e la sua famiglia non hanno di che mangiare?
Questo enigma è divenuto per l’uomo moderno un nodo del tutto aggrovigliato e pressoché inestricabile proprio perché egli è stato abituato – per non dire «educato» – a vivere quasi tutto in chiave di appagamento di bisogni (con l’atteggiamento interiore del soddisfacimento di brame) e quasi nulla in chiave di espressione libera di talenti (con l’atteggiamento interiore dello straricco che fantasiosamente crea e doviziosamente dispensa).
Ognuno di noi deve allora riscoprire in sé l’Edipo che di fronte al grande enigma evolutivo della Sfinge non vi ravvisa solo le brame e i bisogni animali – quelli del toro, del leone, dell’aquila – ma in primo luogo il mistero dell’uomo che si avvale della natura animale dentro di sé per farne uno strumento in vista dell’evoluzione della propria libertà.
Se le montagne di denaro che vengono usate per sfruttare e per rovinare l’umanità venissero investite nella cosiddetta formazione dei giovani – che abbraccia, oggi, in fondo, tutta la prima metà della vita – avremmo su tutta la terra una gioventù sempre meno stremata dalla zavorra dei bisogni e sempre più entusiasmata dal lievito dei talenti. La gioventù è fatta per avere la possibilità di provare e sperimentare tutto il possibile e l’immaginabile in modo da imparare, imparare, imparare senza lasciar sotterrato nessun talento, senza lasciare incolta nessuna capacità e ciò soprattutto grazie ai propri sbagli. Lo scopo vero dell’imparare nella prima metà della vita è quello di imparare a imparare anche per la seconda metà della vita, cioè quello di acquisire la capacità di imparare sempre.
La parabola evangelica del figliol prodigo loda quel figlio giovane che è andato via di casa e ha sperperato – consumato – tutta l’eredità per fare le sue esperienze. Il figlio maggiore, che è rimasto a casa, condanna il fratello come se si fosse comportato moralmente male e, a riprova di ciò, inventa le vicende con le meretrici che, invece, non esistono nel racconto pur particolareggiato dell’evangelista. Così argomentando protesta presso il padre, proprio come ha sempre fatto e ancora fa la versione moraleggiante di una religione poco convincente, che predica ai giovani solo la morigeratezza e l’obbedienza.
È una società disumana, è un’economia antieconomica quella che costringe il giovane a mettere in primo piano i propri bisogni – sorti troppo prematuramente e contrabbandati come doveri – in base all’ansia dei genitori che non vedono l’ora che si laurei (oggi c’è bisogno di un pezzo di carta!), che trovi un posto di lavoro (bisogna sistemarsi nella vita!), e magari si sposi (hai bisogno di metter su famiglia!). L’assillo dei bisogni propri, che sembrano ineluttabili, costringe il giovane ad adeguarsi omettendo l’esperienza diretta di che cosa sia l’espressione libera di un talento.
Il giovane è invece venuto al mondo per mettere in primo piano i bisogni altrui: ha bisogno dei bisogni altrui, potremmo dire. Solo così facendo può riconoscere per esperienza diretta il richiamo, l’urgenza d’espressione di tutti i suoi talenti. Basta che si rimbocchi le maniche tuffandosi nel mare della vita – senza inseguire piste preordinate come fanno i cani da tartufo perché il padrone ha bisogno di tartufi – e si accorgerà ben presto di quanto gli viene richiesto da ogni parte. Potersi sentire liberi di mettersi a disposizione: ecco l’esperienza che manca ai giovani dell’epoca nostra.
Proprio l’esercizio di questa versatilità inesauribile evocata dall’aiuto premuroso diretto agli altri, suscita e affina nel modo migliore i talenti del giovane, non ultimo il talento più prezioso: quello di saper sceverare bene i propri talenti. Il coltivare e vagliare i propri più autentici talenti richiede un’infinita sperimentazione, che oggi è resa possibile quando in gioventù si consente al destino di portarci incontro i bisogni degli altri, quando si riesce a frenare la tirchieria mentale e l’ottusa sete di potere della generazione precedente che vede in questo cimento pluridirezionale il segno di una gioventù «sbandata».
Solo una generazione adulta che non ha conosciuto la libertà vera della gioventù può negare questa stessa libertà ai propri giovani: Ma chi non ha vissuto da giovane l’ebbrezza che dà la libertà di assaggiare la vita senza aver già definito «cosa si farà da grandi» costui viene costretto ad avvelenare l’amore che dovrebbe sorgere con la maturità, snaturandolo in una perpetua brama di recupero di una libertà che non si può più riafferrare.
Infatti soltanto se la gioventù viene rettamente vissuta è possibile «nel mezzo del cammin di nostra vita» invertire le priorità passando dalla libertà che è propria dell’uomo giovane all’amore che dev’essere proprio dell’uomo maturo. Da giovani il mettere in primo piano i bisogni altrui aveva lo scopo di appropriarci nel modo più vivo dei nostri propri talenti. Da uomini maturi siamo sì chiamati a mettere in primo piano i nostri talenti – ormai ben collaudati e individualizzati – ma con lo scopo opposto: quello di servire grazie ad essi nel modo migliore possibile i bisogni degli altri. Sono oggi tante le persone anziane logorate dal dubbio che forse avrebbero fatto meglio da giovani ad imboccare una strada del tutto diversa… ma ormai, in età avanzata, è troppo tardi.
Un’economia mondiale degna dell’uomo sarà così generosa con i giovani che vengono a fecondarla da non costringerli prematuramente a essere così bisognosi da dover snaturare i talenti vivendoli come se fossero bisogni. Concederà loro da giovani di provare tutte le vie perché non debbano pentirsi in seguito di essere rimasti incastrati in un vicolo cieco.
Se comprendiamo bene queste due leggi fondamentali dell’esistenza – oserei chiamarle proprio così –, comprendiamo sempre meglio anche la polarità fondamentale della vita stessa: da giovani c’è un crescere e un esuberare di vitalità e di forze fisiche, poi l’evoluzione si inverte e lo strumento corporeo entra nella fase del lento declino della morte. Nel suo risvolto psichico-spirituale ciò vuol dire che è nella natura della prima metà della vita che essa ci venga data per vivere nell’amore inebriante per la libertà, e che l’età matura invece ci venga donata perché conquistiamo la libertà saggia dell’amore. L’amore di libertà nella gioventù, se è vissuto in verità, si trasforma per sua natura nella libertà dell’amore nell’età matura.
Ma il risvolto economico di queste considerazioni si esprime nella drammatica domanda che risuona già da decenni: fino a quando avremo una economia mondiale governata dallo strapotere decadente e miliardario di veri e propri imperi dinastici che mirano solo a foraggiare se stessi e per i quali le guerre e il traffico della droga pagano meglio che non il sostenere la gioventù dell’umanità, ai loro occhi capace solo di sperperare?
Il talento del lustrascarpe e della lavandaia
Nel contesto di queste riflessioni va aggiunta una parola sul concetto stesso di talento. C’è chi pensa che «talento» significhi qualcosa di speciale o di straordinario. C’è chi pensa di avere meno talenti di altri, talenti più modesti di altri. Va detto allora subito che il talento non risiede mai in ciò che una persona fa, bensì nel modo in cui lo fa, cioè nel suo modo di essere. Non esistono talenti che abbiano maggiore o minore valore o che siano più o meno importanti. Solo l’essere umano ha valore, e il valore dell’essere umano non varia da persona a persona ma è ugualmente infinito in ogni persona, perché ogni persona è in se stessa un valore infinito.
Noi oggi ci abituiamo già da giovani a confondere il talento – e il corrispettivo valore che gli attribuiamo – con l’attività esterna che una persona compie. In questo modo paragoniamo il talento del pittore con quello dello scrittore ma mai con quello del lustrascarpe e della lavandaia. Diamo allora più o meno importanza ai «talenti-mestieri» a seconda del prestigio di cui essi godono tradizionalmente nella società (con conseguente remunerazione economica). E pensiamo erroneamente che un dato talento valga di più o di meno di un altro.
Se invece di considerare i talenti dall’esterno – con l’occhio inquinato che attribuisce valore e peso agli uomini a seconda della loro posizione sociale – noi cominciassimo a considerarli dall’interno, cioè in base a ciò che l’uomo vive e diviene nelle profondità del suo essere grazie a ciò che compie, allora comprenderemmo che è possibile compiere tutte, proprio tutte le attività, anche le più modeste e quotidiane, con sommo, anzi con geniale talento. Che al suo livello più perfetto diviene il talento della libertà e dell’amore.
Il talento non viene allora più visto in ciò che si fa ma in ciò che si è. Che si tratti di far le pulizie o di imbandire la tavola, di suonare il violino o di spurgare i pozzi neri, di fare una passeggiata o di tenere una conversazione, di rammendare le calze o di leggere il giornale, di pilotare un Jumbo o di andare in bicicletta… il talento vero di chi compie queste azioni risiede nel modo in cui le compie, cioè nella sua interiorità. Il talento risiede nel modo del tutto individuale e unico di creare i pensieri che accompagnano le azioni quotidiane, nella genialità del cuore che sa dire mille volte «io ti amo» senza ripetersi mai, nella forza travolgente di ideali eterni che sanno collocare il più umile gesto quotidiano nel contesto di una evoluzione che abbraccia millenni.
Nella misura in cui una persona fa l’esperienza della gioia e della pienezza inerenti all’esercizio quotidiano dell’unicità del proprio essere – la lavandaia lavando e il lustrascarpe lustrando le scarpe – essa impara a ben distinguere tra l’amore stesso all’azione quale puro esercizio di beatitudine umana e il suo risultato, o risvolto estrinseco, che è il peso sociale riconosciuto all’azione compiuta, che è il successo, o la lode, o la stima, o la risonanza.
Per la piena esplicazione dei propri talenti, per il fiorire rigoglioso della propria fantasia morale, nessuno ha bisogno di cambiare mestiere o mansione per salire una supposta scala di valori o di carriera: ogni cambiamento è vero e sensato solo quando è la conseguenza dell’essere se stessi, non quando ne vorrebbe essere il presupposto se non addirittura il surrogato. Chi cambia posto per poter diventare se stesso, lo vuol diventare grazie al posto, non per forza propria: così cambierà il posto e resterà lo stesso di prima! Solo colui che è capace di esplicare i suoi talenti pienamente in ogni situazione – cioè qui e ora – troverà sempre il suo posto giusto nella comunità umana, perché non sarà il posto a rendere giusto lui, ma lui a rendere giusto ogni posto che occupa. Non sarà mai una mansione o una situazione ideale a rendere possibile una piena esplicazione dei talenti: sarà sempre quest’ultima a conferire a ogni situazione una sovrabbondante misura di realismo e di idealismo.
C’è un pane vero che discende dal cielo?
L’essere umano moderno, da buon materialista, è convinto di alimentarsi fisicamente con i cibi materiali che ingerisce. Rudolf Steiner fa a questo proposito un’affermazione rivoluzionaria (che però riprende una verità nota a tutti gli antichi centri misterici di iniziazione nonché alle religioni e alle antiche mitologie) che dice: non è la materia dei cibi che noi assumiamo a costruire e ricostituire il nostro corpo fisico, ma la vera materia che ci alimenta, anche e proprio al livello fisico, viene dal cosmo. Dalla luce, dall’aria, dal calore, da tutte le forze eterico-vitali dell’universo… Forse vale la pena, anche se a titolo puramente informativo, entrare un po’ nel merito di questa affermazione a tutta prima sconvolgente, lasciando naturalmente a ognuno la libertà interiore di farne ciò che vuole.
Qui ci viene detto: noi non assumiamo direttamente la sostanza materiale dei cibi che ingeriamo, ma distruggendoli grazie alla digestione noi generiamo le controforze di natura sovrasensibile necessarie per permettere alla materialità cosmica di venire assimilata dall’organismo per ricostituirlo sempre di nuovo. Questo potrebbe spiegare, per esempio, come possano esserci persone che mangiano, mangiano, mangiano e restano sempre uno stecchino e altre che solo a guardare i cibi ingrassano.
Il vangelo di Giovanni, a proposito della cosiddetta «moltiplicazione dei pani», parla nel sesto capitolo per ben dodici volte del «pane che discende dal cielo». Lì si intende proprio il pane «celeste» che edifica il nostro corpo fisico, composto da dodici parti che sono state da sempre riferite ai dodici segni dello Zodiaco, le cui forze in grado di plasmare l’essere umano discendono dal cielo in modo realissimo. La corrispondenza di forze tra i segni zodiacali e le parti del corpo umano fu sempre vista nel modo seguente:
ariete: capo
toro: laringe
gemelli: braccia
cancro: torace
leone: cuore
vergine: addome
bilancia: anche
scorpione: organi genitali
sagittario: cosce
capricorno: ginocchia
acquario: gambe
pesci: piedi
Secondo questa visione delle cose, il pane fisico, quello che dà vita e forza al nostro corpo materiale, non viene dalla Terra, ma in senso reale e oggettivo viene dal cielo, dal cosmo. Questo alimento celeste è il viatico intriso di amore che gli Esseri spirituali ci inviano dallo Zodiaco e dal sistema solare per alimentarci con le loro forze, giorno dopo giorno: è questo il pane quotidiano e sostanziale che ricostituisce sempre e nuovamente il nostro corpo fisico. E i cibi materiali che noi ingeriamo, nei quali vive la quintessenza delle controforze della Terra, permettono alla materialità cosmica di ricostituirci ogni giorno nelle dodici nostre parti fisiche, che vengono tutte compenetrate e unificate dall’Io, così come il Sole visita tutti i dodici segni dello Zodiaco.
«Il pane sostanziale che discende dal cielo» sono allora i pensieri, le ispirazioni, gli impulsi amanti degli Esseri spirituali che l’essere umano è in grado di far suoi. Egli ne diventa così un’attiva eco vivente sulla Terra: in base alla sua struttura corporea – che è la sintesi microcosmica di tutto il macrocosmo – egli può con le forze della sua anima e del suo spirito riverberare tutti i pensieri luminosi, i sentimenti di amore e gli impulsi volitivi ed evolutivi degli Esseri spirituali che hanno creato sia il macrocosmo sia il microcosmo. E ciò ricostituisce quotidianamente l’essere umano nel suo corpo fisico, nella sua anima e nel suo spirito.
Questa interazione cosmica trova la sua espressione schiettamente economica nella solidarietà associativa, nel dialogo prettamente associativo fra gli uomini. La fruizione riconoscente dei talenti altrui mi edifica giornalmente là dove io non basto a me stesso, e lo stesso vale per gli altri nei miei confronti. Questo è il «karma» quotidiano che ci consente di vivere l’intreccio amoroso di infinita interdipendenza grazie alla quale noi ci nutriamo a vicenda e ci concediamo l’un l’altro la possibilità di esistere. La cerchia dei Dodici (Pietro e Giuda compresi!) è un’associazione archetipica di esseri umani che si completano a vicenda perché nessuno può vivere senza gli altri. La loro unità organica viene espressa dal Tredicesimo, l’Essere solare, che lava i piedi a tutti così come il sole visita tutte le dodici costellazioni dello Zodiaco.
Nel Padre Nostro viene detto «dacci oggi il nostro pane quotidiano»: oggi e quotidiano sembrano la ripetizione inutile di un unico concetto. Ma la parola επι − ιουσον (epì iùson), fonte di secolari discussioni esegetiche, nel testo greco di Luca non significa «quotidiano» ma sostanziale, cioè spirituale, in quanto discendente (ιουσον è un participio!) dai vasti spazi dell’intero macrocosmo per ricreare e ricostituire dentro di noi, senza sosta, il microcosmo, che è l’essere umano stesso nella sua pienezza.
La sfida dell’economia moderna, l’abbiamo visto, è quella di non restare indietro a uno stadio evolutivo della coscienza che non comprende ancora l’unità universale che i fatti già hanno operato: tutti dipendiamo oggi ormai da tutti, al di là di ogni confine di nazione, di lingua, di popolo, di religione o di razza. L’essere di ognuno di noi ha fame e sete del nutrimento di quei pensieri spirituali che si adeguino alla realtà già costituita dell’unità dell’umanità, della solidarietà anche materiale al livello planetario. Si tratta di fare delle sorti dell’umanità le proprie stesse e intime sorti, di generare nel proprio spirito pensante e amante una sollecitudine appassionata per ciò che riguarda l’umanità intera. L’interesse ardente per le sorti dell’umanità diviene così vero cibo della mente, calore del cuore e forza di volontà.
Denaro che invecchia, deperisce, muore. E rinasce
Uno dei fenomeni più importanti dell’economia mondiale attuale è quello delle minacciosissime concentrazioni di capitali in forma di credito, che sono in balia dell’arbitrio della speculazione di borsa, che è il più inesorabile e disumano che si possa immaginare. È come nel mare o nella giungla: l’unica «regola del gioco» è che gli esseri più grossi e più forti divorano quelli più piccoli e più deboli.
Le ingenti quantità di denaro immobilizzato, concentrato e così sottratto alla circolazione capillare dentro l’organismo sociale, provocano da una parte scarsità di beni di consumo, dall’altra disoccupazione di massa. In Russia per esempio vediamo oggi su grande scala il primo fenomeno: la gente non ha da mangiare, non ha di che riscaldarsi, viene sempre di più gettata nella disperazione; se ci spostiamo invece verso l’Occidente e in particolare verso il Sud, tocchiamo il secondo fenomeno: a milioni e milioni di persone manca il lavoro. La Cina si sta «risvegliando» a entrambe le forme di disperazione.
Sia la fame sia la disoccupazione di massa sono due effetti dell’accentramento del potere reso possibile dagli immani ingorghi di denaro. Ciò rende nell’umanità intera i beni di consumo e il lavoro così scarsi da portare le masse a un punto di avvilimento tale che il ricevere poi un po’ di briciole appare loro come una grande conquista, come la soluzione migliore e unica dei problemi sociali. Si provocano così premeditatamente gravissimi danni per abituare poi le masse a vedere il senso della vita nel risarcimento dei danni.
Prima si porta via tutto, poi si distribuiscono molliche di pane e la gente, respirando appena un po’, è comunque contenta, perché, per quanto male, sta meglio di prima. Questo «rimedio» perverso riprende la ben nota strategia romana del panem et circenses: al popolo diamo il pane giusto giusto per campare alla meno peggio e poi qualche divertimento, in modo che si distragga e non pensi che la vita può offrire ben altro.
Questa assurda logica del cinismo si emancipa ormai da ogni atavico pudore e si mostra a viso aperto. Lo stratega statunitense della nuda brutalità del potere Z. Brzezinski ha coniato l’espressione diabolicamente geniale di «tittytainment» per il suo ideale di una società con il 20% della popolazione sempre più ricca e l’80% sempre più povera. I poveri vanno tenuti buoni e a bada con un’accattivante combinazione di «tits» (tette) e di «entertainment» (divertimento). Forse erano più saggi i romani, che oltre ai giochi del circo almeno avevano previsto per il popolino anche un po’ di pane!…
Chiediamoci ora: sarà mai davvero possibile evitare che il denaro ristagni nelle mani di pochi centri di potere che decidono delle sorti di tutta l’umanità? Sì, lo si può evitare.
La scienza dello spirito di Rudolf Steiner indica anche qui una via di soluzione concreta che è tanto geniale quanto ardua – ma non impossibile! – per la comune mentalità oggi in vigore. Ciò di cui c’è bisogno è un aiuto reale, di natura puramente economica, per superare l’egoismo insito nell’accumulare denaro. E che cosa si può fare perché a un numero sempre maggiore di esseri umani passi la voglia dell’accumulo di denaro grazie al sorgere di una voglia migliore?
Si tratta di provocare un’inversione di marcia nell’attuale dinamismo economico, un’inversione di portata tale da ingenerare in noi tutti una vera repulsa nei confronti dell’ammassare denaro. Questo è possibile se l’uomo si deciderà a «umanizzare» il denaro anche nella sua dimensione fisica: come? Facendolo invecchiare, deperire e morire!!
Se è vero che il denaro rappresenta tutte le cose materiali che con esso si possono comprare, esso deve seguire la loro legge evolutiva: esse non sono eterne, col passare del tempo si consumano e periscono tutte. È una vera assurdità, una contraddizione economica assoluta il fatto oggi reale che ciò che rappresenta tutte le cose si comporti in modo opposto alle cose stesse. È una concorrenza del tutto sleale quella che conferisce al denaro un assoluto potere di sfruttamento rispetto a tutte le altre cose che, al contrario di esso, col passare del tempo perdono di valore. Infatti il denaro che noi abbiamo col passare del tempo acquista, grazie agli interessi e alle speculazioni di borsa, sempre maggior valore. Tutti i beni che esso rappresenta, invece, valgono sempre di meno perché vengono consumati, deperiscono e muoiono. Tutto ciò che il denaro rappresenta col trascorrere degli anni vale sempre di meno mentre il denaro si ostina a valere sempre di più.
Se noi avessimo delle banconote con stampigliata sopra la data di emissione e di scadenza – in un ciclo di quattordici o ventun’anni, per esempio – che cosa avverrebbe alla voglia di conservarle oltre la scadenza? Sparirebbe, perché alla data di scadenza la banconota non varrebbe più nulla e verrebbe ritirata dalla circolazione. Di conseguenza, naturalmente, tutti i titoli, gli effetti e i valori verrebbero ogni anno corrispondentemente e sistematicamente svalutati. Sarebbe questa una soluzione economica fenomenale se avessimo la ragione e la forza di adottarla: una soluzione che richiederebbe tecniche di attuazione concreta non facili, certamente, come non sono mai facili tutte le grandi azioni veramente umane.
Questa «soluzione» ha però senso e forza propulsiva unicamente se è l’espressione di una nuova mentalità e di una nuova cultura economiche. Questa nuova mentalità è ben possibile generarla: per me, per te, per tutti, subito. Contribuire a questa moderna rivoluzione copernicana è proprio l’intento di queste pagine.
Sarà necessario adottare questo sistema di pura «amicizia economica» per aiutare ciascuno di noi a vincere il meccanismo della paura e del conseguente accumulo di denaro, e invogliare tutti a far circolare il più possibile e a livello capillare il denaro, anziché a trattenerlo. Solo in questo modo, procedendo in questa direzione, l’economia potrà confermare essa stessa un altro grande mistero della vita: che soltanto ciò che muore può risorgere!
Quando i frutti sono maturi vengono consumati e il seme ricade nella Terra: e il ciclo ricomincia! Dal seme sorge di nuovo la pianta e da essa il frutto. Dobbiamo consentire anche al denaro questo ciclo di morte e di resurrezione! Tutto ciò che vive ha la capacità reale di morire. Solo ciò che è già morto non è più in grado di morire; ed essendo per natura morto non può neppure rivivere. Il denaro che non muore è già morto ed esercita un’azione mortifera sugli esseri umani.
Noi abbiamo del denaro un concetto astratto e mummificato, non ne conosciamo la vera realtà vivente: che è quella di nascere, crescere e morire per poi rinascere. Anche se noi non lo sappiamo, il denaro non rimane mai uguale a se stesso: c’è nella realtà concreta dell’economia un denaro giovane, c’è un denaro adulto e c’è un denaro vecchio. E il denaro vecchio, quello che sta per morire, vuol essere donato. Il denaro giovane, di massima vitalità, è quello di cui abbiamo assoluto bisogno per le nostre compravendite. Il denaro adulto, di vitalità media, è quello che prestiamo perché non ne abbiamo immediato bisogno. Il denaro vecchio è quello che ha perso per noi ogni forza vitale proprio perché non ne abbiamo affatto bisogno. Non ci serve a nulla, ci ingombra soltanto, aspetta solo di morire e desidera che glielo concediamo. Solo così potrà risorgere dando vita ai talenti altrui.
Bella donazione! – sento già obiettare – liberarsi di un denaro che non vale più nulla! Eppure abbiamo appena detto che ciò che muore risorge sempre: ma come? Torna qui di nuovo in primo piano la realtà dinamica delle associazioni, vero fulcro di un sano avvenire dell’economia. Noi potremo donare il denaro vecchio alle associazioni perché la legge riconoscerà ad esse il diritto di ritirare il denaro scaduto e di immettere in circolazione denaro nuovo, denaro rinato, assegnandolo ai talenti di altri esseri umani. E questo sarà il modo veramente economico di ridare sempre nuovamente vita al denaro e all’economia umana. Ma il presupposto fondamentale è che esso possa prima morire, cioè sparire tramite la donazione. Il denaro vecchio, che se non muore fa morire noi interiormente, morendo fa rinascere a vita un altro essere umano e con lui l’umanità intera, compreso il donatore.
L’obiezione sulla poca «moralità» di una donazione fatta con denaro di rimessa è un’obiezione moraleggiante. Quando io mangio dei fichi non mi faccio problemi di coscienza e non mi chiedo se sto compiendo un gesto egoistico o altruistico. È egoistico mangiare i fichi? Certo, ma se ho fame di fichi li mangio e va bene così! È egoistico donare il denaro perché dopo poco non mi varrà più nulla? Certo! Ma va bene così!!!
Noi oggi maneggiamo un denaro che dà morte perché non vuol morire. E ciò perché non c’è mai venuto in mente di cambiare il nostro rapporto col denaro consentendogli di accompagnare il ciclo evolutivo, dinamico e vivente, di tutte le merci e di tutti i beni di consumo che esso rappresenta e che vengono prodotti, consumati e di nuovo prodotti.
Se il denaro «vecchio» è il denaro di donazione per eccellenza, il denaro giovane, quello rinato, è il denaro col maggiore potere d’acquisto e sarà perciò adatto per la compravendita e per il capitale d’impresa che va a finanziare cicli produttivi a lunga gittata; il denaro adulto è invece adatto per i prestiti a media e breve scadenza, a seconda che sia denaro appena entrato nell’età adulta o alle soglie dell’anzianità.
I bisogni – che sorgono, vengono appagati e sorgono di nuovo – corrispondono ai beni che vengono essi stessi prodotti e consumati: il denaro materiale che ben corrisponde ad essi è dunque unicamente un denaro capace esso stesso di morire e di rinascere.
Nella parabola evangelica dei talenti, in base al doppio significato della parola ταλαντον (tàlanton) che abbiamo già rilevato, ci viene mostrato anche il dinamismo opposto: l’esercizio dei talenti spirituali fa sì che essi fruttino all’infinito. Non decrescono né muoiono, quei «denari»: né debbono restare gli stessi. Colui che li conferisce non approva nel testo evangelico l’uomo che ha ricevuto uno e riporta solo uno; ricompensa invece, congratulandosi, coloro che da uno gli riportano due o cinque o dieci. Far morire tutto ciò che è materiale – e il denaro con esso – è la premessa di infinite resurrezioni dello spirito. La legge fondamentale della materia è la morte, quella dello spirito è la resurrezione.
Il dinamismo intrinseco del bisogno è quello di consumare: ci tocca far perdere sempre nuovamente il valore alle cose che soddisfano i nostri bisogni, perché per soddisfarli dobbiamo far perire ciò che usiamo e consumiamo. E i bisogni si ripresentano sempre da capo. I prodotti e le merci che non possono venire consumate generano un’economia di detriti, di scarti, di rifiuti morti. Nasce così un mondo di scorie col carattere apocalittico della «seconda morte». La «morte prima» è quella di tutte le cose che morendo si aprono alla possibilità di rinascere. La «morte seconda» è quella di ciò che è «morto da morto», di ciò che in vita ha distrutto la sua semenza spirituale, ha sepolto – ha «mortificato» – l’essere stesso. Il dinamismo del talento spirituale, delle qualità interiori dell’essere umano, frutta invece con un tasso di interesse maggiorabile all’infinito, senza limiti: esso non crea ingorghi o scorie, ma promuove ovunque l’umano e il vivente.
La circolazione e la distribuzione capillare del denaro materiale appaga i bisogni materiali e consente i giusti vantaggi per tutti. Questi profitti, invecchiati bene dal buon uso, vanno poi a confluire, grazie alla donazione, nel finanziamento delle attività umane più vere e feconde, di tipo culturale, scientifico, artistico e religioso.
Grazie allo spirito umano, capace di donare, il denaro muore – e nello spirito creatore e libero esso rinasce: l’incessante creatività dello spirito umano è la zecca aurea sempre produttiva e veritiera, quella che permette il conio di un denaro non fittizio anche sul piano fisico. Essa avvia un circolo virtuoso, che redime quello vizioso.
La nuova missione di un cristianesimo rinnovato
Volgendo ora al termine delle mie riflessioni, vorrei riprendere alcuni pensieri fondamentali in vista di una sintesi riferita alla nostra cultura occidentale di matrice cristiana.
Per dare un volto umano all’economia mondiale moderna bisogna che ci siano sempre più esseri umani che vogliano usare il denaro non per consolidare il proprio potere terreno sfruttando e asservendo i talenti altrui, bensì per favorire tutto l’umano e dunque tutti i talenti degli altri. La classe privilegiata che una volta coincideva con la classe borghese e politica è col tempo divenuta di stampo prettamente economico. I privilegi esistono oggi sempre di meno in base alla cultura o alle cariche sociali e sempre di più grazie ai milioni e ai miliardi. Osservando la distribuzione della ricchezza sulla terra si vede che la minaccia sociale più paurosa è quella di uno scontro terribile tra i pochi ricchi che diventano sempre più pochi e sempre più ricchi e i molti poveri che diventano sempre più numerosi e sempre più poveri, e alla mercé degli altri.
Ritorniamo con i nostri pensieri ai tempi dei greci e dei romani. Pensiamo a un Platone e a un Aristotele per i quali il fatto sociale della schiavitù era così scontato che neppure l’hanno messo in questione. Essi accettavano che i nove decimi della popolazione vivesse in schiavitù per apprestare l’infrastruttura economica che consentiva al rimanente decimo di dedicarsi alla cultura, all’arte, alla filosofia. Questa cultura greco-romana, stando ai suoi valori morali, non aveva in sé alcuna possibilità di cambiare lo stato delle cose poiché mancava proprio di quei presupposti di pensiero in grado di portare a coscienza l’inconciliabilità fra la schiavitù e la pari dignità di ogni persona umana.
E che cosa, allora, ha fatto sparire la schiavitù, se pur faticosamente, dalla faccia della Terra? È stato il cristianesimo! Per quanto incipiente e imperfetto sia stato il cristianesimo dei secoli trascorsi, l’umanità deve alla forza incredibile dell’amore di Colui che per primo morì per i poveri e per i diseredati, per gli stranieri e per i peccatori, quell’umana e universale solidarietà che da Lui attinse la sua forza sorgiva e che mirò, almeno in linea di principio, a rendere tutti gli uomini uguali nella loro dignità inalienabile di «figli di Dio».
Però questo progetto evolutivo di amore universale è, dopo duemila anni, davvero ancora agli inizi. La nostra cultura attuale è il risultato di quella greco-romana: la nostra arte e la nostra scienza sono l’ultimo prodotto di una classe borghese che ha ereditato i privilegi economici dei greci e dei romani continuando a vivere del sudore di infinite schiere di lavoratori, non più ritenuti schiavi veri e propri ma costretti pur sempre a vendere il lavoro delle loro mani. Una volta c’era il commerciante di schiavi che di città in città comprava e poi rivendeva uomini ai maggiorenti della società; oggi il datore di lavoro, colui che abbiamo già chiamato il «commerciante travestito», compra e rivende lucrando non l’uomo intero, ma una parte di lui: il suo lavoro, il suo sudore. Il grido della classe lavoratrice degli ultimi due secoli è il grido, se pur a volte inconsulto e tumultuario, di una umanità che aspira al riconoscimento sincero e concreto della pari dignità di tutti gli esseri umani.
Le masse dei poveri che diventano sempre più poveri nella nostra opulenta civiltà industrializzata rappresentano quel disumano «residuo di schiavitù» che ci dice con voce possente che il cristianesimo vero si accinge – nei tempi della seconda venuta del Cristo, di natura spirituale – alla sua seconda grande missione. Questa missione consiste nel compiere in campo sociale ed economico tutte le scelte e tutti i passi necessari per far sparire ogni forma di lavoro compiuto in vista del salario. Nei sogni più belli e nei desideri più profondi di ogni essere umano emerge già da ora un’umanità in cui nessuno sarà più costretto a lavorare per vivere, perché ciò significa essere costretto a lavorare per sé anziché per gli altri.
La grande sfida economica non solo degli anni ma anche dei secoli futuri è tutta racchiusa nella drammatica domanda: che cosa bisogna fare per scindere l’attività lavorativa in quanto tale da ogni remunerazione, così che il pagare venga riferito unicamente al prodotto, al risultato del lavoro e non più al lavoro stesso, che è inscindibile dalla persona umana che lo compie?
Per svolgere questo immane compito bisogna che gli esseri umani instaurino una sfera giuridica che sia genuinamente indipendente da ogni ricatto del potere economico e che sia in grado di sancire e di far rispettare il pari diritto di ogni persona umana a ricevere – del tutto indipendentemente dal fatto che lavori o no – tutto il necessario per vivere in modo degno dell’essere umano. Solo in questo modo si potrà dire: nessuno più è costretto a lavorare per vivere, nessuno più deve lavorare per sé.
A chi obiettasse che in questo modo si instaurerebbe una pigrizia universale che non consentirebbe più a nessuno – altro che a tutti! – di vivere, va risposto che la sua affermazione parte dall’ipotesi pregiudiziale che l’ignavia sia l’impulso primigenio dell’essere umano, mentre tutti i fenomeni umani, se letti rettamente, confutano questo presupposto – come ho cercato di mostrare in tutte le riflessioni di questo libro.
L’egoismo del lavorare per sé, eretto a principio motore del convivere umano, è una contraddizione in termini: come può sorgere il sociale – cioè l’essere gli uni per gli altri – se lo si fonda sull’essere ognuno solo per sé e ognuno contro gli altri? Non vediamo dappertutto intorno a noi i risultati rovinosi e minaccianti di questa paranoia della società moderna? L’egoismo del più ricco, che mira – se ne renda conto o no – a sfruttare il più povero, costringe il povero a far proprio il gioco del ricco e a lavorare, a sua volta, per egoismo – cioè per la paga, per sé – e gli nega ogni possibilità di lavorare per gli altri, cosa che sarebbe possibile solo se non fosse più costretto a lavorare per vivere. Questa «condanna all’egoismo forzato» inflitta dai potenti a miliardi di esseri umani è il disumano più tragico del nostro tempo e la liberazione da esso rappresenta la grande missione che incombe a un cristianesimo rinnovato nel nuovo millennio.
Questo cristianesimo nuovo potrà però sorgere solo grazie a un modo nuovo di attingere alle sorgenti spirituali, solo grazie a una nuova e moderna scienza dello spirituale che sappia conversare in termini di problemi attuali con quell’Essere pieno di amore che rivisita invisibilmente l’umanità e la muove a ulteriori conquiste proprie della forza dell’amore. Questa scienza moderna dello spirito ci ammonisce – lo abbiamo più volte accennato – che è urgente una articolazione ternaria dell’organismo sociale col primo compito di conferire alla vita giuridica, indipendente da ogni potere economico e da ogni privilegio culturale, la possibilità reale di far scomparire l’ultimo residuo di schiavitù riconoscendo per legge ad ogni essere umano il diritto al necessario alla vita, cosicché nessuno sia più costretto a lavorare per sopravvivere ma possa lavorare per far vivere sempre meglio sé e gli altri.
E che cosa avviene nella vita economica vera e propria quando anch’essa si affranca da ogni prepotenza di dirigismo statale e da ogni adulterazione settaria e dogmatica di stampo ideologico? Avviene che ogni produttore, lavorando in vista di una merce quale risultato del suo lavoro, non avrà più neppure lui la possibilità di lavorare per sé! Infatti il produttore che lavora in vista del suo profitto lavora per sé, non per il consumatore. Ma la vita giuridica permetterà al consumatore di non essere più costretto a sottomettersi alle leggi ferree dell’egoismo dei grandi «produttori» – i cosiddetti global players – perché non sarà più costretto a lavorare per vivere… In altre parole, una umanità nuova sta per nascere nella quale chi produce per sé, cioè per il suo profitto, non riuscirà più a vendere perché il consumatore vorrà una merce fatta per lui, non per il produttore.
La differenza è immane da un punto di vista prettamente economico: si passa dall’impostare tutti i processi di produzione che puntano al massimo profitto del produttore stesso – secondo la legge «ferrea» dell’egoismo di tutti contro tutti – all’impostare gli stessi processi volgendoli al soddisfacimento sempre più genuino dei bisogni reali dei consumatori – secondo la legge «umana» dell’amore di tutti verso tutti.
Questa seconda grande missione di un cristianesimo rinnovato che si avvale del «giusto», della vita giuridica, per far scomparire l’ultimo disumano residuo di schiavitù e che instaura nella vita economica uno spirito di fratellanza, che è insito nel suo retto funzionamento, sarà possibile solo se sopravverrà anche l’autonomia della terza sfera, quella culturale e spirituale, grazie alla quale ogni essere umano non si viva più solo come un essere economico (più o meno bisognoso di altri) o come un essere giuridico (più o meno uguale agli altri), ma come un essere spirituale che, proprio vivendo sulla Terra, abita in un mondo di esseri divinamente creatori e capaci di sconfinato amore.
La missione individuale sostiene e sostenta l’uomo
Con ciò torniamo ai pensieri già espressi in merito all’eredità: se da un lato l’eredità materiale non è affatto un cibo che davvero ci nutre, ma è un pane stantio, anzi ammuffito che ci fissa nell’atteggiamento ignavo dell’assicurarci la vita sfruttando gli altri, ci fa intristire interiormente, dall’altro lato l’alimento sostanziale e vero per ognuno di noi è la missione individuale per l’assolvimento della quale portiamo con noi dai mondi spirituali tutti i nostri talenti. Non dai genitori, non dall’eredità terrestre riceviamo ciò che davvero ci sostiene e ci sostenta, ma dall’eredità celeste che portiamo come viatico divino sulla Terra grazie alla nascita.
Di nuovo veniamo posti di fronte a una grande scelta: possiamo appoggiarci e contare su un accumulo egoistico e tutto già pronto di beni materiali, oppure possiamo volgerci dinamicamente verso l’avvenire e fare affidamento sulle capacità interiori individuali, nella consapevolezza che ciascuno di noi viene sulla Terra per realizzare un compito specifico, individuale, che è il senso tutto positivo della sua vita. Da un lato c’è l’eredità materiale che io ricevo bell’e fatta dai genitori o dai familiari, dall’altro una missione tutta individuale e tutta da svolgere che io porto con me dai mondi spirituali.
L’eredità viene dal passato e viene da altri: in ciò risiede la duplice alienazione dell’umano. Viene dal passato, non è il diretto frutto del lavoro di chi la riceve, e paralizza il presente. È un anacronistico residuo di anima di gruppo, dove le generazioni precedenti decidono delle sorti di quelle successive. L’eredità serve in questo modo a paralizzare i talenti, anche se non ce ne accorgiamo, anche se non vogliamo riconoscere che sia così. Una persona ricca per eredità, anche se lavora alacremente, possiede una sorta di rete di sicurezza oggettiva che tende ad alterare la percezione dello sfruttamento reale e a mortificare le forze più sacre del suo essere.
Come il buon maestro è colui che grazie al suo operare si rende nel tempo superfluo perché ha promosso e favorito negli allievi la loro stessa capacità di autocondursi nella vita, così il buon genitore è colui che aiuta i figli a non contare sui lacci dell’eredità sia mostrando loro con l’azione diretta gli infiniti vantaggi che il denaro – poco o tanto che sia – procura circolando in tutte le sue forme d’uso, sia provvedendo lui stesso a non lasciargliela, l’eredità.
Ripenso a ciò che ho vissuto a New York diversi anni or sono mentre lavoravo presso una comunità di italo-americani: accadde, nel giro di poche settimane, che decine di giovani, tra i quindici e i diciassette anni, presero a distruggere diverse strutture pubbliche del quartiere – pali della luce, vetrine, portoni, cabine telefoniche, ecc. – per poi sparire da casa e dalla città senza lasciare alcuna traccia.
Con i parenti di questi ragazzi, genitori e nonni per lo più emigrati italiani, ci riunimmo per chiederci cosa stesse mai succedendo: la spiegazione che stava dietro a quella rabbia inconsulta venne espressa dai giovani rimasti, e fu di una lucidità agghiacciante. Voi ci avete dato tutto, dissero, vi siete ammazzati di fatica per assicurarci un’esistenza materialmente agiata e sicura e così facendo ci avete negato la cosa più importante della vita: la forza di volontà. Dandoci tutto ci avete privato della possibilità di conquistarci le pur minime cose con le nostre forze e con la nostra fatica, ci avete impedito di mettere alla prova la nostra reale capacità d’impegno e di ingegno, che è stata nei fatti sempre in secondo piano per voi, tutto sommato sempre superflua.
Fu causa di tristezza infinita, per quei genitori e quei nonni, l’essere posti di fronte a un bilancio così terribile: si resero conto quasi all’improvviso di aver minato la vita proprio delle persone che amavano di più e per le quali si erano sacrificati tutta una vita. Nello sforzo quotidiano proteso a conquistare per i propri figli tutte le cose materiali che la vita non aveva loro regalato, quegli adulti non erano riusciti a capire che il dinamismo dello sforzo e della lotta era la cosa più preziosa che essi stessi avevano «ricevuto». Ma questo è proprio l’opposto del ricevere in regalo. Regalando ai figli i frutti del loro capitale li avevano privati di una gioia che essi avevano invece sempre gustata: quella di conquistare le cose tramite lo sforzo, che è puro esercizio di libertà.
Ci vuole molta forza interiore a non adagiarsi spiritualmente in una situazione economicamente agiata! Ma questa forza maggiore, che può essere il risultato del cammino interiore di tutta una vita, non possiamo e non dobbiamo esigerla dai giovani, che sono solo all’inizio di questo lungo cammino.
Ciascuno di noi viene all’esistenza non per vivere di rendita ma per nutrirsi quotidianamente della sua missione, dei suoi ideali, del suo avvenire. Ognuno di noi viene sulla Terra per ararla con il dinamismo suo proprio, per adornarla con la sua propria bellezza, per riscaldarla con la sua bontà, per illuminarla col suo anelito conoscitivo verso la verità. Il senso della vita non ha nulla a che fare con il bagaglio tanto luccicante quanto pesante dell’eredità: l’essere umano è proteso verso l’avvenire e solo l’avvenire gli appartiene davvero.
Amare il dinamismo insito in ogni essere, riconoscere e gustare la propria creatività dentro all’organismo umano, essere consapevoli del fatto che ciascuno di noi è unico e irrinunciabile per l’umanità intera: tutto questo è pura fiducia nell’umano, pura positività che fa sprigionare dall’essere di ognuno di noi le forze migliori.
Ma dobbiamo capire che questo talento del vivere bene – essendo noi stessi sempre viventi – è possibile dissotterrarlo solo rifiutando coscientemente di appoggiarci sul fattore opposto: sull’accumulo del denaro fisico che viene dall’eredità. E questo vale sia per chi l’eredità la riceve veramente, sia per chi eternamente si lamenta di non essere altrettanto «fortunato» e la desidererebbe tanto.
Concludo questi pensieri con una frase che ormai da duemila anni accompagna l’umanità: non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non di solo pane materiale, ma delle parole di saggezza e di amore che ci parlano di libertà e di fraternità.
La vita economica è la grande palestra umana della solidarietà e della fratellanza: qui possiamo vivere la positività del denaro condiviso che diventa supporto vivente dei nostri bisogni altrettanto viventi. Ma qui possiamo altresì sempre meglio scoprire la vera umana ricchezza, quella che fa di ognuno di noi un re che si nutre di nettare divino: della luce dei propri pensieri, degli ideali del proprio cuore, delle forze tenaci della propria volontà.
La vita economica è materiale e spirituale ad un tempo e ci dà la possibilità di riconfermare ogni giorno la nostra esistenza terrestre e celeste, nella gioia contagiosa dell’inesauribilità dell’umano. In essa possiamo comprendere e rinnovare il gesto dell’Uomo Vero che vive in ognuno di noi e che spezza e condivide il pane della vita, avverando ogni giorno quell’Umano che è la nostra comunione.