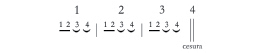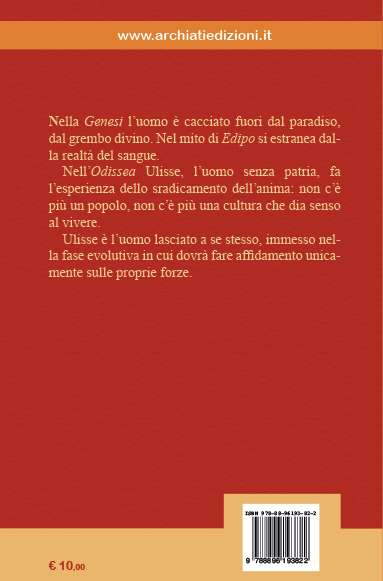Prefazione
Questi cenni sull’Odissea risalgono a diversi anni or sono. In un Convegno per artisti a Firenze fui invitato a commentare il testo omerico avvalendomi degli strumenti di quella scienza moderna dello spirituale che è stata inaugurata all’inizio del ventesimo secolo da Rudolf Steiner. Il presupposto che viveva alla base del mio commento era – ed è – la convinzione che Omero racconta un’Odissea, cioè una peripezia evolutiva, che è non solo un vagare esteriore ma più ancora un camminare di natura interiore e spirituale. Ci presenta l’evoluzione dell’anima e dello spirito umani, non meno di quella del corpo.
Sono stati degli amici a premere perché dessi alla stampa queste pagine. Io ero riluttante sia perché, data l’esiguità del tempo che avevo a disposizione in quel Convegno, nelle mie relazioni dovetti limitarmi a pochi cenni di carattere più che altro metodologico, sia perché mi rivolgevo ad ascoltatori muniti di conoscenze scientifico-spirituali che io potevo presupporre. Ho comunque deciso di rielaborare il testo, soprattutto con l’intento di renderlo accessibile a tutti.
Mi auguro che siano gli amici ad aver ragione e che questi spunti, per quanto succinti e modesti, valgano a convincere molti dello splendore artistico e della profondità sapienziale del testo omerico. I miei pensieri non vogliono essere che l’avvio ad altri, infiniti pensieri creati dal lettore stesso a partire dalla lettura di queste pagine e più ancora, s’intende, dalla lettura dell’insuperabile Odissea di Omero.
Pietro Archiati
Primo capitolo
Odissea, un testo
di meditazione per l’umanità
La moderna riunificazione di scienza, arte e religione
Cari amici,
inizierò con l’evidenziare alcuni aspetti di carattere generale della splendida peripezia umana che è l’Odissea. Il nostro è un Convegno sull’arte, l’avvenire della quale sarà tutto nel superare a mano a mano ogni elemento di arbitrarietà. In base a una rinnovata conoscenza dei mondi invisibili l’artista dei tempi moderni – e soprattutto l’artista dei tempi futuri – è chiamato a riscoprire in termini di conoscenza oggettiva le sorgenti spirituali dell’arte.
Scienza, arte e religione, queste tre grandi espressioni dell’umano, erano, al loro primo apparire, un’unità inscindibile. Poi, nel corso dell’evoluzione, in vista dell’acquisizione della libertà, si sono a vicenda perdute di vista. La religione ha perso di vista la scienza e l’arte; l’arte ha terminato di mostrare il suo carattere religioso e sapienziale; e la scienza moderna ha sempre più ignorato sia la religione sia l’arte.
La nostra situazione culturale-spirituale è questa:
• la scienza non ne vuole più sapere della religione. È diventata una scienza moralmente neutra, è a-morale (anche se non anti-morale);
• l’arte sgorga da una fantasia che si sbizzarrisce arbitrariamente in tutte le direzioni, senza trovare un’ancora fissa nella verità oggettiva, nella moralità, nel religioso;
• la religione ha sempre più disdegnato il bello, si è allontanata dal vivere della vita stessa della verità, sostituendole il dogma fisso e morto.
È importante comprendere che l’arte del futuro potrà essere vera arte solo nella misura in cui il bello diventi, al contempo, anche buono e vero. Le future generazioni non potranno considerare bello, e dunque artistico, ciò che non sia al contempo oggettivamente vero e moralmente, religiosamente buono.
Era necessario che l’antica unione di scienza, arte e religione si sciogliesse. Nella sua forma antica essa era data per grazia divina. Diventare liberi significa invece avere la fortuna di essere noi stessi a ritrovare il connesso universale che fa una cosa sola del bello, del vero e del buono. È ciò che dice Dante alla fine del canto di Pier delle Vigne: «… raunai le fronde sparte». Le tre grandi «fronde sparte» del divenire umano sono la scienza, l’arte e la religione. L’esercizio umano della libertà è l’esperienza della «fontana zampillante» di cui parla il Vangelo di Giovanni, alludendo alla sorgente che scaturisce dal di dentro di ognuno e che ricostruisce quell’armonia a cui tutti aspiriamo.
La fantasia oggettiva e morale
In questi giorni, meditando sul testo dell’Odissea, sarà mio compito mostrare come l’interpretazione oggi prevalente faccia torto a Omero. L’uomo moderno non sa più che Omero appartiene ancora ai tempi in cui il bello era visto bello solo perché era al contempo vero e buono.
Le traduzioni per lo più partono dal presupposto che le cose che Omero racconta siano un puro prodotto della sua fantasia. E invece è un testo di una verità e oggettività che possono farci stupire. Nell’Odissea sono espresse, per esempio, nozioni di fisiologia così scientifiche e precise da non aver nulla da invidiare ai trattati della moderna anatomia o biologia.
L’uomo moderno si preclude la via di accesso a un’opera come l’Odissea perché la interpreta a partire dalla compagine interiore sua propria che, nell’attività artistica, è abituata a inventare di sana pianta e conosce solo una fantasia senza nessuna regola o pretesa di oggettività.
Noi non riflettiamo sul fatto che questo tipo di fantasia è invalso nell’umanità soltanto negli ultimi secoli e che non esisteva affatto ai tempi di Omero. Non ci rendiamo sufficientemente conto delle mutazioni profondissime avvenute nell’animo umano nel corso del tempo.
Omero era un vero e proprio iniziato e come iniziato non poteva permettersi nell’Iliade e nell’Odissea, poste al fondamento della cultura occidentale, nemmeno una parola che non indicasse un contenuto di assoluta oggettività. Nemmeno una parola. Eppure tanti commentatori lasciano intendere, per esempio, che il linguaggio greco, specialmente quello omerico, ricorra a innumerevoli “riempitivi” solo per far quadrare la rima, la prosodia, il metro ecc. Non esistono riempitivi in Omero! Sono impensabili, come lo sarebbero in un libro moderno di fisica o di matematica!
Se è vero che il bello dovrà in avvenire corrispondere al vero, saremo noi a doverci spogliare della zavorra dell’arbitrarietà per riconquistare quella che chiamerei una fantasia oggettiva. La forza creatrice dell’artista dell’avvenire sarà tutta protesa a sviluppare in sé una fantasia oggettiva. Il termine fantasia va conservato, perché l’arte non sarà mai una metafisica, dove gli elementi sono già tutti, in un certo senso, prestabiliti. La fantasia continuerà a creare qualcosa che prima non c’era, ma diventerà oggettiva, ancorandosi al reale in un modo tale da non permettersi più di agire arbitrariamente sul reale stesso.
C’è un grande artista moderno che ha esercitato questa fantasia, come precursore dell’arte del futuro: è Goethe. Io credo che il modo più bello per definire l’operare artistico di Goethe è il dire: era un essere umano che ha esercitato in modo sommo la facoltà della fantasia oggettiva.
Lo studio della metamorfosi delle piante è stata la sua via maestra: egli si è immedesimato nella creatività fantasiosa dell’essere che noi chiamiamo pianta. Infatti, dove vediamo esemplarmente all’opera la fantasia oggettiva della natura? Nelle piante! Negli animali di meno, perché le forme negli animali sono più rigorose; esistono forme tipiche che consentono solo variazioni secondarie. Nel mondo vegetale, invece, le variazioni sono infinite: lì la fantasia della natura non conosce limiti.
Immedesimandosi nelle forze formatrici viventi che creano tutte le piante a noi visibili, Goethe è entrato nel cuore della natura e ha imparato da lei i misteri della fantasia oggettiva. Le forme delle piante sono ben fantasiose, però non sono affatto arbitrarie: sono tutte oggettive nel loro offrirsi alla nostra conoscenza e allo stupore religioso del nostro cuore.
Noi tutti cerchiamo, anche senza saperlo, un’arte che diventi, nell’artista stesso, un creare simile a quello della natura. Ogni artista cerca di imitare la pianta primigenia, quella che Goethe chiama Urpflanze: essa crea, in base alle forze vitali del mondo eterico, forme sempre nuove e opera nella pianta singola la metamorfosi che parte dal germe, fa sorgere lo stelo, moltiplica le foglie, trapassa dai sepali ai petali colorati, e termina il suo ciclo nei frutti. Per poi ricominciare da capo grazie al seme.
Diventando oggettiva, grazie all’amore al vero, la fantasia dell’artista del futuro diverrà a un tempo moralmente responsabile nei confronti della natura e, così, anche profondamente religiosa. Per l’arte dell’avvenire, l’altro elemento che recupera il buono lo chiamerei fantasia morale. È questa una dimensione dell’arte del tutto nuova, morale e religiosa a un tempo, capace di farsi carico della conduzione del cammino spirituale della natura e dell’umanità intera: sarà una fantasia pedagogica in seno all’evoluzione umana – pedagogica perché è oggettiva e morale a un tempo.
Il futuro della religione può solo risiedere in una religione artistica o in un’arte religiosa. Colui che si porrà di fronte a un’opera d’arte o sperimenterà il divino, l’eterno, l’assoluto, oppure dirà: non è bello. E l’uomo religioso troverà buono unicamente ciò che lo riempirà di gioia perché è bello e vero.
Le scuole misteriosofiche all’origine
della scienza, dell’arte e della religione
L’arte, insieme alla scienza e alla religione, è nata nelle scuole misteriche dell’antichità. L’esperienza principale che si faceva in quei Misteri era un’imitazione di ciò che ciascuno di noi vive varcando la soglia della morte. Il processo dell’iniziazione, espresso nei suoi infiniti aspetti dalle mitologie e dalle religioni dei vari popoli, fu sempre un’anticipazione, nella vita, di ciò che si attraversa quando si muore. Morire significa entrare nei mondi spirituali; essere iniziati significa aver fatto l’esperienza dei mondi spirituali da vivi. La religione, l’arte e la scienza sono sempre state le tre vie maestre per entrare nei mondi spirituali.
Gli iniziati non potevano comunicare a tutti ciò che avveniva nei Misteri. Soltanto pochi erano in grado di operare quella purificazione interiore che si richiede per accedere ai mondi dello spirito. Il popolo ordinario non era in grado né di comprendere né di far buon uso di una comunicazione diretta di ciò che l’iniziato aveva vissuto e sapeva.
Per questo motivo gli iniziati elaborarono per il popolo tre forme indirette di partecipazione agli eventi dei Misteri:
• la prima forma è il mito
• la seconda forma è il rito
• la terza forma è l’immagine artistica
Nei Misteri troviamo l’origine del mito, del rito cultico e della creazione artistica. Tutti i miti autentici dell’umanità sono racconti fatti da iniziati per svelare al popolo in modo velato (ecco il paradosso!) ciò che essi avevano vissuto nei mondi spirituali durante l’iniziazione. I miti rappresentano sempre un qualche aspetto delle infinite esperienze spirituali legate all’iniziazione. Il mito è perciò una creazione artistica fantasiosa, ma del tutto “vera”, del tutto fedele alla realtà oggettiva delle esperienze che racconta.
Ma non bastava il mito, per il popolo: ci voleva anche una specie di imitazione a livello dell’azione, un’imitazione per così dire drammatica o rituale, fatta di gesti e di azioni, sempre relativi alle esperienze compiute nel mondo spirituale. Per questo è stato dato all’umanità il rito cultico, l’azione liturgica che è alla sorgente di tutte le religioni.
Infine, se uniamo insieme il mito che racconta – e si rivolge maggiormente al pensiero – e il rito che agisce – operando maggiormente a livello della volontà – abbiamo il dramma originario dell’umanità: il dramma misteriosofico, che agisce direttamente sul sentimento. La tragedia, la forma originaria dell’elemento drammatico, rappresenta l’incontro del mito col rito: l’elemento di racconto, di conoscenza, diventa azione sulla scena. Ecco perché era così importante la tragedia per i greci: essa faceva confluire nell’azione drammatica la sacralità del culto e la verità del mito.
Evoluzione dell’arte narrativa:
mito, saga, fiaba, storia
Alla ricerca di una chiave di interpretazione fondamentale che ci consenta di accedere alle grandi opere dell’antichità, fra le quali c’è l’Odissea, propongo di seguire i quattro gradini fondamentali dell’evoluzione dell’arte narrativa: il mito, la saga, la fiaba, la storia.
Queste quattro forme esprimono quattro fasi dell’evoluzione dell’umanità intesa quale processo di individualizzazione dell’essere umano e di conquista della libertà:
1. la prima fase di questo lungo cammino è quella in cui l’essere umano era ancora immerso nel divino, è il tempo del mito, la cui caratteristica è quella di porre al centro una figura divina. Il mito è una narrazione che gravita attorno all’operare di esseri divini, dèi o dèe. L’uomo è ancora immerso nel grembo divino che gli dà vita, vive ancora nel “paradiso” della divinità come il bimbo nel grembo della mamma;
2. il secondo gradino viene narrato dalle saghe che pongono al centro non più gli dèi, ma i semidei o gli eroi. Il concetto di semidio va compreso in rapporto all’evoluzione umana. L’essere umano, a uno stadio ben definito della propria evoluzione, comincia a distaccarsi dalla matrice universale divina per diventare sempre più autonomo. Era soltanto un inizio, però: vigeva un’interazione tra la conduzione divina e il primo apparire dell’autonomia umana. Non c’è modo migliore o più oggettivo di denominare questo essere che dire: l’essere umano è, a questo stadio evolutivo, un semi-dio. Uno dei genitori è un dio, l’altro è già un essere umano, e il figlio fa la somma di tutti e due.
I semidei sono i grandi eroi dell’umanità, sono i fondatori di religioni, i promotori di nuove culture e di nuove comunità sociali: le poleis, le città greche, lo ricorderete, hanno tutte un semidio come fondatore. La differenza essenziale tra Achille e Ulisse, per fare un esempio, è proprio questa: Achille è ancora un semidio, mentre Ulisse è già del tutto un essere umano.
Se ci spostiamo dalla Grecia verso l’Asia Minore o la Mesopotamia, risalendo ancora più indietro nel tempo, la distinzione fra il divino e l’umano si fa ancora più precisa: nella saga di Gilgamesh, il primo meraviglioso testo letterario che possediamo, il protagonista viene presentato per due terzi come dio e per un terzo come uomo. L’essere umano, fatto di pensiero, di sentimento e di volontà, non può che emanciparsi dal divino dapprima nell’elemento del pensiero. Questo terzo del suo essere diventa umano, libero e autonomo prima degli altri due.
Poi, con l’andar del tempo, si spera (stiamo ancora sperando!) che, in base a questa prima autonomia, l’uomo possa gestire sempre più autonomamente anche i propri sentimenti cessando di subirli passivamente: è allora che vigono in lui due terzi umani e un terzo divino.
In un cammino successivo si tratta di governare anche gli impulsi volitivi. In fondo, nel nostro agire (inteso anche come puro movimento) siamo ancora tutti divini perché, tanto per fare un solo esempio, perfino il semplice atto del sollevare un oggetto si sottrae alla nostra normale coscienza diurna. Noi non sappiamo che cosa avviene, di fatto, nei muscoli, nelle forze del ricambio, quando afferriamo un oggetto e lo solleviamo. La nostra coscienza ordinaria non è in grado di comprendere e di governare gli impulsi della volontà (pensiamo alla digestione!): in essi siamo ancora dormienti, abbandonati alla saggezza divina che opera in noi attraverso le forze della natura;
3. la terza grande fase dell’evoluzione si esprime nella forma narrativa della fiaba. Le fiabe originarie raccontano esperienze specificamente umane. La fiaba è sorta dunque più tardi, quando gli esseri umani cominciarono a occuparsi maggiormente e centralmente di se stessi. La fiaba parla però di un essere umano che ha ancora coscienza di vivere in un mondo di esseri e realtà spirituali, di non appartenere soltanto al mondo fisico.
Col sopravvenire del materialismo moderno si persero di vista gli dèi, sparirono i semidèi e gli eroi, si perse non meno ogni capacità di creare fiabe vere e proprie. Le fiabe moderne sono state create dalla fantasia che ho chiamato arbitraria, non più oggettiva, e per la quale può andare bene tutto. Le fiabe antiche invece sono veraci, sono oggettive nel senso che esprimono esperienze umane obiettive, fatte in mondi spirituali che sono non meno veri e reali di quelli che noi conosciamo.
Prendiamo per esempio le fiabe classiche raccolte dai fratelli Grimm: sono di una veridicità stupefacente, in ogni minimo particolare. Non c’è nulla di arbitrario o di inventato in esse: sono state percepite nella loro oggettività grazie a un’immaginazione spirituale oggettiva. I primi creatori di fiabe raccontavano fedelmente ciò che avevano visto o vissuto nei mondi spirituali. Per questo lo sforzo di interpretazione non sempre è facile per l’uomo d’oggi.
Un esempio di trapasso dalla saga alla fiaba lo troviamo nel Parsifal, nella versione di Chrètien de Troyes e ancora di più in quella di Wolfram von Eschenbach. Wolfram non sapeva leggere, non sapeva scrivere: dovette dettare a un canonico tutto il testo (più di ventimila versi). E che cosa gli dettava? Quello che vedeva nel mondo spirituale! Non c’è nulla di inventato arbitrariamente. Per questo motivo Wolfram non era del tutto soddisfatto dell’opera di Chrètien de Troyes e diceva che la vera storia era quella di Kyot, il quale si era rifatto a un certo Flegetanis: entrambi arabi che avevano conoscenza degli eventi cosmici stellari, dove si possono leggere anche gli eventi umani nella loro oggettività;
4. l’umanità degli ultimi secoli, orientandosi unicamente verso il mondo fisico, ha creato la forma narrativa della storia vera e propria – che sfocia poi sempre più nella cronaca –, con un’ancella tutta a modo suo che è la storiella. Da un lato ci si dà all’osservazione dei fatti e degli eventi che, venendo considerati solo nel loro risvolto esterno, vengono riconosciuti come oggettivi solo in quanto esteriormente documentabili; dall’altro lato è sorta una fantasia del tutto arbitraria, senza più alcun ancoraggio nella realtà: le storielle. Nessuno chiede a una storiella di essere vera, nessuno andrebbe a interpretarla in riferimento alla realtà oggettiva: una storiella, si sa, è semplicemente inventata.
I quattro modi umani di concepire il divino
Prima di venire all’Odissea vorrei ancora premettere una duplice riflessione sull’origine delle mitologie. Nel corso del tempo sorgono mitologie in chiave sia monoteistica, sia politeistica, sia panteistica; la fase ateistica o materialistica dell’umanità rappresenta la fine delle mitologie. È importante, allora, capire da dove nascono
• il monoteismo,
• il politeismo,
• il panteismo,
• l’ateismo.
A questo riguardo c’è un gustoso scambio epistolare avvenuto fra Goethe e Jacobi. Jacobi era una persona religiosissima e, pur essendo molto amico di Goethe, pur essendogli affezionato, si preoccupava della sua evoluzione interiore, che gli appariva troppo poco religiosa, troppo poco pia. Viceversa Goethe riteneva che l’amico, tutto preso dalla sua teologia metafisica, si perdesse in pure astrazioni. E gli scrisse: «Dio ha punito te con la metafisica e ha benedetto me con la fisica». Bellissima questa espressione! Dio mi ha benedetto con la fisica, cioè con l’amore per la sua creazione, che è la natura.
Il 6 gennaio 1813, giorno dell’Epifania, Goethe scrive al suo amico Jacobi queste parole: «Ciò che divide gli esseri umani è il modo di pensare, ciò che li unisce è il modo di sentire. Per quanto mi riguarda, considerando le molteplici dimensioni del mio essere (Goethe non aveva certo problemi di falsa modestia!), non posso accontentarmi di un solo modo di pensare. In quanto poeta e artista io sono un politeista. In quanto scienziato della natura io sono panteista, e l’uno non meno risolutamente dell’altro. Avendo poi bisogno di un Dio unico (quindi del monoteismo), in quanto uomo morale, non ho nessun problema (c’è la religione che insiste a dirmi che di Dio ce n’è uno solo)».
Goethe aveva già raggiunto queste altezze duecento anni fa! Noi oggi arranchiamo ancora per avvicinarci a queste vette: penso alla teologia che ho studiato, dove mi si diceva che solo il monoteismo è giusto. Panteismo e politeismo sono errori! C’è un solo Dio, quello dei cristiani! E gli altri?, chiedevo io da studente. E tutti gli dèi e le dèe della Grecia, così belli! Via, tutti via!, tutti al diavolo! era la risposta.
Goethe afferma che si può essere veri scienziati solo in quanto panteisti, e veri artisti unicamente in quanto politeisti. Tutto ciò che l’umanità ha detto sul divino non può essere che un prodotto umano! Feuerbach aveva ragione nel dire che, sì, Dio avrà pur creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, ma quelli erano affari suoi, all’inizio della creazione. Adesso che noi ci siamo, è nostro compito creare, cioè concepire Dio a nostra immagine e somiglianza! Che altro possiamo fare? C’è mai stato un uomo che ha pensato sul divino con una testa non umana, ma divina? Se Dio ha creato l’uomo a sua immagine, il Dio che l’uomo crea genuinamente a sua immagine non potrà far torto al Creatore!
Ci sono allora quattro possibilità fondamentali di concepire il divino, corrispondenti alle quattro dimensioni fondamentali del nostro essere, che sono:
• il corpo fisico-materiale;
• il corpo delle forze vitali, che costituiscono la differenza tra un corpo vivo e un cadavere. Questo corpo di forze vitali lo abbiamo in comune con le piante (la scienza dello spirito lo chiama corpo eterico);
• l’anima, cioè tutti gli affetti e le passioni che costituiscono la nostra vita interiore fatta di pensieri, di sentimenti e di impulsi volitivi. Gli impulsi dell’anima sono multiformi, polivalenti, cioè politeistici per natura;
• l’io, cioè il nucleo dell’autoesperienza in quanto essere attivo nel pensiero e nella volontà, è la coscienza di sé in quanto spirito vero e proprio, che coordina e guida ciò che è fisico, vitale e psichico. L’esperienza dell’io è per natura unitaria, monoteistica.
Vediamo ora questi livelli in rapporto al divino:
1. Là dove l’essere umano si esperisce interiormente come un io, riconduce all’unità i molteplici impulsi che agiscono nella sua anima: l’esperienza dell’io è, per eccellenza, l’esperienza dell’unità del proprio essere. Se non facessimo questa esperienza di unità come potremmo, senza mentire, usare la parola io? Nessuno di noi pensa a due, tre o quattro io quando dice io. Dicendo io vivo tutto ciò che è in me, pur nella sua molteplicità infinita, nel suo carattere di unità, che è essenziale per l’autoesperienza umana. Se mi sentissi solo come una molteplicità di impulsi e mai come un essere unitario che tutti li guida e tutti li ha in mano, non sarei in grado di dire io a me stesso.
Le culture umane che nell’economia complessiva dell’evoluzione hanno avuto la missione di far sorgere, o di privilegiare l’autoesperienza umana dell’io, sono le culture in cui è invalso il monoteismo. «Non avrai altro Dio fuori di me»: non avrai un altro io oltre al tuo io. Devi ricondurre il tuo essere all’unità se non vuoi sentirti interiormente dilaniato.
2. Chiediamoci ora: c’è soltanto un essere divino, nel cosmo, o ce ne sono molti? E se ce ne sono molti, sottostanno a qualche reggimento unitario? Il popolo greco, che ha saputo conversare con una molteplicità di esseri divini, ha vissuto non meno il desiderio di farli, in qualche modo, convergere.
La paura del caos è insita nell’essere umano: ecco allora che Zeus (Giove) si affanna per mantenere l’ordine nell’Olimpo anche se poi, ogni tanto, gli sfugge qualche dio di qua, qualche dèa di là, oppure lui stesso si addormenta e allenta il controllo e qualcun altro disobbedisce e si ribella… Ma nell’insieme il pantheon greco non è un chaos ma un cosmos ordinato e strutturato.
Il popolo greco, immerso nella realtà psichica del politeismo, ha sì vissuto l’anelito verso l’unitarietà dell’Io, ma l’elemento portante nella sua esperienza del divino non è l’unità propria dello spirito bensì la molteplicità delle realtà, delle forze e delle esperienze dell’anima. Dall’esperienza della pluralità di impulsi insiti nel proprio essere animico sorge, nella contemplazione del mondo, il politeismo.
Il politeismo è dunque la religione dell’anima, è la descrizione dell’operare divino dentro le multiformi forze dell’anima. Pallade Atena (Minerva) non simboleggia le forze del pensiero: è l’essere divino, vero e reale, che ispira il pensare umano. Lo stesso vale per il rapporto di Afrodite (Venere) con le forze dell’amore, di Era (Giunone) con le forze di volontà, e così via.
3. Il panteismo, poi, ravvisa il divino effuso nella natura con tutte le sue leggi e le sue forze. Considera per esempio l’elettricità, la gravità, il magnetismo come realtà non puramente materiali ma di origine spirituale e divina. Non distingue tra Dio e natura – deus sive natura, diceva Spinoza – e vede nella natura stessa una realtà divina. Il panteismo considera il divino sotto l’aspetto dell’onnipresenza impersonale delle forze di natura.
4. Quando poi l’umanità ha perso la comunione con esseri divini di natura spirituale (monoteismo), con esseri divini di natura psichica (politeismo) e con le forze sovrasensibili all’opera nella natura (panteismo), ha cominciato ad avere esperienza soltanto del mondo fisico ed è sorto l’ateismo, cioè la convinzione che non esista alcuna realtà spirituale.
L’identificazione con la propria fisicità ha portato l’uomo a collocare nella materia l’origine stessa della vita: così ha deificato la materia e, poiché la materia è peritura, ha ucciso il divino in sé. Questa autonegazione del divino a partire dall’esperienza di sé è l’essenza dell’ateismo, in rapporto al divino, e del materialismo, quale capacità di considerare reale solo la materia.
Il compito delle varie culture che si sono storicamente succedute era di volta in volta specialistico: le forze del divenire bisogna prima squadernarle una dopo l’altra per poi esercitarsi, nella seconda parte dell’evoluzione, a integrarle tutte insieme, a viverle una dentro l’altra.
Il mito: l’uomo si avvia all’indipendenza
Il mondo della mitologia è sconfinato e infinitamente appassionante. L’evoluzione umana ha comportato il frantumarsi dell’umanità, all’inizio unitaria, in tanti esseri individuali ognuno dei quali è in grado di dire io a se stesso. I vari miti esprimono vari aspetti di questo inesauribile mistero. L’essere umano, all’inizio, era inserito in una realtà spirituale, animica e corporea comune. Agivano in lui esseri spirituali; parlava in lui l’anima di gruppo umana; e operava in lui la natura, il sangue.
Pensiamo a tutte le tragedie basate sull’ereditarietà del sangue (la stirpe di Tantalo, per fare un esempio): destini interi determinati dal fatto di portare in sé un dato tipo di sangue, e poi il cammino per liberarsene. Edipo è l’uomo che non riconosce più il suo proprio sangue: uccide il padre e sposa la madre.
La realtà dell’anima è quella comune a tutto un gruppo di persone, quella del linguaggio, della cultura. Un italiano che fosse oggi unicamente prodotto dell’italianità, che esprimesse soltanto ciò che è comune al popolo italiano, non avrebbe nulla di individuale. Sarebbe una pura espressione dell’anima di gruppo, della cultura, della lingua, del modo di sentire di una certa porzione dell’umanità.
Quando invece mi chiedo: chi sono io?, non basta dire che sono italiano, oppure che sono un membro della tal famiglia, oppure che sono figlio di Dio. Figli di Dio siamo tutti, italiani siamo in tanti, di una certa generazione del sangue sono un buon numero di miei parenti. Ma chi sono io? L’individualità, l’io, è ciò che viene aggiunto a ogni tipo di comunanza.
I miti si riferiscono al cammino di individualizzazione dell’uomo, descrivono la lotta che l’individuo deve fare per affrancarsi da tutto ciò che fa parte di un gruppo.
Prendiamo il mito del peccato originale nel primo libro della Bibbia, la Genesi: è un mito di separazione. Il peccato originale indica l’esperienza del rendersi indipendenti nei confronti della divinità.
Il mito di Edipo parte dal polo opposto, quello del sangue, della natura. Con un brivido di orrore il greco di tremila anni fa si sentiva dire: Edipo è un essere umano nel quale il sangue non parla più! Egli non riconosce suo padre e lo uccide, non riconosce sua madre e la sposa! Il sangue non è più in grado di sorreggere e di guidare l’essere umano; il figlio non riconosce più il padre e la madre. D’ora in poi l’essere umano dovrà trovare un altro orientamento o sarà perduto!
Molti miti narrano l’esperienza del venire espulsi, dell’essere estromessi dalla propria corrente di sangue in vista dell’autonomia, della libertà individuale. Nella Genesi l’uomo è cacciato fuori dal paradiso, dal grembo divino. Nel mito di Edipo si estranea dalla realtà della natura e del sangue; nell’Odissea Ulisse, l’uomo senza patria, fa l’esperienza dello sradicamento dell’anima: non c’è più un popolo, non c’è più una cultura che dia senso al vivere. Ulisse è l’uomo lasciato a se stesso, immesso nella fase evolutiva in cui dovrà fare affidamento unicamente sulle proprie forze.
Macrocosmo e microcosmo nell’Odissea
L’Iliade e l’Odissea sono i due grandi poemi dell’umanità occidentale ai suoi primordi. Essi rappresentano un’importante polarità: l’Odissea parla di un essere umano: «Cantami, o Musa… Ulisse», mentre l’Iliade parla di una forza impersonale: «Cantami, o Musa, l’ira di Achille».
L’Iliade tratta dell’ira che trascina Achille, non propriamente di Achille. È un poema rivolto verso il passato, verso il periodo di cultura egizio-caldaico-assiro-babilonese che stava concludendosi. Abbiamo come una sintesi della spiritualità di queste civiltà negli eventi descritti nell’Iliade dove l’essere umano, non ancora in grado di autogestirsi, è mosso da un impulso di natura, o divino, che lo travolge, che lo rende iracondo.
Nell’Odissea, invece, Ulisse è l’uomo che comincia a essere capace di autonomia interiore. Egli anticipa il cammino del periodo di cultura successivo, quello greco-romano, che vedrà sorgere i grandi filosofi e il civis romanus.
Le due grandi epopee omeriche vanno dunque viste l’una come il risultato finale di un periodo di civiltà dell’umanità, l’altra come l’inizio di un altro, come un programma di sviluppo di una nuova civiltà. Questa chiave fondamentale di lettura consente di comprendere correttamente i contenuti di questi testi.
Noi ci limiteremo in questi giorni ai canti IX - X - XI - XII dell’Odissea. Troviamo in essi ciò che Ulisse racconta ai Feaci circa la sua peripezia: Polifemo, Circe, la discesa agli Inferi, le Sirene, Scilla e Cariddi, l’isola di Trinacria con i vitelli del Sole… Col XII canto termina il racconto del ritorno. Nei primi 12 canti Ulisse è il grande girovago mentre gli ultimi 12 li passa a Itaca, a casa.
C’è una polarità tra i primi 12 canti e gli ultimi 12. I primi narrano la peripezia dell’uomo nel macrocosmo; i secondi il cammino di esplorazione del microcosmo. Tutto ciò che avviene a Itaca, la lotta con i Proci, rappresenta la lotta interiore dell’essere umano con se stesso: ognuna delle figure itacensi va compresa in prima linea come appartenente agli impulsi interni all’essere umano.
A questo proposito è importante ricordare che esistono due tipi fondamentali di mitologie nell’umanità:
1. le mitologie dei popoli del nord parlano delle esperienze che si fanno uscendo fuori da sé per entrare nel macrocosmo. Ne fanno parte tutta la mitologia persiana, tutta la nordico germanica dei celti. Descrivono esperienze di natura estatica;
2. le mitologie dei popoli del sud, che comprendono l’indiana, l’egizia e in buona parte la greca, si dedicano maggiormente alle esperienze di natura mistica, fatte dentro l’interiorità umana, nel mondo del microcosmo.
L’Odissea rappresenta un primo tentativo di unificare le due grandi vie delle mitologie: nei primi 12 canti prevalgono le esperienze estatico-macrocosmiche, negli ultimi 12 quelle mistico-microcosmiche.
Aristotele, nella descrizione della tragedia quale via di purificazione, indica due esperienze fondamentali: la paura e la compassione.
L’esperienza che fa l’essere umano quando fuoriesce da sé e si espande nelle vastità del macrocosmo è quella di una smisurata paura, perché amplia il proprio essere a un punto tale da avere l’impressione di diluirsi del tutto e di perdersi: per questo bisogna prepararsi esercitandosi ad anticipare il confronto con la paura.
Quando invece l’essere umano penetra nei recessi reconditi del proprio essere, nel microcosmo, sente profondissima vergogna perché viene confrontato con la realtà del proprio egoismo. Il sorgere dell’egoismo è stata una necessità evolutiva, propedeutica all’autonomia: ma oggi abbiamo già di gran lunga oltrepassato la giusta misura di amore di sé. Ognuno si occupa quasi soltanto di se stesso, anche se non lo vuole ammettere. Che cosa ci aiuta a superare l’egoismo eccessivo? È la compassione verso altri esseri, la seconda esperienza catartica di cui parla Aristotele.
Possiamo allora dire: la prima metà dell’Odissea tratta dei misteri della paura; nella seconda metà l’essere umano, entrando sempre di più dentro di sé, scopre l’egoismo e si adopera a vincerlo grazie alle forze della compassione.
Secondo capitolo
L’Odissea esoterica
La saga esoterica di Elena
Rudolf Steiner afferma che nell’antichità la saga di Elena aveva due versioni: una essoterica e una esoterica. Verità essoteriche sono quelle che possono venir comunicate a tutti senza danno e senza pericolo che se ne faccia cattivo uso. Esoteriche sono invece quelle verità che è lecito comunicare solo a coloro che hanno compiuto uno specifico cammino di purificazione interiore, che consente loro di farne buon uso per sé e per gli altri. Omero, essendo un iniziato, era a conoscenza del contenuto esoterico, ma nei suoi poemi ci ha dato soltanto la versione essoterica.
Euripide accenna alla saga esoterica di Elena, che ritroviamo anche nel Faust di Goethe. L’opera del tedesco Hugo von Hofmannsthal, Elena egizia, si riferisce alla difficoltà di Elena di distinguere tra la sua immagine e la sua realtà. Rudolf Steiner riassume il contenuto esoterico di questa saga, nei suoi tratti fondamentali, in una delle sue conferenze sul Faust: Elena gioca infatti un ruolo fondamentale nel Faust di Goethe.
La saga a noi nota, quella essoterica, dice che Paride andò a Sparta, rapì Elena, moglie di Menelao, e se la portò a Troia, a Ilio: gli eserciti greci, con a capo Agamennone, nell’intento di aiutare Menelao a riconquistare Elena, si misero in moto e per dieci lunghi anni combatterono alle porte di Ilio finché vinsero e si ripresero Elena.
La saga esoterica, invece, presenta le cose in modo diverso: gli iniziati sapevano che la storia di Elena aveva ben altri significati. Mentre era in viaggio con Elena verso Troia, Paride naufragò e fu costretto ad approdare in Egitto. Il faraone si invaghì di Elena (giustamente, perché la sua bellezza è l’elemento importante) e se la tenne per sé. A Paride consegnò un’immagine di lei, un quadro o, se vogliamo, una fotografia. E Paride dovette accontentarsi e tornarsene a Troia con un mero ritratto, senza la Elena in carne e ossa.
I greci combatterono – stando alla versione misterica – dieci lunghi anni non per la Elena reale, ma per la sua mera immagine. Solo alla fine se ne resero conto: caduta Troia, entrando nelle stanze del palazzo dove Menelao pensava di riabbracciare la moglie, ne trovarono soltanto il bel ritratto. Venuti a sapere dove era rimasta la vera Elena veleggiarono verso l’Egitto. Lì trovarono la vera Elena, la realtà della Elena, e la riportarono in patria.
L’Odissea è profondamente intrecciata con la vicenda dell’Iliade. Lo stratagemma decisivo per entrare in Troia, il cavallo, venne escogitato dall’eroe dell’Odissea, da Ulisse. L’iniziato Omero, pur conoscendo il contenuto esoterico della storia di Elena, non ne fa trapelare nulla. Infatti noi, leggendo le due epopee omeriche, siamo convinti che i greci abbiano trovato a Troia la vera Elena in carne e ossa. È chiaro, allora, che dobbiamo chiederci che cosa ci fosse di pericoloso nella versione esoterica, così da proibirne il racconto al popolo.
Ebbene, nella versione esoterica è contenuto uno dei misteri più profondi dell’evoluzione dell’umanità. Questo mistero consiste nel fatto quanto mai tragico e sconcertante che l’umanità era destinata a perdere, nel periodo di cultura greco-romano, ogni contatto con la realtà vera dello spirito e ne avrebbe conservato solo l’immagine, che è il mondo fisico: il mondo della parvenza, dell’apparenza ingannevole che l’oriente chiamava maya, pura illusione. Per acquisire la libertà interiore, l’essere umano dovette spogliare le sue rappresentazioni, tutte le immagini della sua fantasia, di ogni realtà spirituale che sarebbe stata cogente secondo le leggi di tutto ciò che è reale e operante.
Prima dei greci, gli esseri spirituali agivano nell’uomo e attraverso l’uomo. Nella cultura greca nascono il filosofo e l’artista: l’uno e l’altro con un mondo interiore fatto di pure immagini che, come tali, non causano nulla e consentono l’esperienza interiore della libertà.
Osserviamo com’è ancora oggi il nostro pensare: se noi, nei nostri pensieri ordinari, avessimo delle realtà vere e proprie non saremmo liberi. Quando io penso a una rosa non ho, dentro al pensiero, la rosa vera e propria ma solo l’immagine rappresentativa. Quando mando qualcuno al diavolo nei miei pensieri non sia mai che lui ci vada veramente! L’uomo è potuto diventare libero soltanto conservando nel suo pensare la sola immagine del reale la quale, appunto perché è pura immagine, pura rappresentazione astratta, non può causare nulla. È così che siamo in grado di pensare una cosa e dirne un’altra, di progettare una serie di azioni senza compierle. Nel nostro pensiero abbiamo immagini riflesse, speculari (da qui la parola speculazione). L’immagine che vedo nello specchio non è una realtà: non può fare nulla e come tale mi lascia del tutto libero.
Col nascere della filosofia, appunto in Grecia, il pensare umano ha perso l’esperienza diretta della realtà spirituale. Colui che ha vissuto un ultimo residuo di realtà nel pensare è stato Platone: le sue idee non sono ancora dei concetti astratti, non sono ancora le idee di Hegel. Se le idee di Platone fossero già le idee astratte che abbiamo noi oggi, egli non potrebbe dire: le idee sono la vera realtà e le cose che noi vediamo esteriormente sono soltanto un’effimera immagine, un’immagine priva di realtà. Dopo Platone, a partire da Aristotele, in fondo viene riconosciuto come realtà soltanto ciò che si vede esteriormente, nel mondo fisico.
Anche gli impulsi volitivi, per diventare liberi, dovettero dapprima affrancarsi dalla conduzione diretta di esseri spirituali. Ecco che i greci hanno instaurato un modo di guardare la natura scevro di moralità. L’Antico Testamento è tutto fondato su impulsi morali: i dieci comandamenti vengono posti a fondamento della vita del popolo ebraico. Nell’Iliade, nell’Odissea, non troviamo considerazioni di tipo morale: gli dèi omerici non conoscono leggi morali. Non si parla mai del fatto che essi agiscano bene o male da un punto di vista morale.
Per ciò che riguarda il vero, sorge l’astrazione propria del pensare; per ciò che riguarda l’agire morale sorge l’arbitrarietà, che non conosce norma moralmente vincolante; per ciò che riguarda il bello sorgono i sentimenti suscitati dalla mera parvenza, dalla fantasmagoria del mondo visibile.
L’umanità ha dovuto, al tempo dei greci, perdere nel proprio pensare, nel proprio sentimento e nella volontà la realtà sostanziale dello spirituale al fine di conquistare la triplice libertà interiore nei pensieri, nei sentimenti, e nelle decisioni della volontà.
Terzo capitolo
quattro gradini di discesa verso la libertÀ
L’ultima cultura a vivere nella realtà dello spirituale (e non nella sua mera immagine visibile) è stata quella che ha preceduto la greca: la cultura egizio-caldaica. È questa l’affermazione formidabile della versione esoterica della saga di Elena: la realtà vera di tutto ciò che appare come bello (la realtà spirituale di Elena) è rimasta in Egitto e i greci hanno paradossalmente lottato per instaurare una cultura fondata su quel bello che da sempre oscilla tra essere e non essere, tra apparizione e parvenza.
Supponiamo che il mondo visibile sia l’opera di artisti divini che creano in modo analogo all’artista umano. Consideriamo ora i vari livelli della realtà e dell’operare di un artista, nonché i vari modi nostri di venire a contatto più o meno diretto con questa realtà:
1. Al livello supremo c’è l’intuizione dell’essere vero e proprio dell’artista, c’è la piena comunione col suo io. Immaginiamo che sia un pittore e che noi siamo in grado di metterci in comunione non solo col quadro morto, ormai staccato da lui, ma con la sorgente intima e irraggiante del suo stesso essere di artista creatore.
2. A un gradino inferiore si colloca ciò che l’artista ci comunica di sé. Supponiamo di conversare con lui e che egli ci dica in che modo compie le sue creazioni artistiche, o quali sta progettando. Ponendoci nell’ascolto della sua automanifestazione, attingiamo a una realtà che è meno centrale al suo essere di quanto lo sia l’io creatore intuito direttamente.
3. Ci allontaniamo ancora di un passo dall’artista quando ne consideriamo l’operare verso l’esterno: per esempio possiamo osservarlo mentre dipinge. È pur sempre un rapporto col suo essere che, però, non ci si manifesta più direttamente dal di dentro tramite la parola. Ne vediamo solo la manifestazione esteriorizzata, l’operare per così dire “muto” verso l’esterno.
4. La massima distanza dall’artista è quella che non ci consente più alcun rapporto diretto con la sua vera e propria realtà. Ciò avviene quando siamo posti (restando all’esempio del pittore) di fronte al quadro ultimato, all’opera fissa e morta, senza accesso diretto all’artista.
Se ciò che vediamo attorno a noi è come un quadro dipinto da esseri spirituali, che cosa conosciamo, noi, di questi esseri spirituali? Solo l’opera compiuta e morta, ormai portata al suo termine. Vediamo la natura, l’opera muta di esseri spirituali che hanno a loro volta creato da artisti.
In termini filosofici, questa descrizione concorda con la quadruplice causalità di Aristotele. In un’opera d’arte la causa materiale sono i colori, il marmo, la creta ecc.; la causa formale è l’idea creatrice e operante (una Pietà, una Trasfigurazione, un colonnato…); la causa finale è il perché dell’opera, lo scopo: per esempio adornare un tempio, celebrare un evento, il semplice guadagnare o quant’altro. E la causa efficiente è l’artista stesso in quanto essere vero e proprio capace di creare.
Noi che siamo gli eredi della cultura greca non siamo più in grado di vedere il cosmo a livello di causa efficiente, né di causa finale, né di causa formale (Platone è stato l’ultimo che ha contemplato il cosmo a livello di causa formale): ci è rimasta soltanto la causa materiale. In altre parole, ci siamo abituati a vedere il materiale del cosmo come se ne fosse la sola realtà. Gli Artisti divini non hanno smesso di essere reali, ma noi non li conosciamo più, non viviamo più in comunione con loro.
E allora la civiltà greco-latina dove ha lasciato il vero spirito di Elena? L’ha lasciato nel periodo di cultura precedente, in Egitto: lì è rimasta la realtà dello spirituale, perché l’umanità potesse avviarsi verso la libertà. La saga esoterica di Elena afferma dunque che l’umanità deve «ripassare per l’Egitto» se vuol ritrovare la realtà vera delle cose, che è lo spirito.
L’uomo moderno è ormai abituato a conoscere solo la parvenza esteriore del mondo. Gli interessano unicamente le cose concrete: quelle che si vedono, si toccano, si mangiano… Non immagina nemmeno di vivere di sola parvenza e di doversi mettere a cercare la vera realtà.
Però faremmo un grosso errore psicologico se pensassimo che dire al greco dei tempi omerici che la realtà andava perdendosi avrebbe avuto lo stesso effetto – o meglio, lo stesso non-effetto – che constatiamo oggi. L’uomo comune di allora sarebbe stato gettato in un abisso di disperazione. Il greco non iniziato avrebbe sentito mancarsi la terra sotto i piedi. È per questo che il risvolto esoterico, quello più profondo e di natura morale, del mito di Elena veniva comunicato solo agli iniziati.
Ma oggi, con le forze di un pensiero divenuto veramente libero, possiamo comprendere che ci è dato di superare questo nulla di realtà con quella libertà del pensare che conferisce realtà a tutte le cose. Tocca a noi «ripassare per l’Egitto» per riconquistare la realtà spirituale nascosta nel mondo della bellezza visibile, per riconquistare cioè la realtà spirituale di Elena meramente simboleggiata nella sua immagine, che è il mondo della percezione sensibile. La bellezza esteriore è soltanto l’immagine di quella bellezza vera che è lo spirito.
Il significato dei nomi e dei luoghi nell’Odissea
L’Ulisse dell’Odissea ha vinto Troia (città retta da Priamo, re-sacerdote, ultimo rappresentante di una cultura di stampo orientale) con le forze del pensiero espresse nel cavallo. Achille, l’uomo in cui agisce l’ira divina, muore a Troia e muore con Troia. Il futuro appartiene non all’uomo dell’ira, ma all’uomo dell’intelletto, della razionalità che calcola a sangue freddo. Questa trasformazione della compagine interiore umana si esprime in modo paradigmatico nel nome della moglie – dell’anima stessa – di Odisseo: Penelope. Ogni figura femminile – nell’Odissea come in ogni altro testo antico – esprime un qualche aspetto dell’anima di ogni uomo.
Qual è, allora, la realtà animica con la quale Odisseo si congiunge come con sua moglie e verso la quale tutta la sua peripezia tende? Quale realtà viene espressa nel nome di Penelope?
Nell’Odissea, non meno che in altri testi antichi, i nomi sono delle chiavi fondamentali di lettura. Nel nome si esprimeva oggettivamente l’essenza, la caratteristica fondamentale della persona da esso designata. Non è però sempre facile cogliere il significato dei nomi dell’Odissea perché spesso non si tratta di nomi greci. Molte parole risalgono a epoche preomeriche.
Tutte le parole del linguaggio umano erano, ai primordi, onomatopeiche. Per designare una cosa o un’esperienza si usavano i suoni che oggettivamente le corrispondevano. Esprimere certi suoni non serviva a indicare astrattamente qualcosa, ma a far fare l’esperienza reale dell’essere di quella cosa.
Prendiamo un esempio dall’Odissea stessa: Circe abita l’isola Aiaia: che cosa ci dice il suono ai ai ai ai… Che è l’isola dei guai! Vivendo interiormente questi suoni, rifacciamo l’esperienza che fece Ulisse. È una parola fatta di sole vocali, e che perciò si riferisce a una pura esperienza interiore.
La lingua originaria dell’umanità constava di dodici consonanti e sette vocali, come il sanscrito, che è il più vicino a essa: le consonanti sono l’imitazione delle dodici forze plasmanti del cosmo provenienti dallo Zodiaco; le sette vocali sono invece i sette modi o moti fondamentali dell’anima (i sette pianeti in movimento), le sette esperienze soggettive originarie: gioia, dolore, stupore ecc.
La parola Aiaia si riferisce esclusivamente al soggettivo animico. In questo modo ci viene detto già in partenza che, con Circe, Odisseo farà delle esperienze principalmente interiori, che farà i conti con se stesso.
PhnelÒpeia (Penelòpeia): dal greco pÁnoj (pènos) tessuto, da cui viene la parola latina pannus = panno, tessuto, e le…pw (lèipo) che significa sciolgo, diluisco. L’anima di Odisseo (Penelope) è la grande scioglitrice di tela. Penelope significa la scioglitela, colei che sempre disfa la tela.
I Proci assediavano la moglie di Ulisse perché si decidesse a risposarsi, visto che il marito non accennava a tornare. E lei, con la scusa di dover prima tessere il panno per le spoglie del padre, rimandava le nozze al giorno in cui il lavoro sarebbe stato compiuto. Però, di giorno tesseva e di notte disfaceva.
Noi, eredi della cultura greca, facciamo esattamente lo stesso: di giorno tessiamo, col nostro pensare astratto mille fantasticherie e le intrecciamo fra di loro. Quando ci addormentiamo ed entriamo nei mondi spirituali sparisce tutto ciò che c’era nella coscienza ordinaria. Durante il sonno, dei nostri pensieri diurni non rimane più nulla. Sono privi di realtà, questi pensieri, sono pure rappresentazioni, e perciò nel mondo della realtà spirituale spariscono nel nulla. La tela di Penelope che si disfa ogni notte è quindi il pensare astratto dell’uomo moderno che contiene in sé immagini puramente speculari, non più reali dell’immagine che si vede nello specchio, che ora c’è e poco dopo non c’è più.
Nei Feaci, ai quali Ulisse narra le sue peripezie, possiamo vedere gli abitanti dell’antico continente atlantico, di cui parla anche Platone, e che col passar del tempo è stato sommerso dalle acque. Omero li descrive come esseri che si muovono del tutto sovranamente nell’elemento dell’acqua. Le loro navi, più che veleggiare, volano sul mare. Non hanno bisogno di remi, e in una sola notte Ulisse viene trasportato dall’isola dei Feaci a Itaca, la sua patria.
Dove va, dove è diretto Odisseo? È diretto a Itaca = ʼIq£kh (Ithàke). I-q»kh (I-thèke) è la teca dell’Io, cioè il corpo fisico quale scrigno dello spirito umano individuale. La vocale I esprime – e non solo nella lingua greca – l’esperienza oggettiva del raggio di luce dell’Io in posizione eretta. Di esempi ne potremmo addurre molti: ‡dioj (ìdios), il singolo; „Òj (ìos), la freccia; „Òj (ìos), uno; †sthmi (ìstemi), sto in posizione eretta, mi ergo; ƒstÒj (istòs), albero maestro; „scÚj (iscüs), forza che oppone resistenza…
Il ritorno in patria di Ulisse, in altre parole, è il cammino evolutivo che è stato percorso dagli esseri umani per discendere fin nel corpo fisico quale luogo di individuazione che, solo, rende possibile l’autocoscienza che si ritiene separata da altri esseri e autonoma.
Purtroppo oggi ha la meglio l’interpretazione dell’Odissea in termini materialistico-geografici anche se, ormai, secoli di analisi omerica dovrebbero averci convinto che Omero non è comprensibile in base a simili parametri. Infatti, ora dice che i personaggi sono in occidente, poi, senza che nessuno si sposti, dice che sono in oriente. Bisognerebbe capire, almeno da queste singolari contraddizioni, che non si tratta di località geografiche esterne: Itaca non è in primo luogo una data isola del Mediterraneo, ma è il corpo umano, nel quale ciascuno di noi si isola, appunto, da tutti gli altri esseri. È la patria dell’uomo che abita il suo corpo come spirito individuale. Non più l’umanità, non più la stirpe, non più il popolo sono i miei confini, si dice l’uomo Ulisse, ma il mio corpo: lì approdo alla patria dell’uomo chiamata Itaca, o teca dell’Io.
La corporeità terrestre esprime la possibilità di separarci da tutti gli altri esseri. Nei nostri pensieri, invece, non siamo separati gli uni dagli altri. La vicenda dell’io, che si rende indipendente staccandosi da ogni gestione dall’esterno, è essenzialmente connessa con l’abitare questa teca, questo scrigno, questo corpo fatto di materia che però è il tempio del nostro spirito.
Meta del cammino umano è dunque l’autonomia dello spirito individuale: a esso occorrono un’Itaca, una teca corporea che isoli l’uomo, e una Penelope, un’anima che tessa di giorno una tela di rappresentazioni prive di realtà, che la libertà è sempre in grado di disfare e di far sparire nel nulla.
I Lestrìgoni e la formazione dei dodici sensi
Partendo dal presupposto che Omero non inventi nulla ma descriva oggettivamente le varie fasi dell’evoluzione umana, proviamo a cimentarci con i suoi Cìconi, con i Lotofàghi (o Mangiatori di loto), il ciclope Polifemo, Circe, Scilla e Cariddi…
Iniziamo con la vicenda dei Lestrìgoni, al canto IX: i compagni di Ulisse entrano in un ampio porto dall’ingresso angusto con dodici navi, mentre Ulisse ormeggia fuori la sua nave, la tredicesima. A proposito di quante fossero le navi ci sono diverse opinioni: ma è chiaro dal verso 202 del canto IX che sono dodici più una, quella di Ulisse. Mi pare evidente il riferimento all’essere solare che percorre i dodici impulsi cosmici dello Zodiaco. Ulisse non può essere uno dei dodici: deve essere il tredicesimo, il rappresentante del Sole, come vuole l’esoterismo di tutte le antiche culture.
Il tredicesimo è di natura diversa dai dodici, non può essere messo sullo stesso piano. Infatti, i dodici periscono tutti miseramente e alla fine resta soltanto Ulisse, l’essere umano come tale. Le navi che entrano in porto sono dodici: Ulisse, con la tredicesima, getta l’ancora fuori. I Lestrìgoni scagliano macigni sulle dodici navi e le distruggono: Ulisse e i compagni che sono sulla sua nave tagliano gli ormeggi e si salvano.
La mitologia persiana parla degli Amshaspand o Amesha Spenta: le dodici forze, sei occulte e sei manifeste, poste alla base delle dodici (sei doppie) correnti neurosensoriali della sfera cranica.
In tempi antichi l’essere umano era visto come dotato non di cinque, ma di dodici sensi, con dodici organi di senso corrispondenti: questi dodici organi erano inizialmente delle correnti viventi in connessione diretta col cosmo, quali si esprimono, per esempio, nelle corna ramificate del cervo.
Una delle differenze più importanti tra l’uomo e l’animale è che nell’animale gli organi di senso sono maggiormente vitalizzati che non nell’uomo. L’occhio animale, per esempio, è maggiormente intriso di forze vitali mentre quello umano è pressoché morto. Un grande passo sulla via dell’umanizzazione dell’uomo fu dunque compiuto quando gli organi di senso vennero mortificati. Se ciò non fosse avvenuto, i nostri sensi sarebbero oggi troppo vitalizzati, troppo sensibili: tenderebbero a vivere in se stessi le varie sensazioni senza farsi trasparenti per ciò che l’uomo vuol vivere attraverso di loro. Oggi l’occhio, il nostro organo di senso più perfetto, funziona quasi esattamente come una camera oscura, è un apparato fisico vero e proprio messo a disposizione della coscienza umana. Prima di questa trasformazione gli uomini sentivano per esempio il blu come qualcosa che li risucchiava, il rosso come qualcosa che li assaliva. Il toro non può reagire oggettivamente alla percezione del rosso: la percezione stessa lavora nel suo organo di senso e non lo lascia libero. Perciò, per designare questo tipo di esperienza riferita agli animali, sarebbe più esatto il termine sensazione (azione dei sensi), anziché percezione.
Ulisse ripercorre con i Lestrìgoni la grande tappa del divenire umano in cui le dodici forze cosmiche della vita penetrano nel cranio dell’uomo e diventano nervi cranici. Ulisse rivede quei dodici vascelli, carichi di forze viventi, entrare in un porto dall’imboccatura stretta e poi ampio e circolare, dalle acque quiete. Qui le dodici forze cosmiche del vivente vengono uccise dall’elemento del minerale: i Lestrìgoni buttano giù dagli scogli dei possenti macigni, a significare l’elemento fisico terrestre che uccide, dentro gli organi di senso umani, il pulsare della vita.
Ulisse ora prosegue – come ciascuno di noi a partire da quel momento dell’evoluzione – con una dodecuplice morte in sé: le percezioni sensorie divengono puramente speculari, morte e passive, al fine di lasciarci liberi nei loro confronti, quando di fronte alla percezione ci concentriamo sul pensiero.
Quarto capitolo
L’iniziazione di Odisseo
L’ira e il dolore nel nome Odisseo
Il nome ʼOdusseÚj (Odüssèus) può essere ricondotto fondamentalmente a due verbi: ÑdÚssomai (odüssomai) che significa mi adiro e ÑdÚromai (odüromai) che significa soffro.
Platone affronta la questione dell’origine del linguaggio nel suo Cratilo. Cratilo sostiene che il linguaggio è sorto nell’umanità non per via di convenzione, ma come un fatto di natura: ogni parola è stata creata imitando oggettivamente il fenomeno o la cosa che vuole significare, oppure per esprimere l’esperienza che l’uomo ne fa. Egli difende la tesi che nel linguaggio umano nulla è arbitrario, ma tutto è oggettivo.
Prendiamo un esempio dall’italiano, anche se l’italiano è ormai lontano dal linguaggio iniziale: vi pare possibile pronunciare la parola correre per indicare un camminare flemmatico? Non è possibile, perché nell’esperienza che produce l’udire questi suoni c’è l’urgere interiormente vissuto della corsa col suo affanno reale. Si sente la spinta iniziale e il rotolare delle rrrrrrrr!
In tedesco, per prendere un altro esempio, c’è il verbo gehen (ghéhen) che significa andare: si sente la resistenza della terra sotto i piedi: ghé-hen, un passo dopo l’altro, si preme sulla terra. Potrebbe la parola springen (schprìnghen) significare andare? No! Ascoltiamo bene: sprin… sprin… O potrebbe forse significare dormire? No! Questa parola fa svegliare: si vive come uno slancio, un’elevazione! Infatti significa saltare. Ancora, ascoltate: schlafen… schlafen… (schlàfen, col suono sc come in sciare)… qui sì che si può dormire! E infatti schlafen significa dormire. E perché l’acqua si chiama in tedesco Wasser, e non come da noi? È perché lì al nord l’acqua è più fredda, ti fa rabbrividire – www, sss, rrr –, mentre noi quando siamo al mare, al sole caldo, possiamo distendere le braccia e dire: aaa - cquaaa!
La tesi del Cratilo è dunque che il linguaggio originario era oggettivo, come del resto troviamo implicitamente detto anche nella Bibbia: «All’inizio l’umanità aveva un linguaggio unico» (Genesi, XI,1). Perché? Perché le parole esprimevano oggettivamente la cosa o l’esperienza che indicavano.
Una volta, parlando in Sudafrica del linguaggio, esprimevo proprio queste considerazioni sull’oggettività dell’esperienza dei suoni. Un giovane studente della tribù degli Owambo volle mettermi alla prova. Propose di pronunciare alcune parole fondamentali della sua lingua (come: Dio, acqua, terra, sole, vento…) invitandomi a intuirne il significato fondamentale: accettai, rispondendo che forse non sarei stato precisissimo. Su circa cinquanta parole che pronunciò ne azzeccai, anche se talvolta con qualche approssimazione, più di quaranta, tanto da fargli sospettare che avessi studiato la sua lingua di nascosto! Per me fu una conferma strepitosa della tesi di Cratilo. Oltre a Platone, devo dire che mi sono valso anche delle considerazioni che fa Rudolf Steiner sulla natura oggettiva dei vari suoni del linguaggio.
Consideriamo, in questa chiave, il nome di Ulisse ʼOdusseÚj (Odüssèus). In esso troviamo i suoni che hanno dato origine alle seguenti parole:
• Ñduj (odüs) da cui il latino odium, odio: od…d, d, d,… si sente la resistenza odiosa nella d come nella parola duro o dito;
• ÐdÒj (odòs), la via. Anche qui faccio un’esperienza di resistenza che mi costringe a prendere posizione: è la posizione del piede che preme sulla terra nel camminare;
• ÑdÚnh (odüne) che in greco vuol dire dolore: anche il dolore si vive là dove si incontrano resistenze e si è indotti a resistere;
• ÑdoÚj (odùs), dente, il duro dente che azzanna e morde.
Troviamo Ñduj sia in ÑdÚssomai (odüssomai) che, come abbiamo già visto, significa mi adiro, vado in collera, sia in ÑdÚromai (odüromai), soffro. L’adirarsi e il soffrire sono due aspetti fondamentali del chiudersi in sé, del diventare individuo libero e autonomo.
Il primo ci pone contro tutti gli altri, è il fenomeno fondamentale dell’egoismo: la capacità di porci contro tutto il resto del mondo, il gesto egoico che ci fa trovare noi stessi. La prima fase della libertà, la cruna dell’ago dell’evoluzione, è sempre l’egoismo.
La seconda grande fase è l’amore, che consiste nel superamento progressivo dell’egoismo: è la forza che, un po’ alla volta, vince l’egoismo estendendo l’amore anche agli altri.
L’egoismo è necessario all’evoluzione e ha due aspetti fondamentali, dai quali deriva il nome, l’essenza di Odisseo: nel rapporto con gli altri, successivo allo smembramento dell’umanità, c’è dapprima l’opposizione tra essere e essere, la resistenza e dunque l’insorgere della collera, dell’ira; successivamente subentra il dolore, il soffrire nel sentirsi soli e isolati, ma anche grazie alla misericordia e alla compassione che ci fanno immedesimare nella sofferenza altrui.
Achille, di fronte alla morte di Patroclo, prova solo ira, non dolore. Ulisse è l’essere umano che diventa capace anche di dolore: comincia a sentire in sé l’altra forza dell’egoità, quella che sopraggiunge dopo il distacco che ci oppone agli altri. È la forza dell’amore verso gli altri.
Dunque Odisseo porta nel suo nome sia l’esperienza della collera, espressa da ÑdÚssomai (odüssomai), sia la capacità di sofferenza dell’ÑdÚromai (odüromai): è un essere autonomo perché è in grado di soffrire, di patire e di compatire.
Nel nome Odisseo c’è tutto il cammino umano, tutta l’evoluzione verso l’io.
Penelope, l’anima pensante
È interessante studiare, in Omero, anche l’uso degli aggettivi. Consideriamone tre riferiti a Penelope:
• ™cš-frwn (echèfron)
• per…-frwn (perìfron)
• da�-frwn (daìfron)
La parola frwn (fron), viene da fr»n (frén) che significa diaframma, anima, cuore, mente, e la cui radice troviamo nel verbo fronšw (penso): è dunque una parola di significato complesso. Da essa è derivato anche l’odierno termine frenologia. In Omero, la sede del pensiero è nella regione del diaframma, nella sfera mediana del sentimento, non in quella della testa. Frone‹n (fronèin, pensare) in greco si riferisce a quel processo incipiente del pensare che si esprime nel sentimento. Penelope è colei che ha una capacità di pensare qualificata e diversificata da:
1. ™cšfrwn (echèfron) = che ha il pensare:
œcein (echèin) = avere;
2. per…frwn (perìfron) = che pensa intorno alle cose: per… (perì) = intorno;
3. daifrwn (daìfron) = che pensa attraverso, cioè fino in fondo:
dai (dai), omerico per di£ = attraverso;
1. Che cosa compiamo con la nostra facoltà di “avere” la mente? Esercitiamo la concentrazione: ci poniamo al centro di un cerchio, al centro del nostro mondo, al centro dell’universo.
2. Che cosa succede quando facciamo “girare intorno” la nostra facoltà pensante? Viviamo nella contemplazione: siamo in un ampio tempio e lo abitiamo contemplandolo. Con il nostro pensiero ci poniamo in questo caso contemporaneamente al centro e alla periferia.
3. Infine, quando il processo pensante «va da un punto all’altro tracciando una linea», abbiamo la meditazione: compiamo un percorso che media vari contenuti del pensiero collegandoli tra di loro.
In queste tre qualifiche date da Omero a Penelope, nell’esperienza stessa delle parole greche, sono espressi i tre modi fondamentali di pensare.
Le sirene ovvero il fascino irresistibile del mondo fisico
Le varie stazioni dell’iniziazione di Odisseo (i Cìconi, i Mangiatori di loto, il Ciclope, Eolo, i Lestrìgoni, Circe, le Sirene, Scilla e Cariddi, le vacche del Sole) rappresentano, come già accennavo, gli stadi evolutivi che tutti noi abbiamo attraversato a partire da ciò che la Bibbia chiama la cacciata dal paradiso terrestre.
L’Odissea ci parla del nostro passato, da quando abbiamo cominciato ad abitare in un corpo fisico (questo è infatti il senso della cacciata dal paradiso): prima di allora la nostra realtà umana non era ancora frantumata in singoli uomini. Esisteva l’umanità unitaria, nessuno di noi era ancora un essere individuale. Abbiamo cominciato a individualizzarci proprio congiungendoci con un corpo fisico.
L’XI canto dell’Odissea narra la discesa agli Inferi, cioè il sorgere nell’umanità del principio dell’iniziazione. Discendere agli Inferi significa venire iniziati ai mondi spirituali: venire a contatto con i morti, infatti, significa sperimentare direttamente il mondo spirituale. Il post-mortem, il regno delle ombre, non è un luogo ma uno stato di coscienza che si può sperimentare anche da vivi nel corso dell’iniziazione.
Il greco considerava la vita senza il corpo come un’esistenza umbratile. Aristotele ha ravvisato l’immortalità dell’anima nella capacità dell’essere umano morto di ricordarsi della vita trascorsa nel corpo: solo in questo riferimento al corporeo egli vedeva la possibilità dell’immortalità. Anche per lui la vita senza il corpo non è una vita piena. Il greco ha lottato molto profondamente col mistero della morte e l’uomo d’oggi lo ha reso ancora più drammatico perché la scienza moderna, coerente nel materialismo, non può immaginare un’esplicazione di facoltà spirituali e animiche senza il corpo, e dunque ritiene implicitamente che dopo la morte ci sia il nulla.
Conclusa la discesa agli Inferi, nel XII canto Odisseo termina il suo racconto ai Feaci: in esso viene descritta l’evoluzione degli ultimi millenni, fino al tempo di Odisseo stesso.
Nell’evoluzione non esistono scansioni arbitrarie del tempo e della storia. Osservando il rapporto inscindibile che c’è tra macrocosmo e microcosmo si possono delimitare periodi specifici con caratteri di volta in volta diversi. Il Sole impiega 25.920 anni (il noto anno platonico) per compiere un giro di 360°, cioè l’intero cerchio dello Zodiaco. Ogni grado corrisponde dunque a una percorrenza lunga 72 anni, che è anche la vita media dell’uomo (25.920 : 360 = 72).
Ciò significa che ogni 72 anni il Sole sorgerà arretrato di un grado al momento dell’equinozio di primavera (precessione degli equinozi). Poiché ogni segno si estende per 30° nel cerchio dello Zodiaco (360° : 12 = 30°), ogni 2.160 anni (72 x 30 = 2.160) il Sole sorgerà in un segno diverso al passaggio dell’equinozio di primavera. Il tempo in cui il Sole dimora in un segno zodiacale rappresenta una unità evolutiva nel senso che le condizioni sia geografico-climatiche, sia culturali, hanno per tutto quel tempo un carattere unitario. Quando il Sole passa nel segno successivo si verifica un mutamento profondo di tutte le condizioni di vita sulla Terra, e si può con ragione parlare di un nuovo periodo di cultura, diverso dal precedente.
Seguendo a ritroso il percorso che il Sole ha compiuto negli ultimi millenni, troviamo alla data 1413 d.C. l’ingresso del Sole nel segno dei Pesci: esso inaugura il periodo di cultura attuale che durerà fino al 3573 d. C. (1413+2160 = 3573). Va naturalmente tenuto conto del fatto che tutti i trapassi evolutivi sono graduali: in chiave di preparazione i pionieri dell’evoluzione devono anticipare ciò che gli altri conseguiranno più tardi; in chiave di necessaria controforza da offrire al nuovo ci devono essere anche i conservatori ritardatari che si abbarbicano a ciò che è ormai diventato anacronistico.
Nell’epoca precedente la nostra il Sole sorgeva nell’Ariete, e i 2160 anni che corrispondono alla sua durata ci portano dal 1413 d.C. al 747 a.C., anno della fondazione di Roma. In questo periodo, come sappiamo, sono stati culturalmente alla guida prima il popolo greco e poi quello romano. Nei 2160 anni ancora precedenti, quando il Sole sorgeva nella costellazione del Toro, erano culturalmente alla guida i popoli caldeo, assiro, babilonese ed egizio. Al tempo in cui il Sole sorgeva nella costellazione dei Gemelli fu il popolo paleo-persiano a guidare spiritualmente l’umanità e durante la costellazione del Cancro la guida spirituale fu nelle mani del popolo paleo-indiano.
La prima prova di Ulisse – quella del canto ammaliante delle Sirene – si riferisce al carattere comune di tutti questi periodi di cultura, il cui compito fu quello di inserire l’essere umano sempre più profondamente nel mondo della materia. La cultura indiana – intrisa di ricordi e di nostalgia dei tempi in cui gli esseri umani vivevano nel mondo spirituale – chiama maya, illusione, il mondo fisico che, però, le culture seguenti dovranno imparare a prendere sul serio come luogo d’acquisizione dell’autonomia e della libertà umane.
Il canto delle Sirene esprime dunque l’ammaliamento, l’attrattiva irresistibile esercitata dal mondo fisico. La voce delle Sirene è il fascino del mondo materiale che caratterizza tutta l’evoluzione a partire da quando il Sole sorse a primavera per l’ultima volta nel Cancro. Precedentemente gli esseri umani vivevano più nel mondo spirituale che in quello fisico.
All’inizio del canto XII Ulisse racconta l’incontro con l’indovino Tiresia, avvenuto negli Inferi. Perché proprio un indovino? Perché essere iniziati significa acquisire la capacità di anticipare l’avvenire in base all’interpretazione del passato: indovinare significa, cioè, capire le leggi fondamentali dell’evoluzione passata e futura. Il karma, o destino, funziona come la semina e il raccolto: come faccio a sapere come e quando sarà il raccolto? Lo so nella misura in cui comprendo la natura del ciclo vegetale.
Ciò non contraddice il fatto che ci siano tanti fattori imprevedibili – per esempio una grandine che distrugge il raccolto. Il grande fattore imprevedibile dell’evoluzione è la libertà umana: l’esito finale del cammino evolutivo è lasciato aperto alla libertà di ognuno, anche se le leggi dell’evoluzione sono valide per tutti, come la legge che regola il rapporto tra la semina e il raccolto.
Odisseo è allora colui che passa in rassegna tutto il trascorso dell’evoluzione umana in modo tale da trarne la conoscenza dei tratti fondamentali dell’avvenire. La sua iniziazione, la discesa agli Inferi, consiste nel fatto che Tiresia, l’indovino che guarda nel futuro, gli dice quello che dovrà accadere in futuro in base a ciò che è già accaduto nel passato.
Anche Circe è in grado di dirgli ciò che avverrà in futuro:
Tu però ascolta
e fa’ come io ti dirò: te lo ricorderà anche un dio.
(XII, 37-38)
Con questo la profetessa Circe gli dice: quando ciò che ti dico si avvererà, la parte divina di te, poiché ormai sei stato iniziato, ti ispirerà e tu saprai che cosa devi fare per il futuro, saprai esercitare presenza di spirito di fronte agli eventi.
Tu arriverai, prima, dalle Sirene, che tutti
gli uomini incantano, chi arriva da loro.
(XII, 39-40)
Non incantano tutti gli uomini, bensì tutti quelli che arrivano da loro. È l’Occidente che ha fatto i conti col mondo della materia: l’Oriente vi ha sempre fatto resistenza, chiamando la materia pura illusione.
A colui che ignaro s’accosta e ascolta la voce
delle Sirene, mai più la moglie e i figli bambini
gli sono vicini, felici che a casa è tornato,
ma le Sirene lo incantano con limpido canto,
adagiate sul prato: intorno è un gran mucchio di ossa
di uomini putridi, con la pelle che si raggrinza.
Perciò passa oltre: sulle orecchie ai compagni impasta
e spalma dolcissima cera, che nessuno degli altri
le senta. Tu ascolta pure, se vuoi:
mani e piedi ti leghino nella nave veloce
ritto sulla scassa dell’albero, ad esso sian strette le funi, perché possa udire la voce delle Sirene e goderne.
Se tu scongiuri i compagni e comandi di scioglierti,
allora dovranno legarti con funi più numerose.
(XII, 41-54)
L’essere umano si accosta ignaro alle Sirene quando non ha ancora compreso che il mondo visibile non è automaticamente amico dell’uomo, ma che può esserne anche il nemico. Nel mondo materiale non c’è solo da vincere: si può anche perdere. L’uomo deve perciò imparare che, se si riduce a processi di natura, perde la sua umanità.
L’essere umano è ben altro che una somma di meccanismi e determinismi di natura: è la vittoria su di essi. Ma per poterli vincere, bisogna che ci siano! Viverci dentro per vincerli, non scappare e non lasciarsi schiacciare: questo è il compito della libertà umana.
Che cosa diranno allora le Sirene a Ulisse?
Vieni, celebre Odisseo, grande gloria degli Achei,
e ferma la nave, perché di noi due possa udire la voce.
Nessuno mai è passato di qui con la nera nave
senza ascoltare dalla nostra bocca il suono di miele,
ma egli va dopo averne goduto e sapendo più cose.
Perché conosciamo le pene che nella Troade vasta
soffrirono Argivi e Troiani per volontà degli dèi;
conosciamo quello che accade sulla terra ferace.
(XII, 184-191)
In questo «canto delle Sirene» vengono assommate le tentazioni offerte all’essere umano grazie al vivere nel mondo fisico. «Ferma la nave» sta a dire: arresta il tuo cammino, termina di evolverti, lasciati in tutto e per tutto causare dal mondo fisico. Le Sirene sono qui “ridotte” a due, a indicare la polarità di fondo dell’essere umano, fatto di pensiero e di volontà: la sua capacità di conoscere e di trasformare il mondo. Se si lascia ammaliare dalla loro voce, Ulisse lascia fare tutto alla natura sia nel suo pensiero – rendendolo puramente speculare e meccanico – sia nella sua volontà – lasciandola al livello puramente istintivo, specifico dell’animale.
«Nessuno mai…»: non esiste evoluzione umana senza fare i conti col mondo della materia. Tutto sta nel modo in cui ognuno si pone e agisce nei suoi confronti. Come il serpente biblico del paradiso terrestre ad Adamo ed Eva, così le Sirene promettono a Odisseo il dono della conoscenza: egli potrà procedere oltre «sapendo più cose». La vicenda della caduta, la discesa nella materia, serve a far distinguere il bene dal male, rendendo così possibile la libertà di scelta. Le Sirene (v. 191) si dicono esperte in ciò che viene generato (gšnhtai, ghènetai) dentro all’essere umano grazie al suo vivere sulla Terra, che è ferace, doviziosa di doni (poulubÒteirh, pulübotèire).
L’albero maestro al quale Odisseo deve restare fermamente ancorato è la spina dorsale del corpo fisico quale tempio dell’essere umano-divino che ognuno di noi è. Quando noi al risveglio “leghiamo” la nostra coscienza alla spina dorsale, diventiamo coscienti di noi stessi e del mondo. Circe dice a Ulisse che per superare la prova delle Sirene deve mantenere la coscienza desta. Quando ci stacchiamo dall’albero maestro, ci addormentiamo. L’autocoscienza desta ci consente l’esperienza della forza autonoma dell’io.
L’insegnamento dato a Ulisse per affrontare la vicenda del mondo fisico è: non scappar via, non turarti le orecchie, affronta la realtà della Terra, ma con la forza della libertà autocosciente. Guai a te se ti stacchi dall’albero maestro, dal supporto del sistema neurosensoriale che ti dà la possibilità di prendere coscientemente posizione di fronte ai fenomeni del mondo.
E che cosa sono le funi che lo devono tener legato al palo, allora come oggi? I compagni di Odisseo rappresentano la molteplicità degli impulsi dell’anima presenti in ogni essere umano: affetti, brame, sentimenti, passioni, paure… Odisseo è l’io, e di io ce n’è uno solo. La vicenda del poema è anche la vicenda dell’interazione tra Odisseo e i compagni: è l’evoluzione dell’io umano nel suo intento di padroneggiare le forze animiche dentro di lui. I compagni e le loro azioni sono, così visti, dimensioni dell’unico essere di Odisseo, dell’essere umano.
Retrocedendo di circa 9.000 anni, troviamo il Sole che sorge a primavera nel segno del Cancro. Ci fu allora una grande svolta nell’evoluzione, un nuovo grande inizio, espresso dalla inversione di marcia del Sole, che sta a indicare come una creazione dal nulla. L’emblema del Cancro, con le sue due direzioni opposte senza soluzione di continuità, con un vuoto tra una direzione e l’altra, vuol indicare proprio questo. La “cultura-guida” a quei tempi fu, come ho già accennato, quella sorta sul territorio dell’India.

Il nuovo grande inizio fu dovuto al fatto che, a partire da allora, l’umanità ebbe il compito di venire alle prese col mondo fisico. Nel periodo indiano del Cancro ciò avvenne dapprima, come dicevo, con profonda esitazione, anzi con paura nei confronti del mondo fisico, nonché con una profonda nostalgia del mondo spirituale che andava scomparendo dall’esperienza umana, a mano a mano che ci si sentiva cacciati dal paradiso. Nell’epoca successiva, quella dei Gemelli condotta dal popolo paleopersiano, il grande Zarathustra insegnò agli esseri umani a non più temere, ma ad amare il mondo della materia. Poi venne il periodo del Toro, poi quello dell’Ariete… come l’Odissea ci sta per narrare.
Torniamo alle funi che ci tengono legati all’albero della spina dorsale: esse sono i fasci dei nervi che sono alla base dei processi di coscienza. Altri fasci di nervi lungo la spina dorsale sono alla base del sistema nervoso simpatico, che non siamo ancora in grado di portare a coscienza. Ciò avverrà nel cammino successivo della nostra evoluzione: in futuro, diventeremo capaci di indipendenza non soltanto nel pensiero, ma anche nella sfera del sentimento (grazie ai fasci di nervi mediani) e nella volontà (grazie ai fasci di nervi ancora più bassi).
Questi testi, a mano a mano che li riscopriremo in chiave scientifico-spirituale, con la precisione di una scienza dello spirito degna dei tempi moderni, diventeranno fonte ispiratrice di creazioni artistiche senza fine. Ogni artista può fare dell’Odissea un suo paradiso, perché immagini più belle e più ricche è difficile trovarle. Esse sono vere, belle e buone a un tempo perché esprimono oggettivamente il cammino che rende l’uomo sempre più “buono”, cioè sempre più umano.
Scilla e Cariddi ovvero la polarità fra la testa e le viscere
Nel secondo periodo di cultura a cui accennavo, quello paleopersiano, è sorto nell’umanità il principio della dualità. Zarathustra riconduce ogni fenomeno all’operare della luce e della tenebra: Ahura Mazda (Ormuzd) e Angrya Mayniu (Arhiman), il bene e il male. Mentre gli antichi indiani del primo periodo postatlantico vivevano nella nostalgia del mondo spirituale, gli antichi persiani hanno cominciato a sperimentare la tensione tra spirito e materia come favorevole all’evoluzione. È il periodo di cultura dei Gemelli, delle grandi polarità della vita:

Nell’episodio di Scilla e Cariddi, Ulisse deve imparare a passare in mezzo a due scogli, a due pericoli mortali, evitando sia l’uno sia l’altro. Se avessimo più tempo potremmo vedere come tutti i particolari di Scilla e Cariddi diventino significativi se interpretati in chiave di fisiologia.
Ciò non significa che Scilla e Cariddi indichino soltanto una polarità corporea che è in noi: si riferiscono anche a tutte le polarità dell’anima e dello spirito. Il greco non viveva la realtà del corpo come qualcosa di separato dall’anima e dallo spirito. Non conosceva dicotomia tra spirito e materia: ciò che viveva a livello corporeo era al contempo un’esperienza dell’anima e dello spirito.
Nella realtà corporea, la polarità fondamentale è quella della testa e dello stomaco. Tramite la testa si svolgono i processi di coscienza e nello stomaco avvengono i processi vitali. Quando noi pensiamo uccidiamo forze vitali nel nostro corpo, e quando rigeneriamo le forze vitali possiamo farlo solo diminuendo la forza pensante, come durante una laboriosa digestione o durante il sonno.
Scilla si riferisce ai processi della testa. In inglese c’è proprio una parola che deriva da Scilla e ha lo stesso significato: skull (cranio), in ebraico shahal. Cariddi è il metabolismo: di essa viene detto che tre volte al giorno succhia tutto e poi rimanda fuori. Sono i tre pasti quotidiani ingeriti e distribuiti a tutte le propaggini del corpo. A Odisseo viene detto: tieniti piuttosto dalla parte di Scilla – perché solo nella testa, nell’elemento del pensiero, noi siamo liberi. E Ulisse, diversamente da Achille tutto preso dall’ira, è l’essere umano in cui nasce l’elemento del pensiero e che si consulta con Pallade Atena, la dèa della saggezza cosmica che si fa pensiero umano dentro alla nostra testa, grazie a Scilla.
Parlando della polarità testa-metabolismo, ci riferiamo alla realtà corporea; se consideriamo la polarità tra coscienza e vita, ci riferiamo all’anima; se, infine, vogliamo indicare l’alternanza fondamentale che vive il nostro spirito, dobbiamo riferirci alla polarità che c’è tra la veglia e il sonno.
L’Odissea richiede un’interpretazione che comprenda tutti questi livelli, quindi non univoca: essa deve essere da un lato la più vasta possibile, dall’altro la più precisa, in grado di distinguere anche i minimi particolari.
Circe dice, a proposito di Scilla:
Dall’altro sono due scogli: uno con la vetta aguzza
arriva al vasto cielo, l’avvolge una nuvola scura
che mai si disperde: mai l’aria è limpida
intorno alla cima, d’estate o d’autunno.
Un uomo mortale non potrebbe scalarla o salirvi
neppure se mani e piedi ne avesse venti.
(XII, 73-78)
Vedete come qui è inesatta la traduzione? Trattandosi della testa, l’aggettivo giusto è acuta, non aguzza. Ma se si crede che Omero stia descrivendo un paesaggio della natura esterna all’uomo, è inevitabile sbagliare! ’OxÚj (oxüs) in greco vuol dire acuto. Questa vetta acuta «arriva al vasto cielo»: sono i nostri pensieri che arrivano al cielo, allo spirituale. La luce dei pensieri è ottenebrata però dalla maya, dal mondo visibile: la vera luce non è di natura fisica, ma è sovrasensibile. Solo chi percepisce la luce spirituale delle idee (idea è parente del latino video, vedo) si accorge di essere avvolto dalla nube scura e graveolente del mondo fisico. «Mai l’aria è limpida intorno alla cima»: se così non fosse, vedremmo il mondo spirituale. Ma solo intorno alla cima non è limpida: ciò vuol dire che la percezione e la conoscenza del fisico-visibile, che avviene «alla base del picco», va facendosi di contro sempre più nitida, precisa e, diremmo oggi, scientifica.
Sette qualità di Odisseo
Diamo ora uno sguardo agli attributi di Odisseo, di colui che già nel nome, l’abbiamo visto, esprime l’esperienza dell’odio, dell’opposizione, quali presupposti per diventare liberi e autonomi. Ciò vale anche per l’esperienza del dolore.
Ogni aggettivo qualificativo che riguarda Odisseo è composto dall’aggettivo polÚj (polüs, neutro polÚ, polü, usato anche come avverbio) seguito da un sostantivo. PolÚj significa molto e sta a indicare la poliedricità, la versatilità di Odisseo. Egli non è un essere umano a senso unico. Il suo impulso è quello della libertà ed essere liberi significa essere capaci di muoversi nelle più svariate direzioni… polÚ (polü). Le grandi mancanze o carenze dell’essere umano sono le sue parzialità e le sue omissioni. Odisseo vive nella pluralità (vedi il latino plus) propria della libertà e delle sue vie sempre tutte aperte.
Di Ulisse viene detto che è:
1. polÚ-mhtij (polü-metis) dal pluriforme ingegno, pieno di intuizioni;
2. polÚ-ainoj (polü-ainos) molto lodato, molto apprezzato dagli uomini, stimato come degno di imitazione;
3. polῠ-m»canoj (polü-mèchanos) dalle molte tecniche, dai multiformi espedienti, dall’ingegno inesauribile;
4. polÚ-tlaj (polü-tlas) dalla molta sopportazione e perseveranza, tetragono ai colpi di sventura;
5. polÚ-tropoj (polü-tropos) dalle molte direzioni e vie d’uscita, dalle infinite “trovate”;
6. polÚ-stonoj (polü-stonos) dai molti lutti, che rimpiange molte perdite e piange per molti distacchi;
7. polÚ-frwn (polü-fron) dal molto senno, pieno di saggezza e di sagacia.
1. Iniziamo da polÚ-mhtij: mhtij ha la stessa origine di mente, mens (lat.), m»domai (mèdomai) meditare, misurare, meditor (lat.). Da qui viene la parola meditazione, che è un percorrere col pensiero un passo dopo l’altro. Odisseo è colui che esercita un pensare meditativo, misurato e discorsivo, che conosce sia la meta sia la via da percorrere in tutti i minimi passi.
PolÚ-mhtij ricorre solo tre volte nell’Iliade e ben 68 nell’Odissea. È usato soltanto per Ulisse, perché è ciò che più essenzialmente lo caratterizza: il sorgere nell’essere umano della forza pensante che crea i vari nessi logici che vanno da un pensiero all’altro, che connettono una cosa con un’altra;
2. polÚ-ainoj, molto lodato: ricorre nell’Odissea una volta sola perché per l’essere umano che diventa libero è molto secondario l’essere lodato dal di fuori, da altri. Ciò di cui si tratta è la forza che scaturisce dall’interno dell’essere, indipendentemente dal fatto che venga da altri lodato, riconosciuto o biasimato. Il fatto però che altri lo lodino dice qualcosa su di loro: testimonia la loro stima e la loro aspirazione verso ciò che Ulisse ha già esemplarmente conseguito;
3. polῠ-m»canoj viene da mhcan» (mechané), meccanismo, da cui è derivato il nostro termine macchina. È la capacità di elaborare una strategia, un piano d’azione. Se polÚ-mhtij si riferisce alle intuizioni della immaginativa morale, polῠ-m»canoj indica quella tecnica morale di cui c’è bisogno per concretamente realizzare in seno al mondo visibile gli ideali morali che concepiamo.
Polpolῠ-m»canoj è dunque l’essere umano versatile nell’elaborare piani concreti di azione che gli consentono di inserire nel mondo della percezione ciò che ha colto con la facoltà del pensare. È la capacità di trasfondere nel reale ciò che si concepisce nella mente. Mhcan», in greco, non è la meccanica come la intendiamo noi: è l’abilità di colui che sa ingegnarsi in ogni situazione concreta. È la comunione col proprio Genio che ci dice come comportarci nelle varie situazioni della vita. Questo aggettivo, riferito a Ulisse, ricorre nell’Odissea sedici volte.
4. PolÚ-tlaj viene da tl£w (tlào) sopporto. Atlante (”Atlaj, Àtlas) è colui che porta il mondo sulle sue spalle. PolÚ-tlaj = capace di portare, e perciò di sopportare, tante cose. È colui che sa perseverare, che è tetragono ai colpi di sventura. È l’uomo del Vangelo divenuto capace di prendere il proprio «lettuccio» (Gv 5,8), il proprio fardello karmico dal quale prima era trasportato e che ora è in grado di portare liberamente sulle proprie spalle. Achille era nelle mani del destino, Ulisse prende il destino nelle proprie mani.
È questa una qualità maggiormente morale: è la forza interiore propria di chi sa che non si può diventare individualità forti senza le prove. I colpi del destino sono colpi non di sfortuna ma di fortuna e mirano sempre al positivo. Odisseo è colui che ha capito questo.
La parola fortuna inizialmente significava il destino. Noi italiani siamo così fortunati che della parola fortuna abbiamo preso soltanto il lato positivo! Lo dobbiamo al genio della lingua! Col termine destino esprimiamo piuttosto un senso di rassegnazione. È essenziale al cammino di Odisseo, al cammino verso la libertà, imparare a prendere su di sé il proprio destino e a trasformarlo in fortuna, in occasione positiva di crescita. L’aggettivo polÚ-tlaj compare nell’Odissea trentasette volte.
5. PolÚ-tropoj da tršpw (trèpo), rivolgersi, significa che sa orientarsi in tutte le direzioni. È colui che sa guardare la realtà da diversi punti di vista per agire di conseguenza. Questo aggettivo compare due volte.
6. PolÚ-stonoj compare una volta sola: è la capacità dell’essere umano di reagire in sintonia alla meteorologia che lo circonda e alla composizione degli elementi di natura. È l’uomo che si adatta, fa o prende il meglio di tutto ciò che lo circonda, soprattutto in relazione al regno degli elementi naturali.
Stšnw (stèno), da cui il nostro stendere, distendere, è la capacità di porsi in sintonia con la terra, con l’acqua, con l’aria, col fuoco. Viene di solito tradotto con gemere, ma è un gemere simile a quello delle piante nel loro rapporto con le forze della natura.
7. PolÚ-frwn (polü-fron): è colui che è versatile nella capacità di riflessione in generale. Frone‹n (fronèin) è la capacità di pensare, di riflettere prima di agire e in vista dell’agire. La differenza fondamentale tra polÚ-mhtij e polÚ-frwn sta nel fatto che mÁtij si riferisce al pensare in quanto gestito individualmente e liberamente dall’essere umano; frwn indica quelle intuizioni che vengono date dall’alto in chiave rivelatoria o ispirativa. Ulisse è in grado di capire con la mente (mÁtij) ciò che il cuore (frwn) gli ispira.
Per ogni peripezia Omero usa l’aggettivo giusto, cioè il modo giusto di affrontarla.
Erbe magiche e veleni
Consideriamo ora brevemente l’incontro con la maga Circe, che viene narrato nel X canto. Ricorderete che Odisseo manda avanti Euriloco con ventidue compagni, i quali vengono da Circe trasformati in porci: Euriloco ritorna e racconta in lacrime. Odisseo non si lascia scoraggiare e va a ricercarli: gli appare per strada Mercurio che gli dà una specie di erba magica che, dice Omero, nel linguaggio degli dèi si chiama mîlu (molü).
Nell’Iliade e nell’Odissea Omero distingue a più riprese il modo in cui le cose vengono chiamate dagli dèi e il modo in cui vengono chiamate dagli uomini. Per fare un esempio: il fiume che scorre davanti a Troia si chiama X£nqoj (Xànthos) nel linguaggio degli dèi e Sk£mandroj (Scamàndros) nel linguaggio degli uomini. Qual è il significato di questa distinzione? Gli dèi fanno della realtà un’esperienza e gli esseri umani ne fanno un’altra. Perciò il linguaggio non può essere lo stesso. Ancora una volta ha ragione Cratilo nel dire che nessuna parola all’inizio è stata inventata per arbitrio, ma per esprimere oggettivamente l’esperienza che si compie venendo a contatto con la cosa che la parola designa.
Gli dèi sono immortali perché non abitano, come noi, un corpo di materia. Ci invidiano però quella libertà umana che sorge solo grazie alla nostra interazione tra spirito e materia. Là dove lo spirito interagisce con la materia per vincerla e trasformarla, si vivono tutt’altre conquiste, e le parole che le esprimono debbono essere diverse.
Nel caso di mîlu ci viene indicato soltanto il nome divino. Vuol dire, allora, che non si tratta di un’erba materiale. Dice Omero che è nera alla radice e bianca nel fiore; e aggiunge che soltanto gli dèi sono in grado di fruirne. Si tratta insomma di una realtà nota soltanto agli dèi: l’opposto dell’erba mîlu sono infatti i farmaci che Circe propina agli uomini per trasformarli in porci.
Abbiamo qui da un lato il farmaco degli dèi e dall’altro il contro-farmaco di Circe. Il regno di Circe è il sistema del metabolismo, e il metabolismo è proprio in grado di trasformare gli esseri umani in porci. Nei testi antichi questi termini hanno un significato tecnico: I cani e i porci di cui parla anche il Vangelo rappresentano, sotto altri aspetti, la stessa polarità espressa in Scilla e Cariddi. Il figliol prodigo della parabola evangelica, al punto infimo della sua peripezia, prima del ritorno a casa, si congiunge con la realtà dei porci: mangia le ghiande riservate ai porci (e poi neanche più quelle). La qualità più spiccata del cane è il suo fiuto. In termini di autoesperienza umana è la capacità di fiutare, con l’astuzia e la sagacia proprie del pensiero, le situazioni che vanno sfruttate a proprio vantaggio. Il maiale è una calzante immagine delle forze dell’egoismo che chiudono l’essere in se stesso, come il maiale che si avvoltola nei propri escrementi. Nel metabolismo (Circe) l’essere umano è del tutto chiuso in sé, nei propri processi organici. La capacità di fiutare il mondo esterno invece, la facoltà pensante, lo apre alla realtà circostante.
La parola Circe, in greco K…rkh (Κìrke), esprime un’esperienza di chiusura. Kerker in tedesco è il carcere: ker-ker, ker-ker… È proprio una cinghia che avvolge, che “cerchia” e chiude. Circe è la cerchia dei processi del metabolismo, della digestione, di tutti i processi vitali che sfuggono alla nostra coscienza: in essi noi siamo, in un certo senso, incarcerati perché non li possiamo contemplare dal di fuori e gestire coscientemente. Lì la natura agisce in noi. Quando i processi vitali sommergono i processi di coscienza (e questo avviene, per esempio, quando ci ubriachiamo) invece di nutrirci e farci sani, agiscono come veleni: avvelenano, cioè ottenebrano, il nostro spirito.
Circe ha a sua disposizione due armi: la prima sono i farmaci stregati, cioè i cibi che mangiamo. Tutto ciò che ingeriamo diventa veleno, veleno nel senso tecnico di ciò che uccide il polo della coscienza; la seconda arma di Circe è la bacchetta magica che trasforma in porci.
Tutto ciò che mangiamo e beviamo può divenire veleno se ingerito in modo non giusto. Proviamo a bere dieci litri d’acqua tutti insieme! Ciò che mangiamo e beviamo è sempre potenzialmente un veleno perché il compito del nostro organismo è di opporvi resistenza, generando la controforza che superi il veneficio e riemerga in processi di coscienza.
L’antidoto ermetico, cioè mercuriale contro i cibi che diventano veleno è chiamato mîlu e rappresenta il sano rapporto col cibo. Non dimentichiamo che noi mangiamo a tre livelli: con la bocca ingeriamo i cibi propriamente detti; col naso ingeriamo aria; con i sensi ingeriamo le percezioni. Il cibo può diventare sia un veleno che ci uccide, sia un miele (mîlu-mšli, mèli, miele) che ci fa vivere. Siamo vincitori sul cibo quando lo trasformiamo in zucchero (miele) e riemergiamo con processi di coscienza ancora più chiari e cristallini.
L’altra arma di Circe è il ·£bdoj (ràbdos), la verga, un elemento di magia che contrasta l’esercizio della libertà. Contro quest’arma Odisseo è munito dello x…foj (xìfos), che è una piccola spada, un pugnale.
La verga serve a picchiare, mira ad annullare l’autonomia dell’altro. La spada taglia, divide, separa: è la facoltà del distinguere. Inizia distinguendo le polarità fondamentali dell’essere per poi ulteriormente sottodistinguere. L’esempio appena citato ci ha fatto distinguere il polo delle funzioni vitali da quello della coscienza come opposti fra loro.
Ogni distinzione ha due corni. Un bravo pensatore, se interrogato, non ama rispondere univocamente, ma preferisce distinguere. Distingue frequenter, numquam errabis, dice l’antico proverbio: distingui spesso, non errerai mai. L’arte del pensare è l’arte del distinguere.
In questo X canto la maga Circe rappresenta allora lo stadio dell’evoluzione umana previo al pensiero e alla libertà. A quei tempi l’essere umano veniva governato da quella magia divina che le religioni e le mitologie esprimono nelle immagini più diverse. La bacchetta magica è un’immagine greca per ciò che il cristianesimo, per citare un esempio, chiama «volontà di Dio». Ulisse è l’uomo nuovo: egli rappresenta lo stadio del pensiero che distingue tra il bene e il male e che de-cide (ecco il taglio della spada!) di fare solo il bene.
L’impulso della Trinità e l’isola Trinacria
Nel XII canto Ulisse rammemora – portandolo così a coscienza e a conoscenza – ciò che l’umanità ha vissuto quando il Sole sorgeva in primavera nel segno del Toro.

Ciò ci riporta al tempo in cui la cultura caldaico-egizia ebbe il ruolo di guida nel divenire umano. Come quella paleo-indiana si era svolta in chiave di unità e quella paleo-persiana si era incentrata su tutti i fenomeni di dualità e di polarità (lotta fra il bene e il male), così quella egizio-caldaica si dedica principalmente al mistero della trinità, per esempio nella triade fondamentale di Osiride, Iside, Horus.
Omero ci narra a questo punto la vicenda delle vacche del Sole, che si svolge sull’isola Trinacria. Quest’isola non sta a indicare in primo luogo la Sicilia o, per lo meno, non è il riferimento a un luogo fisico che importa rilevare. La Sicilia è a forma di triangolo per il fatto che l’impulso che l’ha fatta sorgere è un impulso ternario, ed è quest’impulso cosmico che Omero sta ricordando dando il nome di Trinacria all’isola delle vacche del Sole.
Il fatto che sull’isola dalle Tre Corna Odisseo e compagni trovino le vacche del Sole ci dice che abbiamo a che fare con quel periodo di cultura in cui il Sole sorgeva nella costellazione del Toro. Odisseo e compagni, confrontati con queste esperienze dell’isola del Sole, si trovano a ripercorrere, per portarlo a coscienza, il cammino che l’umanità ha percorso quando il Sole sorgeva nel segno del Toro.
Calypso, ovvero il tempo della scienza occulta
Dopo la vicenda dell’isola del Sole viene narrato l’incontro con la dèa Calypso. Kaluyè (Kalüpso) viene da kalÚptw (kalüpto) che vuol dire occulto, nascondo. Per sette anni Ulisse deve imparare i segreti reconditi dell’universo in cui viviamo. Calypso significa, in senso vero e proprio, la scienza occulta, la sofìa occulta.
Ci vien fatto di chiedere: perché è occulta questa sapienza e non, invece, palese? Goethe parlava di mistero palese (das offenbare Geheimnis), particolarmente in riferimento alla natura. Intendeva dire che essa è, da un lato, accessibile a tutti, ma dall’altro occulta, perché occorre sviluppare precise qualità per comprenderne i misteri più profondi.
Questa realtà ovvia e palese esprime al contempo il più grande mistero dell’evoluzione: che nessuno può venire a conoscenza dei più intimi segreti del mondo prima di essere in grado di farne buon uso, cioè un uso giovevole per tutti. Ciò vuol dire in altre parole: ognuno di noi capisce le cose più profonde della vita nella misura in cui vince in sé l’egoismo e cessa di ricercare unicamente il proprio tornaconto.
Solo nell’umanità moderna e sedicente democratica è invalso il principio che si può dire tutto a tutti e che tutti hanno il diritto a saper tutto. Per fortuna quello che si ha oggi per lo più da dire contiene ben poco di pericoloso, visto che le conoscenze più profonde degli iniziati antichi sono andate perdute. Prima dei nostri tempi, la distinzione tra il palese e l’occulto, tra l’essoterico e l’esoterico (tra ciò che è per tutti e ciò che va detto solo a chi ha percorso un ben definito cammino di purificazione interiore, come si diceva) veniva osservata rigorosamente. Platone e Aristotele sanno bene che cosa possono affidare allo scritto (reso accessibile a tutti) e che cosa va comunicato solo oralmente.
Anche nei vangeli si distingue chiaramente tra le parabole – che contengono immagini che sono per tutti, perché ognuno le capisce per quel che può e non di più – e la spiegazione delle parabole – che avviene in forma concettuale ed è per i soli discepoli.
Il fatto che Odisseo venga a conoscenza della sapienza occulta (si unisce con Calypso) significa appunto che ha compreso che l’essenza del cammino umano è un percorso di purificazione interiore: bisogna prima diventare capaci di far buon uso di quelle conoscenze che il pensiero umano va via via conquistando.
Quinto capitolo
Verso l’uomo nuovo
Respiro cosmico e canto umano
Ci siamo soffermati su quattro canti fondamentali dell’Odissea, limitandoci a pochi cenni di carattere orientativo. Avremmo bisogno di molto più tempo se dovessimo avvalerci di queste chiavi di lettura per affrontare il testo nei particolari.
I ventiquattro episodi dell’Odissea vengono chiamati canti e non libri o capitoli. Dicendo libro o capitolo dimenticheremmo che siamo di fronte a una tradizione orale: questi testi venivano veramente cantati, come una cantilena, al ritmo dell’esametro (un verso lungo sei piedi, o misure).
All’interno di ogni piede abbiamo il dattilo, che racchiude una sillaba lunga (equivalente a due brevi) e due brevi: uu ( ( lunga breve breve; oppure abbiamo lo spondeo uu uu lunga lunga (equivalente a quattro brevi), anche qui vige un rapporto di quattro a uno. È lo stesso rapporto che c’è tra i due ritmi fondamentali dell’organismo umano. Il battito cardiaco (72 volte al minuto) e il respiro (18 volte al minuto) hanno tra loro un rapporto di quattro a uno: un respiro ogni quattro battiti.
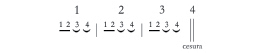
Nelle infinitesimali variazioni e sfumature di questo rapporto si esprime l’individualità di ciascuno.
Si tratta quindi di una recitazione declamata che si avvicina al canto. L’uomo greco aveva ancora la capacità, recitando o cantilenando l’Odissea e l’Iliade, di imitare fedelmente il rapporto biologico di quattro a uno che vige tra circolazione e respirazione. Il ritmo del corpo accompagnava quello del canto e il canto imitava il ritmo biologico. Mens sana in corpore sano!
In questo modo il greco non solo esprimeva nei suoi versi il ritmo naturale del suo organismo fisiologico, ma viveva l’armonia col macrocosmo dal quale provengono tutti i ritmi posti alla base del corpo umano. Il rapporto ritmico quattro a uno è infatti uno dei più importanti del nostro sistema solare. L’epatta (o nodo) lunare, cioè il tempo che occorre perché Sole, Luna e Terra si ritrovino nello stesso rapporto fra loro, è di diciotto anni (e qualcosa). In settantadue anni, vita media dell’uomo, questo evento si verifica quattro volte. Quindi il greco che declamava l’esametro si metteva in comunione col canto cosmico, con l’armonia delle sfere. Nel suo organismo umano sentiva l’eco delle armonie del mondo e il suo canto era l’eco fedele di entrambi.
Traduttori, traditori?
Vorrei fare un breve cenno alle difficoltà insite in ogni traduzione moderna dei testi greci antichi, testi intrisi di una spiritualità che noi, e le nostre lingue, non conosciamo più. Il tanto esecrato materialismo si esprime nel nostro stesso linguaggio. Vi porto un esempio banalissimo per darvi un’idea di ciò che voglio dire.
Prendiamo il primo verso del IX canto, un verso di per sé (o per noi) insignificante, che ricorre a più riprese e che dice semplicemente:
Rispondendo gli disse l’astuto Odisseo…
tÒn d’¢pameibÒmenoj prosšfh polÙmhtij ʼOdusseÚj
(Ton d’apameibomenos prosefe polümetis Odüssèus)
Osserviamo che cosa va necessariamente perso nella traduzione: ¢pÒ (apò) vuol dire venir via da, staccarsi da, migrare da: indica una realtà che si stacca da qualcuno per andare verso qualcun altro; prÕj (pròs) significa verso, in senso dinamico di movimento. L’accusativo tÒn (tòn), retto da prÕj, non può venir reso bene dal nostro gli (dativo per il complemento di termine) che indica che io son qui tranquillo e beato e mi rivolgo all’interlocutore che è là, senza minimamente pensare che c’è qualcosa di reale emesso da me, che parte da me, viene da me messo in movimento e va verso di lui.
Il verbo ¢me…bw (amèibo) significa migrare, mutare, cambiare, trasformare. I pensieri di Ulisse, migrando da lui verso il suo interlocutore, si trasformano al contempo per farsi compatibili con lo spirito dell’ascoltatore, dal quale devono venire accolti. Ogni dialogo è un velocissimo e continuo andirivieni tra il pensare i propri pensieri e il pensare quelli altrui.
Per meglio capire questo realismo spirituale insito nella lingua greca, pensiamo al primo versetto del Vangelo di Giovanni: ’En ¢rcÍ Ãn Ð LÒgoj, kaˆ Ð LÒgoj Ãn prÕj tÕn QeÒn.
(En archè en o Lògos, kaì o Lògos en pròs ton Theòn), «In principio era il Verbo, e il Verbo era dinamicamente proteso verso il Dio». Così era nel principio (letteralmente: dentro al principio, cioè in seno alla realtà spirituale iniziale) perché in seguito il Verbo è diventato carne e si è orientato verso l’umano. Nel prÕj (pròs) c’è anche qui il movimento dinamico di tutto l’essere.
Continuiamo a esaminare questo verso dell’Odissea: prosšfh (prosèfe) viene da proseipomai (proséipomai) che significa dire, ma non il dire astratto nostro, bensì l’inviare verso l’altro qualcosa di reale, un mandare verso (prÕj) di lui la realtà di pensiero e di sentimento che si vuol condividere con lui. ”Epoj (èpos) è la parola in quanto viene pronunciata, parlata, emessa vocalmente così che voli e giunga all’orecchio dell’altro. Da èpos abbiamo i nostri epopea, epico ecc.
L’immagine del verso citato, di Odisseo polÙmhtij, versatile nei processi logici di pensiero, che si rivolge ad Alcinoo alla corte dei Feaci per narrare le sue peripezie, in lingua greca può essere resa soltanto con il reale gesto di tutte queste preposizioni che dicono: Una realtà spirituale si diparte da (¢pÒ) Odisseo versatile e migra versatile verso Alcinoo (apoj tÒn…), sulle ali del linguaggio che è comunicazione vivente di realtà spirituali da essere a essere.
Che cosa va perso in ogni traduzione moderna? La realtà spirituale e vivente dei pensieri che vengono comunicati! Il greco era ancora in grado di percepire e vivere questa realtà spirituale vivente. Quando noi oggi leggiamo «Rispondendo gli disse l’astuto Odisseo…» ci sorge forse l’immagine vivente di una realtà spirituale lanciata da un essere verso un altro? No, tutto ciò va perso! Proprio in questo consiste la tendenza moderna all’astrazione. È stata una necessità evolutiva, certamente, ma che però attende ora di venir superata nella sua unilateralità.
Non pensate che stia facendo violenza al testo greco: non sto inventando nulla. Se noi togliamo il tÒn accusativo e ci mettiamo il dativo; se noi togliamo ¢pÒ che è un partire da, uno staccarsi da; se togliamo il prÕj che è la meta del movimento, la meta verso cui la realtà delle parole si dirige; se togliamo questi tre elementi dinamici, non abbiamo più il verso omerico!
Goethe era innamorato di Omero e conosceva a memoria interi canti dell’Odissea: tra quelli che più amava c’era il VI, dove si narra l’incontro fra Odisseo e Nausicaa, un canto sublime, ma anch’esso impossibile da tradurre. Perciò Goethe si augurava una traduzione dell’Odissea in prosa, nonostante l’esimia tradizione tedesca di traduzioni in versi. Nella poesia l’essenziale non è infatti il contenuto teorico, bensì l’elemento artistico che si esprime nei ritmi e nell’armonia dei suoni, delle rime, delle allitterazioni. Goethe capiva che le nostre lingue moderne non sono più in grado di recuperare queste epopee in quanto opere d’arte poetica e ci tocca perciò accontentarci di comprenderne il più fedelmente possibile il significato espresso in prosa, che basta a darci un’idea della loro ricchezza inesauribile.
Il desiderio di essere sovrani
Consideriamo ora più da vicino alcuni contenuti del canto IX:
Rispondendo gli disse l’astuto Odisseo:
«Potente Alcinoo, insigne fra tutti i popoli,
certo è bello ascoltare un cantore
così come è questo, simile per la voce agli dèi.
Perché penso non v’è godimento più bello,
di quando la gioia pervade tutta la gente,
i convitati ascoltano nella sala il cantore
seduti con ordine, le tavole accanto son piene
di pane e di carni; dal cratere attinge vino
il coppiere, lo porta e nelle coppe lo versa:
questo mi sembra nell’animo una cosa bellissima.
Ma il tuo cuore s’è volto a chiedere delle mie dolorose sventure, perché piangendo io gema di più.
Quale devo narrare per prima, quale per ultima?».
(IX, 1-14)
Odisseo sta qui dicendo:
«È bella questa vostra anima di gruppo, questo vostro sentirvi uniti, dove l’essere umano è ancora inserito nell’armonia del tutto; e proprio tu, Alcinoo, che sei il capo di questa realtà comunitaria, senti in te, come essere umano, il desiderio di ascoltare il racconto delle peripezie che affronta colui che lascia il grembo della originale appartenenza, che viene scagliato fuori dal paradiso per vivere l’esperienza dell’essere umano a sé stante. Non vive più l’esperienza dell’armonia iniziale, ma fa l’esperienza dolorosa e sofferta della separazione che rende individui autonomi. C’è in te, Alcinoo, rappresentante dell’anima di gruppo, l’anelito a non restare in questa protezione ancora ignara della libertà del singolo: tu desideri sentire il racconto di ciò che si vive lungo il cammino che fa diventare un essere umano autonomo».
E ancora più in profondità questi versi dicono:
«O Alcinoo, la tua richiesta che l’Odisseo, l’uomo individuale, razionale, che ha tanto sofferto per diventare se stesso, ti racconti come ciò avvenga, è il desiderio più profondo di ogni essere umano che è stato creato per uscire dal grembo materno, dal paradiso iniziale, per diventare un io individuale e responsabile. L’essere umano avverte da un lato che questo cammino è pieno di sofferenza e solitudine, ma dall’altro lo desidera profondamente perché sa che è divinamente bello: il tuo cuore desidera proprio questo».
Viene espresso in questi versi il contrasto sublime tra il vivere nell’impulso dell’anima di gruppo (i Feaci) e ciò che avviene quando si è espulsi, cacciati fuori dalla spada del Cherubino e si comincia la vicenda dell’essere soli. Soli e pieni di sofferenza, ma anche di gioia perché si nasce all’essere proprio, su questa via. È la versione omerica della parabola evangelica del figliol prodigo.
Qui a Firenze sono vissuti dei veri colossi dello spirito: basti pensare a un Michelangelo, a un Leonardo da Vinci, a un Dante… Dante è sommamente un uomo odissiaco: la forza dell’individualità autonoma gli comporta una misura colma di sofferenza, ma è anche una fontana zampillante di creatività, che viene sempre di nuovo alimentata proprio dal dolore.
La spada e la parola
Nell’episodio a tutti noto del ciclope Polifemo, Omero ci parla di due piani di battaglia che Odisseo concepisce per affrontare il gigante dall’unico occhio: il primo lo abbandona, il secondo lo attua.
Il primo piano era quello di uccidere il Ciclope con la spada, conficcandola nella parte mediana del petto, dove c’è il diaframma: ma Odisseo rinuncia perché pensa che, uccidendo il ciclope, eliminerebbe l’unico essere in grado di rimuovere l’enorme macigno che chiude la caverna. Qui si mostra all’opera la capacità di Odisseo di valutare diverse strategie e di scegliere la migliore.
Il secondo piano non prevede di uccidere: gli stadi evolutivi che lasciamo dietro di noi non devono venire distrutti, ma superati. Invale qui il principio della metamorfosi, che domina in questo canto. Metamorfosi dolorosa in senso esteriore, ma grandiosa in senso evolutivo perché permette di trasformare l’occhio unico di Polifemo (l’occhio dell’atavica, sognante chiaroveggenza) nei due occhi che tutti abbiamo oggi, fatti per guardare le cose del mondo a modo nostro. Perfino il ciclope, alla fine del canto, deve ammettere che questo evento era stato preannunciato. Gli era stato detto che sarebbe venuto un essere umano più forte di lui, che l’avrebbe vinto.
In tante fiabe si ritrova il tema della grande mole senza intelligenza (il gigante) e della piccola mole nella quale alberga l’intelligenza (il nano). La piccola mole vince ciò che, come realtà di natura, è molto più grosso. Davide vince Golia. L’ingegno ha la meglio sulla forza bruta.
Questo tema indica il movimento e il significato complessivi dell’evoluzione umana: la natura viene gradualmente trasformata dallo spirito e in spirito. Le forze cieche della natura sono chiamate a servire il cammino dell’intelligenza umana, non a impedirlo. In ciò consiste la vittoria del nano astuto sul gigante energumeno ma stupido.
Il secondo piano di salvezza sostituisce la spada con il palo d’ulivo tagliato, dice il testo, alla lunghezza di una tesa – cioè di due braccia allargate – che è uguale all’altezza della persona dalla testa ai piedi. La realtà principale, anche se non la sola, espressa nel palo d’ulivo è la spina dorsale con in cima il cervello. Viene qui fatto riferimento al mistero della posizione eretta dell’essere umano. In questo canto si ripassa in rassegna tutta l’evoluzione: dall’epoca in cui l’essere umano è pervenuto alla posizione eretta, all’epoca durante la quale si è appropriato della facoltà del linguaggio, fino alla nostra epoca, dove sempre più acquisisce la facoltà del pensiero.
Questi tre grandi stadi del divenire umano racchiudono le tre grandi facoltà che ci distinguono dagli animali. Sono le tre tappe che ogni bambino deve ripetere in modo individuale dopo la sua nascita, a differenza degli animali che nascono già compiuti nella loro natura di specie.
Polifemo è in posizione orizzontale, è disteso a terra (il testo lo ripete più volte), è l’essere umano che non ha ancora conquistato le forze della stazione eretta: in lui viene vinto, col palo della verticalità, lo stadio dell’antica, sognante chiaroveggenza espressa nell’occhio frontale singolo.
Una differenza sostanziale tra il piano di uccidere Polifemo e quello di accecarlo è la scelta tra un’evoluzione senza continuità e un’evoluzione in base a trasformazione. Il secondo piano, quello poi adottato da Odisseo, non uccide l’essere umano già esistente, ma gli trasforma la vista, conciliando nel divenire la continuità con l’innovazione.
Nel Vangelo di Giovanni, al momento della cattura del Cristo, vediamo da un lato i soldati e dall’altro Pietro che tira fuori la spada e taglia l’orecchio al servo. Anche qui abbiamo la spada, come nel primo piano di Odisseo, ma in relazione all’orecchio: anche l’orecchio, infatti, è riferito al mistero della parola, che la bocca emette e l’orecchio riceve.
La spada di Pietro è la parola che ferisce, che manipola l’altro: quindi offende l’orecchio. E il Cristo gli dice: «Rimetti la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce di spada perisce». Chi manipola con la parola verrà lui stesso manipolato, perché non riconosce quella libertà grazie alla quale gli esseri umani si dicono soltanto ciò che c’è, e lasciano a ognuno la decisione individuale su ciò che c’è da fare.
Abbandonata la spada e preso il palo d’ulivo, che cosa nasce nei due occhi che sostituiscono l’occhio del Polifemo accecato? Nasce la capacità di vedere oggettivamente ciò che sta davanti a noi. I due occhi ci rendono liberi di guardare il mondo e di vedere le cose come sono, nella loro oggettività. Gli occhi sono la sorgente di informazione oggettiva più preziosa che abbiamo: guardiamo ciò che vogliamo e quando vogliamo. Essendo due, i fasci di luce emessi dagli occhi s’incrociano, e toccandosi fanno sorgere la coscienza dell’io.
Odisseo, ossia il Nessuno, il non qualcuno
Un altro importante tema di questo canto è il nome, o non-nome, di Odisseo. Al ciclope che gli chiede come si chiami risponde: il mio nome è Nessuno. Nel nome, l’abbiamo già accennato, viene espressa la realtà profonda dell’essere e Odisseo ha questa bella trovata da polÙmhtij (polümetis, ingegnoso) qual è.
A Polifemo che gli chiede il suo nome dice di chiamarsi oÜ-tij (ù-tis), non qualcuno. È l’uomo che non è ancora divenuto qualcuno: colui che ancora si identifica con l’anima di gruppo, che non è ancora emerso come singolo sviluppando l’individualità. È proprio l’opposto di ciò che Odisseo è, nella duplice caratteristica fondamentale della collera e della sofferenza che abbiamo già visto. Grazie all’impulso della collera e all’esperienza della sofferenza Odisseo è l’uomo per eccellenza che diventa individuale, autonomo, libero. Nessuno, in italiano, non rende bene la parola greca che significa non-uno, un non individuo.
È una menzogna questo stratagemma di Odisseo? È moralmente riprovevole il fatto che dica a Polifemo questo nome? Ulisse tiene conto del livello di coscienza oggettivo del Ciclope e gli dice: per te, io non sono nessuno, poiché tu non puoi capire l’avvento dell’Io sono, dell’io individuale. Per te è nulla ciò che per me è tutto.
Ricordiamo la scena del Faust dove Faust vuole scendere nel regno misterioso delle Madri e Mefistofele gli dice che là non troverà nulla, niente e nessuno. E Faust risponde: In deinem Nichts hoff’ ich das All zu finden! Nel tuo nulla io spero di trovare il tutto!
Per Polifemo Ulisse dunque non-è, perché il Ciclope conosce solo quelle forze dentro l’essere umano che impediscono di diventare qualcuno, che sono “nessunificanti”.
Se la vicenda fosse da intendere solo sul piano fisico, immaginate voi il gigante che, di fronte a questi omiciattoli che armeggiano rigirandogli l’enorme palo nell’occhio, solo alla fine, ormai accecato, comincia a urlare e a difendersi? Ma non li avrebbe nemmeno lasciati incominciare, si sarebbe svegliato subito all’inizio!
Si tratta dunque di esperienze spirituali, benché realissime, che rendono, in chiave di visione e di immagini, l’oggettività dei passi compiuti dall’evoluzione umana. Il palo con la punta temprata nel fuoco, questo palo col fuoco in cima, è la nostra spina dorsale con la sua cima nel cervello e dalla cui sommità irraggia la luce luminosa delle forze del pensiero. La cima il testo omerico la chiama aguzza: il cervello dev’essere acuto, sennò che cervello è?!
C’è un vaso greco, nella collezione di antichità di Monaco, che raffigura Ulisse che esce aggrappato al ventre dell’ariete e dei compagni infilati sotto le pecore legate a tre a tre. È bellissimo. Dei dodici compagni ne sono rimasti ormai solo sei perché Polifemo ha divorato gli altri sei. Anche in questo episodio ritorna il dodici, a rappresentare i sei doppi fasci nervosi (sei fisici e sei eterici) che entrano nel cranio e costituiscono la base dei sensi. Odisseo resta per ultimo e, non avendo nessuno che lo leghi, si tiene aggrappato sotto la pancia dell’ariete al quale Polifemo dice: «Tu montone (sarebbe molto meglio tradurre con ariete), che sei sempre uscito per primo, ora sei l’ultimo…».
Consideriamo le tre forme degli ovini: la pecora è femminile e non ha corna, la capra è femminile e ha le corna, l’ariete è maschile e ha le corna. Il riferimento è qui alla qualità maschile e femminile, non alla realtà fisica dell’essere maschio o femmina. Queste tre forme rappresentano gli stadi fondamentali dell’evoluzione che ci conduce dal gregge (delle pecore) all’essere autonomo (l’ariete): la capra è uno stadio intermedio. La pecora è l’animale gregario per eccellenza. Il Vangelo dice che c’è più festa per una sola pecora che si perde staccandosi dalle altre cento, che non per le altre novantanove che restano nel gregge. La grande meta dell’evoluzione è proprio che l’uomo impari a emanciparsi dal gregge e a diventare individualmente responsabile.
Tornando al vaso di Monaco, abbiamo, diversamente colorati rispetto a tutto il resto, i tre impulsi che rappresentano il sorgere del pensiero (V. immagine a p. 91):
1. le corna dell’ariete (segno zodiacale del periodo di cultura dei greci e dei romani) sono luminose e ben circonvolute. Il Sole sorgeva nel segno dell’Ariete quando nacque nell’umanità la filosofia, la capacità di pensare, in seno alla cultura greca. Il tratto principale dell’ariete sono le corna ricurve al punto da percorrere quasi un cerchio intero per tornare a toccare il proprio punto di partenza. Le corna dell’ariete – che anche Abramo fu chiamato a offrire – rappresentano ciò che gli Scolastici chiamavano la recurvatio in se ipsum, cioè la capacità del pensiero di diventare autocosciente, di pensare il pensare – per dirla con Aristotele;
2. la testa di Odisseo, che fa pensare al suo prolungamento nella spina dorsale;
3. il palo con la punta aguzza e infuocata che Odisseo porta via con sé. Questo palo non genera da sé la luce, ma è stato acceso, temprato da una brace che covava sotto il letame del Ciclope: infatti i contenuti del pensare, che sorgono nella nostra testa, alla punta del palo che è la spina dorsale, li inventiamo forse noi? No! Li prendiamo dal mondo che ci circonda. E in che cosa consiste il trapasso dal fuoco che va spegnendosi sotto la brace alla luce del palo? È il passaggio dalla sapienza cosmica all’intelligenza umana singola: l’intelligenza umana è sapienza cosmica individualizzata. È il passaggio dalla percezione, che è un frammento di mondo, al concetto, che è un illuminarsi della mente umana. Questa differenza è importante: di sapienza è pieno il mondo, ma l’intelligenza deve venire elaborata dall’uomo, per forza propria e libera.
La tentazione evangelica di buttarsi giù dal pinnacolo (alto e luminoso) del tempio è la tentazione sempre in corso di abdicare alla facoltà luminosa e libera del pensiero e di abbandonarsi alla sfera “bassa” degli istinti e delle brame. Ulisse vince il Ciclope con la luce del pensiero, non rinunciando al pinnacolo del tempio (il tempio è esso pure un’immagine del corpo umano, col pinnacolo che è la testa – più o meno pensante!).
Il periodo di cultura greco-romano è posto sotto il segno dell’Ariete (sia nell’immagine dell’agnello sacrificale ebraico e cristiano, sia nell’immagine greca del vello d’oro):

Polifemo, l’antico chiaroveggente ispirato
Polifemo è uno dei ciclopi: kÚklwy (küklòps) da kÚkloj (küklos) che significa cerchio, giro e êy (ops) occhio da Ðr£w (orào) vedo (futuro Ôyomai, òpsomai). Quello di Polifemo è un occhio che vede tutt’intorno. Vede tutto panoramicamente, e perciò non può ancora distinguere nulla. Il passaggio dall’occhio panoramico di Polifemo ai due occhi nostri è il passaggio da una veggenza onnicomprensiva – che ancora non conosce, perciò, i concetti singoli – a quella vista che deve consciamente rivolgersi verso quella specifica cosa che vuole di volta in volta percepire, rinunciando a percepire tutto il resto. Era l’occhio della percezione spirituale, quello dell’antica chiaroveggenza che vedeva, fuori dal tempo, la compresenza del tutto: non c’era ancora la storia, non c’era il mondo materiale, non c’era l’evoluzione, non c’era lo scorrere del tempo. I nostri due occhi sono invece quelli che vedono le cose del mondo sensibile una dopo l’altra, sono quelli dell’evoluzione nel tempo.
L’opposto della parola kÚklwy è ˜l…kwy (elìcops), che guarda a elica, a spirale. Questa parola ricorre sia nell’Iliade che nell’Odissea: è il modo di guardare dei pianeti, il modo di guardare orientato, che ha una traiettoria, che deve preferenziare per vedere di volta in volta cose nuove e diverse.
I ciclopi sono tanti e il nostro si chiama Polifemo. PolÚfhmoj (Polüfemòs) è colui che dice tutto: fhm… (femì) significa parlare, narrare». È l’antica ispirazione divina che narra non una cosa dopo l’altra, ma tutto insieme, nel contesto universale. Noi tutti, del ciclope che eravamo, abbiamo perso da un lato la chiaroveggenza atavica – che ci faceva vedere tutto in una volta – e dall’altra l’ispirazione atavica – che ci faceva udire tutto contemporaneamente. L’antico vedere si è fatto sveglio nel nostro guardare, e il vecchio udire si è fatto attivo nel nostro ascoltare.
Vediamo ora in quale modo questo essere umano antico, il ciclope Polifemo, dotato di forze veggenti e ispirative del passato, si rivolge all’impulso dell’ariete. Finché l’ariete era stato al suo servizio, era uscito sempre per primo; ora che l’ariete si è unito a Odisseo, che porta aggrappato al ventre, esce per ultimo. Ciò che si concepisce per primo è lo scopo che si vuol raggiungere ed è al contempo ciò che si realizza per ultimo. Nell’intelligenza umana avviene un’inversione di marcia: essa è la capacità di concepire per prima cosa ciò cui si vuol arrivare in ultimo. Nella pianificazione dell’evoluzione umana la meta da raggiungere, la cosa concepita per prima, fu l’impulso dell’ariete, cioè la chiamata a essere autonomi e liberi nel pensare. Ma proprio questa meta si può raggiungere solo alla fine, perché è il fine di tutta l’evoluzione. Ecco allora che l’ariete, in chiave di attuazione del piano evolutivo per opera di Odisseo, compare alla fine. Esce dalla caverna vuol dire: si affranca dai determinismi di natura.
E noi tutti, non meno di Odisseo, siamo sempre all’inizio della fine: siamo all’inizio della realizzazione del fine complessivo dell’evoluzione che è l’acquisizione della libertà e dell’amore, resi possibili solo dal pensare autonomo.
Ascoltiamo le sublimi parole di Omero:
Caro montone, perché vieni per la spelonca così,
per ultimo? Prima non sei mai venuto dopo le pecore,
ma primissimo correvi a brucare i teneri fiori dell’erba, a gran salti; per primo raggiungevi il corso dei fiumi;
per primo bramavi tornare alle stalle,
la sera; e ora invece sei l’ultimo. Forse tu piangi
l’occhio del tuo padrone? Lo ha accecato un vigliacco, coi suoi vili compagni, dopo avermi vinto la mente col vino: Nessuno, che penso non è sfuggito ancora alla morte.
Oh se potessi anche tu pensare e parlare,
per dirmi dove lui fugge dal mio furore.
A lui, sbattuto qua e là per la grotta,
si spaccherebbe il cervello per terra e il mio cuore avrebbe sollievo dai mali che questo Nessuno da nulla mi diede.
(IX, 447-460)
Il doppio lancio del macigno: coscienza e istinto
Un’altra cosa interessante è il doppio lancio del macigno: Polifemo è figlio di Poseidone, dio del mare, vive cioè ancora in uno stato di coscienza non entrato nella fisicità della terra. L’acqua è il simbolo delle forze cosmiche della vita, non ancora intrise di materia terrestre. Polifemo chiede vendetta al padre, lo supplica di intervenire contro Odisseo.
Ma appena distai quanto basta per sentire chi grida,
allora con parole taglienti dissi al ciclope:
«Ciclope, non certo i compagni di un uomo vigliacco
avresti mangiato nella cava spelonca con dura violenza.
E i misfatti dovevano ricadere proprio su te,
sciagurato, che non hai esitato a mangiare gli ospiti
nella tua casa: perciò ti ha punito Zeus e gli altri dèi».
Dissi così, e lui si adirò nel cuore di più,
divelse e scagliò la cima di una grande montagna:
la fece cadere oltre la nave dalla prora turchina;
alla caduta del masso il mare si sollevò:
l’onda rifluendo sospinse la nave a terra,
il riflusso dal largo, e la strinse contro la costa.
Io, però, afferrata una lunghissima pertica,
la spinsi di fianco e ordinai ai compagni, incitandoli,
di gettarsi sui remi, per scampare al pericolo,
con cenni del capo: ed essi remavano, piegandosi avanti. Quando avanzando sul mare distammo il doppio,
allora gridai al ciclope; intorno, i compagni
chi di qua chi di là mi frenavano con dolci parole:
«Sciagurato, perché vuoi irritare un selvaggio?
che anche ora, lanciando il masso nel mare, ha risospinto verso terra la nave, e credevamo di lasciarci la vita.
Se sentiva fiatare o parlare qualcuno,
ci fracassava le teste e i legni di bordo,
colpendoci con una ruvida roccia: perché tira lontano».
Così dicevano, ma non convinsero il mio cuore magnanimo, e di nuovo gli dissi con animo irato:
«Ciclope, se qualche uomo mortale
ti chiede dello sconcio accecamento dell’occhio,
digli che ad accecarti fu Odisseo, distruttore di rocche,
il figlio di Laerte che abita ad Itaca».
Dissi così, ed egli mi rispose gemendo:
«Ahimè, una profezia molto antica si avvera.
C’era qui un indovino valente e grande,
Telemo Eurimide, che eccelleva nell’arte profetica
e profetando invecchiò fra i Ciclopi:
egli mi disse che un giorno tutto questo si sarebbe compiuto, d’essere privato della vista per mano di Odisseo.
Ma io ho sempre aspettato che arrivasse qui un uomo
grande e bello, vestito di grande vigore:
invece uno che è piccolo, da nulla e debole,
ora mi ha orbato dell’occhio, dopo avermi vinto col vino. Ma vieni, Odisseo, ché ti offra i doni ospitali
e induca lo Scuotiterra glorioso a scortarti:
di lui sono figlio, padre mio dice d’essere.
Egli mi guarirà, se lo vuole, lui e nessun altro,
né degli dèi beati, né degli uomini mortali».
Disse così, ed io rispondendogli dissi:
«Magari avessi potuto privarti dell’anima
e della vita e scortarti nella casa di Ade,
come non guarirà il tuo occhio neppure lo Scuotiterra». Dissi così, ed egli a Posidone signore
elevò una preghiera, tendendo le mani al cielo stellato: «Ascolta, Posidone che percorri la terra, dai capelli turchini, se sono tuo veramente, padre mio dici d’essere,
che a casa non giunga Odisseo distruttore di rocche,
il figlio di Laerte che abita ad Itaca.
Ma se è suo destino vedere i suoi cari e tornare
nella casa ben costruita e nella terra dei padri,
tardi vi giunga e male, perduti tutti i compagni,
sopra una nave straniera, e a casa trovi dolori».
Disse così pregando, lo udì il dio dai capelli turchini.
Egli sollevato di nuovo un macigno molto più grande
l’avventò roteando, gli impresse un impeto immenso:
cadde dietro la nave dalla prora turchina,
poco lontano, e quasi colpì l’estremità del timone.
Alla caduta, il mare si sollevò,
l’onda sospinse la nave, la spinse verso la costa.
Quando arrivammo nell’isola, dove aspettavano
insieme le altre navi ben costruite – i compagni sedevano intorno gemendo, sempre attendendoci –,
spingemmo sulla sabbia la nave, appena arrivati, e noi stessi sbarcammo sulla riva del mare.
Tratte le greggi del ciclope dalla nave ben cava,
le dividemmo, perché nessuno partisse privato del giusto.
I compagni dai saldi schinieri, divise le bestie,
assegnarono il montone a me solo, a parte: immolandolo
a Zeus Cronide dalle nuvole cupe, che di tutti è signore, ne bruciai sulla riva i cosci. Ma non accettò il sacrificio:
meditava come potessero perdersi tutte
le navi ben costruite e i miei fedeli compagni».
(IX, 473-555)
Che cosa sono i due macigni scagliati dal ciclope Polifemo? Al primo lancio il masso va a finire oltre la prua e risospinge la nave verso la terra del ciclope. La seconda volta Ulisse e compagni avanzano del doppio: il macigno cade prima della poppa, quindi dietro al timone, e la nave viene sospinta in avanti verso l’isola delle Capre.
L’isola delle Capre, dove viene portato l’ariete, è un polo, quello degli impulsi coscienti; l’isola del ciclope è l’altro polo, con l’essere umano disteso e accecato, con gli impulsi non coscienti della volontà istintiva e delle forze di natura. Al centro, la nave di Odisseo, la sfera mediana del cuore e della parola.
Abbiamo la testa (isola delle Capre), gli arti (isola di Polifemo con gli impulsi ciechi di natura) e il cuore: quando nobilitiamo il nostro essere solo a metà – lasciando sì la sfera buia degli istinti, ma entrando soltanto in quella semilibera dei sentimenti – veniamo risucchiati di nuovo nella sfera buia.
La sfera dei sentimenti è da un lato il risultato di impulsi più profondi, e dall’altro ci fa sempre di nuovo ricadere in essi. Se, invece, ci sforziamo di andare il doppio più lontano, mirando decisamente al polo della coscienza illuminata, allora tutto ciò che ci viene dall’altro polo ci aiuta, ci fa da sostegno. Infatti, se noi non ricreiamo sempre di nuovo le basi del metabolismo non possiamo neanche pensare. Ma un conto è che il sistema del metabolismo faccia da sostegno, che ci consenta di vivere la libertà della sfera della testa, e un conto è che annulli questo impulso, risucchiandolo nella sfera dell’istinto.
Polifemo è dunque l’uomo naturale, che conosce solo istinto e sentimento. Se in noi vigono soltanto l’istinto e il sentimento, siamo in un continuo ondeggiare tra l’uno e l’altro: l’istinto fa sorgere i sentimenti e i sentimenti rimandano agli istinti. Il nostro compito è quello invece di rafforzare sempre di più l’altro polo, quello del pensiero, che trasforma sia l’istinto sia il sentimento in positivi aiuti: ciò che prima era lo scopo diventa ora lo strumento, ciò che era primo diventa ultimo.
L’essere della libertà
Il ciclope ricorda la profezia che gli era stata fatta circa l’arrivo di Odisseo. L’evoluzione non improvvisa: i gradini necessari all’evoluzione dell’uomo sono stati concepiti – cioè pre-visti! – tutti fin dall’inizio. Noi ci arriviamo dopo, ma sono già messi in conto. A noi resta o di capirli o di non capirli, di attuarli o di ometterli.
Noi ci troviamo dentro un’evoluzione progettata in tutto il suo svolgersi fin dal suo stesso sorgere. E non è cosa da poco sentirsi avvolti da una saggezza eterna che abbraccia tutto il tempo dall’inizio fino alla fine.
Che l’essere umano diventi libero, autonomo, è stato da sempre previsto e voluto: Polifemo deve dar atto che gli era già stato predetto che la sua condizione mono-oculare non poteva essere lo stadio ultimo del divenire. E perché – potremmo chiederci – Polifemo non predice a sua volta a Ulisse che verrà anche per lui qualcuno che lo vincerà? Perché l’autonomia dello spirito individuale non è a sua volta uno stadio intermedio: è la meta complessiva e finale di tutto il divenire umano e come tale non può essere in vista di qualcos’altro. È in vista di sé, anche se consente infiniti gradi di intensità e di perfezionamento.
L’individuo che è libero nel suo pensare e che ama nel suo volere non è superabile da qualcosa di meglio ancora: è potenziabile all’infinito, ma mai superabile. Non è previsto uno stadio che sia un superamento della libertà attuata: non c’è niente di più alto o di più bello. Però Polifemo predice a Ulisse che il conseguimento di questo stadio supremo del divenire della Terra gli costerà molto. Questo sì, che è previsto!
E perché Polifemo si oppone al nuovo, pur vedendone la necessità evolutiva? Perché il ciclope rappresenta ciò che in noi è vecchio e duro a morire: se si ritraesse contento non avremmo nulla da vincere, saremmo già alla fine dell’evoluzione! Il compito di ciò che è vecchio è sempre quello di porre ostacoli al nuovo. Gli ostacoli sono necessari per l’esercizio della libertà: se tutto andasse liscio e la strada fosse sempre sgombra non ci sarebbe nulla da fare per la libertà, tutto andrebbe avanti per forza d’inerzia.
L’incontro di Ulisse con Polifemo non è una brutta sventura, che sarebbe meglio se non ci fosse, ma è la più grande fortuna offerta alla libertà di ogni giorno.