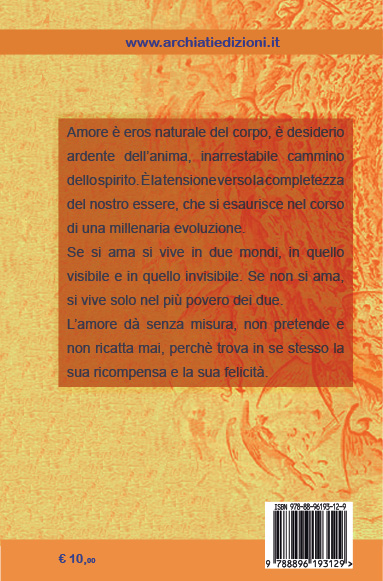Pietro Archiati
IL MISTERO
DELL’AMORE
che vive in ogni uomo

Pietro Archiati
IL MISTERO
DELL’AMORE
che vive in ogni uomo

Redazione a cura di Stefania Carosi
In copertina: La rosa celeste di G. Dorè
Elaborazione grafica di G. Bonicatto e F. Delizia
www.liberaconoscenza.it
ISBN 978-88-96193-12-9
Gli autori difendono la gratuità del prestito bibliotecario e sono contrari a norme o direttive che, monetizzando tale servizio, limitino l’accesso alla cultura.
Gli autori e l’editore rinunciano a riscuotere eventuali royalties derivanti dal prestito bibliotecario di quest’opera. Tale opera è pubblicata sotto Licenza Creative Commons, che recita: si consente la riproduzione parziale o totale dell’opera e la sua diffusione per via telematica, pubblicazione su diversi formati, esecuzione o modifica, purché non a scopi commerciali o di lucro e a condizione che vengano indicati gli autori e che questa dicitura sia riprodotta.
Ogni licenza relativa a un’opera deve essere identica alla licenza relativa all’opera originaria.


Indice
Il campo da gioco della simpatia e dell’antipatia
L’amore è davvero l’opposto dell’odio?
Lontananze e vicinanze tra il maschile
La sessualità è un «bene» o un «male»?
È possibile goderci al massimo sia i piaceri
del corpo che quelli dello spirito?
L’irresistibilità delle forze sessuali nell’adultera
La via all’insù e la via all’ingiù
La fantasia femminile e la brama maschile
Amore, morte e sessualità: c’è un nesso?
«Ti amo perché posso vivere anche senza di te»
L’amore che travalica nascita e morte
I pensieri, le opere e le parole dell’amore
La meraviglia, la compassione, la coscienza morale:
Può davvero lasciarci una persona amata?
SI, MA IL CUORE HA LE SUE RAGIONI
Logica della testa e logica del cuore
Tre battute del dialogo fra mente e cuore
La giustizia calcola, l’amore è generoso
Si può essere giusti anche senza amare, non si può
amare senza essere anche giusti
Il determinismo scientifico dell’Islam domina
Dov’è la scienza d’amore del Cristianesimo?
L’UOMO, QUESTO ETERNO INNAMORATO
Realismo e idealismo: il mondo che già c’è
Chi è artista della vita è un gran signore
La stoffa dell’artista: l’inventiva intessuta
Diventare come bambini, ovvero: camminare,
I pensieri belli sono la bellezza della vita
Lirica, epica e drammatica: tre arti
Prefazione
Ci vuole una certa spregiudicatezza a scrivere oggi un libro sull’amore. Questa parola è talmente inflazionata che può significare tutto quel che si vuole, e rischia perciò di non dire quasi più nulla. Ma proprio questo rischio mi ha invogliato a scrivere, restando io convinto che siano numerose le persone che cercano l’esperienza vera dell’amore, perché sanno che è la realtà più importante e più sacra della vita. Sono tante oggi, queste persone, ma pur sempre troppo poche. Io sarei felice se questo libro le facesse aumentare anche solo di una.
Non vorrei mancare di dire a chi mi leggesse per la prima volta che mi sento infinitamente debitore nei confronti di Rudolf Steiner in merito a tutte le cose che ho da dire e da scrivere. Non credo che senza la sua scienza dello spirito avrei potuto esprimere tanti dei pensieri qui esposti sull’amore. Riguardo al tema quanto mai controverso della sessualità, per fare un esempio, io stesso la pensavo ben diversamente prima di poterla vedere nel quadro evolutivo più ampio che una scienza dello spirituale presenta.
Non pochi lettori di Steiner deplorano il fatto che, pur avendo lui detto e scritto su tutto e su tutti, non si sia pronunciato sulla sessualità – un argomento che per molti è uno dei più importanti. Ma non è vero che Steiner, da uomo arcimoderno qual è, non abbia mai detto la sua in merito: basta, e avanza, leggere anche solo la conferenza che tenne il 22 luglio 1923, la terza di una triade intitolata Tre prospettive dell’antroposofia (nel volume 225 dell’O.O.), e che è stata pubblicata anche in italiano dall’Editrice Antroposofica sotto lo stesso titolo.
C’è una cosa fondamentale sulla quale vorrei intendermi chiaramente col lettore: benché io ritenga corrispondente al vero quello che scrivo, il mio scopo principale non è mai quello di esprimere delle verità assolute – che non esistono –, ma quello di stimolare nel lettore il suo pensiero, quello di provocarlo a non restare passivo, ma a prender posizione attivando la propria facoltà pensante. A quali conclusioni lui giunga nel creare i suoi pensieri, sono affari suoi: a me interessa aver contribuito a che diventi sempre più agile nell’arte del pensare, perché sono convinto che questo lo condurrà sempre più avanti nella sua ricerca della verità. Il lettore che io più mi auguro non è allora né quello che è d’accordo con me né quello che dissente, ma il lettore che, stimolato dai miei pensieri, ne sa pensare mille altri che vanno oltre.
Possano queste pagine essere in qualche modo utili a tutti coloro che portano in sé la convinzione che l’amore sia ciò che più manca nel mondo d’oggi, che sia la realtà per tutti più urgente da riconquistare, e di conseguenza l’oggetto di un desiderio quanto mai intenso e profondo, anche se inconfessato.
Pietro Archiati
1. AMORE E ODIO:
il sale e il pepe della vita
Il campo da gioco della simpatia e dell’antipatia
Amore e odio sono le due forze che dall’interiorità di ogni essere umano danno il via a tutto ciò che avviene nel mondo. Ovunque ci siano degli uomini abbiamo a che fare con l’amore e con l’odio.
Usando due parole meno forti, potremmo dire che viviamo l’amore ogni volta che sentiamo simpatia, cioè attrattiva verso qualcosa o verso qualcuno, e viviamo l’odio quando proviamo antipatia, cioè avversione nei loro confronti. Simpatia e antipatia sono i due sentimenti che ci portano a fare quasi tutto quel che facciamo. La natura umana si presenta proprio come una coppa ricolma di simpatie e di antipatie, di cose che piacciono e perciò vengono desiderate, e di altre che non ci vanno giù e che vogliamo evitare.
La simpatia (l’amore) e l’antipatia (l’odio) sono davvero come il sale e il pepe della vita, sono il campo da gioco sul quale si susseguono tutti gli eventi dell’esistenza e sul quale si svolge la nostra evoluzione interiore. Vale la pena, allora, approfondire questo fenomeno, cercar di capire più a fondo la dinamica di queste due reazioni fondamentali con le quali ogni momento rispondiamo alla realtà circostante e agli avvenimenti della vita. È quasi impossibile, infatti, avere un animo del tutto neutro, insensibile al piacevole e allo sgradevole: se così fosse, smetteremmo di essere uomini.
Sarebbe un travisare la natura di queste due forze voler subito stabilire se sono buone o cattive, se sono un bene o un male. Buone o cattive non possono essere le simpatie e le antipatie che nascono in noi, ma solo le azioni che compiamo spinti da esse. È nella nostra natura di uomini essere attraversati da un fascio di simpatie e di antipatie, d’inclinazioni e d’incompatibilità, che naturalmente variano da persona a persona. La somma delle attrattive e delle repulse di una persona è del tutto diversa da quella di un’altra.
Consideriamo due esempi significativi: da una parte l’innamoramento e dall’altra una viscerale avversione. L’innamoramento è un’esperienza fra le più intense, che ci afferra e travolge senza che possiamo farci nulla, spingendoci a cercare la vicinanza dell’altro. Invece una forte antipatia è quella pulsione altrettanto irresistibile che ci porta a detestare una persona, a volerla evitare a tutti i costi.
Odiare o amare con tutto il nostro essere è un’esperienza che non capita molto spesso. Perciò possiamo orientarci meglio partendo dalle nostre dosi quotidiane, più modeste, di simpatia e di antipatia, che raggiungono l’intensità maggiore nell’innamoramento, e nell’avversione.
L’amore è davvero l’opposto dell’odio?
È proprio vero che l’odio sia l’opposto dell’amore, come comunemente si pensa? L’odio e l’amore sono davvero due realtà contrarie, che si escludono a vicenda quali il coraggio e la viltà, l’allegria e la tristezza, il buio e la luce? Se lo fossero, dovremmo constatare che in ognuno di noi più c’è amore e meno c’è odio, e più c’è odio meno c’è amore... E invece non è così.
Il mondo è pieno di persone che dichiarano di amare moltissimo qualcuno e di odiare non meno qualcun altro. Tanto Otello era innamorato di Desdemona quanto odiava Jago – per fare un solo esempio. E, più semplicemente, nella vita di ogni giorno sperimentiamo che la simpatia che sentiamo verso qualcuno non comporta lo scemare dell’antipatia che rivolgiamo a qualcun altro. Se siamo allegri, invece, vediamo tutto roseo, e se siamo tristi il mondo intero diventa grigio. L’allegria caccia via la tristezza, e viceversa. Invece l’amore non esclude l’odio e l’odio non esclude l’amore.
E allora? Allora se è vero che gli estremi si escludono a vicenda ma che ciò non avviene per l’amore e per l’odio, non sarà che l’amore non è un estremo e perciò non ha opposti? Non sarà che nulla è per natura il contrario dell’amore, che nulla può causarne automaticamente la diminuzione?
È proprio così: niente può opporsi all’amore, perché l’amore è quella forza che ci fa muovere in mezzo a tutti gli opposti della vita. È la tensione interiore che ci rende insopportabile ogni posizione estrema facendoci tendere verso il suo riequilibramento. Ogni estremo è una forma di unilateralità, una specie di carenza che prima o poi ci porta a volere – ad amare! – anche l’altro lato. L’amore è quella sete di crescita che ci fa cercare la pienezza rendendoci antipatica ogni lacuna. Quando ci troviamo in una posizione unilaterale – e gli opposti della vita non sono altro che posizioni unilaterali –, l’amore fa nascere in noi il desiderio di andare verso l’altro lato, verso quel che ci manca. In altre parole, l’amore ci mantiene interiormente in movimento tra le forze che si oppongono fra di loro, e per questo non può essere a sua volta l’opposto di qualcos’altro.
Prendiamo ad esempio il maschile e il femminile: sono di sicuro due poli opposti. Quando si diventa troppo unilaterali dal lato del maschile, l’amore ci fa desiderare il femminile. Desiderare: è proprio questo il significato della parola originaria che i greci hanno coniato per indicare l’amore: «eros». Eros significava il desiderio, l’anelito verso qualcosa o qualcuno, a tutti i livelli dell’essere. Verso qualcosa che fa già parte di me perché lo penso e lo amo, e che non fa ancora parte di me perché devo diventarlo.
Supponiamo che una persona si sia messa in testa che tutti i problemi della vita si risolvano con la bontà, la remissività e la dolcezza, e che di conseguenza si ritrovi sempre un passo indietro agli altri. Prima o poi si renderà conto che questa posizione estrema fa male a lei e agli altri, e sentirà il desiderio di mostrare anche un po’ di grinta – non diciamo subito i denti –, una maggiore determinatezza nell’affrontare le situazioni, altrimenti nel suo contesto sociale avrà sempre meno voce in capitolo. Se invece un altro è unilaterale dal lato delle certezze baldanzose, se fa lo spavaldo e come conseguenza comincia a ricevere botte di ritorno, nascerà in lui la voglia di muoversi verso l’altra parte per diventare più remissivo e moderato. Questo desiderio del giusto equilibrio tra accondiscendenza e risolutezza non è altro che amore.
La forza dell’amore è quella vivace mobilità interiore che ci porta a integrare tutti gli opposti, nello sforzo di superare ogni parzialità. È l’aspirazione verso l’armonia del nostro essere, verso l’equilibrio di tutte le nostre forze, e questo ci consente di dare il meglio di noi stessi e di essere contenti.
A questo punto si può obiettare: se davvero non c’è nulla che possa opporsi all’amore, allora ogni uomo non può far altro che amare, e tutto deve andare per il meglio! Ma non è così, lo sappiamo bene: dov’è mai tutta questa sovrabbondanza dell’amore nel nostro mondo?
In realtà esiste una controforza dell’amore, ed è la sua assenza – possiamo anche dire: la sua omissione. L’opposto dell’amore non è qualcosa: è la sua mancanza. L’amore è l’essere vero dell’uomo e il suo opposto è la carenza dell’umano. L’amore non ha allora contro di sé «qualcosa»: contro l’amore non può esserci che l’amore omesso – e questo non è altro che il concetto di «peccato di omissione». Nel momento in cui i peccati sono di «commissione», nel senso che noi compiamo un’azione o dal lato della simpatia o dal lato dell’antipatia, ci tocca fare i conti col mondo, restiamo nel campo dell’amore, cioè della tensione interiore.
Quel che uccide l’amore è in altre parole la povertà dell’anima, la mancanza di desideri, la stasi interiore. In una parola: l’indifferenza. La lingua italiana ha un vocabolo molto significativo per indicare l’opposto dell’amore: il «disamore» – che dice chiaramente: qui manca l’amore. Il disamore è l’assenza di ogni affetto, di ogni interessamento agli altri. L’opposto dell’amore è allora il vuoto d’amore, ed è ben più difficile colmare questo vuoto che non vincere una qualsiasi forma di odio. Finché sento odio resto nell’umano più di quanto non accada quando in me c’è l’indifferenza nei confronti di tutto e di tutti.
La grande miseria del materialismo moderno è proprio il disamore, una vistosa carenza delle forze di tensione interiore. Se facciamo qualcosa di storto danneggiamo meno la nostra evoluzione di quando abbiamo il vuoto dentro di noi, di quando non siamo mossi né dalla simpatia né dall’antipatia. Affrontare l’indifferenza è un compito arduo per la coscienza: come si fa a vincerla, come si fa a farla sparire?
Non è possibile amare un po’
L’amore è una forza che può solo o esserci o mancare, che non è passibile di aumento. L’amore non è come il potere, o come la conoscenza, che possono incrementarsi diventando sempre più intensi. L’amore non conosce aumento: rispetto a ogni oggetto da amare o c’è tutto o manca del tutto.
Qualcuno dirà: ma non è vero, si può amare di più o di meno! L’amore può crescere e diminuire, eccome!... Invece io insisto che si possono, sì, moltiplicare gli oggetti dell’amore, nel senso che possiamo amare di volta in volta qualcosa o qualcuno che prima non amavamo: ma in riferimento a ogni singolo essere da amare, l’amore o c’è o non c’è.
In altre parole, non si può amare qualcosa o qualcuno solo un po’: o lo si ama o non lo si ama. Ciò che rende misterioso l’amore è che non si diventa più capaci d’amore in quanto l’amore stesso aumenta in intensità, ma per il fatto che esso si estende a un numero di esseri sempre maggiore. Ma l’amore in sé e per sé non è mai di più o di meno.
Prendiamo due fidanzati: per un certo tempo fra di loro c’è la percezione chiara di volersi bene, di amarsi. Poi arriva un momento in cui, poniamo, la ragazza dice al ragazzo: tu non mi ami più. Non le viene spontaneo dire «mi ami un po’ di meno» o «molto di meno»; dice «non mi ami più». Perché? Corrisponde ai fatti quest’assolutezza, questo «o mi ami o non mi ami», come si faceva una volta sfogliando la margherita?
Il cuore dice che è così. Chiede: mi vuoi bene o no? Non dice: fammi sapere se mi ami al dieci per cento, o al venti o al sessanta, così vedo se mi posso accontentare. Questo ragionamento il cuore non lo fa. L’amore è in altre parole indivisibile, e ciò rende ancora più difficile approfondirne l’enigma, perché non si può giocare sulla comoda falsariga della «quantità» che può aumentare o diminuire secondo infinite gradazioni.
Crescere nell’amore significa allora aprire il proprio cuore a sempre nuovi esseri, fino ad abbracciarli e amarli tutti – e questa è anche la differenza fondamentale fra innamoramento e amore. Nell’innamoramento concentriamo il nostro desiderio verso una sola persona – «per me esisti solo tu», si dice – mentre il vero amore tende per natura a interessarsi a tutti gli esseri, senza esclusioni. L’amore è la facoltà – Aristotele e Tommaso d’Aquino direbbero: la potenzialità – insita nel cuore di ogni persona di aprirsi gradualmente a tutto e a tutti.
Questa capacità è presente tutta intera in ognuno di noi. Nessuno è più o meno capace di amore: tutti lo siamo all’infinito perché siamo tutti in grado di amare tutti gli esseri che esistono. Dandoci la forza dell’amore, Dio – o chi per lui abbia creato l’uomo – non ha fatto preferenze nel suo amore per noi, non ha favorito qualcuno più di qualcun altro; ci ha reso tutti ugualmente capaci di un amore senza confini, che non esclude nessuno.
Gli esseri a cui io non m’interesso sono allora quelli verso cui non ho ancora esteso il mio amore. Ma la facoltà di amare ce l’ho anch’io tutta. A nessun uomo manca neanche un frammento della tensione ad amare, perché ognuno è stato creato a immagine di quell’Essere che ama tutto l’universo, tutte le sue creature. L’amore è allora una facoltà che va esercitata, che va attivata in tutte le situazioni, così come fa chiunque sappia suonare uno strumento musicale, o scalare montagne, o cucire abiti, o cucinare cibi prelibati.
Se l’animo di ogni uomo è fatto in modo da poter amare tutto il creato, l’indifferenza di una persona è la somma dell’amore in lei ancora mancante oppure omesso: l’indifferenza che ho in me è tanta quanto l’amore che non ho dato. Avrei potuto interessarmi a questo e a quello, avrei potuto amare quella e quell’altra persona, ma non l’ho fatto: così ho generato in me l’indifferenza nei loro confronti. Il vuoto d’amore è proporzionale a quanto ho tralasciato di amare, là dove mi era possibile. Nessuno può avere più indifferenza di quanta ne abbia suscitata lui stesso in sé trascurando l’amore.
In altre parole, nessuno di noi può lamentarsi con gli altri per l’indifferenza o il vuoto d’amore che sente dentro di sé. Ognuno è artefice sia di tutti gli amori che nutre, sia di tutti i disamori con cui impoverisce il suo cuore. E se l’amore è la capacità che ho d’interessarmi a tutto e a tutti, se il disamore è ciò che mi svuota, allora devo dirmi che l’amore dipende in tutto e per tutto dalla libertà. Non è affatto questione di puro sentimento, com’è per l’innamoramento, ma riguarda la libera volontà di ognuno.
Se noi, capaci come siamo di amare il mondo e tutta la gente che ci vive, fossimo costretti a farlo, se l’amore sorgesse in noi grazie a un puro istinto di natura e non potessimo far altro che assecondarlo amando per forza, vivremmo un amore di cui non è possibile fare a meno, che non si può omettere. Ma a queste condizioni non sarebbe affatto un amore umano. Tutti avvertiamo che il mistero dell’amore è inscindibile da quello della libertà. Soltanto dove c’è libertà può esserci amore. Solo l’amore che io do liberamente, in quanto potrei anche non darlo, è vero amore.
In questa prospettiva c’è da chiedersi se gli animali, in particolare tutti i gattini e i cagnolini che vivono con noi, che ci fanno le feste e a volte ci difendono, siano anch’essi capaci di odio e di amore. Quando si pone questa domanda c’è sempre chi si affretta a rispondere: gli animali degli altri non so se siano capaci di amore, ma il mio di sicuro sì! Però, se l’amore, come lo intendiamo e viviamo noi uomini, è inscindibile dalla libertà e se la libertà non può che fondarsi sulle forze del pensare che illuminano le decisioni e le scelte, forse dobbiamo rivedere certi preconcetti, certi luoghi comuni che ci fanno interpretare alcune reazioni puramente istintive degli animali come fossero espressione di un libero amore. E se volessimo chiamare «amore» il comportamento istintivo dell’animale, dovremmo usare una parola diversa per l’amore umano, che è di tutt’altra natura rispetto all’«amore» che attribuiamo agli animali.
Tre modi umani di amare
L’amore umano si esprime in tre campi diversi, che corrispondono alle tre realtà che costituiscono l’uomo: quella del corpo, quella dell’anima e quella dello spirito. Corpo, anima e spirito sono oggi per molti parole vuote che attendono di venir nuovamente riempite di significato. Nel passato tanti sapevano a che cosa concretamente si riferissero; oggi dobbiamo riconquistarcene la realtà, ognuno riflettendo più a fondo sulla propria esperienza di vita.
Se torniamo indietro alle origini della cultura occidentale e cristiana, cioè alla cultura greca classica che ne ha posto i fondamenti filosofici e artistici, vediamo che la lingua greca sapeva esprimere la realtà dell’uomo e dell’amore in modo più diversificato di quanto siamo in grado di fare noi oggi. Noi, che non solo non sappiamo più distinguere tra anima e spirito, ma neanche tra corpo e anima, perché secondo molti tutto ciò che è di natura psichica non è che puro effetto di processi corporei.
I greci avevano tre parole diverse per indicare le varie dimensioni dell’amore: chiamavano eros l’amore corporeo nel quale domina l’istinto; filìa l’amore dell’anima, intessuto di sentimenti, di emozioni, di simpatia; poi, soprattutto in seguito al sorgere del Cristianesimo, è comparsa una terza parola, agàpe, per indicare la natura spirituale dell’amore, quella che si origina nelle scelte libere di ogni uomo. Già il cosiddetto «amore platonico» puntava decisamente in questa direzione.
Si tratta di tre sfere del tutto diverse l’una dall’altra: ognuna ha una bellezza e una bontà sua propria, perché l’amore esprime la pienezza della vita e può essere vissuto positivamente in tutte le sue manifestazioni. Anche qui si tratta di vedere come il male dell’amore consista sempre in una qualche sua carenza, mai nella sua presenza.
La bellezza dell’eros, dell’amore fondato sulle forze del corpo, nasce dalla bontà insita in tutto ciò che è naturale. Quello che la natura fa è tutto buono e bello perché si compie secondo pensieri impressi in lei da Esseri divini pieni di sapienza e di amore. L’eros non riguarda solo l’ambito sessuale: c’è eros anche nell’istinto della nutrizione, per esempio, che è amore al proprio corpo in quanto ha bisogno di sostentamento. Ma proprio perché l’uomo vuol essere libero in tutto il suo essere, la libertà nei confronti dell’eros si esprime nella duplice possibilità di scelta: possiamo viverlo in modo tale che ostacoli l’amore dell’anima e dello spirito – rendendoci carenti proprio nella parte più preziosa di noi – ma possiamo viverlo anche in modo che favorisca la pienezza dell’amore in tutte le sfere del nostro essere.
Il modo in cui l’uomo si avvale di ciò che è natura in lui è giovevole se lo fa progredire nella sua anima e nel suo spirito, ed è dannoso se lo fa retrocedere nel suo cammino. Se il rapporto con la natura fosse di necessità positivo, l’uomo non sarebbe libero; per esserlo, deve avere la possibilità di confrontarsi con essa sia in modo positivo che negativo. Positivo o negativo non è dunque il dato di natura in sé – l’eros, in questo caso –, ma il suo favorire o precludere l’amore animico e quello spirituale.
Le forze della filìa sono per eccellenza quelle dell’amicizia: non si fondano sull’istinto di natura ma sull’inclinazione dell’animo, sulla sintonia interiore, sulla contentezza del sentirsi fatti l’uno per l’altro e di capirsi al volo. Filìa sono anche i nostri hobby, tutto quello che ci piace fare per una spontanea disposizione interiore.
L’amore spirituale infine, l’agàpe, è bello perché si esprime sempre nella volontà libera, nella decisione autonoma e individuale di ognuno. Questa terza corda della lira dell’amore non poggia sull’istinto e neanche ha bisogno del venticello favorevole della simpatia, ma vive della forza stessa della volontà, esiste solo per decisione libera dello spirito che comprende e vuole il bene di ogni persona che ama.
Un esempio d’amore puramente spirituale, dove non sono determinanti né la forza dell’istinto né quella dell’allettamento, è il cammino della conoscenza. Qualcuno potrebbe obiettare: beh, però a tanti piace studiare e capire cose sempre nuove! Dunque siamo sempre nel campo della filìa, del piacere dell’anima, non dell’agàpe puramente spirituale.
Prendiamo allora l’esempio di una persona che abbia un posto di lavoro cosiddetto fisso: il famoso posto statale che ti garantisce a vita uno stipendio sicuro, con tutti gli «scatti di anzianità» che prescindono dalla qualità della tua prestazione professionale. Se questa persona mette a disposizione il massimo delle sue capacità, della sua attenzione e del suo ingegno ben oltre il puro dovere e nonostante nessuno la ringrazi e, anzi, qualcuno se ne infastidisca pure, questo è amore spirituale, in quanto del tutto libero e gratuito. È quell’amore di fronte al quale si leva spesso una domanda: ma chi te lo fa fare? E la risposta è sempre la stessa: io! Nessuno me lo impone, e proprio per questo sono io stesso a volerlo, in tutta libertà.
L’amore corporeo è in misura minima libero, perché è di natura e non può non esserci. L’amore spirituale è massimamente libero perché può venire omesso, cioè può anche non esserci. L’amore dell’anima oscilla tra l’uno e l’altro.
C’è amore e amore
L’amore è un fatto di evoluzione interiore. Non si può parlare dell’amore in assoluto, in astratto, senza tener conto dei gradini evolutivi sia dell’umanità intera sia del singolo – dalla sua nascita alla sua morte. Capiamo il mistero dell’amore nella misura in cui riusciamo a interpretarlo in chiave di continua crescita, proprio perché è la tensione evolutiva insita in ogni essere umano.
In altre parole, bisogna considerare l’evoluzione delle forze dell’amore, approfondirne la metamorfosi nel corso del lungo cammino umano. Bisogna chiedersi: come hanno amato gli antichi greci, i romani, i persiani, gli egiziani...? Come hanno amato gli uomini da induisti, da buddisti, da shintoisti e così via? Che tipo d’amore tende a vivere l’umanità di oggi che si trova in condizioni evolutive del tutto nuove rispetto alle epoche passate? Quali sono le nuove conquiste dell’amore che il nostro tempo rende possibili per la prima volta?
C’è amore e amore nell’evoluzione: le forze dell’amore si esprimono in tutt’altro modo in un bambino di quattro anni rispetto a quelle che sentono una ragazza o un ragazzo quattordicenni, all’affacciarsi della pubertà, e tutt’altra ancora è la qualità dell’amore che si può vivere a venti, quaranta, sessanta, ottant’anni. Cadremmo in vuote astrazioni se parlassimo dell’amore senza diversificarlo lungo il cammino evolutivo dell’uomo, anche se per la sua vastità può sembrare arduo riuscire a coglierlo di volta in volta nella sua concretezza specifica.
Non va sottovalutato il fatto che noi abbiamo sotto i nostri occhi, sempre e ovunque, una ripetizione in piccolo di tutta l’evoluzione già trascorsa: nella vita di ogni uomo. L’embriologia, che va dal concepimento alla nascita, è una sintesi dei primordi dell’evoluzione; l’infanzia, la pubertà, la giovinezza e l’età adulta ripetono in modo concentrato tutte le tappe millenarie della vicenda dell’uomo e del suo amore, fino ad oggi.
Osservando la biografia umana, abbiamo l’occasione di farci dei concetti sempre più concreti su tutti gli aspetti dell’evoluzione, e dunque anche sulle metamorfosi delle forze d’amore. Se è l’amore a farci compiere tutto quello che facciamo, non può essere una realtà statica, ma sempre in divenire, anche se le leggi di questo divenire sono ben precise. L’evoluzione dell’uomo è in una parola una cosa sola con l’evoluzione dell’amore umano.
Il Simposio (o Convito) di Platone, è un dialogo che si svolge in sette discorsi sull’eros, in sette elogi dell’amore. È uno dei testi più belli dati all’umanità, e vale la pena rituffarcisi dentro a tutti gli stadi della vita: vi si possono scoprire cose sempre nuove. La parola eros viene usata nel Simposio a indicare tutta la gamma dell’amore: abbraccia l’eros del corpo, dell’anima e dello spirito, cioè tutta la profondità e la vastità della tensione interiore di ogni uomo.
Il discorso di Socrate è il sesto, mentre il settimo, quello culminante, viene riservato ad Alcibiade. In questi sette discorsi si esprime in modo sublime il dinamismo evolutivo dell’amore, che procede salendo sette gradini, e ci aspetteremmo perciò che l’ultima parola venga concessa a Socrate. Invece la sua è la penultima, e dice: tutti quelli che hanno parlato prima di me hanno intessuto un elogio dell’amore senza preoccuparsi del fatto che quel che dicevano fosse vero o no. Hanno detto che l’amore è il più antico fra tutti gli dèi, che è bellezza, armonia, desiderio, che è artefice di tanti beni..., ma io, povero Socrate, se il capotavola di questo bel simposio me lo concede, vorrei dire sull’amore la pura e semplice verità.
E così il discorso di Socrate s’incentra sulla verità riguardo all’amore, non su una qualche lode sperticata che gli gira intorno senza coglierne il nocciolo. Socrate vuole aiutare i suoi ascoltatori a conoscerlo nella sua realtà oggettiva, l’amore. E allora ci può essere mai qualcosa di ancora più eccelso di quel che Socrate ha da dire sull’amore, se lui più di tutti è in grado di esprimere la verità più profonda sul mistero dell’amore? Sì, c’è.
Ecco comparire sulla soglia Alcibiade, un giovane discepolo di Socrate, ubriaco per giunta, che viene invitato fra i commensali e che non fa un discorso sull’amore, ma parla del suo Maestro, di come lui stesso si è sentito amato da Socrate. Parla cioè del modo in cui Socrate ama. Va detto che per i greci l’amore tra maschi non era del tipo spesso poverello che conosciamo oggi, ma si riferiva – e lo si capisce chiaramente da ciò che Alcibiade racconta parlando di Socrate – alla capacità pensante autonoma che a quei tempi preponderava nell’elemento maschile. Anche qui tocchiamo con mano il procedere evolutivo dell’umanità: oggi possiamo ben constatare che l’attività del pensiero è ugualmente accessibile sia alle donne che agli uomini.
Abbiamo allora nel sesto discorso del Simposio platonico la verità sull’amore (il discorso di Socrate) e nel settimo la realtà dell’amore (la testimonianza di Alcibiade sull’amore di Socrate). Perché un conto è avere le idee giuste sull’amore, cioè dire la verità sull’amore, un altro è rendere reale l’amore nel proprio essere e nel proprio modo di vivere.
Ma veniamo al contenuto del discorso di Socrate, che sa dire la verità sull’amore proprio perché l’ha reso reale nella sua vita. Parla dapprima delle cose più semplici in fatto di amore, ma quando arriva al punto di doverne penetrare gli aspetti più profondi e più veri, dice: vi riferisco ora ciò che sui misteri dell’amore mi ha detto la divina Diotima. Il nome Diotima significa «colei che ha venerazione per la Divinità», colei che attinge i suoi pensieri alla sorgente divina dell’amore umano.
E Diotima ha confidato a Socrate: l’amore è fatto così che s’innamora a tutta prima di ciò che si vede e si tocca, per esempio del corpo di una persona. È nel dinamismo proprio dell’amore che si cominci da ciò che è corporeo e che si ami, come un tutt’uno, il bello e il buono di quell’essere (το καλον καγαθον, to kalòn kagathòn). Per i greci di allora il bello non poteva essere bello senza essere anche buono, e il buono non poteva essere buono senza essere bello. S’inizia con l’innamorarsi di qualcosa di così reale da poterlo toccare, dice Diotima, ma poi ci si rende conto che non è la realtà materiale del corpo a essere bella e amabile, ma la sua forma immateriale, nonché l’anima che lo abita.
In realtà, la nostra anima è innamorata della bellezza delle cose, ma la bellezza non è fatta di materia. La bellezza si svela e si vela in ogni cosa che vediamo, si rivela nascondendosi e si nasconde rivelandosi. Ed è proprio questo gioco al nascondino che piace da morire. L’uomo ama gli esseri perché li vede belli, ma la bellezza è più nei suoi occhi innamorati che nelle cose che gli stanno davanti. Le ama perché le sente partecipi della bellezza che lui stesso porta dentro di sé.
L’essere umano, prosegue Diotima col suo discepolo Socrate, in questa tensione interiore s’innamora prima o poi del bello e del buono in quanto tali, nella loro perfezione, così come sono ancor prima di manifestarsi imperfettamente qua e là, in questo o in quel corpo. L’uomo arriva così a poco a poco a immergersi nella realtà vera, eterna e tutta spirituale delle cose, partecipando alle forze invisibili che plasmano tutto ciò che è bello e buono. Queste forze, che Platone chiama idee, non sono «qualcosa», sono sempre «qualcuno»: sono gli Esseri che da sempre creano il mondo trasformando il caos – la bruttezza di ciò che è ancora «caotico» – in un cosmo, cioè in un mondo tutto bello. Kosmèin (da qui la nostra «cosmetica») significa in greco «ordinare», «far bello». Per i greci, la creazione è stata una meravigliosa cosmesi, la più bella di tutte quelle venute dopo: ha fatto nascere questo bellissimo «cosmo» in cui viviamo.
L’uomo è un artista che vive dapprima il bello in quanto visibile e il buono in quanto tangibile. È la creatura che rifà a ritroso il cammino degli Esseri creatori, i quali hanno espresso da artisti sommi il bello e il buono della loro mente e del loro cuore creando tutte le cose del mondo.
«Fare l’amore»
C’è un fraintendimento ricorrente sull’amore e sta nel fatto che in italiano, come pure in altre lingue, si chiami «amore» sia l’istinto di natura – «fare l’amore» –, sia l’espressione somma della libertà – cioè «amare». È un equivoco che gioca brutti scherzi e il cui senso è proprio quello di venire individuato e risolto.
L’inganno che sta qui alla base consiste nel fatto che non sempre si distingue tra amore e amore, arrivando così ad equiparare l’amore di natura con quello che ognuno si conquista con la sua libertà. Nel «fare l’amore» sono le forze della natura in noi ad assumere un ruolo di guida; viceversa, quando si tratta di amare un’altra persona mettendo in secondo piano i nostri interessi, l’istinto di natura non ci soccorre più, e dobbiamo agire in base alla conoscenza dell’altro e alla libera scelta della nostra volontà.
In un certo senso, oggi l’umanità si trova a una grande svolta evolutiva, che possiamo chiamare la svolta dell’amore. È quella «conversione» – intesa come cambiamento di direzione – di cui il Cristianesimo parla da ben duemila anni. Ne parla, ma in fatto di amore più che mai tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare!
Colui che gli ebrei chiamavano il Messia e i cristiani chiamano il Cristo – e che sta a indicare anche la parte migliore in ogni uomo – immette nell’umanità le forze che consentono a ognuno una conversione interiore, una vera e propria rivoluzione riguardo al modo di vivere l’amore. Prima di quell’evento storico, che in questo contesto possiamo chiamare «l’evento dell’amore pienamente libero e individuale», l’amore veniva vissuto dall’uomo come un dono di natura. A partire da quel grande atto storico d’amore, ogni uomo è in grado di trasformare sempre più il suo amore in pura libertà.
L’uomo che vive «dopo Cristo» è chiamato a tramutare l’amore che dà la natura – divinamente bello, ma senza la bontà suprema che è la libertà – in un amore che sia l’opera d’arte della sua libertà. Questa trasformazione interiore è una lunga e diuturna «conversione» che rappresenta una vera e propria inversione di marcia nel cammino di ogni uomo verso l’umano.
In difesa del primo amore
La purezza dell’amore che dà la natura si evidenzia nel modo in cui ognuno ama se stesso. Uno dei danni più gravi causati dal moralismo, quello cattolico in particolare, sta nell’aver spesso e volentieri presentato l’amore di sé come qualcosa di non buono. Invece, come dono di natura, non può essere né buono né cattivo, perché buono o cattivo è solo ciò che l’essere umano compie liberamente. L’amore di sé è necessario, cioè indispensabile, perché senza di esso non è possibile il libero amore per il prossimo. Infatti, l’amore di sé è quello che dà a ognuno la possibilità di essere qualcuno. Se io non sono nulla, se non ho creato nulla in me e per me, non sono neanche in grado di offrire amore agli altri.
Il male morale non è allora nell’amore di sé, ma nell’assenza dell’amore per gli altri. Questo «secondo amore» può anche non esserci proprio perché non viene regalato dalla natura. È libero: c’è in me nella misura in cui io rinnovo ogni giorno la mia libera decisione di amare gli altri. L’amore per me stesso, invece, me lo ritrovo dentro per inclinazione naturale, nessuno può fare a meno di questo «primo amore», e coloro che pensano di non amare se stessi s’ingannano.
Perfino il suicida si ama, e si ama fino al parossismo: il suicidio è un atto estremo di amore di sé, perché chi lo compie si ripromette di trarne un vantaggio assoluto, altrimenti neanche riuscirebbe a uccidersi. L’unico motivo veramente efficace per riuscire a togliersi la vita è vedere in questa decisione qualcosa che cambi in positivo la propria situazione. È meglio morire, dice il suicida.
Se per poter amare bisogna prima essere, allora ciò che noi chiamiamo odio non è che una forma d’espressione dell’amore di sé. È la forza che ci consente di non farci incamerare da altri, è una forma radicale di attaccamento a se stessi. Ognuno di noi odia ciò che in qualche modo minaccia il suo essere.
Una persona che non avesse alcuna capacità di respingere le indovute ingerenze altrui, che si lasciasse infatuare da altri e trascinare dall’altrui volontà, finirebbe per annullarsi e non sarebbe più in grado di amare a sua volta gli altri. Ciò che noi chiamiamo odio, nella sua espressione più naturale, è esso pure né buono né cattivo, fa parte dell’amore verso di sé, è la forza che ci fa respingere ogni gestione dal di fuori.
Visto così, l’odio non può essere l’opposto dell’amore. È quel sano e indispensabile amore di sé che ci fa respingere tutti i tentativi di chi dal di fuori vorrebbe manipolarci o cancellarci. Ovunque ci sono istanze a noi esterne che tendono a schiacciarci, a far di noi dei puri strumenti per i loro scopi. L’odio naturale è la forza primigenia dell’individuo che gli consente di difendere la propria autonomia.
Questa forza è necessaria alla vita, è non meno importante di quella che ci fa dedicare agli altri. Proprio in questo senso amore e odio non possono essere due forze opposte che si escludono a vicenda. L’odio è la forma più radicale dell’amore di sé quale necessario fondamento dell’amore verso l’altro. Soltanto nella misura in cui sanamente «odio», sono cioè in grado di respingere chi minaccia la mia autonomia, avrò anche la forza di scegliere liberamente quello che faccio, senza costrizioni, senza manipolazioni. Solo così potrò amare liberamente anche gli altri.
L’evoluzione dell’odio
L’amore di sé, la tendenza naturale a favorire la propria esistenza singola, si perfeziona nella misura in cui non si limita a ciò che la natura gli dà, ma liberamente si apre all’altro per riconoscere e promuovere anche la sua bellezza, la sua bontà e verità come individuo a sua volta autonomo.
La «conversione» dall’egoismo che ama solo se stesso a quell’amore che ama tutti vince l’illusione che all’amore possa bastare il solo occuparsi di sé. La vera salute, la completezza del proprio essere, si vive nel ricongiungersi agli altri, nell’offrire all’umanità intera il valore incommensurabile della propria libertà e della propria autonomia conquistate, e nel ricevere in contraccambio dagli altri tutti quei doni che sono necessari alla nostra esistenza.
Nello stesso modo l’odio, in quanto difesa della propria singolarità, ha una sua evoluzione da compiere. Ognuno deve imparare a odiare tutto ciò che va contro l’umano, non solo riguardo a sé, ma anche riguardo agli altri. Anche il disumano si esprime, non meno che l’umano, in tre modi fondamentali: c’è il disumano dello spirito, c’è il disumano dell’anima, e il disumano del corpo. E così ci sono tre forme fondamentali di odio.
Ogni uomo odia, in quanto spirito pensante, l’errore e la menzogna, che sono il disumano in fatto di ricerca della verità. Ciascuno di noi sanamente odia, anzi aborrisce al di sopra di tutto la menzogna, perché essa traendolo in inganno gli nega quella verità che appassionatamente cerca.
Nella misura in cui io ometto l’amore alla verità, divento povero nel mio spirito. Ogni errore è una parzialità del pensiero, è un pensiero deficitario. Più vuoti ho nel mio pensare, meno so pensare con la mia testa, e più sono esposto alla menzogna e all’inganno altrui. Ogni uomo odia spontaneamente l’inganno perché, pur a modo suo, cerca sempre la verità e l’inganno gliela nega.
La seconda realtà che ognuno di noi odia è l’egoismo altrui in quanto impedisce all’altro di aprirsi nei nostri confronti. L’egoismo ci porta a strumentalizzarci a vicenda e il nostro odio si scaglia a tutta prima contro l’egoismo degli altri. Solo un po’ alla volta si può vivere la «conversione» interiore che trasforma l’odio verso l’egoismo altrui in odio verso l’egoismo proprio – ed è questo l’inizio dell’amore verso il prossimo.
L’uomo odia, e deve odiare, ogni modo di agire che si serve degli altri come strumenti per i propri scopi. Ognuno di noi odia questa offesa profonda all’anima umana, e prova un forte sdegno quando vede che un uomo sfrutta un altro uomo. Ognuno sente dentro di sé che siamo fatti per favorirci l’un l’altro.
Il terzo tipo fondamentale di odio, che investe direttamente la sfera fisico-corporea, fa sì che ogni essere umano debba opporsi con tutto se stesso a ciò che minaccia la salute del suo corpo: e cioè la malattia e la morte. La natura dà all’uomo un sano odio verso quel che mina la sua costituzione fisica, che è la base della sua esistenza.
L’uomo odia la malattia e la morte perché ama la salute del suo corpo: questo è il suo primo amore. Egli odia ogni forma di gretto egoismo perché la sua anima ama sopra ogni cosa l’amore: questo è il suo secondo grande amore. E ognuno di noi odia l’errore e la menzogna perché il suo spirito ama tenacemente la verità e tende alla veracità: terzo grande amore dell’uomo.
Amando la verità l’uomo ama lo spirito in sé e negli altri; amando l’amore ama la bellezza della sua e dell’altrui anima; amando la salute fisica ama il suo corpo non meno di quello di tutti i suoi simili. L’odio al triplice male umano non è che un triplice amore verso tutto ciò che è buono per l’uomo. Queste tre forme dell’odio sono presenti in noi per natura, ma l’uomo è chiamato a trasformare sempre più l’odio naturale che ha verso tutto ciò che è male in un libero amore verso tutto ciò che è bene.
Più l’uomo diventa libero e più può redimere anche l’odio – perché ne ha sempre meno bisogno. Capisce sempre meglio che quel che odia fuori di sé è come un richiamo a qualcosa che va odiato, cioè purificato e vinto, dentro di sé. Capisce che ognuno può odiare negli altri soltanto quel che non ha ancora risolto in se stesso.
Ogni forma di odio che sorge in me è allora un compito evolutivo tutto mio. Quando odio la menzogna altrui, che cosa detesto in realtà? Il fatto che mi lascio abbindolare. Mi tocca così ammettere che sono ingannabile, che non sono sempre capace di distinguere il vero dal falso. Se lo fossi, l’altro potrebbe dir menzogne finché vuole, ma io me ne accorgerei subito, e non avrei bisogno di odiare la sua menzogna. Là dove mi mancano elementi di percezione per esprimere un giudizio fondato, non ho che da sospenderlo per evitare di farmi trarre in errore.
La terapia, la catarsi dell’odio, sta nel capire che io parto odiando qualcosa fuori di me, ma lo scopo di quest’odio, il suo approdo, è di evidenziarmi tutto ciò che ho da vincere dentro di me. Un essere umano che fosse perfetto non odierebbe nessuno.
Analogamente al mio odio per la menzogna, io odio l’egoismo degli altri quando sento che mi usano: ma cosa mi dice quest’odio? Mi dice: devi superare dentro di te il tuo stesso egoismo che tende a far degli altri dei puri mezzi per i tuoi fini personali. Non hai il diritto di pretendere dagli altri quel comportamento che tu stesso non hai nei loro confronti. L’odio innato per l’egoismo altrui è sano perché il suo scopo è d’insegnarmi l’odio contro l’egoismo che è in me, con l’intento di lavorare incessantemente a superarlo. La natura mette in cuore all’uomo un grande amore per la libertà, e sta a lui conquistarsi nel corso degli anni la libertà dell’amore.
A mano a mano che l’uomo scioglie il proprio egoismo, non ha più bisogno di detestare quello altrui. Solo chi non ha nulla da perdere può lasciar volentieri tutto agli altri, anche il loro odio, perfino il loro bisogno di sfruttare. L’essenza di ciò che viene chiamato «Cristianesimo» è il comportamento di Colui che non ha avuto nemmeno bisogno di difendere la sua vita. Ha lasciato che si dicesse il falso su di lui, che si fraintendessero le sue opere e che lo si condannasse a morte. Non aveva nulla da perdere e gli andava bene morire. Sapeva amare non solo la vita, ma anche la morte. Non aveva bisogno di odiare l’egoismo altrui perché nel suo cuore c’era solo amore.
Le cose più profonde della vita si possono esprimere solo in paradossi, e uno è questo: posso permettermi di lasciar fare agli altri tutto quello che vogliono solo se pur danneggiandomi non mi danneggiano! Se per esempio qualcuno m’imbroglia facendomi perdere diecimila euro, mi danneggia? C’è una bella differenza fra il dire «m’ha fatto sparire diecimila euro» – dato oggettivo –, e il dire «m’ha danneggiato». «M’ha danneggiato» non è un dato oggettivo, è casomai un vissuto mio. Supponiamo che io dica: meno male, diecimila grane in meno – e questo sì che è un altro bel paradosso! Nella stessa situazione una persona diversa potrà dire: ma mi servivano per campare, quei soldi! E le si può sempre rispondere: se ti servivano per campare, come mai sei campato finora senza spenderli?
Il sale che dà sapore alla vita è amare in noi stessi la forza che ci porta ad amare gli altri. Il pepe che rende piccante la vita è odiare in noi stessi tutto ciò che ci impedisce di amare gli altri.
L’amore non è un sentimento
Torniamo alla domanda posta all’inizio: come si fa a vincere il disamore, l’indifferenza interiore? Se è vero che l’indifferenza è il nemico acerrimo dell’amore, in quanto vuoto d’amore, allora la vita diventa tanto più bella quante più sono le cose a cui ci interessiamo, e la somma massima della gioia è l’aprirsi pieni di stupore e di meraviglia verso tutti gli esseri del mondo.
Interessarsi non significa condividere la vita con tutti – questo sarebbe impossibile nell’esistenza fisica. Ma aver interesse per tutto e per tutti è una cosa possibile. Un esempio che ho spesso citato: quando un libro è noioso di solito lo metto via dicendo: ho di meglio da fare! Ma se io riuscissi a interessarmi al fenomeno affascinante della noia, cioè a come si fa ad essere noiosi da morire, potrei dirmi: ma guarda, io non sarei mai capace di essere così noioso! È un genio della noia, questo scrittore! Ma come fa? E allora leggo, leggo, leggo... straordinario, questo libro... ecco, ecco qual è la chiave della noia... Interessantissimo! Magari sono le tre di notte, ma io rimango sveglio immerso nel fenomeno puro della noia che assorbe tutto il mio interesse!
L’amore è la capacità che ha il cuore di ognuno di rendere interessanti tutti i fenomeni del mondo. Non esiste qualcosa di oggettivamente non interessante: tocca a me aprirmi e prendere a cuore tutto ciò che esiste. Non sono le cose a dover interessare me, sono io che devo interessarmi ad esse. Per chi è interessato a tutto, tutto è interessante, e questo lo rende l’uomo più felice di questo mondo.
Ma la nostra domanda era proprio questa: come si fa a interessarsi a tutto e a tutti? Il problema è che spesso crediamo che l’amore sia un sentimento che spunta in noi da sé, ma a pensarci meglio ogni sentimento non è che l’eco suscitato nell’animo dalle realtà più varie che incontriamo nella vita. In questo senso anche l’amore, in quanto sentimento, è l’eco interiore di una musica che deve prima risuonare fuori della nostra soggettività.
È proprio così: l’amore che sentiamo dentro è l’eco dell’amore che doniamo agli esseri fuori di noi. Di solito noi siamo così interessati a godere questa risonanza interiore dell’amore, che ne trascuriamo la sorgente oggettiva, cioè la sua origine fuori di noi. Il nostro sentimento della gioia è un riverbero dell’amore che diamo agli altri, che riversiamo fuori di noi intessendolo alla loro vita – e questo, solo questo, ci riempie di gioia. Può godere in sé l’amore, può vivere il sentimento dell’amore, solo chi veramente sa dedicarsi agli altri.
A volte sembra possibile provare gioia anche solo ricevendo amore, sembra cioè di poter gioire per un amore la cui sorgente è nell’azione d’amore di un altro. Per esempio provo gioia se qualcuno mi dice che mi ama, oppure quando guardo lo scintillio del cielo stellato, o l’azzurro incantevole del mare. Se però osservo bene la mia dinamica interiore, mi accorgo che prima di poter provare questo tipo di gioia devo io stesso amare l’essere che mi ama, nelle mille forme in cui mi è possibile. Se fosse il cielo stellato a commuovermi, dovrebbe commuovere tutti, sempre e in egual misura. Il mondo è invece commovente solo per chi sa commuovere se stesso. Se non sono capace di commozione, la bellezza del creato non la vedo nemmeno, o addirittura mi sgomenta, e l’amore di un altro può persino darmi fastidio.
Il motivo per cui nell’umanità c’è poca gioia va ricercato nelle tante omissioni d’amore. Proprio perché amare è una scelta libera della volontà, non siamo costretti a interessarci agli esseri attorno a noi, e di conseguenza la gioia del cuore è quel poco che è.
L’amore è un vero e proprio circolo virtuoso: l’attenzione della mente e del cuore rivolta agli altri ci riempie l’animo di gioia e rafforza la nostra volontà, che riconferma ogni giorno la decisione di riandare verso gli altri e verso il mondo. Soltanto l’individuo singolo può coltivare dentro di sé le forze dell’amore, decidendo liberamente momento per momento, situazione per situazione, di aprire il proprio cuore e di interessarsi agli altri. Ma deve capire che è una decisione tutta sua e sempre possibile, che può nascere solo nella libertà della sua coscienza.
In ogni momento io mi posso domandare: che cosa c’è ora intorno a me che mi chiede attenzione e premura? E se mi accorgo di quanta attesa c’è perché il mio cuore si apra, capisco che l’amore mi è sempre accessibile, che la libertà ne conosce da sempre la via e che il cuore ne può sempre assaporare la gioia.
Alla ricerca dell’altra metà
Un’esperienza tutta particolare dell’amore è quella che si vive nella ricerca reciproca del maschile e del femminile. Si dice non a torto che quella tra l’uomo e la donna è una storia vecchia quanto il mondo. In un certo senso è così, ma l’essere umano primigenio – l’Adamo della Bibbia – non era ancora scisso nel maschile e nel femminile. La separazione dei sessi è sopraggiunta in un secondo tempo e fa parte della cosiddetta cacciata dal paradiso, cioè del mistero della graduale «caduta» dell’uomo dal mondo puramente animico-spirituale in quello materiale – sempre più giù, fino a considerare la realtà visibile come l’unica reale.
«Paradiso» viene chiamato quello stato di coscienza in cui ognuno di noi era completo ma non ancora autonomo, un po’ come il bambino nel grembo della madre. Con la discesa in terra siamo diventati ognuno una metà che cerca l’altra metà. Il senso di questo dimezzamento è proprio l’anelito incessante verso l’altra parte di noi: non possedendola già, è motivo di desiderio, di graduale conquista, di dinamismo evolutivo. Il femminile è la somma delle conquiste evolutive del maschile, e il maschile è la somma della tensione evolutiva del femminile. E per quanto riguarda l’amore: il maschile è il grande amore della donna e il femminile è il grande amore dell’uomo maschio.
Si può sentire un certo disagio di fronte al fatto che in italiano la parola «uomo» indichi sia l’essere umano in generale sia il maschio in particolare: questo non è particolarmente gentile nei confronti delle donne e la dice lunga su una millenaria cultura patriarcale. In tedesco la parola Mensch vale per «essere umano», a prescindere dal sesso, poi c’è der Mann, che è l’essere umano maschio, contrapposto a die Frau, la donna.
La parola «sesso» viene dal latino sexus, participio del verbo secare, «dividere», «tagliare». Nel Simposio di Platone, nel quarto discorso tenuto da Aristofane, viene narrata in modo simpaticissimo la vicenda di Giove che, temendo che gli uomini cominciassero a fargli concorrenza, decise di dimezzarli. Divide et impera, dicevano gli antichi romani. L’androgino originario, maschio e femmina in uno, venne così scisso in due affinché invece di montarsi la testa dando la scalata all’Olimpo degli dèi, si occupasse della ricerca di quella metà dell’umano che ora gli veniva a mancare!
Questo bellissimo mito, oltre a esprimere una verità fondamentale dell’evoluzione umana, è una fedele versione greca di ciò che dice anche la Bibbia: Dio creò l’essere umano maschio e femmina, cioè a sua immagine in quanto essere in sé completo. Dio è pienezza, è completezza, e se ha creato l’uomo a sua immagine, l’ha creato intero, non ridotto a metà. Al testo ebraico corrisponde meglio una traduzione che dice: «Dio creò l’essere umano maschile e femminile in uno». L’immagine geniale della costola di Adamo da cui viene plasmata Eva sta proprio a dire che l’essere primigenio è stato solo in un secondo momento differenziato in maschile o femminile. Da uno che erano, l’uomo e la donna divennero due esseri distinti, e da allora ebbe inizio l’eterna ricerca l’uno dell’altra.
Comprendere l’evoluzione del rapporto d’amore tra il maschile e il femminile significa allora comprendere il senso stesso dell’evoluzione. Viceversa, capire l’evoluzione è capire il modo in cui si susseguono i vari stadi del rapporto che intercorre fra l’uomo e la donna. In questa storia d’amore possiamo distinguere per sommi capi tre stadi:
• il primo stadio è quello dell’unione primigenia, dell’androgino adamitico (ανηρ, anèr, «maschio» e γυνη, güné, «femmina») che è maschile e femminile insieme;
• il secondo, in cui ci troviamo tuttora, è quello della scissione in maschile e femminile, in uomini e donne;
• il terzo stadio, quello finale verso cui tende tutta l’evoluzione, sarà costituito dal loro ricongiungimento, è la realizzazione dell’anelito evolutivo che mira a rifare a un livello più alto l’unione delle due metà che da sempre si cercano.
Il senso della separazione dei sessi è allora quello di offrire alla libertà del singolo la sfida a rimetterli insieme. Un ricongiungimento che non potrà essere opera della natura, quindi, ma solo dell’individuo e del suo creare libero. E proprio questo rende la vita bella e buona sia per le donne che per gli uomini. Proprio perché siamo spaccati in due, la nostra libertà vive nella tensione evolutiva che vuol costruire una comunione sempre più intima e profonda tra il maschile e il femminile. E dipende in tutto e per tutto da noi in quale misura sappiamo rendere bello questo gioco.
Lontananze e vicinanze tra il maschile e il femminile
Che ognuno di noi sia maschio o femmina nel suo corpo è ovvio, e questo vale anche per l’omosessualità che è più che altro un’inclinazione dell’animo. Ci sono infatti anche una mascolinità e una femminilità dell’animo, meno note a un’umanità materialista com’è la nostra, tutta fissata su ciò che è corporeo. La bellezza e la bontà del corpo risiedono proprio nel suo diventare uno strumento musicale da cui far risuonare le melodie dell’anima – sentimenti, desideri, emozioni... L’orizzonte limitato al corporeo comporta un impoverimento dell’uomo perché rappresenta il suo più grande peccato di omissione, quello che gli impedisce di godersi il meglio della vita, cioè tutto ciò che solo l’anima e lo spirito possono dare.
La caratteristica fondamentale del mondo fisico-materiale, infatti, è che resta a noi esterno, cioè estraneo a quel che viviamo dentro di noi. Di questo mondo corporeo possiamo far nostro solo ciò che riusciamo a interiorizzare. Una pietra può entrare in me quando io, vedendola, me ne faccio una rappresentazione o un concetto. Ma non potrò mai penetrare per esperienza diretta la sua materia.
Trasposto in ambito di sessualità ciò vuol dire: le sensazioni, le pulsioni legate al solo corpo, non sono comunicabili all’altro. Ognuno ha esperienza del proprio corpo attraverso le sensazioni che solo lui ne ha – e il maschio ha sensazioni di tutt’altra natura che non la femmina, proprio perché le due costituzioni fisiche sono biologicamente del tutto diverse. In altre parole, al livello corporeo ognuno resta chiuso in se stesso. E ciò vale anche per qualsiasi altra esperienza legata ai sensi: il freddo, il caldo, il sapore, l’odore, il prurito, il dolore, la fame, la sete...
Però, oltre alle sensazioni del corpo ci sono le emozioni che, essendo un fenomeno specifico dell’anima, sono almeno in parte comunicabili e condivisibili. Questo non vuol dire che l’uomo possa sentire in tutto e per tutto le stesse emozioni che sente la donna, o viceversa; vuol solo dire che ognuno può immedesimarsi nell’altro interessandosi a quel che vive in lui. Quando per esempio «faccio mia» la gioia dell’altro, non è che sento in me la stessa gioia che sente lui, ma mi dà gioia il fatto che lui gioisca. Sono due gioie del tutto diverse. Questo primo gradino della comunione tra il maschile e il femminile – quello dell’anima – sorge dalla capacità di con-passione, cioè del gioire o soffrire con l’altro, per il motivo stesso che l’altro gode o soffre.
Oltre alle sensazioni del corpo e alle emozioni dell’anima, ci sono i pensieri dello spirito. Nella sfera spirituale dei pensieri la polarità del maschile e del femminile si risolve in una comunione che può diventare completa. Però un uomo e una donna che diventano spiritualmente uno nei loro pensieri, restano pur sempre uomo o donna nel loro animo – con un mondo di emozioni largamente determinato dall’essere uomo o donna –, e più ancora nel loro corpo – con una serie infinita di sensazioni che fa di ognuno un essere a sé stante.
L’appassionante gioco tra il maschile e il femminile si suona allora su una lira a tre corde, si svolge su tre campi diversi: quello del corpo, dove ognuno resta un inestricabile enigma per l’altro – e questa «irraggiungibilità» non fa che aumentarne il fascino –; quello dello spirito, dove ognuno può diventare una cosa sola con l’altro, in una comunione non meno avvincente dell’estraneità –; e il terzo campo è quello dell’anima, in cui si gode l’infinito oscillare tra l’estraneità elettricamente polare dei corpi e la sintonia indicibilmente profonda degli spiriti.
La sessualità è un «bene» o un «male»?
La sessualità, in quanto realtà biologica, rappresenta una sfera che l’uomo ha in comune con gli animali. Ma l’essere umano, nonostante questa comunanza di natura, non può vivere la sessualità come un animale perché ha un corpo abitato da un’anima tutta diversa da quella degli animali, e da uno spirito individualizzato – che possiamo chiamare Io – che gli animali non hanno. L’uomo è di conseguenza massimamente «animale» nel suo corpo, massimamente «umano» nel suo spirito, mentre l’anima gioca fra i due, creando infiniti arricchimenti reciproci tra il mondo della natura e quello dello spirito.
Gli animali non possono prendere liberamente posizione di fronte al loro corpo. Non possono che assecondare in tutto e per tutto l’istinto di natura. L’uomo invece, pur avendolo, è in grado di rifletterci sopra, di interpretarne il senso, di non limitarsi a subirlo, ma di farne uno strumento per conseguire dei fini tutti suoi.
L’attrattiva verso il corpo dell’altro sesso è l’istinto di natura più irresistibile che ci sia. In ordine di travolgenza non è certo da meno di quello dell’autoconservazione, che si manifesta nel bisogno di mangiare, bere, dormire. L’istinto sessuale è cogente in assoluto in quanto tende non solo a conservare un corpo già esistente, ma a raddoppiarlo di sana pianta generandone uno nuovo nel figlio che viene a nascere.
La legge naturale di questa «inesorabilità» è la procreazione: la natura umana tende per natura a perpetuarsi, non vuole perire. La specie umana porta impresso in sé l’istinto all’autoconservazione. Questa volontà assoluta di procreare ci dice che l’uomo non è in grado di arrestare il suo cammino evolutivo.
L’atto sessuale avviene allora secondo leggi che non vengono dettate dalla libertà umana. L’uomo è libero di decidere se entrare in quel gioco o no, ma non ne può decidere il come, non ne può stabilire le regole. Una volta deciso di «stare al gioco», viene preso nel vortice di forze che conoscono solo la sapienza prestabilita delle leggi di natura, quali le ha impresse il Creatore in ogni sua creatura. In altre parole, l’uomo subisce sia la dinamica che il piacere del sesso.
Il dato di natura è pre-morale, cioè precede il fatto morale. Il bene e il male morali si affacciano quando sopravviene la libertà dell’uomo, quando egli prende posizione operando delle scelte nei confronti del fatto di natura. Solo dove c’è la possibilità di andare sia di qua sia di là, subentra la responsabilità morale; dove non c’è libertà non esiste nemmeno moralità.
La libertà umana può servirsi delle forze di natura sia per il bene sia per il male. E la domanda importante che qui si pone è: quale uso della sessualità è un bene e quale è un male per l’uomo? E per rispondere bisogna prima sapere che cosa sia bene e che cosa male per l’uomo.
Un primo orientamento generale è già stato espresso: bene è tutto ciò che fa vivere l’uomo in pienezza, male è tutto ciò che lo diminuisce, che provoca delle carenze o delle mancanze nel suo essere. Se l’uomo è fatto di corpo, anima e spirito, è bene tutto ciò che favorisce l’integrità e l’armonia di queste tre sfere. Però questo orientamento generale va ora concretizzato e specificato riguardo alla sessualità, al modo di vivere le forze poste alla base della procreazione.
Essendo gli uomini tutti diversi gli uni dagli altri, non esiste soltanto ciò che è bene o male in modo uguale per tutti. Ci sono anche un bene e un male individuali: tante cose che possono costituire un bene per una persona, nel senso che favoriscono in positivo la sua evoluzione singola, possono essere un male per un’altra perché invece di farla progredire la fanno regredire.
Un esempio concreto: come faccio io a sapere se è bene o male per me avere dei figli? A questa domanda non esiste una risposta che sia valida per tutti, che rappresenti una norma morale generale. Ognuno deve trovare la risposta giusta per sé, e la troverà grazie alla sua esperienza di vita, non certo in base a un puro ragionamento teorico. Dovrà conoscere sempre meglio se stesso, e per far questo dovrà dar fiducia alla vita – alla sua vita.
Poniamo che una persona decida che per lei è bene non avere figli o, caso più frequente, che le bastano i figli che già ha: significa che sarà bene per lei anche astenersi dall’atto sessuale? Detto in altre parole: quando non c’è l’intento di procreare, che cosa è bene e che cosa è male in fatto di sessualità? Anche qui la risposta la deve dare l’esperienza personale: non servono a nulla né le condanne della cultura cattolica né le assoluzioni di quella laica. Sono posizioni ambedue moralistiche, perché il moralismo sta proprio nel voler stabilire a priori, cioè in modo vincolante per tutti, cosa è bene e cosa è male.
Ognuno deve invece far l’esperienza personale di ciò che la pratica sessuale causa in lui: se lo fa crescere o diminuire nel suo essere, se lo rende più libero o meno libero. Se la libertà interiore è il valore supremo della moralità, è per me morale ciò che rende me più libero, ed è immorale per me tutto ciò che rende me meno libero. Le riflessioni espresse in questo libro si possono riferire solo a quei tratti che fanno parte della natura umana in quanto comune a tutti noi. Il modo concreto di esprimerli nella propria vita non può che variare da persona a persona.
Sesso e libertà
Non mi è sempre facile sapere che cosa davvero mi libera e che cosa costituisce invece per me una libertà solo apparente. Negli ultimi decenni la cultura occidentale, volendo abbattere i molti tabù legati al sesso, è partita in quarta con un binomio dato da molti per scontato: sesso e libertà. Promuovendo la cosiddetta «liberazione sessuale», si sono messe insieme due realtà dell’umano che sono invece polarmente opposte l’una all’altra: la libertà, che è espressione dello spirito autonomo dell’uomo, e il sesso, che è legato ai determinismi di massima istintualità.
Questa errata impostazione di pensiero ha ingenerato risvolti morali contraddittori: molti hanno creduto e credono di poter trovare l’apice della libertà là dove domina invece la non libertà dell’istinto.
Se i piaceri del corpo si sperimentano in un ambito che rafforza in noi il polo di natura – quello non libero –, nulla vieta, però, che ci siano dei godimenti dell’anima e dello spirito che invece favoriscono la libertà. Se così fosse, non servirebbe a nulla predicare l’astensione dai piaceri del corpo a persone che non hanno mai goduto realmente l’altro tipo di felicità – senza parlare del fatto che spesso chi la «predica» la conosce non più di coloro a cui rivolge il suo sermone.
La vita è fatta apposta per darci la possibilità di scoprire che genere di felicità si può trovare nell’anima e più ancora nello spirito. Il godimento del corpo, se ce lo dà la natura, non può farci più felici di quello dello spirito che è tutto frutto di conquista della nostra libertà. Del resto, basta osservare lo scorrere degli anni nella biografia di ogni uomo: da piccoli piccoli il massimo del piacere è bere il latte ed essere cullati; poi, da più grandicelli, si gode per la cioccolata, la pizza, i giocattoli e un bel giro in bicicletta. Poi la felicità diventano le ragazze, o i ragazzi; ancora dopo si scopre magari una passione per il cinema, per la discoteca, per il teatro, per la musica – e già qui siamo nell’ambito dei piaceri dell’anima.
Se poi nasce, sempre col passare degli anni, un forte interesse per la matematica, o la medicina, l’agricoltura, la filosofia, la finanza, la storia, il commercio, l’antropologia, l’ingegneria navale, l’arte culinaria... e così via, entriamo nell’ambito dei piaceri della conoscenza, che sono di tipo spirituale. Per goderceli, infatti, dobbiamo diventare attivi, dobbiamo produrre qualcosa, inventare, creare: il tipo di soddisfazione che andiamo qui cercando ha a che fare con la nostra libera attività individuale, con le scoperte del nostro pensiero, con la nostra capacità di progettare, d’intuire, di metterci alla prova... Tutte azioni dello spirito. Tutti piaceri non subiti. Tutti piaceri liberi, e che ci rendono perciò massimamente felici.
Proprio per questo l’eros dello spirito umano è infinitamente più intenso e beatificante di quello del corpo, e ci porta a far di tutto perché anche il corpo diventi lo strumento più adatto per raggiungere questo fine. Se sono immerso in attività che impegnano il mio spirito, i piaceri del corpo non saranno più in prima linea nella scala dei miei valori – senza bisogno che qualche norma morale a me esterna mi dica se sono un bene o un male. Sarò io, sarà la mia libertà a sapere se lo sono o no. Sarò io a stabilire le mie preferenze, a scegliere, fra le tante cose che posso godere nella vita, quelle che mi fanno sentire meglio in tutto il mio essere, e che mi arricchiscono di più.
Se i piaceri del corpo li dà la natura e quelli dello spirito li conquista la libertà, da giovani si ha tutto il diritto di essere più «naturali» e da meno giovani quello di diventare sempre più liberi. E la vita è bella proprio nella misura in cui se ne fa un cammino di progressiva liberazione. È per questo che procrea chi è giovane e non chi è vecchio: chi è vecchio invece di procreare può creare – presupponendo che non rimbambisca prima, tralasciando di esercitare e godere l’attività del proprio spirito. È per questo che il corpo è bello robusto in gioventù, mentre lo spirito mostra la sua profondità e la sua saggezza solo con l’andare degli anni.
È un malinteso moralismo quello che vuol castrare il corpo in gioventù: la conseguenza sono infiniti sensi di colpa, cioè la castrazione dell’anima, nel mezzo del cammino della vita, e la paura del castigo eterno, cioè la castrazione dello spirito, della propria individualità, man mano che ci si avvicina alla morte.
Ed è altrettanto disumana una cultura materialista che voglia limitare e fermare la capacità di godimento dell’uomo alla sola sfera corporea – o perlomeno concentrarla lì. Quel che l’uomo d’oggi cerca è proprio il coraggio di scoprire nuovi e sempre migliori tipi di «orgasmo», esplorando quelle sconfinate regioni dell’umano che sono aperte all’eros della mente e del cuore.
Se la natura è fatta di determinismi, se non ammette libertà, allora l’essenza della libertà consiste per l’uomo nell’aggiungere a quel che dà la natura tutto ciò che essa non può dare, e che per esserci dipende in tutto e per tutto dall’uomo. La libertà umana è fatta per trasformare a poco a poco la natura da elemento conduttore che occupa dapprima l’intero campo della vita in un agile strumento nelle mani dello spirito umano.
C’è chi pensa che in campo sessuale quest’aggiunta libera alla natura debba andare nella direzione dell’erotismo. In esso vuol vedere non solo l’apice duraturo della felicità, ma perfino della moralità in quanto forma perfetta di abnegazione di sé nel dono incondizionato all’altro. C’è anche chi vuol vedere nel sesso la forma suprema della religione e dell’arte, e non gli mancano le «sacre scritture» a cui richiamarsi – come la tradizione millenaria del Tantrismo o del Kamasutra, senza bisogno di attingere da De Sade e compagnia o di ricorrere all’apoteosi della libido del patriarca Freud. All’estremo opposto c’è chi vede nel godimento sessuale qualcosa in sé moralmente cattivo e «peccaminoso».
Questi due estremismi hanno in comune il bisogno quasi fisiologico di risolvere una volta per tutte il problemino delle forze di natura nell’uomo. Comodo: decretando che sono un male, o che sono un bene, ci si risparmia la lotta quotidiana e continua che è necessaria per far sì che diventino un bene. Ciò può avvenire solo in modo del tutto graduale e individuale. Il giusto equilibrio tra due comportamenti che, arrestando l’evoluzione, mortificano entrambi l’umano più autentico, è quello di restare sempre in divenire.
Questo giusto equilibrio non è mediocrità, ma mediazione tra estremi, mai statica e definitiva, ma da rifare ogni giorno. Equilibrio e mediazione che, per rendere giustizia all’uomo, variano da persona a persona, essendo gli uomini profondamente diversi gli uni dagli altri.
Sia la paura del sesso, sia la sua esaltazione, la sua demonizzazione come la sua deificazione, sono due forme di povertà umana, due volti di una stessa inerzia interiore. Mancano ad entrambi il dinamismo generato dal calore dell’anima e dalla luce dello spirito, mancano l’amore e la verità – criterio supremo di ogni moralità.
La vita è la maestra più saggia che vi sia: la sua arte pedagogica è un’arte maieutica, come quella della levatrice che tira fuori il bambino dal grembo della madre. Educare, e-ducere, significa proprio «tirar fuori» dall’essere umano tutte le facoltà in lui sopite che gli consentono di ampliare all’infinito il suo campo d’azione. Il compito della morale non è quello di mettere in riga gli uomini, ma di dargli fiducia perché portino alla luce tutto il bene che hanno dentro, quello che fa toccare il cielo col dito non per un momento fuggevole, ma ogni giorno e ogni ora della vita.
Questo mio corpo, che è la quintessenza della natura in me, può essere il tutto di me, oppure può diventare nelle mie mani uno strumento preziosissimo che permette alla mia anima di amare sempre più esseri e al mio spirito di ideare sempre nuove creazioni. Questa è la scelta fondamentale della libertà umana: lasciarsi andare al dato di natura, capitolare di fronte a ciò che ha leggi proprie e ferree, omettendo così le conquiste aperte all’uomo; oppure avvalersi di tutte le forze della natura per tendere a quegli ideali che rendono sempre più tenero il cuore e sempre più luminosa la mente.
L’anima umana vive nella tensione fra questi due «amori», e mettiamola fra virgolette questa parola perché, l’abbiamo visto, noi chiamiamo amore sia ciò che la natura fa a noi tramite l’attrazione sessuale, sia ciò che noi facciamo di lei con la nostra anima e il nostro spirito, quando diamo agli altri tutta la nostra attenzione e la nostra premura.
È possibile goderci al massimo sia i piaceri del corpo che quelli dello spirito?
Voler ridurre l’amore al sesso è come voler quadrare il cerchio. Il che vuol dire: i conti non tornerebbero, perché cercheremmo la felicità – la pienezza – là dove non esiste. Voler quadrare il cerchio è come pretendere dalla natura che mi renda libero e felice. Invece la felicità si prova, e si trova, nei pensieri e nelle azioni libere che si avvalgono della natura per creare qualcosa che natura non è.
Ma scendiamo più nel concreto e chiediamoci: non è possibile godere al cento per cento sia i piaceri del corpo sia quelli dello spirito? C’è qualcosa che impedisce all’anima di gustare al massimo le sensazioni che dà il corpo e allo stesso tempo anche le gioie dello spirito? Non sarebbe proprio questo il culmine della felicità?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo analizzare spassionatamente – senza subito condannare o giustificare in sede morale – ciò che ogni donna e ogni uomo vivono interiormente nei momenti in cui le forze della sessualità, a livelli più o meno intensi, hanno il sopravvento, cioè quando le sensazioni del corpo prevalgono sulle emozioni dell’anima e più ancora sui pensieri dello spirito.
Prima constatazione: più mi abbandono alle forze della natura che si esprime nel mio corpo e meno sento di decidere del tutto liberamente ciò che faccio. Mi sento sempre più passivo, sempre meno attivo. La forza della mia volontà diminuisce in proporzione alla sensazione che ho di «lasciarmi andare». Se a questo punto la voce della coscienza si fa sentire, tanti, per metterla a tacere, dicono che è bello e buono abbandonarsi ai sensi, finirla una buona volta di voler sempre controllare tutto e tutti, persino la natura – che è così piena di saggezza che val la pena affidarsi a lei.
Però questa prima constatazione, se è oggettiva, mi dice: non puoi contemporaneamente essere passivo e attivo, non è possibile allo stesso tempo esercitare in pieno la libertà e abbandonarsi alle forze della natura. Ti tocca scegliere: o l’uno o l’altro. Puoi mettere in primo piano la libertà solo facendo recedere l’esuberanza delle forze di natura in te. L’esperienza della libertà non si fa accanto o dopo quella della naturalità, ma avviene sempre e solo vincendo l’istinto di natura. La libertà è una forza autentica solo quando è «più forte di» ciò che compie la natura in te, cioè quando causa direttamente una diminuzione della forza dell’istinto. Se l’istinto è passività dell’anima e dello spirito, si diventa interiormente attivi e liberi solo superando via via quell’automatismo di natura.
Essere liberi vuol dire allora avere una volontà forte. Ogni volta che cedo a spinte che non provengono da una mia autonoma decisione indebolisco la mia volontà e divento di tanto meno libero, cioè meno capace di fare ciò che voglio io. Invece, ogni volta che vinco in me i condizionamenti della natura, rafforzo la mia volontà e divento più libero. Non posso essere contemporaneamente padrone e schiavo in casa mia. Il mio corpo è o il mio padrone o il mio servo. Certo che può essere alternativamente sia l’uno sia l’altro, ma più aumentano le occasioni in cui gli faccio fare da padrone e più diminuiscono le mie possibilità di ridiventare padrone io nei suoi confronti. Fino all’estremo limite in cui le pulsioni del corpo possono diventare una vera e propria ossessione. La storia dei vari tipi di tossicodipendenza parla un linguaggio ben chiaro.
Seconda constatazione: le forze dell’istinto, che l’uomo ha in comune con gli animali, non sono individualizzate, ma funzionano secondo quella «natura umana» che come tale è la stessa in tutti gli uomini. In altre parole, quando mi affido alle forze di natura rinuncio, anche se momentaneamente, a esprimere una mia fisionomia individuale. Non posso rimettermi a un istinto che funziona in tutti in modo più o meno uguale, e contemporaneamente agire in modo individuale, creativo e tutto mio. Ciò che è spirituale – per esempio la conoscenza, il pensiero – consente un massimo di individualizzazione perché può esprimersi in infinite sfumature diverse; il corporeo, invece, – per esempio l’istinto puro – consente solo un minimo di variazione individuale.
Per quanto fantasiosa possa essere l’inventiva erotica – che è un modo di manifestarsi dell’anima durante la dinamica sessuale –, l’impulso da soddisfare è sempre lo stesso, e rimane al livello del corpo. L’anima invece, nella sua natura genuina, tende ad aprire tutto ciò che è corporeo verso lo spirito: è la ben nota principessa delle fiabe che cerca il principe capace di sciogliere tutti gli incantesimi. Per questo l’inventiva che l’uomo attiva in sé per raggiungere, anche con mezzi fisici, mete tutte sue e mai generalizzabili, fa nascere e soddisfa tensioni sempre nuove e dà frutti dal sapore ogni volta diverso.
Terza constatazione: quando vivo nelle sensazioni del mio corpo mi chiudo in me stesso, perché il corporeo, come si è visto, non è comunicabile. Il campo della reciproca comunicazione è l’anima, il luogo della piena comunione è lo spirito. Nell’umanità di oggi aumenta in tante persone il senso della solitudine proprio perché il materialismo ha messo sempre più in primo piano il corpo.
La sessualità, in quanto puro turbinio di sensazioni corporee, è il gioco di due esseri ognuno chiuso in sé, è l’incontro di due egoismi che a conti fatti non fa che esasperare in entrambi il senso della solitudine. Due egoismi diversi, certo, perché nel maschio la ricerca della soddisfazione dell’istinto è molto più nitida e dichiarata che non nella donna, la quale spesso cerca maggiormente l’emozione «dell’essere posseduta e del possedere», quella sensazione rassicurante che le conferma di volta in volta l’intensità del reciproco bisogno, o della reciproca dipendenza.
Se l’amore è attenzione verso l’altro, la sessualità pura è proprio l’opposto dell’amore, è l’espressione della sua carenza, della sua mancanza. Ci si può aprire all’altro, si può veramente amare l’altro, e non solo se stessi, soltanto uscendo da quell’isolamento nel quale il godimento delle pulsioni sessuali costringe. L’autoerotismo, la masturbazione, è per certi versi il modo in cui l’uomo onestamente fa l’esperienza di questa chiusura. Non c’è che da riconoscere gli stessi meccanismi anche in un tipo di rapporto sessuale a due che miri solo al puro soddisfacimento dell’istinto.
Con tutta schiettezza ci tocca dire: non c’è apertura dell’anima senza vittoria sulla chiusura nel proprio corpo. Nessuno è aperto all’altro per natura: per natura ognuno tende a godere l’altro in funzione di sé. E questo perché l’imparare ad aprirsi, se frutto di libertà, dà molta più gioia che non essere già di per sé o da sempre «aperti».
Quarta constatazione: quando vivo l’istinto puro la mia mente si oscura. L’orgasmo fisico e quello spirituale, cioè l’intuizione pensante, si escludono a vicenda, e sono ben padroni di farlo: la natura umana non l’abbiamo progettata noi. Come la chiusura in sé esclude l’amore – che è la forza innata dell’anima –, così la sensazione corporea indebolisce il pensare – che è la forza primigenia dello spirito.
Non è possibile vivere contemporaneamente il delirio dei sensi e avere una mente così lucida e concentrata da permetterci le più grandi intuizioni dello spirito. La procreazione fisica e la creazione spirituale si escludono a vicenda nell’ambito della coscienza umana. Più i piaceri del corpo fanno presa su di me e più diminuisce la mia capacità di fare del mio corpo uno strumento docile e perfetto per le conquiste del mio spirito. Le forze della vita e quelle della coscienza sono opposte le une alle altre: sviluppare la coscienza significa consumare le forze vitali, e queste si possono ricostituire solo facendo recedere la coscienza, come per esempio avviene quando dormiamo.
L’irresistibilità delle forze sessuali nell’adultera del Vangelo e nel Parsifal
Il Vangelo di Giovanni affronta questi misteri con immagini che sono vita vissuta, in quanto racconta ciò che ha detto e ha fatto il Cristo, venuto ad amare gli uomini al punto infimo della loro caduta.
Gli scribi e i farisei, un giorno, portano dinanzi al Cristo una donna sorpresa in adulterio: «Rabbi di Nazaret, che ne dici, che facciamo?» gli chiedono, già pronti a lapidarla. E pensano: ora di sicuro non se la cava, perché se dice di non lapidarla si mette contro la legge di Mosè, e se dice di farlo contraddice tutto ciò che ha sempre detto sull’amore e sul perdono. Ma il Cristo li spiazza ponendo le cose su un tutt’altro piano, e risponde: «Chi di voi è senza peccato scagli per primo la pietra».
E il Vangelo narra che a uno a uno se ne vanno tutti, a partire dai più anziani – più uno è avanti negli anni e più ne ha combinate! – finché non rimane più nessuno. E allora il Cristo dice alla donna: nessuno ti ha condannato? Neanch’io ti condanno, io non sono venuto per condannare, ma per amare. Perciò ti dico: impara dai tuoi sbagli, trasforma la tua caduta in un’ascesa e non fermarti mai. La traduzione comune dice a questo punto: «Non peccare più e va’!», ma il verbo πορευω (porèuo) significa «rimettersi sulla via», «procedere», continuare a camminare e a evolversi.
Il Cristo è qui posto di fronte all’irresistibilità delle forze sessuali – questa è la traduzione in termini moderni dell’adulterio, che certo non riguarda solo la donna perché per commettere un adulterio bisogna ben essere in due. Significativo è il modo in cui il Cristo agisce in questa situazione: non condanna e neanche approva. Indica il cammino di liberazione, ma lascia alla libertà del singolo il percorrerlo.
Un’altra bellissima immagine che può illuminare questo aspetto della vita si trova nel Parsifal, uno dei più poderosi poemi della cristianità medievale – sia nella versione di Wolfram von Eschenbach che in quella di Chrétien de Troyes. Uno dei momenti decisivi del cammino interiore di Parsifal è quello in cui, posto per la prima volta di fronte al re del Gral, l’Anfortas gravemente ferito e sofferente, omette di chiedergli: qual è il tuo male? E ciò perché ancora gli mancano le forze dell’interessamento agli altri, gli manca ancora la compassione per la loro sofferenza.
Parsifal deve imparare che amare significa accorgersi del dolore e della lotta dell’altro, significa aver misericordia del suo stato di caduta e trovare in sé la forza e la volontà di partecipare al suo dolore. E la seconda volta che Parsifal si trova nel castello del Gral è in grado di porre la decisiva domanda: cos’è quella ferita, Anfortas? Di che cosa soffri? E Anfortas risponde: questa mia ferita è misteriosa, sanguina sempre e non guarisce mai. È all’inguine, ma nessuno mi sa dire quale sia la sua causa e quale la cura.
Quella ferita rappresenta in modo artistico l’irresistibilità delle pulsioni corporee che hanno separato la coscienza umana dal mondo dello spirito – sono questi i due lembi della ferita che da millenni non si rimargina. La coscienza umana viene proprio spaccata in due nel suo precipitare nel mondo della materia, perché immergendosi nelle forze di natura perde il meglio di sé, non sa più se la realtà è quella che tocca e che vede o è quella dello spirito che chissà dov’è, forse irrimediabilmente lontano.
Sempre di più l’uomo-Anfortas subisce la prepotenza delle forze della natura, la cui quintessenza si esprime nell’impulso alla procreazione. Perciò quella ferita è all’inguine, là dove lo scorpione conficca nell’uomo il suo pungiglione di morte, quel «pungolo della carne» che dette non poco filo da torcere già a quel Saulo di Tarso, meglio conosciuto come san Paolo.
In quest’immagine così pregna di significato viene spiegata all’uomo l’arcana ferita della sua anima, la lacerazione interiore di una coscienza piombata nei meccanismi della natura dai quali è chiamata a liberarsi ricongiungendo fra loro i due lembi dolenti del proprio essere, che sono la materia e lo spirito. E le scelte della libertà sono due: o compiere ciò che porta alla liberazione oppure omettere di compierlo. Ma il presupposto imprescindibile per iniziare questo cammino di affrancamento è capire il senso della ferita che da sempre ci fa soffrire, che ci rende infelici e soli, prigionieri della natura a un punto tale da non conoscere quasi più la libertà.
Voglia di tenerezza
Di fronte alla ferita di tutte le ferite, ogni uomo, come Parsifal, può sentire compassione per l’altro perché vive in sé lo stesso patimento. La compassione è la passione dell’amore, cioè la capacità d’immedesimarsi in ciò che l’altro patisce o, più in generale, subisce. La misericordia – un’altra bellissima parola che oggi fa ingiustamente arricciare il naso a tanti – è la consonanza del cuore (cor, cordis - in latino) di fronte alla «miseria», cioè alla debolezza dell’altro, perché è anche la propria.
E c’è anche un’altra parola che va riconsiderata in questo contesto: la parola «tentazione». Anche nei confronti di questo vocabolo è stata commessa una grave ingiustizia: rivestendolo di moralismo, è servito per secoli a indicare «i peccati in agguato», a rimarcare un imposto e malinteso senso di colpa. Tutt’altra cosa che la consapevolezza di una caduta non colpevole – nei confronti della quale ogni senso di colpa sarebbe una contraddizione –, il cui significato è quello di venir trasformata in una libera riascesa. Analogamente, il significato oggettivo di ogni «tentazione» è quello di una duplice scelta offerta alla libertà dell’uomo: una piace e non costa niente (e perciò «tenta», cioè alletta), l’altra comporta invece uno sforzo, una vittoria su di sé.
È interessante rilevare che nella nostra cultura la parola tentazione, riferita al sesso, da qualche decennio è stata pressoché bandita. Chi si sente più «in tentazione» di fronte all’occasione di un atto sessuale? Ben poche persone, forse. Anzi, come reazione a un cristianesimo moralista di lunga data, in occidente ci si è adoperati per cancellare qualsiasi possibile resistenza interiore di fronte alla «liberante» sessualità.
Ciò va detto perché è importante intendersi su una questione di fondo: «la compassione», «la misericordia», «la tentazione», sono tutti stati di coscienza che presuppongono in chi li prova l’aver recuperato nella propria interiorità il senso e l’esperienza di ciò che l’umanità da sempre ha chiamato «caduta». Altrimenti tutte queste parole non fanno che continuare a dar fastidio.
Volersi amare a vicenda interpretando tutto ciò che avviene nella sfera del sesso come senz’altro buono e favorevole alla crescita dell’uomo, è un conto; cedere, magari per l’ennesima volta, alla «tentazione» di abbandonarsi alle forze sessuali restando però convinti che sono una sfida alla libertà umana affinché le trasformi, è un tutt’altro conto. C’è una grande differenza tra il compiere gli stessi atti dando loro un significato, oppure il significato opposto. Nessuna azione umana ha una moralità oggettiva: il bene o il male risiedono nel valore che l’uomo le dà.
Amarsi come maschio e femmina significa allora aiutarsi a vicenda ad attenuare sempre più l’inesorabilità dell’istinto, donandosi una reciproca comprensione. Se non ci fosse in noi questo impeto travolgente dei sensi, mancherebbe la palestra più importante per rinvigorire la libertà. L’amore reciproco benedice la tendenza della natura a cancellare la libertà perché è il presupposto indispensabile per ogni atto di liberazione interiore. Ogni esperienza di libertà è difatti una liberazione, e non c’è liberazione senza qualcosa da cui potersi liberare.
È questo il momento in cui può avvenire un salto qualitativo nel rapporto fra uomo e donna: essi smettono di fissare il proprio legame sul corpo e cominciano a cercare l’anima l’uno dell’altra, per fare sempre più profondamente l’esperienza di essere due spiriti creatori. In questo modo la ferita della separazione viene a poco a poco rimarginata, e il male atavico della solitudine, della chiusura in sé, trova il suo senso in quella comunione che si vive nelle ripetute vittorie della libertà umana.
Se sono una donna, posso provare a capire il fascino misterioso che il mio corpo esercita sul maschio inducendolo a godere e volere non sé per me, ma il mio corpo tutto per sé; e non avrò bisogno di rinfacciargli la solitudine che provo, e che non fa che aumentare quando mi accorgo che anche altri corpi di donna possono sollecitarlo non meno del mio. Potrò avere compassione e aprirmi a lui con amore, senza condannarlo ma anche senza mentire sulla ferita dell’anima che abbiamo in comune e che attende di venir rimarginata dalle forze risanatrici del nostro amore.
E se la donna si libera a poco a poco dall’atavico ruolo di colei che deve sedurre intensificando l’istinto del maschio, non solo non condannerà più la pulsione veemente che vede in lui, ma neanche si prodigherà per rafforzarla. Le forze della con-passione le diranno di volta in volta come agire, perché «patire insieme» la spinta pressante della natura significa capire che siamo in due a essere caduti e che possiamo risalire solo insieme.
Se sono un maschio, e se cerco l’anima della donna che amo al di là del suo corpo, mi libero sempre più dal vincolo dell’istinto di natura, e anche dal ruolo che m’inchioda al dover fornire «prestazioni». Più amo quell’anima che soltanto lei mi può portare incontro, e più mi accorgo io stesso di avere un’anima, anche se a lungo dimenticata.
E potrò, a mia volta, avere compassione della costrizione tutta femminile che spinge spesso la donna a ingenerare nel suo compagno una dipendenza dalle sue, e solo dalle sue, «grazie» – rincarando così la dose della sua non-libertà. Perché se per il maschio è spontaneo equiparare il bisogno sessuale a quello del mangiare o del bere, per la donna non è così: proprio per questo alla sbrigativa impellenza degli istinti maschili, essa ha aggiunto quella dilatazione del tempo che sa creare solo l’anima e che è fatta di seduzione – rendendo così ancora più arduo, ma anche più bello, il compito della libertà.
È ben chiaro che questi pensieri non vanno nella direzione di una certa moderna psicologia occidentale che molto si adopera per risollevarci da un tutt’altro tipo di caduta: la cosiddetta «caduta del desiderio» – dovuta allo stress, alla noia, al femminismo... si dice. È interessante vedere quante indicazioni oggi ci vengano offerte per «aiutarci» a lasciarci andare, per rafforzare la reciproca attrattiva e mantenere acceso il richiamo sessuale che pare si vada un po’ spegnendo. Ma se questo è da una parte un altro aspetto della confusione che si fa tra sesso e amore, dall’altra è forse proprio il segno che la sessualità da sola non convince più, non basta più, e che sia gli uomini sia le donne cercano un incontro più interessante, più vero e profondo.
E allora, forse val la pena porre attenzione a un altro segnale che si fa sempre più forte nei nostri tempi, e che di solito viene descritto con le parole «voglia di tenerezza». Se a questa espressione togliamo i toni dell’abbandono sentimentale o dell’indulgenza un po’ infantile, potremmo scoprirvi una nuova via che le forze dell’amore possono tracciare. È il desiderio di essere accolti con dolcezza quando siamo del tutto inermi nel mostrare la nostra nudità, è il desiderio di non essere giudicati quando emergono in noi le contraddizioni di una libertà minacciata. È il desiderio che fra uomo e donna ci si possa incontrare nel profondo, evitando di rincarare la dose degli istinti, avendo ognuno a cuore l’interezza della vita dell’altro tanto da riuscire a benedirla tutta con una carezza.
La via all’insù e la via all’ingiù
Se per un verso, nel corso dei millenni, l’anima femminile ha riscattato la sessualità dalla pura sfera animale, per un altro verso l’ingresso dell’anima – delle emozioni, dei sentimenti... – nella dimensione degli istinti corporei ha apportato nuove dipendenze. Se questo è vero, oggi l’uomo e la donna sono in grado di porsi una nuova domanda: cosa ne è, qui, del nostro spirito?
L’uomo è fatto di corpo, anima e spirito: nel corpo egli vive necessariamente la natura con tutti i suoi determinismi, nello spirito vive (se vuole) la capacità di creare pensando e amando liberamente, e nell’anima vive il raccordo oscillante fra i due mondi, la tensione che media fra due stati di coscienza polari. L’anima, in ogni campo della vita, è aperta sia al corporeo sia allo spirituale, può percorrere, cioè, sia «la via all’ingiù» che «la via all’insù»: è questo il libero arbitrio.
Però, se s’instaurasse un equilibrio stabile fra questi due grandi oggetti del desiderio dell’anima, non potrebbe esserci evoluzione. L’uomo oscillerebbe in modo sempre uguale tra spirito e materia. È per questo che la via dell’anima non rimane per sempre e ugualmente duplice: nel corso del tempo, l’anima umana o si apre sempre di più allo spirito, oppure si perde un po’ alla volta dentro il mondo della materia.
Nel primo caso l’anima cerca con sempre maggior determinazione le esperienze proprie dello spirito, e allora questo, attraverso di lei, raggiunge e compenetra di sé la realtà di natura «tirandola all’insù». Nel corso dei millenni lo spirito, l’Io di ogni essere umano, può assumere in sé, cioè assimilare e umanizzare l’interezza della materia terrestre fino a spiritualizzarla tutta in una «Terra Nuova»1.
Nel secondo caso, invece, l’anima tende sempre di più a immedesimarsi nei meccanismi del corporeo, e allora lo spirito può sempre di meno raggiungere la materia perché, per così dire, trova il passaggio ingombrato da forti brame volte al corporeo. L’anima comincia allora a dimenticare lo spirito, appagata da ciò che il corpo le può offrire. Allora l’Io, lo spirito umano, può solo riflettersi nella sua anima in tono minore, non può compenetrarla interamente, e questa sua debole luce riflessa (l’ego, l’io della normale coscienza intellettuale) si orienta essa stessa all’ingiù, verso la materia. La nostra epoca materialistica si trova proprio in questo sbilanciamento: vive di un’intelligenza che si dedica quasi esclusivamente al mondo materiale.
Come lo spirito è in grado, per attività sua, di spiritualizzare la materia, così la materia è in grado, per sua inerzia, di materializzare lo spirito riducendolo a pura luce riflessa – il che significa: involuzione. La materializzazione dell’intelletto umano si compie a mano a mano che l’individuo s’identifica con le leggi e i processi già stabiliti della natura, fino a farne in tutto e per tutto la sua logica. Può rafforzare talmente l’adesione alla sua dimensione di natura da elevarla a legge universale dell’esistenza. Un mondo fatto di macchine non è altro che questo. In questo modo l’uomo rinuncia gradualmente alla sua libertà, cioè all’individualizzazione del suo spirito, fino a perderlo del tutto rimanendo connesso al solo mondo della materia con tutte le brame che esso ingenera in lui – a un livello simile a quello animale. È la Bestia quale viene descritta nell’Apocalisse.
La fantasia femminile e la brama maschile
Come molti sanno, la scienza dello spirito, della quale Rudolf Steiner ha posto i formidabili fondamenti, è diventata la grande passione della mia vita. C’è una conferenza di Steiner del 4 gennaio 1922, nel volume 3032, dove vengono offerti degli spunti che mi paiono passibili d’infiniti svolgimenti di pensiero. Steiner non è solito far teorie: descrive in modo oggettivo ciò che percepisce nel mondo sovrasensibile, e proprio per questo le sue indicazioni possono essere estremamente feconde. Egli afferma in questo caso: l’anima della donna vive nella fantasia, nel mondo dell’immagine; l’anima dell’uomo vive nella brama, nel desiderio.
Va premesso che negli ultimi tempi, proprio a seguito del progressivo impoverimento dell’umanità volta al solo mondo materiale, numerose sono le donne che non conoscono più la loro anima, che vanno sempre più perdendo quel mondo di fantasia che l’uomo può ricevere in dono solo dalla donna. Tuttavia l’animo femminile da sempre porta in sé, per quanto oggi sopita, un’immagine ideale dell’essere umano e la cerca in ogni uomo.
Non è una ricerca intenzionale, la sua, non è un impegno o una conquista che deve fare volutamente giorno dopo giorno: la donna porta da sempre nella sua fantasia l’immagine compiuta dell’uomo ideale, cioè di quella parte migliore di sé che è l’Io vero di ognuno. Lo custodisce come un’intuizione morale più o meno nitida, a seconda del suo stadio evolutivo.
Che poi questa idealità si realizzi sulla terra solo un po’ alla volta, che in certi casi sia solo abbozzata, questo non ha importanza per la donna, perché nel suo animo l’immagine dell’umano rimane sempre pura e perfetta. La donna vive nel quadro compiuto di un ideale eterno nella sua bellezza, a cui non manca nulla, e lo intesse di una fantasia che non è capace di venire a compromessi.
Il maschio, invece, capisce poco o nulla di questo mistero di bellezza assoluta, perché la sua forza la esercita nel conquistarsi i frammenti dell’umano uno dopo l’altro, con lo scorrere del tempo, realizzandoli a brano a brano nell’esistenza terrestre. Egli vive nella brama evolutiva che aggiunge pezzo a pezzo, e va incontro alla donna sempre nel desiderio di rendere reale un altro aspetto dell’umano, e poi un altro e un altro ancora.
Il maschio dice: a che serve bearsi di un ideale tutto bello e perfetto se poi nella realtà ce n’è così poco? Quello che conta è ciò che siamo capaci di concretizzare nel mondo visibile. L’uomo maschio ama «il successo» che scandisce e realizza il suo operare nel tempo, egli conta e mette in mostra a una a una le conquiste che fa vivendo sulla terra.
L’umano è fatto di eternità – che la donna protegge nella propria fantasia –, ed è fatto non meno di evoluzione nel tempo, dove le dimensioni dell’essere devono venir conquistate una dopo l’altra dalla libertà umana – e il maschio sente qui il pulsare della sua stessa vita.
Nell’atto di procreazione la donna accoglie dentro di sé l’archetipo dell’umano che s’incarna nel suo figlio, e il maschio col suo sperma distrugge nell’ovulo femminile le forze formanti della matrice universale della specie umana, per far posto a quelle del tutto individuali di colui che s’incarna per vivere una vita che è tutta sua.
Così, la donna vive di fantasia e l’uomo vibra di brama. L’uomo cerca nel tempo la realizzazione frammentata e martellante dell’umano, e la donna ne custodisce gelosamente in sé l’immagine integra e immortale per impedire al logorio del tempo di snaturarla o di farla perdere.
Possiamo così capire meglio perché il maschio nella vita oscilli tra il corpo – strumento e luogo di tutto ciò che «prende corpo» sulla terra – e lo spirito, fonte di ogni pianificazione e di ogni progetto. L’elemento mediano, quello dell’anima, dove il corpo e lo spirito s’incontrano e si «animano» a vicenda, lui lo conosce poco. Perciò il corporeo rischia di diventare per lui pura materia priva di spirito, e lo spirito tende in lui a farsi pura astrazione, speculazione avulsa dalla vita.
La donna si sente a casa sua nel mondo dell’anima: in lei la materia anela allo spirito, e lo spirito vuol sempre tornare a vivificare il mondo della materia. Perciò le donne vivono più intensamente degli uomini nel mondo delle emozioni, dei sentimenti, delle gioie e dei dolori, degli slanci del cuore.
L’anima viene coltivata troppo poco nella nostra cultura materialistica. Il maschio dedica tutte le sue energie alla scienza (allo spirito astratto, senza anima) e alla tecnica (al mondo della materia, che nega la realtà dello spirito). Si sente a suo agio nella dimensione puramente fisicomateriale, da un lato, e in quella puramente logico-razionale, dall’altro. Senza troppa anima che s’intrometta a disturbare o a complicare le cose più di tanto. Alla donna, alla sua anima, vorrebbe riservare solo la sfera «privata» della vita.
Se la cultura in cui si vive è di stampo patriarcale – quello che non sopporta l’anima della donna e non le concede i suoi spazi –, il maschio viene a trovarsi in una situazione dove quel poco di risonanza che il mondo gli suscita nell’animo viene del tutto ignorata, mentre la donna vede continuamente mortificato il suo stesso essere, che si muove in modo privilegiato proprio nell’anima e che deve lottare per il puro diritto di poter respirare almeno un po’. Si può immaginare che molte donne vivano una delusione dopo l’altra in un mondo tutto rivolto a ciò che si vede e si tocca, che non ha tempo per i gesti dell’amore, che pensa di sprecar tempo quando si tratta di dar voce all’anima.
1 Questo è il processo di incarnazione dello spirito umano individuale ― l’Io ― che puo’ cosi nel lungo corso del tempo operare la redenzione, o liberazione, di tutto ciò che e corporeo, quella che il Cristianesimo esprime nel mistero finale della resurrezione della carne o transustanziazione, cioè mutamento di sostanza, di tutta la realtà fisico-materiale.
2 Rudolf Steiner Il sano sviluppo dell’essere umano O.O.303, vol. II – Editrice Antroposofica, Milano 1998.
Amore, morte e sessualità: c’è un nesso?
Gli uomini hanno da sempre avvertito che c’è un misterioso rapporto fra il sesso, l’amore e la morte, e l’hanno espresso nei loro miti e nelle loro opere d’arte. Questo tema fondamentale investe tutti i livelli dell’umano: l’atto sessuale tocca la natura del corpo, l’amore è la forza più profonda dell’anima, e la morte è la vicenda più radicale nell’evoluzione dello spirito.
Il senso della «caduta» verso il basso, cioè verso il mondo della materia, è quello di poter venire gradualmente trasformato dalla libertà umana in una caduta verso l’alto. La natura ha fatto cadere l’uomo per dargli la libertà di risalire, se vuole e come vuole. La discesa dello spirito umano dal «paradiso» dello spirito fin nelle strettoie della natura è stato un lungo e graduale processo evolutivo di oscuramento della coscienza. Ai primordi dell’evoluzione terrena l’uomo era illuminato di spirito ma non aveva ancora coscienza di sé come individuo singolo, perché il sentirsi separati dal resto del mondo è un’esperienza che sorge solo grazie alla materia.
Anche la procreazione avveniva in tempi antichi senza che l’uomo vi partecipasse coscientemente, come del resto accade ancor oggi per tanti processi fisiologici. Basti pensare alla digestione, che è un fatto di natura non meno della procreazione: non sia mai che il nostro stomaco compia soltanto quello di cui noi siamo consapevoli o quello che gli comandiamo noi! Fa tante cose di cui non abbiamo nemmeno un barlume di coscienza, e proprio per questo digeriamo tranquillamente. Ci rendiamo conto di avere uno stomaco solo quando ci fa male – vale a dire: quando interveniamo con la nostra coscienza cominciano i pasticci.
Con la caduta nella materia, la coscienza umana è penetrata a poco a poco nella sfera degli istinti, e così si è aperta per lei la possibilità non soltanto di provare delle sensazioni ma anche di sapere di provarle. Un animale, o anche un bambino appena nato, sentono sia piacere che dolore, ma non sanno di sentirli, non se ne rendono conto, e di conseguenza non ci possono far nulla. Non potendo riflettere sul proprio stato, non possono neanche intervenire a gestirlo liberamente, come fa l’adulto quando dice: oh come sto bene! dunque continuo a far questo... Oh come sto male!, dunque provo qualcos’altro...
Nella fase infantile dell’evoluzione, erano le forze naturali della procreazione ad agire nell’uomo e tramite l’uomo, sfociando «per natura» nella riproduzione, come avviene tutt’oggi per gli animali. Col passar del tempo la coscienza umana è «caduta» dentro le forze della generazione, e l’uomo ha cominciato a poter decidere consapevolmente e liberamente come usarle, servendosene per esempio per procurarsi un piacere puramente egoistico.
Come conseguenza di questa libertà nei confronti della sessualità è sorto uno sbilanciamento che ha messo in forse anche la parità fra uomo e donna. Piacere sì, piacere no, le donne per secoli e secoli hanno continuato a partorire e allevare numerosi figli. Là dove subentra la coscienza, quel che conta è però l’intenzione che l’essere umano mette nel compiere un’azione: un uomo e una donna possono avere molti figli e tuttavia, per motivi diversi, non averli tutti «voluti». Dio ce li ha mandati, sono doni di Dio, si diceva una volta – e magari si dice ancora, da qualche parte. Ma di tutta questa generosità divina, forse, molti avrebbero fatto volentieri a meno.
Nell’atto sessuale l’uomo arriva dunque a potersi chiudere in sé, staccandosi dallo scopo per natura «altruistico» di quelle forze che servono all’incarnazione di un altro essere. La sessualità comporta allora di necessità la scelta fra l’intenzione di generare e quella di negare la vita. L’atto del procreare non può che essere o il massimo di apertura verso un altro uomo per offrirgli l’accesso alla vita, oppure il massimo di chiusura in sé e di conseguente solitudine.
Tutte le forze di natura che non siano quelle sessuali danno vita o morte in modo non assoluto: si può esagerare col mangiare, col bere, con la veglia e con il sonno, stravolgendoli oltre quella misura giusta che la sana vita del corpo richiede, e costringendo così anche il proprio spirito a languire, perché avrà sempre più difficoltà ad avvalersi di uno strumento terreno strapazzato. Le forze della procreazione, invece, se vengono pervertite nella loro natura, se vengono invertite nel loro scopo naturale, agiscono direttamente sullo spirito umano mortificandolo senza mezze misure. In questo campo si decidono in modo radicale le sorti della libertà umana.
Si può allora dire che il punto cruciale della caduta, quello in cui la libertà ha la possibilità di darsi essa stessa la morte, è il confondere fra loro amore e sessualità. L’esperienza del massimo egoismo, del più totale annullamento di sé dentro gli istinti del proprio corpo, impedisce all’uomo di aprirsi ad altri esseri in quanto lo chiude ermeticamente in sé. E non aprirsi agli altri, non amare, è per l’uomo come morire.
Ogni essere umano che abbia vissuto fino in fondo la solitudine – che è il frutto maturo di tutte le forme di egoismo, non solo nell’ambito della sessualità – saprà cosa vuol dire decidere di lasciarsela il più possibile alle spalle. Chi ha vissuto intensamente la morte della chiusura in sé non ha bisogno che qualcuno gli vada predicando il dovere morale di vincere l’egoismo: decide volutamente di farlo proprio perché l’esperienza ripetuta del relegarsi in sé non l’ha reso felice – anzi l’ha reso infelice, estraniandolo sempre più dagli altri e dal mondo.
«Ti amo da morire»
Amo l’altro di un amore ogni giorno più vivo solo quando sento che diminuisce in me il bisogno del suo corpo. Soltanto facendo gradualmente affievolire l’intensità di questo bisogno sarò sempre meno costretto ad andargli incontro solo perché non ne posso fare a meno.
Il corpo rappresenta il mondo complessivo dei nostri bisogni, e perciò è anche il luogo dei forti contrasti, delle reciproche esclusioni: se la pastasciutta che ho davanti deve saziare la mia fame, non potrà contemporaneamente sfamare te. Nessuno, per il semplice fatto di consumare cibi e bevande alla stessa tavola, si sognerebbe di dire che sta appagando il bisogno dell’altro, e che perciò lo sta incontrando e amando. Nell’atto sessuale, invece, spesso ci illudiamo di amare l’altro perché è difficile ammettere che si sta usando il suo corpo per il godimento che ci dà.
Questa forma d’egoismo viene evocata e accesa dalla presenza dell’altro, e perciò può apparirci come un generoso amore. Ma il fatto che il mio corpo serva a lui non meno di quanto il suo serva a me, non vuol dire che io gli offra anche il mio cuore, e lui il suo a me. E in fondo non posso offrire all’altro in modo libero e amorevole neanche il mio corpo quando sono determinato dal mio bisogno – da ciò che voglio io – anziché dall’amore che, per natura sua, è attenzione all’altro.
Qualcuno potrebbe domandarsi perché nel caso della sessualità non debba valere la stessa «difesa del primo amore», cioè dell’egoismo, che ho lanciato all’inizio di questo libro. Perché quando l’amore verso me stesso chiede la soddisfazione del mio bisogno sessuale, io non posso semplicemente aggiungervi l’amore per il soddisfacimento del bisogno dell’altro – ama il prossimo tuo come te stesso? Si può rispondere che anche qui vale quel che si è già detto, ma forse è necessario approfondire da un’altra visuale il carattere illusorio di tutti gli egoismi.
Poniamo che io sia un grande egoista in fatto di denaro: più ne accumulo e più sono contento. Decido un giorno di voler cominciare a favorire anche i guadagni del mio prossimo: cosa ne conseguirà, col tempo? Che proprio ponendo attenzione e dedizione agli interessi finanziari degli altri, a poco a poco vedrò trasformarsi e ridursi i miei. Non solo: scoprirò che è possibile favorirsi vicendevolmente solo se ognuno vince sempre di più la propria avidità di denaro, sostituendola con una mentalità di solidarietà.
Intendo dire che la dinamica stessa dell’interessarsi all’altro comporta la scoperta di una dimensione del tutto nuova dell’essere, non dell’avere. E proprio in questa reciprocità di attenzioni le mille facce dell’egoismo vengono superate e dismesse, nel corso di un’evoluzione che abbraccia millenni. Amare l’altro come me stesso non significa affiancare due egoismi, il mio e il suo. Significa per entrambi vincere l’egoismo – ognuno il suo, ognuno dentro di sé.
Se fosse vero che nasce la più profonda unione fra due persone quando decidono di assecondarsi a vicenda nelle loro pulsioni sessuali, per quale motivo il mondo dovrebbe essere pieno di «amori» che muoiono e di nuovi che nascono cancellando i precedenti? Pesa dover riconoscere che l’istinto puro ci porta via, anche se dapprima solo momentaneamente, ogni capacità di rendere importante l’altro. Quali che siano i modi dell’eccitazione, è nella loro natura di escludere non solo la coscienza di sé ma anche quella dell’altro. Bisogna annullarsi e «lasciarsi andare», bisogna annullare anche l’altro e «lasciarlo perdere» per far sì che la natura possa operare indisturbata e sovrana. E quando uno dei due, solitamente la donna, davvero vuol pensare all’altro nell’atto sessuale, di fatto pone in secondo piano il proprio bisogno e trova così un appagamento dell’animo che è di tutt’altra natura rispetto a quello fisico.
Nell’istinto puro non si può che morire alla coscienza di sé e non si può che far morire in sé anche la coscienza dell’altro. Questo è il significato vero dell’espressione: «Ti amo da morire». Raramente significa: «darei la mia vita per te».
In una bella fiaba persiana si narra di un giovane che durante un viaggio verso un santuario incontra un monaco con il quale condivide il cammino e il cibo. Al momento di separarsi, il giovane vuol sapere il nome del compagno, ma deve insistere molto prima di ricevere la risposta: «Io sono l’Angelo della morte». «Dimmi allora quand’è che io morirò», chiede il giovane. «Morrai la notte delle tue nozze».
Il giovane per anni rifiuta di sposarsi finché, di fronte all’insistenza dei suoi vecchi genitori, è costretto a rivelare il suo segreto. «Figlio mio», gli dicono il padre e la madre, «non preoccuparti: sposati, e quando l’Angelo verrà noi vecchi gli daremo la nostra anima al posto della tua». Il figlio trentenne celebra il suo matrimonio e, al sopraggiungere della notte, mentre i due sposi novelli stanno prendendosi per mano, puntuale si presenta l’Angelo della morte. Subito il padre, chiamato in soccorso, offre la sua anima, ma quando l’Angelo gliel’ha estratta fino all’altezza del petto, il vecchio ci ripensa, spaventato. Allora si fa avanti la madre ma anche lei, quando sente l’anima arrivarle all’altezza della gola, si tira indietro. Dice allora la sposa: «Io non voglio che si possa dire che io sono la disgrazia del mio sposo. Prendi me». E quando l’Angelo è arrivato a tirarle via l’anima fino al naso, risuona la voce di Dio che dice: «Lasciali in pace tutti e due! Grazie allo spirito di sacrificio della sposa, dono a entrambi trent’anni di vita insieme».
Nelle immagini di questa fiaba è espresso il mistero del legame inscindibile tra amore, sesso e morte. Per non morire all’amore, è necessaria un’altra morte: il sacrificio di sé, cioè della somma del proprio egoismo. Ciò vuol dire che più è viva l’attenzione verso l’altro e più si muore alla pura pulsione dell’istinto. Più ci si «distrae» dalla propria corporeità e meno ci si chiude in se stessi, meno si fa morire l’amore. Più si coltiva questa sana «distrazione» che salva dalla morte interiore, e più si attenua anche, nel tempo, l’irresistibilità della sessualità, la sua irruenza. Proprio come diceva Diotima a Socrate: dapprima ci s’innamora del corpo dell’altro, poi si ama il calore della sua anima, poi la luce del suo spirito – e in essi si risorge dalla morte che il corpo tende a dare quando non ci apriamo al mondo dell’anima e dello spirito.
Ciò che da sempre viene chiamato «purificazione», e che oggi il materialismo volentieri considera come il ripiego ascetico e anche un po’ risibile di chi non riesce a godersi «il meglio della vita» – cioè la beatitudine dei sensi – vuol essere invece il cammino stesso dell’amore. È l’intento di fare dell’altro, giorno dopo giorno, non lo strumento del proprio egoismo, ma il fine del proprio amore. Purificare sé per amore dell’altro non significa reprimere gli istinti o fustigarli; significa volerli capire per quello che realmente sono non solo nella compagine del proprio essere, ma anche nei loro influssi sul rapporto con l’altro e direttamente sull’altro. Significa liberarsi sempre più da tutto quello che ci rende schiavi, così da poter incontrare l’amato con le forze della libertà e della vita, non con quelle della prigionia e della morte.
Amo l’altro quando amo la mia libertà non meno della sua, perché solo nella libertà posso riconoscere l’autenticità e la verità dell’umano anche in lui. Non lo amo quando pongo in primo piano, per lui e per me, il diritto potente e prepotente del nostro reciproco bisogno, cioè la carenza dell’umano e dell’amore.
«Ti amo perché posso vivere anche senza di te»
L’anima è il luogo dei desideri, il corpo quello dei bisogni. Le anime di un uomo e di una donna tendono a incontrarsi, mentre i due corpi non possono far altro che restar chiusi ognuno in se stesso. E solo i loro spiriti di uomini liberi possono diventare uno, grazie all’intuizione pensante che ognuno ha dell’essere dell’altro.
L’uomo cerca nella donna la propria anima, senza voler perdere la forza spirituale del suo pensare razionale, e la donna cerca nell’uomo il proprio spirito, senza voler perdere il calore della sua anima. E in quell’abbraccio reciproco si ricostituisce l’Adamo primigenio che era maschile e femminile a un tempo, in quella comunione si ricongiungono l’eternità, che fa donna la donna, e il tempo, che fa dell’uomo il maschio che procede di conquista in conquista.
E a questo punto possiamo porci la domanda: è immortale l’amore? L’amore non può mai morire, dice l’animo femminile che vuol vivere in ciò che è eterno, che trova angoscioso il pensiero che il suo amore possa perire: oggi l’amore è il tutto di me e poi verrà un giorno in cui non ci sarà più...?
L’abbiamo visto: ciò che muore, dell’amore, è tutto quello che si esaurisce nel corpo, e come il corpo non può che morire, prima o poi. Ma se è vero che non c’è nulla nell’anima e nello spirito che non s’incarni anche nel corpo, che non confermi la preziosità del corpo legandoci ad esso, dev’essere anche vero che il corporeo può diventare immortale ogni volta che l’anima e lo spirito lo prendono con sé e lo umanizzano, liberandolo dalle costrizioni della natura e dalla caducità per renderlo eterno.
Amare significa allora morire quotidianamente a tutto quello che è passeggero, per rinascere a ciò che è eterno. È la decisione di non restare attaccati alle cose destinate a scomparire, di unire il nostro cuore a ciò che non tramonta mai. Ognuno di noi è tanto immortale quanto sa amare.
Una persona che rivolga tutti i suoi desideri a ciò che è materiale, che conosca quasi solo brame per la cui soddisfazione è necessario il corpo, cosa farà dopo la morte, quando il corpo non ce l’avrà più? Ci sono persone per le quali il mangiare e il bere sono l’occupazione più importante della vita: la fame è un istinto del corpo e col corpo scompare, ma i desideri aggiuntivi del buongustaio fanno parte della sua anima, e restano anche quando lascia il corpo. Però, dopo la morte, c’è di nuovo che l’anima, mancando del corpo, non può più appagare quei desideri. È costretta a struggersi in sé fino al punto da letteralmente bruciare e dissolvere quelle brame, così da non patire più la terribile sofferenza di non poterle soddisfare. Tutte le religioni parlano di queste «fiamme del purgatorio» che purificano le anime dei defunti da tutte le brame legate al corpo. Lo stesso vale per chi è patito dello sport – per dar calci al pallone ci vuole il corpo –, per chi è patito del sesso, o del tabacco o del più delizioso Chianti. Nella misura in cui l’uomo volge il suo cuore a ciò che è corporeo, rende effimero il suo stesso «amore».
Se amassimo sempre di più ciò che non passa ci sentiremmo immortali, invece al mondo c’è tanta paura della morte. E questo vuol dire che siamo appena all’inizio di un lungo cammino che ci trasforma in amore. All’inizio, amiamo l’altro col desiderio di venire contraccambiati, e questo è ancora amore di sé. Nulla di male, non lo facciamo certo per cattiveria, però non possiamo chiamarlo puro amore verso l’altro. Quando il mio desiderio di venir contraccambiato è assoluto, questo desiderio si trasforma in bisogno, ed è questo bisogno che io amo. Pongo delle condizioni all’altro – deve amarmi anche lui, e come desidero io – e le pongo a me stesso, perché il mio modo d’amare è deciso da quello che ho bisogno di ricevere. E ogni bisogno che «ha bisogno» del corpo per venire appagato, è in me un frammento di mortalità.
L’amore diventa immortale nella misura in cui diminuisce il bisogno non solo fisico, ma anche animico dell’altro, e io riesco a vivere anche senza la sua presenza fisica. Quando è così, posso continuare ad amarlo anche oltre la sua morte. La ricompensa dell’amore vero è di poter amare, non di venir riamato. La sua gioia più grande è amare senza condizioni, e questo può avvenire anche oltre la morte.
L’amore non è né un diritto né un dovere: non è un dovere perché è un dono del tutto gratuito, e non è un diritto perché chi accampa diritti non ama. Certo che almeno un po’ di bisogno d’essere riamati ce l’abbiamo tutti, ma questo ci dice che non siamo ancora perfetti nell’amore. D’altro canto, tutti abbiamo anche un’idea di che cosa sia l’amore gratuito. E siamo tutti per strada, per trasformare ogni bisogno di essere amati in un puro bisogno di amare. Come il fiore che offre sempre il suo profumo a tutti, senza sognarsi di ricevere ringraziamenti.
L’amore che travalica nascita e morte
Nessuno può avere esuberanti forze d’amore da donare agli altri senza che nel passato tante persone l’abbiano aiutato a svilupparle. Il Cristo si china a lavare i piedi dei suoi apostoli in un gesto di gratitudine, affermando esplicitamente che lui stesso non potrebbe essere il Maestro se non ci fossero i discepoli, non potrebbe essere il Redentore se non ci fossero esseri umani bisognosi di redenzione.
Per ogni uomo che è pieno di forze d’amore, ce ne sono tanti altri che gli hanno dato la possibilità di andare avanti sulla via dell’evoluzione. Ovunque si costruiscano forze positive, esse sono dovute a chi in qualche modo vi ha rinunciato a favore di qualcun altro. Essere più capaci d’amore di altri è sempre dovuto al sacrificio di questi altri – compiuto consciamente o no, non ha importanza. La ricompensa che riceve chi davvero ama è di essere già stato amato nel passato, e ogni amore sincero non può che essere intriso di gratitudine. Chi ama sa di ricambiare col suo amore l’amore altrui, sa di essere infinitamente debitore. Dimmi quanto ami e ti dirò quanto sei stato amato dagli altri nel passato. Amare vuol dire esser grati per una ricompensa già ricevuta in anticipo.
Quando sentiamo quella «compassione» di cui si è già parlato, sentiamo il desiderio di restituire agli altri delle forze d’amore alle quali hanno rinunciato nel passato a favore nostro. Questa compassione non ha nulla a che fare né con una pia condiscendenza, né con un’altezzosa commiserazione, e appare anche ben diversa dal lasciar correre, dal cedere alle richieste dell’altro che vorrebbe fare di me quello che gli piace.
Prendiamo un caso comune: spesso nel rapporto di coppia c’è uno sbilanciamento in fatto di attenzione, di parole e di gesti d’amore. Supponiamo che uno dei due sia convinto che certi nodi si sciolgano solo immettendo nel rapporto più amore di quanto sia capace di metterci l’altro. Non nel senso dell’«amare di più» – perché o si ama o non si ama – ma nel senso di affrontare con forze d’amore un numero sempre maggiore di situazioni, che altrimenti rischierebbero di precipitare nello scontro. Ma proprio questa è la compassione: essere contenti di mettere in gioco più forze d’amore, proprio perché avendole ricevute dagli altri se ne hanno in esubero, e non si cerca una ricompensa, e tanto meno un tornaconto.
Spesso questo accade spontaneamente, senza che se ne capisca del tutto il significato. Ma ciò che concretamente, come reale forza interiore, dà la legittimità di amare in esubero sentendo compassione per l’altro – senza misticismi e senza complessi di superiorità – è soltanto la consapevolezza che l’altro mi viene incontro proprio perché cerca inconsciamente una restituzione da parte di chi si è preso il bel diritto di saper amare di più. Ogni persona che incontra chi ama, lo fa col desiderio di essere fatto partecipe dell’amore dell’altro, perché sa che gli appartiene.
L’amore è per natura compassionevole perché sa mettersi nei panni dell’altro, è una forza redentrice che non emette giudizi o condanne, è sempre liberante perché dice: queste forze di amore che sono intessute al mio essere le ho ricevute anche da te, e come potresti desiderarmi, tu, se non cercassi in me un frammento di te? È un tipo di compassione, questa, che non infastidisce, che non puzza di sagrestia. Ognuno di noi può dare solo ciò che ha, e ciò che ha lo ha ricevuto, e non l’ha ricevuto in diretta da un qualche Padreterno seduto sulle nuvole, ma dall’incontro con altri esseri umani.
Vista così, vissuta così, la sovrabbondanza che è propria dell’amore non ci fa mai dire all’altro: però, tu, non te ne approfittare! Chi ama davvero ha la forza di dire: se l’altro se ne approfitta è una faccenda sua, non mia. Fa male a sé, non a me. Però mi rende la vita difficile, impossibile! –, si sente protestare. Ma non è vero: se dico questo è soltanto perché in me le forze dell’amore e della compassione hanno i loro limiti. Più l’amore coglie occasioni di manifestarsi, di esserci, e meno ha bisogno di ricattare risparmiandosi. Chi ama davvero sa che l’altro non può mai far diminuire il suo amore, e gl’interessa soltanto continuare ad amare. Nessuno può fargli del male, perché amare è la forza che trasforma in bene ogni male. Chi ha la fortuna di poter amare anche chi se n’approfitta, non fa che rendere più forte e immortale il suo amore, e con esso la sua gioia e la sua gratitudine.
Se capiamo questo, ci rendiamo conto che le forze dell’amore, non avendo confini, oltrepassano sia il limite della nascita sia la soglia della morte. Una persona non può essere diventata profondamente capace di amare in una vita sola, e chi gli sta accanto non può averle dato in una sola esistenza tutti i doni che le ha elargito. E allora è fondamentale che si comincino a pensare pensieri giusti a questo riguardo, se non si vuol continuare a vivere in una realtà apparente, che genera una spirale di recriminazioni e prepotenze. E uno dei pensieri più importanti per capire l’amore nella sua immortalità è di chiedersi se è proprio vero che a ogni uomo è dato di amare e di essere amato soltanto in una vita. Se è vero che l’amore è immortale, se dopo la morte non può che rinascere a una vita nuova, allora anche l’amore che adesso sentiamo in noi dev’esser frutto di tanti doni ricevuti in un lungo passato, di un cammino che non si limita all’arco di questa esistenza.
Chi oggi sa amare più degli altri, nel passato deve aver messo in primo piano la propria evoluzione, e in secondo piano quella altrui. Se avesse scelto di dare la precedenza agli altri, oggi quelle forze d’amore le avrebbero loro. Amare significa capire che l’amore è sempre un dono che ci viene dagli altri: nessuno di noi può avere in sé un solo grammo d’amore che non gli sia stato regalato dall’amore altrui. Nessuno può essere diventato ricco d’amore senza che l’umanità intera gliel’abbia consentito, concentrando in lui un bene che viene da tutti ed è destinato a tutti.
Se si guarda alla diversità profonda delle forze d’amore fra una persona e l’altra, si giunge prima o poi al convincimento che l’evoluzione dell’uomo non è racchiusa tra questa nascita e questa morte. L’esperienza dell’amore è l’esperienza di ciò che è immortale ed eterno in noi, perché travalica i confini di ogni nascita e di ogni morte.
I pensieri, le opere e le parole dell’amore
È insita nell’esperienza dell’amore la dinamica di morte e resurrezione, e ciò perché amare significa sempre scegliere, e scegliere vuol dire a sua volta lasciare qualcosa. E ogni volta che si lascia qualcosa si fa un’esperienza di morte, si muore a un frammento di sé, a qualcosa che faceva o poteva far parte del proprio essere. L’amore ci fa morire ogni volta che ci fa scegliere.
È innanzitutto nella sfera corporea che bisogna scegliere, perché essa è per natura esclusiva. Se una donna sceglie un uomo come padre dei suoi figli, deve escludere tutti gli altri uomini dall’esserlo. Le tocca morire a tutte le altre eventualità, vi deve rinunciare: tutti frammenti possibili di sé, tutti altri amori che decide di non far suoi per amare colui che sarà il padre dei suoi figli. Perché almeno questo è certo: ogni bambino che nasce ha un padre solo e una madre sola. L’esclusività in questo campo è assoluta.
Le opere dell’amore che io compio con le mie mani sono dedicate a poche persone scelte. Tutte le altre non le riceveranno da me. E per queste poche persone io potrò prodigarmi coi miei servizi solo finché saranno in vita, non più dopo la loro morte. Io non posso stringere la mano a un defunto, non posso cucinargli un pasto buono, non posso accompagnarlo al teatro né andarlo a prendere in ufficio...
L’amore che si esprime nelle azioni concrete legate alla corporeità ci fa morire a tutto quello che non possiamo fare per altri, ma ci fa anche risorgere alla preziosità assoluta di chi abbiamo accanto, di chi abbiamo scelto e di chi ha scelto noi. Quest’amore incarnato diventa immortale attraverso quel che ci fa vivere nell’animo e che ci fa diventare nel nostro spirito. Ognuno può dire alla persona che ama: per amare te ho dovuto morire a mille altri possibili amori, e perciò mi sei così cara. Le azioni che ho fatto per te hanno impresso nel mio cuore un amore che ti accompagnerà anche oltre la morte.
Se le opere dell’amore ci fanno incarnare l’amore, circoscrivendolo nello spazio e nel tempo, i pensieri d’amore travalicano sia lo spazio sia il tempo, e non hanno bisogno di escludere nessuno, possono abbracciare tutti gli esseri umani e tutte le creature. E allora il modo migliore di amare una persona alla quale siamo fisicamente legati è di vincere l’esclusività amandola per ciò che lei è, da sempre e per sempre, all’interno di quell’organismo vivente che è l’umanità intera. Dedicandomi a lei, pensandola e riconoscendola non solo nella sua dimensione individuale ma anche in quella universale, porto nel mio cuore tutti gli uomini cui lei appartiene per tutta l’eternità.
Alla persona che amo dico: posso amare te solo amando nell’incontro con te l’umanità intera a cui tu e io apparteniamo. Proprio come non posso amare il mio corpo senza amare il suo rene, né posso amare il rene trascurando l’insieme del corpo. I pensieri d’amore non conoscono limiti di spazio o di tempo: lì non c’è nulla da scegliere, non c’è nulla da lasciare. Quando il corpo muore – e la morte è una pura faccenda dell’elemento minerale –, tutti i pensieri d’amore restano illesi e diventano ancora più belli perché vengono vissuti oltre lo spazio della terra e oltre il tempo della vita.
A far da ponte fra le opere dell’amore e i pensieri dell’amore ci sono le parole d’amore. I pensieri esprimono l’amore nello spirito, le opere lo esprimono nel corpo, le parole nell’anima. Le parole che pronuncia un cuore che ama rendono immortale l’amore: vengono dette attraverso gli organi del corpo ma la mente di chi ama e di chi si sente amato le fa sue e le rende eterne, le porta con sé per sempre vincendo ogni paura della separazione e della morte.
Quando dentro di me riecheggia la memoria delle parole d’amore che mi ha rivolto una persona che mi ama, non esiste più alcuna separazione tra me e lei. Questa persona può essere lontana, può perfino morire, ma le sue parole d’amore restano parte di me. Nel dialogo dell’amore voliamo insieme sulle ali dell’anima che rendono immortale ogni moto d’amore. Il cuore custodisce le parole della persona amata facendone la sua vita, e fa eterno anche l’incontro più fuggevole.
Le parole che nascono da un cuore che ama non sono parole qualsiasi: riescono a trafiggere il cuore dell’amato. Più colgo il peso morale delle parole di chi mi ama e più mi entrano nell’anima per non uscirne più. Una persona che si sia sentita amata veramente anche una sola volta in vita sua, porterà con sé quest’amore per tutta l’eternità, nessuno glielo toglierà più. È una grande fortuna aver fatto quest’esperienza, e forse oggi sono troppi coloro che non l’hanno mai fatta.
Abbiamo una grande responsabilità nei confronti delle parole d’amore che ci scambiamo, perché solo se in esse ci mettiamo tutta la dedizione di cui siamo capaci potranno raggiungere il cuore dell’altro, e viverci per sempre.
La meraviglia, la compassione, la coscienza morale: l’amore tre volte immortale
Amare significa morire alla chiusura in se stessi, vuol dire vincere la solitudine dei propri bisogni per aprirsi all’altro e rinascere in lui. Così si muove l’amore, e sono tre le vie che percorre: la via della conoscenza, che è l’amore della mente, la via della compassione, che è l’amore del cuore, e la via della moralità, che è l’amore della volontà che si esprime nelle azioni.
Nel sesto secolo prima di Cristo, quale preludio e preparazione all’entrata nella terra dell’Essere fatto tutto di amore, sono sorte nell’anima umana tre forze nuove: la meraviglia nella Grecia dei primi filosofi; la consapevolezza della necessità della compassione nell’India del Buddha; e la coscienza morale nella cultura ebraica.
I greci affermavano che la filosofia, l’amore alla conoscenza, nasce con la meraviglia, con la capacità di stupirsi θαυµαζειν (thaumàzein). È vero: la mente capisce meglio il mondo ogni volta che rinnovando il suo stupore lo fa entrare in sé in un modo diverso. L’amore non finisce mai di meravigliarsi dell’essere dell’altro, e sa mantenere acceso il desiderio di conoscenza non dando mai nulla per scontato, aprendosi ogni giorno a nuove sorprese, e a nuove scoperte. La capacità di sorprendersi è amore che diventa conoscenza, è apertura incondizionata allo spirito che illumina il mondo.
Questo atteggiamento dell’anima è un’eco del mondo spirituale nel cuore dell’uomo: lo stupore è l’inizio della conoscenza perché capisce veramente le cose soltanto chi si sbalordisce di vederle fuori di sé. Platone sapeva ancora che c’è in ogni uomo un ricordo inconscio di quel che ha vissuto quand’era nel mondo spirituale, prima di piombare dentro il corpo fisico. Lì non viveva fuori degli altri esseri, fuori delle cose, ma si sentiva dentro di loro.
I nostri sensi fisici, invece, ci fanno percepire un mondo che ci sta di fronte, che appare tutto esterno a noi. Questo estraniamento apre uno spazio d’indifferenza che pone una distanza fra noi e le cose, e questo ci provoca a creare col pensiero i concetti che ridanno significato alle cose, che ce le fanno incontrare trasformandole in tante faville del nostro spirito. E così, a poco a poco, facciamo rientrare tutto l’universo dentro di noi.
Vien da pensare al bambino sulle braccia della Madonna Sistina di Raffaello, con quei suoi occhi stralunati: in essi c’è tutto lo stupore, quasi lo spavento di fronte a un mondo che si è distaccato dall’uomo e si svolge tutto fuori di lui. Per questo i bambini vogliono sempre ascoltare le fiabe: perché sono piene di meraviglie. Sono appena venuti dalle vastità del cielo senza confini, e vogliono ancora immergersi in esse. Soltanto chi guarda il mondo con occhi stupiti di bambino lo fa entrare nel suo cuore, e lo rende parte di sé.
Nello stesso periodo in cui i greci parlavano della meraviglia come inizio di ogni conoscenza, in oriente il Buddha affermava che senza compassione e senza amore l’uomo è condannato alla sofferenza. Il Cristianesimo ha poi aggiunto che non basta rendersi conto che senza amore non c’è evoluzione, non basta la teoria della compassione e dell’amore: bisogna che l’uomo faccia l’esperienza anche delle forze reali dell’amore. E così, come il Buddha ha portato all’umanità la consapevolezza del fatto che senza amore non c’è redenzione, il Cristo ha portato la realtà dell’amore, e l’ha reso operante nel cuore di ogni uomo.
Se lo stupore conoscitivo è l’amore specifico della mente, se la compassione è l’amore specifico del cuore, la coscienza morale è l’amore specifico della volontà. È l’amore che si esprime nelle mani, nelle braccia, nelle azioni buone, è la capacità di farsi responsabili dei destini di ogni essere umano, e soprattutto delle persone che ci sono accanto.
L’inizio della formazione della coscienza morale l’umanità lo deve al contributo specifico del popolo ebraico, come preparazione alla venuta del Messia. Il popolo del monoteismo è quello che in modo esemplare ha potuto costruire in sé la forza dell’Io individuale e moralmente responsabile delle sue azioni. Prima d’allora non esisteva neanche la parola per designare la coscienza morale del singolo.
La morte passa, l’amore resta
Che cos’è allora oggettivamente la morte? Nulla. Proprio nulla.
La morte è un fatto soggettivo della coscienza, è quell’illusione specifica che esiste solo nella coscienza umana nel suo stato di caduta. Lì sì che la morte c’è, ed è realissima: è la paura di scomparire nel nulla quando il proprio corpo finisce di vivere. Oltre che in questa paura, la morte non esiste. Il motivo di questa paura, però, è illusorio, perché nulla può perdersi di ciò che vive nel cuore e nella coscienza dell’uomo. Resta tutto illeso oltre la sfera della morte. Come si fa a far morire un atto d’amore: lo fuciliamo?
Ai primordi della storia, gli esseri umani rimanevano ancorati al mondo spirituale anche durante l’incarnazione: l’esperienza d’essere rivestiti di materia non annullava la comunione con gli Esseri spirituali. E la morte, lo svestirsi del corpo, non creava nella coscienza l’angoscia di cadere nel nulla perché già in vita si conversava ogni giorno con i morti, si sapeva per esperienza che morire era come passare da una stanza all’altra, sparendo dalla prima per comparire nella seconda.
Supponiamo per un momento di non essere materialisti come siamo oggi, supponiamo che non sia reale soltanto la materia fisica; supponiamo di non avere un tipo di coscienza che considera tutto il mondo interiore – conoscenza, amore, moralità – come un prodotto del cervello fisico, come un’esperienza di sé che ci è possibile solo grazie al corpo. Facciamo l’ipotesi di essere uomini per i quali la materia che si forma e si disgrega sia reale, sì, ma siano ancor più reali, sostanziali e duraturi i pensieri, gli atti d’amore, tutto ciò che viene creato in noi dalla nostra libertà, e che in natura non esiste. Immaginiamo di viverci come spiriti eterni che entrano nella materia del corpo per vivere sulla terra alcuni decenni e che poi decidono di lasciare l’involucro passeggero del corpo. Che cos’è la morte, se le cose stanno così?
E che cosa direbbe, dopo morto, un uomo come questo che abbiamo immaginato? Direbbe: ho passato alcuni anni dentro un corpo fatto di materia... certo mi stava un po’ stretto rispetto a come sono abituato a vivere quassù, però... però che bella sfida riuscire a rimanere uno spirito libero in mezzo a quel mondo fatto tutto di costrizioni! E l’amore che ho imparato sulla terra e che ho portato con me è ben più gagliardo che non l’amore che si vive quassù... E perciò me lo godo più ancora di quando ero in vita. E guarda lì come mi piangono quelli che sono rimasti laggiù! E mi piangono morto... Ma sono matti?
La morte è la grande illusione di coscienza degli uomini che non vivono più la realtà dello spirito. Diventare immortali significa allora riconquistare, amandola tenacemente, la realtà di ciò che è spirituale. Noi parliamo di morte perché siamo morti all’amore per ciò che è invisibile. L’esperienza di questo amore è la porta che ci riapre il mondo dello spirito, perché l’amore è lo spirito in quanto accessibile all’esperienza di ogni uomo. Tutto ciò che un uomo ama lo rende immortale nel suo cuore, ed è così che diventa immortale lui stesso!
Più io vivo l’amore e più vivo ciò che in me è immortale. Molte sono le anime femminili che dall’esperienza forte dell’amore traggono la certezza interiore che l’essere umano non può mai morire. Troppo poche sono le anime maschili in grado di far questo, perché in loro è di solito più esile il vissuto di quell’amore che vince ogni morte, e ogni paura della morte.
Può davvero lasciarci una persona amata?
Quando ci si separa, o si divorzia, a volte l’altro sembra sparire per sempre dalla nostra vita. Esteriormente la lontananza è reale perché riguarda «i due pezzi di materia», le due corporeità che si allontanano l’una dall’altra. Ma questo vale solo per la realtà esterna.
L’interezza delle due persone abbraccia una realtà complessa che non si limita ai due corpi. Allora la domanda da porsi è: che cosa resta dell’altro, dentro di me, dopo una separazione? E la risposta è una sola: resta tutto l’amore che nutro per lui. Se con la separazione sparisce anche l’amore, non vuol dire che l’amore finisce di esserci, ma che non c’è mai stato. Quando c’è, l’amore non termina mai, per natura non può mai morire.
Una delle esperienze più forti dell’amore si può fare proprio durante l’assenza fisica della persona che si ama. Lo struggimento del desiderio me la rende più intensamente presente di quanto non sarebbe se fosse accanto a me fisicamente. Quando mi consumo dal desiderio, lei è presente in me, eccome se lo è! E questo è proprio il primo passo da compiere per superare le ristrettezze del bisogno di cui dicevamo: colui che io desidero e che mi manca tanto, se lo amo lo porto dentro di me. In fondo è un altro paradosso, questo: amo davvero qualcuno se quando è lontano mi è vicino più che mai.
Ugualmente, se io sono sparito dal cuore dell’altro, se l’altro, come spesso si sente dire, «non mi ama più», questo riguarda lui: per me l’importante è continuare ad averlo nel cuore. Questa è realtà per me. Non posso imporre all’altro la mia presenza esteriore e tanto meno quella interiore. È però possibile vivere una distanza fisica, magari concordata, come un modo per amarsi ancora di più: concedendosi una dovuta distanza esteriore, ci si offre spazio reciproco nel cuore e si evita di togliersi l’aria a vicenda.
La forma più radicale di separazione apparente è la morte della persona amata. È in modo assoluto l’invito a vivere in noi la realtà della sua anima e del suo spirito. Questa persona ci ha portato via il suo elemento visibile per offrirsi a noi nella sua realtà immortale. Dopo la morte finisce ciò che noi siamo gli uni accanto agli altri, ma rimane più che mai quel che siamo gli uni dentro gli altri. Prima della morte la persona amata viveva accanto a me, dopo la morte può vivere più intensamente dentro di me. È bello avere vicino chi amiamo; averlo dentro è più bello ancora.
Lasciar entrare la persona che amo nel mondo dello spirito quando la morte la chiama, significa morire al mio bisogno di averla accanto fisicamente. Quello è un bisogno tutto mio: averla in me è invece il compimento del suo desiderio d’amore per me. Nessuno che ama si accontenta di essere accanto all’altro: vuole entrare dentro l’altro. E soltanto la morte ci consente di vivere in tutto e per tutto gli uni dentro gli altri. Ma devo averla già sperimentata prima della morte la presenza dell’amore, altrimenti non potrò far mio anche oltre la morte lo spirito che è invisibile.
L’amore che vince la morte ci consente di gioire della morte dell’amato come ne gioisce lui. Dopo la morte, ogni essere umano sente una profonda gratitudine, un’indicibile gioia, nel vedere illuminarsi quella coscienza che in vita era così ottenebrata, così mortificata dentro le strettoie della materia. Chi muore vive la sua morte come una liberazione e non può che gioirne.
E come si fa a non gioire insieme a chi si è amato per tutta una vita? Se restiamo prigionieri di noi stessi sentiamo un’infinita tristezza per la morte dell’altro: ci manca tanto quella persona cara. Questo è comprensibile, è umano, ma non esprime certo la perfezione dell’amore: è in fondo un’altra forma di amore di sé. Le lacrime per la persona scomparsa sono lacrime d’amore per noi stessi, che ci sentiamo soli, e privati di chi riempiva la nostra vita. Per quanto possa sembrare paradossale, più diventa tenace e immortale la forza del nostro amore, più riusciamo a condividere la gioia che vive chi solo apparentemente ha lasciato la terra. Vivere con i Morti significa amare come amano loro. Ed essi amano meglio di noi perché la loro coscienza è più vasta e hanno travalicato la sfera corporea piena di amore di sé. Morire significa trasformare ogni frammento di egoismo in puro amore.
I Morti ci parlano sempre: sono qui spiritualmente con noi e hanno tante cose da dirci. Siamo noi che non riusciamo a sentire le loro parole: ci siamo talmente materializzati che per noi lo spirito è come se non esistesse, e ci manca il linguaggio comune per parlare con chi ora vive nei mondi invisibili. È come se i Morti fossero muti, ma siamo noi a essere sordi.
Allora la prima cosa da fare per rendere immortale il nostro amore, è imparare a comunicare con le persone care che sono morte, è imparare il linguaggio del loro spirito. È come un canto che si alza sulle quattro corde di uno straordinario violino che i Morti suonano continuamente, spandendo all’intorno i quattro modi di vivere della loro anima che tanto vorrebbero ispirarci.
Il primo canto dice: «Mi sento in comunione con tutti gli Esseri, qui ho superato ogni separazione! È bellissimo quello che vivo!». E l’amore che cos’è? Non è forse anche per noi l’anelito a superare ogni separazione? Per i morti non ci sono le barriere e le divisioni cui ci costringe la materia, non ci sono ostacoli o lontananze; lassù, tutti vivono in tutti.
Il secondo canto dice: «Vivo nella gratitudine verso tutto e verso tutti». La comunione si fa più concreta: i Morti si rendono conto di ciò che devono a ogni uomo
che il destino gli ha fatto incontrare. Vivono la certezza che tutto ciò che sono gli è stato donato, sanno che ogni spirito umano deve quel che è divenuto a tutto il mondo in cui vive. E i Morti hanno già una premonizione gioiosa di tutte le restituzioni che intendono fare in futuro.
La terza corda del violino dei Morti canta così: «Sono ricolmo di fiducia!». I Morti ora sanno che ogni uomo può evolversi solo aiutando ogni altro uomo, in un mondo che sempre può mostrare a ciascuno il lato che più gli corrisponde per continuare il suo cammino. I Morti vivono nella reciproca fiducia, e nella fiducia in noi che siamo rimasti sulla terra: intuiscono i destini del mondo e sanno di poter contare sulla forza imperitura dell’amore umano.
E sulla quarta corda il canto dei Morti dice: «L’amore che vivo quassù mi rende sempre più giovane». Il tempo che col suo scorrere fa invecchiare i vivi, fa ringiovanire i Morti. Il miracolo più stupendo dell’amore è proprio questo: se noi sulla terra coltiviamo le forze dell’amore contagiandoci a vicenda, il nostro cuore col passar degli anni ridiventa fresco come quello di un bambino. A ottant’anni ci ritroviamo aperti alla vita come lo sono i piccoli: con occhi pieni di stupore, con l’animo pieno di meraviglia.
Logica della testa e logica del cuore
La scienza moderna si fonda sulle forze del pensiero, sul raziocinio, intenta com’è a cogliere il lato oggettivo della realtà. L’amore volge l’occhio al mondo interiore, gl’interessa ciò che vive nell’animo degli uomini. Ciò non vuol dire che l’amore sia una realtà soltanto soggettiva, senza incidenza sull’oggettività delle cose. Se si ama si vive in due mondi, in quello visibile e in quello invisibile. Se non si ama, si vive solo nel più povero dei due mondi.
La ragione e l’amore stanno fra di loro come la testa e il cuore di una persona. Si può perciò usare la parola «testa», o «mente», come sinonimo di tutto quel che riguarda la razionalità del pensiero, e la parola «cuore» o «animo» per indicare le forze dell’amore, quell’impulso dell’essere che va al di là di ciò che è razionalmente dimostrabile. Il cuore non ha bisogno di dimostrare nulla, perché è pieno di doni che muore dalla voglia di mostrare.
Una delle cose più belle della vita sono le mille scintille accese dalla tensione interiore che s’instaura fra la nostra mente e il nostro cuore. Il pensiero vuol dar ragione di ogni azione che l’uomo compie, ma il cuore ha ragioni tutte sue, di tutt’altra natura. Le ragioni del cuore non sono appese sul filo sottile sottile della logica, ma emergono dalle profondità del vissuto, da tutta un’esistenza che non si può ridurre a un puro ragionamento.
Ogni uomo vive in questa salutare tensione. Quando una delle due parti tende a sopraffare l’altra, si genera uno squilibrio interiore che può causare sofferenza e perfino malattie fisiche. Le malattie non hanno mai la loro origine prima in qualcosa che avviene nel corpo: nel fisico si esprime sempre e solo quel che è già avvenuto nell’anima e nello spirito di una persona.
Parlando di mente e di cuore viene spontaneo cercare la razionalità maggiormente nel maschile, e l’amore nel femminile – con tutte le sfumature e le eccezioni che la realtà si riserva di creare, se non altro per confermare la regola. Questo tipo di distribuzione di ruoli – il cervello per gli uomini e il cuore per le donne – non va però assolutizzato, perché è altrettanto importante esaminare il modo in cui queste due dimensioni si ricercano a vicenda in ognuno di noi, indipendentemente dal fatto che siamo un uomo o una donna.
Ognuno desidera stabilire dentro di sé un giusto equilibrio tra ciò che gli detta la mente e quel che gli suggerisce il cuore. Non si può dire che una delle due voci sia più importante dell’altra: non si tratta di maggiore o minore autorevolezza, ma di due mondi, di due contributi specifici del tutto diversi ed entrambi ugualmente indispensabili. Così come il maschile e il femminile non sono l’uno più o meno importante dell’altro, ma sono due universi polari ed entrambi imprescindibili. L’importante è capire sempre meglio qual è l’apporto specifico della mente, e quale quello del cuore.
Amore e scienza sono i due raggi d’azione dell’umano, e non è possibile che in due persone ci sia la stessa identica miscela di mente e di cuore: sicuramente l’una avrà rispetto all’altra un po’ più di forze del cuore o della mente.
Rende appassionante l’amore reciproco proprio il fatto che io posso portare all’altro ciò che in lui è meno sviluppato, e posso ricevere quelle forze che in lui sono più progredite che in me. Un uomo che avesse un equilibrio perfetto tra mente e cuore, senza nessuno scompenso, senza carenze né dall’una né dall’altra parte, non avrebbe più nulla da fare. Un tale individuo non esiste, né è auspicabile che esista, perché gli mancherebbe il più bello dell’umano: essere sempre per strada per riconquistare ogni giorno un equilibrio interiore rinnovato, perché le persone e le situazioni di vita a cui far fronte sono ad ogni passo diverse.
Una persona unilaterale dalla parte del cuore fa fatica a cogliere l’importanza del pensiero che, solo, ci fa intuire l’oggettività dei fenomeni. Il senso degli incontri della sua vita, allora, sarà quello di ricevere dagli altri sollecitazioni a scoprire l’importanza della mente. Questa persona è spontaneamente tentata di dire: ma a che servono tutti questi ragionamenti, così astratti e freddi? Molto meglio il calore del cuore! E perciò il destino le farà incontrare, come aiuto prezioso, delle persone che le diranno: guarda che il tuo amore che ti manda così in solluchero a me non serve a nulla, e se vuoi davvero aiutarmi sarà meglio che ti sforzi di conoscermi usando la tua testa. Io mi sento davvero amato soltanto da chi si prende la briga di capire come sono fatto. Questo è il genere di messaggi che riceverà – sia che si tratti di affetti, sia di attività lavorative, d’impegni artistici o di altro ancora.
Chi d’altro canto ragiona, ragiona, ragiona ed è piuttosto freddino nei rapporti perché non sa dove stia di casa il cuore, verrà aiutato da chi gli dirà chiaro e tondo: a che ti serve avere sempre ragione, se non sai dare e ricevere amore? Tienitela la tua ragione, io me ne vado altrove. Una persona che sia sempre impegnata a far sfoggio di una logica ineccepibile, ma che non sappia nulla dell’amore, diventa prima o poi insopportabile, e fa scappare tutti. L’eccesso di razionalità indica proprio quello che la persona in questione non ha ancora capito: quali siano lo spessore e il peso morale delle forze del cuore, e quanto le ragioni del cuore siano diverse da quelle della testa.
E in questa nostra società così inchiavardata alla logica ferrea della scienza e alla tecnica, dove l’emozionalità e il calore del cuore disturbano soltanto il culto del cervello, le persone che non capiscono la logica del cuore diventano sempre più numerose. Soffrono da morire quando perdono colpi nel mondo degli affari, e non si curano del loro cuore che non ne può perdere nemmeno uno, di colpo, perché non batte più.
La tensione interiore fra due logiche opposte dentro di noi è la molla per ogni passo che facciamo nel nostro cammino. In quest’ondeggiare fra due mondi viviamo la vita e la salute dell’anima, e ritenerlo un fattore negativo sarebbe un vero e proprio errore di giudizio. Tutto sta nel modo in cui ognuno gestisce questa tensione, nel come va rapportandosi alla mente che calcola il proprio tornaconto e al cuore che ama il tornaconto altrui. Se la mia mente pensa a ciò che fa per me, il mio cuore ama sentire ciò che fa per gli altri. Il mio compito è di trovare in ogni situazione il giusto equilibrio tra l’una e l’altro.
Più razionale è la professione che una persona svolge, più bandisce il cuore dal mondo del lavoro facendovi regnare la logica fredda dell’utilitarismo, e più questa stessa persona, quando torna a casa, cerca un compenso tendendo verso l’estremo opposto. Magari nemmeno se ne rende conto, ma nella vita privata vuole tutto lo spazio negato al suo cuore sul lavoro, finendo per ricattare chi gli vive accanto. Questo cosiddetto lavoratore pretende solo attenzione e amore dalla famiglia, si pone nell’atteggiamento di chi ha tutti i diritti di ricevere un po’ d’ossigeno almeno a casa, e non pensa nemmeno lontanamente che è possibile vivere col cuore a casa solo se non lo si è perso già prima in ufficio.
Tre battute del dialogo fra mente e cuore
Il rapporto tra la mente e il cuore è esso stesso in incessante evoluzione, nella quale si possono distinguere tre stadi.
Il primo è quello dell’amore pre-scientifico: il cuore senza la mente – sto calcando un po’ le tinte, ovviamente, ma lo faccio per meglio evidenziare il carattere specifico di ogni fase, di ogni tipo di autoesperienza. Resta scontato che in assoluto non può esserci una mente senza il cuore, e viceversa.
In questo primo stadio si vive la preminenza naturale del cuore. È un modo di vivere che va bene finché è la natura a guidarci, non essendo noi ancora capaci di prendere in mano il nostro amore con la coscienza pensante e libera. Questa prima fase è quella infantile che comporta un esubero delle forze del sentimento, non ancora illuminate dalla razionalità. Nel corso della vita – che ripete in piccolo le fasi dell’evoluzione in grande – il raziocinio viene aggiungendosi a poco a poco al sentimento. Se andiamo indietro anche solo di cinque, seicento anni, al periodo precedente la nascita delle scienze naturali moderne, troviamo un’umanità per la quale la fede – le forze del cuore – era in tutti i campi della vita più importante della scienza.
Il secondo stadio è quello improntato alla scienza: la mente senza il cuore. È polare al primo. Quando il bambino diventa adulto, la sua mente si sente sempre più sicura di sé e tende a prendere le distanze dal cuore. È successo così anche in grande, cioè nel processo di crescita dell’umanità: con l’avanzare delle conquiste della scienza e della tecnica, è stata messa in primo piano la conoscenza oggettiva del mondo, e il rapporto fra mente e cuore si è come capovolto. Ogni formazione scientifica tende a sottovalutare l’importanza del cuore.
La scienza moderna è a-morale, nel senso che non si occupa dell’amore. Immaginiamo che cosa accadrebbe in campo scientifico – in un laboratorio di fisica, di chimica, di biologia – se si cominciasse a parlare d’amore. Che c’entra l’amore?, si direbbe, qui ci sta come il cavolo a merenda. Ignorare l’elemento dell’amore, però, equivale a ignorare la dimensione della vita che per l’uomo è la più importante di tutte: la moralità. E l’essenza della moralità è proprio l’amore, che si esprime anche in tutte le leggi del creato. Appunto ciò che non interessa alla scienza e alla tecnica moderne.
Esse esaltano l’ingegno applicato al progresso inteso come un susseguirsi di nuove scoperte che accrescano l’utile e il comodo, il benessere esteriore, il culto della corporeità con tutti gli annessi che via via diventano imprescindibili e necessari come l’acqua e l’aria. La scienza vede l’universo come un mondo da sfruttare a proprio uso e consumo, e ha creato una società civile imperniata su questi valori, o meglio disvalori. L’intera civiltà occidentale si bloccherebbe, crollerebbe, se venisse per esempio a mancare l’energia elettrica anche solo per un mese.
A questo tipo di scienza e di tecnica interessa intervenire e produrre sempre di più nel mondo del fattibile, moltiplicando così per l’uomo la dipendenza da ciò che gli è esterno – dalle macchine – aggiungendo altri determinismi a quelli che già impone la natura. Per questa scienza e per questa tecnica l’amore per l’uomo è faccenda della vita privata! Lì ognuno se la cavi per conto suo. Semmai tocca alla religione occuparsi dei sentimenti e della morale. Scienza e religione, mente e cuore, se vissute come due binari paralleli che non s’incontrano mai – l’una nella vita pubblica, l’altra nella vita privata –, sono due modi efficaci di uccidere l’uomo, che può sentirsi vivo solo se mente e cuore si danno vita a vicenda.
Per fortuna nella cultura occidentale va rafforzandosi il desiderio di penetrare scientificamente il grande fenomeno religioso sorto duemila anni fa. Molti sono oggi i cristiani a cui la fede non basta più; le forze del pensiero, finora rivolte quasi esclusivamente al mondo esterno, vogliono ora penetrare scientificamente anche il mondo della religione, il mondo dell’invisibile.
Ecco allora affacciarsi la terza possibilità, quella del giusto equilibrio tra mente e cuore, tra razionalità ed emotività: un amore che sa pensare, una scienza che vuol amare. Questa terza esperienza è davvero bella perché ci fa vivere l’armonia della mente e del cuore. L’uomo non si sente più dimezzato dalla prevalenza della sola testa o del solo cuore, ma vive il loro reciproco amore: la mente ama il cuore, e il cuore ama la mente. La mente rende profondo il cuore, il cuore rende calda anche la mente.
Ognuno se lo deve inventare a modo suo questo dialogo interiore, questo scambio d’amore che fa della mente la religione nuova del cuore, e del cuore l’arte nuova della mente. Ognuno ha un’alchimia sua propria di luce e di calore, di verità e di bontà. È la sua mente che vuol rendere vero il suo amore, il suo cuore che lo vuol rendere buono.
Amare a ragion veduta – «Amor che ne la mente mi ragiona», dice Dante –, amare in base alla conoscenza di colui che si ama, significa non fare all’altro ciò che piacerebbe a me, ma quel che giova a lui. Solo questo è vero amore. Se io compio per l’altro le azioni che piacciono a me, o che danno a me la sensazione di essere amante, amo il mio bisogno di essere amante, mi piace essere uno che ama. Però non posso contrabbandare questo pur legittimo amore verso di me per amore verso l’altro. Amo davvero l’altro soltanto quando mi sforzo di conoscere ciò che in questo momento lo aiuta o gli serve, e lo faccio indipendentemente dal fatto che mi piaccia o no. Il mio piacere o dispiacere diventano secondari.
Sentirsi dire: mi sento capito da te, ha un peso morale maggiore che non sentirsi dire: so che vuoi amarmi. Amare l’altro nel modo che mi viene spontaneo è facile; sforzarmi di capirlo richiede un amore più grande. E l’organo della conoscenza è il pensare. Esso sa mettere da parte quel che piace o non piace, e guarda all’oggettività dell’essere altrui. In fondo, ogni persona conosce veramente solo ciò che ha a lungo amato. All’inizio l’amore precede la conoscenza, ed è un amore naturale; ma poi sopravviene la conoscenza e l’amore diventa sempre più libero. Amore e conoscenza continuano a rincorrersi a vicenda, a cercarsi l’un l’altro. Il cuore cerca i consigli della mente e la mente quelli del cuore, in un gioco interiore che è la gioia della vita.
La giustizia calcola, l’amore è generoso
Il rapporto che intercorre fra amore e giustizia è simile a quello tra amore e scienza, perché il giusto, proprio per essere giusto, presuppone un’intesa razionale sull’oggettività delle cose, richiede che ci si metta d’accordo su di esse. L’elemento oggettivo della giustizia può afferrarlo soltanto la razionalità del pensiero.
Che rapporto c’è, allora, tra la giustizia e l’amore? Una domanda importante, questa, perché dalla sua risposta dipende tutta la vita sociale, soprattutto considerando l’affermazione fondamentale del Cristianesimo che dice: duemila anni fa ha avuto inizio la grande svolta che vuol far passare l’umanità da un’evoluzione guidata puramente dalla giustizia (la Legge mosaica), a un’evoluzione fondata sulle forze dell’amore (la legge del Vangelo).
Che cosa vuol dire passare dal registro della giustizia, della legge, a quello della grazia, dell’amore? Se sapessimo esser «giusti» gli uni con gli altri, verrebbe forse da dire, se ci trattassimo tutti secondo giustizia, già ne avremmo che ne avanza! Cosa mancherebbe se dessimo a ognuno il giusto che gli spetta? C’è qualcosa che non va nella sola giustizia?
La giustizia si fonda sull’uguaglianza di tutti gli uomini: per trattare tutti secondo giustizia bisognerebbe dare a ciascuno in misura uguale. Se diamo a qualcuno più di quello che diamo a un altro, siamo ingiusti. Se siamo tutti uguali, nessuno ha il diritto di essere più uguale degli altri.
Eppure l’uguaglianza, se viene assolutizzata, può diventare la cosa più ingiusta del mondo! Per il semplice fatto che se è vero che siamo tutti uguali, è altrettanto vero che nessuno è uguale a un altro. Siamo tutti ugualmente diversi. Siamo uguali in quanto a dignità umana, siamo tutti in ugual modo degli esseri umani, ma in relazione allo stadio evolutivo, ai bisogni e ai talenti concreti, a ciò che ci fa bene o male qui e ora, siamo tutti differenti. Come è possibile, allora, conciliare la giustizia, che ci vuole tutti uguali, con l’uguale attenzione al cammino specifico di ognuno, del tutto originale rispetto a quello di ogni altro?
Non possiamo certo fare a meno delle leggi generali, ma esse non sono risolutive per illuminare il mistero del sociale, non bastano più in tempi di spicco dell’individuo che vuol sentirsi inimitabile nel vivere la sua unicità. La giustizia si occupa del bene comune, di ciò che vale ugualmente per tutti; a questa base necessaria e collettiva bisogna però aggiungere un’altra istanza che si occupi del bene specifico e diverso per ognuno. Ed è questo che sa fare l’amore. La mente ha ragione quando tratta gli uomini in modo uguale; il cuore ha le sue ragioni quando vede e ama in ognuno un mondo diverso.
La giustizia parla il linguaggio razionale dei diritti e dei doveri insiti nella natura umana, e ha la sua legittimità, perché senza questo dare-avere bilanciato, senza questa equa amministrazione, non ci può essere convivenza sociale. L’amore è invece l’arte di trattare ognuno in modo diverso, parla la lingua dell’unicità, che ha non meno una sua legittimità, perché se mancasse verremmo schiacciati come individui. L’arte del sociale è proprio quella di saper dar conto e spazio a tutt’e due le istanze.
Insistere sull’uguaglianza sottovalutando l’amore porta al livellamento degli individui – e genera disamore. Dovendo avere uno sguardo d’insieme, non potendo interessarsi al caso singolo, questo tipo di uguaglianza appiattisce gli uomini; non è suo compito affrontare gli individui nella loro realtà specifica. Per essere giusta, la giustizia di antico stampo deve restare incolore. Perciò i colori deve aggiungerli l’amore.
Si può essere giusti anche senza amare, non si può amare senza essere anche giusti
L’amore è una specie di giustizia superiore che presuppone e comprende in sé tutto ciò che è giusto. La giustizia oggettiva, invece, quella del calcolo razionale e scientifico – la giusta legge – non comprende in sé l’amore perché le crea soltanto pasticci, le scombina le carte in tavola. Un amore genuino, invece, non può che comprendere anche la giustizia, perché un amore ingiusto non sarebbe amore. Si può far giustizia senza amare, ma non si può amare senza essere giusti.
La giustizia dà a tutti la giusta misura, l’amore mira a dare a ognuno infinitamente di più di ciò che è ritenuto giusto. L’amore è un esubero di generosità. La giustizia ama misurare, l’amore ama a dismisura.
L’umanità si trova oggi a una grande svolta nella sua evoluzione perché è giunto il momento in cui a nessuno basta più quel che pare o si ritiene giusto, trovandolo sempre più ingiusto – e questo si può proprio toccare con mano osservando ciò che avviene nel mondo. Aumentano le persone che ritengono insufficiente il puro giusto, e lo vivono perciò come una giustizia falsa.
Non basta più a nessuno fare ciò che tutti devono fare: ognuno cerca spazio per ciò che lui stesso vuole fare, vuol trovare un modo di realizzarsi tutto suo, che sia «giusto» solo per lui e per nessun altro. Soltanto quello può rendere giustizia al suo essere. Il terreno condiviso sul quale gli uomini crescono è la loro comunanza, ma la fioritura del loro essere si esprime nell’individualità singola di ognuno. Mille fiori possono crescere sullo stesso suolo, in uguali condizioni climatiche, con la giusta alchimia di sole, aria e acqua. Ma su quel terreno non spunteranno fiori tutti uguali: il bello salta fuori proprio nel fatto che non ce ne sono due uguali né per forma né per colore. L’osservanza delle giuste leggi uguali per tutti non è il fine della vita, ma il terreno necessario perché ognuno possa far sbocciare una vita del tutto individuale. Se le leggi impediscono ciò che è individuale, diventano del tutto «ingiuste» perché fanno torto all’essere unico di ognuno.
Basta guardare ai più quotidiani rapporti fra gli esseri umani: due persone vivono insieme e si mettono a litigare su quel che è giusto e che non è giusto. Per ore potranno accanirsi: io ho diritto a questo, e tu sei ingiusto... no, io ho diritto a quest’altro, sei tu l’ingiusto... Non si accorderanno mai, se si fermano al livello di ciò che ognuno ritiene giusto o ingiusto.
Questo è uno dei tanti segni da cui si può evincere che oggi è pienamente in atto la gigantesca svolta evolutiva iniziata duemila anni fa. Il raziocinio soppesato della giustizia deve gradualmente far spazio anche alla generosità più che giusta del cuore. L’amore dà più del giusto, perché restituisce agli altri liberamente e volentieri tutto quello che ha ricevuto.
Chi non si fida del cuore può ribadire a questo punto che anche una ragionevole giustizia sa far spazio al cuore. Ma come fa i conti il raziocinio? Guarda alle cose esterne e dice: ho ricevuto cure, cibo e vestiti quand’ero piccolo, poi sono stati spesi altri soldi per farmi studiare, poi m’hanno aiutato a trovare lavoro, poi ho ricevuto frigorifero e lavatrice quando mi sono sposato, ieri m’hanno regalato una bottiglia di vino... Magari la bottiglia di vino posso ricambiarla, domani. Ma allevarmi e sostenermi era un giusto dovere dei miei genitori verso di me. Ho forse chiesto io di nascere? E del resto, se mai avrò figli, ecco lì che dovrò fare lo stesso anch’io, per loro. Perché così è giusto.
L’amore, invece, quando fa i calcoli di ciò che ha ricevuto ragiona in un modo del tutto diverso. Una persona che ama dice: io ho ricevuto dagli altri non soltanto tutto quello che ho, ma più ancora tutto quello che sono! Allora, che cosa ho da restituire? Cos’è che giustamente devo agli altri? Tutto il mio essere. Tutto. La giustizia che solo l’amore sa fare è quella che dice: ognuno di noi deve tutto a tutti, e il cuore si sente giusto solo quando dà tutto di sé – i suoi talenti, le sue energie, il suo tempo, senza calcolare. Se trattiene la pur minima cosa si sente subito ingiusto. La sola giustizia che l’amore conosce è il dono di sé, senza condizioni. Beato chi se lo può permettere, questo amore, perché è proprio una gran bella cosa.
Paradossalmente, ognuno si trova giorno dopo giorno a esigere dall’altro come giusto ciò che l’altro dal suo punto di vista trova ingiusto. No, mi chiedi troppo, è la risposta che si sente sempre. E perché ogni volta ho l’impressione che sia troppo, troppo e ancora troppo quello che l’altro mi chiede? Perché in fondo ciò che vuole da me non ha limiti: vuole tutto e non si contenta mai. E io non chiedo di meno, questo è il bello! Anch’io ho l’impressione che quel che l’altro mi dà sia giusto soltanto quando mi dà tutto se stesso. E forse non mi basta ancora!...
Pur intravedendo anche solo qualche barlume di queste grandi verità, ci si può render conto di quanto sia importante la differenza che c’è tra la logica della giustizia e quella dell’amore. Ai giudici, ai processi, ai tribunali aspetta un futuro difficile se gli uomini non si chiariranno le idee sul mistero del rapporto che intercorre tra amore e giustizia – tra una giustizia che esige la giusta misura e un amore che non conosce misura.
C’è troppo poco amore nel nostro mondo. Siamo tutti egoisti, in fondo, e allora esigiamo il tipo di giustizia che pesa col bilancino. Nella lotta contro il terrorismo, chi ha ragione e chi ha torto? Chi è nel giusto e chi no? Immaginiamo cosa succederebbe se il presidente degli Stati Uniti dicesse: Cari americani, vi esorto ad amare sinceramente tutti i terroristi di questo mondo. Siamo stati profondamente ingiusti nei loro confronti, perché il nostro benessere si è potuto creare solo sfruttando l’intera umanità. È giusto, è più che giusto che restituiamo quel che abbiamo rubato. Cosa direbbero quelli che lo hanno eletto? Direbbero: è matto, cambiamolo subito. La nostra guerra contro l’Iraq è giusta, è doverosa, è dovuta all’umanità!
In una conferenza del 20 dicembre 19183, Steiner afferma che nel nostro tempo è in atto una lotta titanica nel mondo spirituale tra la saggezza e l’amore. Gli Spiriti della Saggezza nel passato hanno avuto in mano le redini dell’evoluzione, e hanno fatto sì che ogni cosa trovasse il suo giusto posto. Ma adesso cominciano a comandare gli Spiriti dell’amore che scombussolano tutto quanto. La saggezza crea ordine nel mondo, l’amore cambia tutti i punti di riferimento. O meglio: l’ordine della saggezza è tutto bello, l’ordine dell’amore è tutto buono. Non si può avere un mondo tutto perfetto quando si ama. Amare vuol dire ricominciare da capo ogni giorno, perché l’ordine della saggezza senza amore assomiglia alla compostezza di un cimitero. Il cimitero è bello preciso, ma non si muove nessuno.
Chi vuole il giusto ordine ha paura dell’amore, ma non è bello vivere nella paura dell’amore. L’ordine è necessario, ma a che serve l’ordine senza l’amore? L’uomo non è stato fatto per l’ordine, bensì l’ordine per l’uomo. L’amore è un ordine che rivoluziona i nessi prestabiliti e che ricompone le cose ogni giorno in modo diverso. Ci vuole più fantasia morale per un ordine che si trasforma continuamente, ma è proprio questo che corrisponde davvero a un mondo dove tutto è in cammino. E amare in un modo nuovo ogni giorno vuol dire essere più che ordinati. La giustizia tende a conservare il giusto ordine già stabilito perché funziona, l’amore è sempre in divenire e inventa ogni giorno di nuovo la vita perché la sa creare. Quando tutto funziona giustamente e manca l’amore, in realtà non funziona nulla. La saggezza senza l’amore non convince nessuno. Invece un amore che ne sa sempre di più dei misteri della vita è la più grande felicità dell’uomo.
Il determinismo scientifico dell’Islam domina l’occidente
Forse non c’è nulla di più interessante, e fruttuoso, per capire meglio il rapporto fra amore e scienza, quanto approfondire il senso del contrasto ora in atto tra il Cristianesimo e l’Islamismo. Il Cristianesimo vero è scienza dell’amore e amore alla scienza: cerca la realtà oggettiva dei singoli uomini nel loro fondamento spirituale. L’Islam parte da tutt’altre premesse: pone al centro l’onnipotenza di Allah, di Dio Padre, negandogli il Figlio, negando l’emergenza del singolo uomo, dello spirito umano individualizzato.
L’ho detto e scritto più volte: il senso del Figlio, nella Trinità cristiana, è che il Padre rinuncia liberamente a essere onnipotente nell’interiorità umana, per far posto alla libertà dell’uomo. Il Padre non ama sé nell’uomo, ma ama l’uomo. Allora si tira indietro per fargli spazio. La Divinità che rinuncia alla sua onnipotenza nei confronti dell’uomo, diventa puro amore per l’uomo. Questo è il Figlio di Dio, che si fa uomo nella libertà e nell’unicità di ognuno.
In senso cristiano noi facciamo l’esperienza del Figlio quando la Divinità termina di condurci in tutto e per tutto, e diventiamo liberi nei nostri pensieri e responsabili per le nostre azioni. Il Figlio, che i cristiani chiamano il Cristo, non vuol agire nell’uomo con onnipotenza: si proibisce di farlo, altrimenti l’uomo non sarebbe libero. Agisce con amore, e ciò vuol dire che gli sta a cuore rendere ognuno sempre più capace di libertà. Già Paolo di Tarso insisteva sul fatto che l’essenza del Cristianesimo è l’amore, un amore così grande, così radicale, da apparire del tutto folle agli occhi dei benpensanti, e del tutto inerme, inchiodato su una croce. Un amore che ha rinunciato a ogni esercizio di potenza, per non ledere la libertà degli uomini. A Pietro che lo voleva difendere dai soldati – giustamente, diremmo noi – il Figlio dice: rimetti la spada nel fodero. Non ha bisogno di difendersi, l’amore, perché è immortale e ha già vinto offrendosi. Pazzo! Scendi da quella croce, mostraci la tua potenza, Figlio del Dio onnipotente! Hai fatto tanto per gli altri, e per te, adesso, che sai fare? – gli dicono i passanti.
C’è da chiedersi quanto sia rimasto di questo spirito del Cristo, a distanza di duemila anni. Non una potente chiesa potrà tener vivo questo spirito, ma solo l’individuo interiormente autonomo che, come si diceva più sopra, sente gratitudine per le forze che porta in sé e ama ricompensando l’amore già ricevuto dagli altri.
Si può favorire la libertà di un altro soltanto non gestendola, e pur tuttavia adoperandosi per renderla possibile. Amare è rendere possibile la libertà all’amato, sempre e in qualsiasi forma, mettendogli a disposizione gli strumenti che gli sono necessari per agire in piena libertà. Il Figlio di Dio è colui che lavora nell’interiorità dell’anima umana per conferirle la facoltà della libertà. Esercitare questa facoltà, tradurla in atto in modi fantasiosi e individuali, è compito dell’uomo: egli può farlo e può anche omettere di farlo. Ma di certo ognuno di noi ha in sé la capacità della libertà, e questa la deve all’amore incondizionato che il Figlio di Dio ha avuto e ha per lui.
Una delle affermazioni più importanti del Corano è questa: Allah è l’unico, il solo, e non ha figlio. In fondo, è proprio la negazione della fantasia dell’amore, di ciò che i cristiani chiamano Cristo. Sono due letture polarmente opposte dell’uomo e dell’evoluzione, quella islamica e quella cristiana, e vi corrisponde un’impostazione di vita altrettanto diversa. Il cristianesimo storico, quello che è invalso nella cultura, assomiglia ben più all’Islam che al Cristianesimo vero. Nella vita pubblica è la scienza a far da padrona, e il cristianesimo come religione è stato relegato alla sfera privata. Nella vita reale dell’Occidente non conta quasi nulla, contano solo i dettami della scienza e della tecnica.
L’assunto fondamentale della scienza naturale che domina la cultura occidentale cosiddetta cristiana è lo stesso del Corano. Questa scienza dice: l’uomo è determinato dalle leggi di natura e la libertà è un’illusione. Lo stesso sostiene l’Islamismo che ritiene l’uomo determinato dall’onnipotenza di Allah. Che si attribuisca la non libertà dell’uomo alle leggi di natura o alla volontà di Dio o di Allah, non cambia nulla, perché in tutt’e due i casi l’essere umano viene considerato non libero. L’idea fondante del Corano è che l’uomo non è libero, perché tutto viene deciso da Allah; l’idea fondante del materialismo occidentale è che l’uomo non è libero, perché tutto viene deciso dai determinismi della natura. Per quanto riguarda l’uomo non vi è alcuna differenza.
Dov’è la scienza d’amore del Cristianesimo?
La religione cristiana vivacchia oggi sottovoce all’ombra dei campanili, rimuginando una nostalgica fede senza scienza: un cuore spremuto che non sa illuminarsi della solarità del pensare. E sul mondo del lavoro domina una scienza deterministica di stampo islamico, senza cuore.
Quale dovrà essere il grande passo in avanti? Quello che solo l’individuo può compiere prendendo sul serio la svolta annunciata e preparata da ormai duemila anni dalla logica di quel Logos che è venuto sulla terra per farsi amore. Ogni individuo può trasformare la regìa della sua evoluzione, facendola passare da una giustizia calcolatrice, dettata dalla scientificità deterministica o dall’Islamismo fatalistico, a una regìa d’amore, di libertà, d’infinita esuberanza e generosità. Solo l’individuo singolo può umanizzare la scienza mediante l’amore, e liberare l’amore illuminandolo di pensiero. Così l’amore diventa vero grazie alla luce della conoscenza, e la scienza attende di venir redenta dalle forze d’amore che ognuno porta in sé.
Sì, tutto bello, dirà qualcuno. Ma da dove comincio? Come si fa? Da più di un secolo ci viene in aiuto una moderna scienza dello spirituale d’immensa portata, inaugurata da un certo Rudolf Steiner. I mondi spirituali che fino al sorgere di questa nuova scienza gli uomini potevano soltanto venerare senza conoscerli, mondi sovrasensibili che per millenni sono stati oggetto della sola fede perché si diceva che il pensiero umano non può osare avvicinarli, oggi possono venir conosciuti sempre più scientificamente e perciò amati ancor più profondamente.
L’impegno d’indagare scientificamente il sovrasensibile si trasforma a poco a poco in amore, un amore che vuol saziarsi di conoscenza avvicinando i misteri dell’uomo e dell’universo. È un metodo vivo e infinitamente versatile, la scienza dello spirito di Rudolf Steiner. È a disposizione di ogni individuo che voglia fare passi avanti nel suo cammino verso l’umano, fatto di mente e di cuore che si arricchiscono a vicenda. Tutti i campi della scienza e della tecnologia, dalla fisica alla biologia alla chimica..., vengono in questo modo umanizzati – redenti – da un amore che sa intuire lo spirito che vive nella fisica, nella biologia, nella chimica...
In questo modo la saggezza e l’amore possono amarsi e illuminarsi a vicenda, e l’uomo celebra l’incontro eterno fra una mente che impara ad amare e un cuore che desidera comprendere.
3 Rudolf Steiner Esigenze sociali dei tempi nuovi O.O.186 - Editrice Antroposofica, Milano 1971.
Realismo e idealismo: il mondo che già c’è e quello che m’invento
La mente è fatta per farci tenere i piedi per terra, il cuore per darci ali per volare, e l’arte della vita sta nel saper fare sia l’una sia l’altra cosa, al momento giusto. Dobbiamo da un lato tenerci ancorati al mondo che c’è, ma è bello anche tendere verso un mondo che è troppo bello per essere già tutto vero. Quando la mente cammina e il cuore vola, l’uomo si sente un vero artista.
Il realismo è il mondo della mente, del pensiero, l’idealismo è la patria del cuore, del sentimento. Il cuore è fatto per rifocillarsi alle fonti fresche di un futuro intessuto di speranza – una vita senza idealismo è arida –, e la mente è fatta per non dimenticare il lavoro del passato, che ci ha portato allo stato attuale delle cose. L’idealismo senza realismo diventa vuota utopia, una fuga dal mondo, un fantasticare da acchiappanuvole. Il realismo che manca di idealismo fa diventare pesanti, pedanti, e prima o poi petulanti.
Nostro compito, oggi, non è tanto quello di sottolineare il realismo, che abbonda nella moderna vita quotidiana. L’umanità di oggi non manca di realismo ma d’idealismo, e perciò il mondo è diventato triste e opprimente. Il nostro compito è quello di alzare lo sguardo agli ideali che possiamo condividere gli uni con gli altri, e che restano astratti solo se l’individuo non li concretizza trasformandoli in vita.
Gli ideali sono la stoffa di ciò che chiamiamo amore. L’amore è fatto di ideali, perché essi sono veri nella misura in cui li amiamo. La realtà oggettiva devo conoscerla e accettarla così com’è, ma ciò che in questa realtà sono chiamato io stesso a creare non posso che amarlo come la parte migliore di me. Ogni ideale è un’ispirazione di pensiero aperta all’evoluzione, è un’aspirazione del cuore a creare con gioia qualcosa di nuovo.
Immersi nel grigio realismo della vita, tutti facciamo l’esperienza dei mille fattori frenanti che la vita c’impone, proprio perché sono reali, per non dire surreali, proprio perché sono inevitabilmente così come sono. In questa ressa di cose già realizzate e incombenti, spesso ci sentiamo già programmati, inermi, vuoti.
L’uomo sente concretamente suoi solo quegli ideali che gli toccano il cuore, che lo innamorano davvero, e solo da quelli può venirgli lo sguardo lungimirante che gli ispira ciò che deve o non deve fare in ogni circostanza della vita. La domanda che accompagna ogni decisione da prendere è sempre la stessa: che cosa devo fare? Come mi devo comportare in questa situazione?
Se cerco la risposta nei consigli degli altri, se mi lascio indirizzare da norme collaudate e fisse, se, insomma, voglio essere un bravo realista e andare sul sicuro, spengo in me ogni guizzo di vera iniziativa, e mi abbandono alla prosa trita di un vivere che s’adatta e si rassegna a quello che già c’è. E faccio morire dentro di me quell’idealità tutta mia, che può diventare realtà solo se non la soffoco ancor prima di farla nascere.
Chiarendo i miei pensieri sui valori fondamentali della vita, e amandoli, potrò stupirmi ogni giorno di come mi diano sempre l’indicazione giusta non solo su ciò che devo fare, ma più ancora su ciò che voglio compiere. La fantasia morale dell’individuo diviene la sorgente di una nuova moralità. Il suo cuore e la sua vita rendono sempre più reale l’uomo ideale.
Il tempo in cui si andava dal padre spirituale, o dal guru, o da qualsiasi altra autorità per ricevere dall’esterno le dritte sul da farsi, è finito. Non siamo più bambini che hanno bisogno di qualcuno che tracci la strada, non essendo ancora capaci d’inventarsela loro. L’adulto, la persona interiormente autonoma, vuol dare un’impronta tutta sua alla vita e al mondo, e questo sigillo inconfondibile è buono della bontà stessa del suo essere quale l’ha creato la fantasia divina.
Se in una situazione decido di mandarti al diavolo, perché ritengo possa far bene a te e a me, sarà importante farlo col genio del cuore. Ogni ispirazione buona viene da un cuore che ama perché è intriso di ideali, e da una mente che s’immerge nei misteri del mondo – e allora non ci sono santi: tu al diavolo ci andrai, e magari pure volentieri, perfino ringraziandomi. L’amore è davvero infallibile. Solo l’amore, però. Ma spunterà sempre di nuovo il tizio con la ricetta universale in tasca che ti dice: ma no, ma no!, non si trattano così le persone, guarda che non è una cosa buona. Devi essere paziente, lascia correre, adattati... In questa gestione dal di fuori uno si pone a sindacare sull’operare di un altro, e così facendo ignora o uccide l’ispirazione tutta originale che vuol esprimersi in lui.
Ogni uomo è un artista capace d’inventare mille comportamenti diversi nelle mille situazioni della sua vita. Non ha bisogno di pareri: inventa, sa cosa deve fare, cosa dire, come muoversi. È sovrano nell’agire e crea: quel che deve lo vuole. E la forza che lo rende artista della vita è solo e sempre l’amore.
Sono immaginabili un Michelangelo, o un Dante, che vadano a elemosinare consigli? Casomai distribuiscono sberle! Sberle benevole, naturalmente, quelle che si danno senza poi nascondere la mano, e che svegliano chi dorme perché non conosce ancora la forza dirompente degli ideali.
L’amore fa le cose giuste, ma non fa soltanto quelle che piacciono, perché la sua meta è renderci tutti migliori a tutti i livelli. L’amore non transige, non conosce mezze misure, perché le mezze misure sono le comode scappatoie dei mezzi amori.
Chi è artista della vita è un gran signore
Chi diventa un artista della vita vive da gran signore, perché è disposto a lasciare tutto pur di non tradire i suoi ideali, pur di non avvilire la carica interiore che porta nella sua mente e nel suo cuore. È un gran signore, perché non ha mai nulla da perdere. Un vero artista ha soltanto da guadagnare. Chi invece ha ancora molto da perdere non può essere fino in fondo libero e creatore: deve preoccuparsi di difendere quello che ha, e che altrimenti potrebbe venirgli sottratto.
L’attaccamento alle cose è molto diffuso nella nostra società. Il materialismo è un malinteso realismo, è quella miopia che vede solo ciò che le sta sotto il naso e dice: sarà limitato questo mondo che vedo, sarà imperfetto quanto vuoi, però è qui, c’è di sicuro. A infonderci questo realismo casereccio ci pensa in fondo la natura. L’idealismo invece non è un dono di natura, e guai se lo fosse! Non avremmo la gioia di alimentarlo noi stessi individualmente. Ogni uomo è tanto libero quanto idealismo porta dentro di sé. Non te lo vende nessuno, l’idealismo, e nessuno te lo può imporre o strappare. Il mondo esterno s’impone, quello ideale no.
Il realismo da solo rende misera la vita, riducendola al già fatto; l’idealismo è la sua ricchezza, perché guarda sempre a quel che c’è ancora da fare. L’idealismo è fatto di mille progetti della mente, è l’amore rivolto a tutte le capacità di crescita insite in ogni creatura. Essere idealisti significa vivere di futuro e di speranza, un futuro reso presente da una fede incrollabile nelle risorse che ogni uomo porta in sé.
Cosa fa l’idealismo di fronte alla nostra cultura fatta di televisione e di telegiornali? Spacca il televisore. Proprio lo butta via, perché ci si possa risvegliare da un imbambolamento mentale e morale che non si limita a ridurre gli uomini terra terra, ma li seppellisce qualche chilometro sottoterra.
È ingenuo pensare di poter godere la vita di un idealista senza pagare nulla. Chi ha paura degli idealisti – cioè ogni genere di potere, per esempio quello di chi fa e vende programmi televisivi –, è lì apposta per fargli scontare a caro prezzo la libertà che vogliono prendersi.
È importante per me capire che io posso godere la libertà di essere idealista soltanto se ho la forza morale di sostenerne le conseguenze. Anzi, se mi beo di poter pagare salato, allora significa che ho delle forze in esubero dentro di me. Molti vorrebbero sentire la gioia di chi ha grandi ideali, grandi valori morali, ma non sono disposti a rischiare niente. E magari si ritengono pure fior di cristiani, stendendo un fitto velo sul fatto che il loro Cristo, duemila anni fa, ha pagato con la vita per i suoi ideali. Sono tanti oggi a pensare di poter vivere da cristiani senza rimetterci niente. Non sanno che pagare per i propri ideali è il privilegio e la gioia dei forti. E non è un discorso elitario, questo, perché anche le persone più semplici possono avere degli ideali e vivere con coerenza.
Che misura d’idealismo e che misura di realismo c’è nella vita di una mamma col suo bambino appena nato? Se fosse solo realista, puramente razionale, che cosa avrebbe di così bello da vedere nella realtà del suo bambino? Un peperino che va pulito ogni mezz’ora, che strilla e non si sa spiegare, che ti consuma tutto il tempo e non ti fa dormire neanche di notte... Questa è la realtà, se si vuol essere realisti, e non c’è dubbio che tanti papà siano in questo campo più realisti di tante mamme.
E come fa quella mamma a non sentire il peso di tutte le fatiche che compie? Ecco di nuovo all’opera la fantasia femminile: nulla è ancora realizzato della vita del suo bambino, e allora lei lo lascia agli altri il piatto realismo. E sogna una vita tutta ideale per suo figlio, e se la sogna bellissima, perché lui non è un bambino qualsiasi. È suo figlio! Non è un essere umano come tanti altri: è «l’essere umano» per eccellenza, in tutta la sua bellezza e pienezza!
Allora, gli ideali hanno o no una forza reale se in nome loro una madre può fare tanto? Certo che ce l’hanno, e sono forti perché sanno plasmare la vita in un modo più travolgente di tutta la realtà che già esiste. Una mamma sa che il suo bambino è nato per diventare più che può un essere umano. Per vivere nella pienezza più che può, nella verità, nella bontà, nella bellezza – più che può. Per amare più che può. E la mamma glielo augura tutto, l’umano: non per un terzo o per tre quarti. Lei sa che quando si diventa grandi è già una fortuna se si riesce a concretizzare un piccolo frammento dell’umano. Lo sa, perché gli adulti li conosce, perché sa anche essere realista. E a maggior ragione è felice di aver lì un bambino dove ancora nulla è deciso dell’uomo che sarà, e dove tutto è ancora possibile. E sa che questo possibile, per diventare reale, ora ha bisogno più di tutto della forza ideale del suo amore.
La stoffa dell’artista: l’inventiva intessuta alla tolleranza
Nel concetto d’arte che di solito abbiamo, noi distinguiamo tra chi è capace solo di goderla – contemplando ciò che altri hanno creato – e chi produce attivamente opere d’arte. E consideriamo artisti solo i secondi: quelli che dipingono, che scolpiscono, che compongono musica... È questo un concetto riduttivo dell’arte. Artista è in realtà ogni uomo, perché essere uomini significa saper creare cose nuove in ogni situazione della vita. Ognuno di noi è uomo nella misura in cui è un artista in tutti i campi, perché tutto ciò che facciamo possiamo farlo artisticamente, in modo originale, senza imitare nulla e nessuno.
Un rapporto d’amicizia può diventare un’opera d’arte del tutto individuale: una fucina che richiede ogni giorno creatività e innovazione. Questo è possibile, ed è possibile per tutti. Chi dice: io non sono capace di essere artista, è solo pigro, sta cercando una scusa per non dare il meglio di sé. L’uomo è la creatura somma fra tutti gli esseri del mondo, gli è stato detto da sempre – e lui lo sa che è vero! – che è fatto a immagine di Dio. Non per niente chiama «Creatore» il suo Dio! E il Creatore è il primo artista dell’universo: non copia, non chiede a nessuno cosa o come deve fare, ma inventa sempre nuovi esseri con la sua fantasia divina. E ama talmente le sue creature da volerle capaci a loro volta di sempre nuove creazioni.
La stoffa del creatore ce l’abbiamo tutti, ma bravi artisti si diventa giorno dopo giorno. La Divinità ci dà una natura capace di creare, ma sta alla libertà di ognuno di noi esercitare questa facoltà, innamorandosene ogni giorno di più.
Va anche detto che finora gli esseri umani sono stati spesso trattati come bambini dalle varie autorità costituite – statali, religiose o economiche, poco cambia. L’intrinseca capacità artistica di ogni uomo non è stata più di tanto incoraggiata dai poteri che per loro natura vogliono soltanto mantenere l’ordine che va bene a loro, e hanno paura della spregiudicata instabilità di un mondo pieno di artisti, perché sono difficilmente controllabili. Solo rendendosi conto di questo si può prendere posizione di fronte alle tante manipolazioni di massa che tendono a uccidere nell’individuo la sua capacità di plasmarsi la vita a modo suo, inventandosela.
Sì, ma poi dove si va a finire? Ognuno calpesterebbe la libertà dell’altro – dice chi vuole il controllo della vita altrui, e chi accetta o addirittura desidera essere omologato, perché così non ha da sforzarsi a vivere come l’artista che è. E invece non è vero che la creatività dell’uno debba necessariamente diminuire o ostacolare quella dell’altro. C’è posto per tutti al mondo, così come nell’organismo fisico c’è posto per tutti i suoi organi e le loro svariate funzioni.
Noi ci pestiamo i piedi a vicenda non quando siamo creatori o artisti, ma quando omettiamo di esserlo e, con frustrata intolleranza, ci accusiamo a vicenda della nostra povertà interiore. Immaginiamo a vivere insieme Dante, Goethe, Shakespeare o chi di grande si voglia: pensiamo che s’intralcerebbero a vicenda? Ma nemmeno per sogno! Ognuno di loro avrebbe molto di meglio da fare che non andare a ostacolare il lavoro dell’altro.
Noi infrangiamo la libertà altrui quando non sappiamo cosa fare della nostra, quando non abbiamo nella mente, nel cuore e nelle mani il progetto del nostro vivere, e siamo scontenti. Invece chi attiva dentro di sé la sorgente cristallina della sua inventiva, ha talmente tanto da fare che lascia in pace il mondo intero e dice: fate, fate, fate pure quello che vi pare! Intralcia il fare altrui solo chi non ha idee e ideali propri da realizzare, e s’illude di far qualcosa mettendosi a gestire le iniziative altrui. Il mondo d’oggi è pieno non solo di gente che non sa cosa fa, ma più ancora di gente che non sa cosa fare! E non sa cosa fare perché non sa cosa vuole.
Se tutti siamo chiamati a diventare artisti, allora tutto ciò che facciamo può essere fatto in modo ingegnoso. E come? C’è un segreto: bisogna amare sinceramente quello che di volta in volta si fa. Una persona che ama l’attività che svolge, la renderà artistica e creativa – che altro significa amare se non essere creativi? Per essere artisti bisogna amare, e per essere artisti in tutto ciò che si fa bisogna amare ogni azione che si compie.
Se voglio rivolgermi a una persona da artista, devo saperla amare; se non la amo, la sorgente della mia azione sarà forse l’abitudine, o la necessità, o l’opportunismo, o l’invidia, o la rabbia, o l’indifferenza o quello che sia. Se invece le mie azioni nascono dall’amore, allora metterò fantasia nel mio rapporto con lei e ogni mio gesto sarà una nuova pennellata su un quadro d’autore, mai scontata, mai uguale a un’altra. L’amore sa fare di ogni più piccola azione un’opera d’arte, perché fa diventare bello e vero tutto il bene che fa.
Diventare come bambini, ovvero: camminare, parlare e pensare con arte
Nel Vangelo si legge: «Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli» – non entrerete cioè nel mondo dell’amore, dove ci sono solo artisti divini. Dice: se non diventerete come bambini; non dice: se non resterete come bambini – che significherebbe non crescere affatto. L’arte di tutte le arti è diventare sempre più come bambini, man mano che passano gli anni. Come si fa? Bisogna considerare le tre arti fondamentali che ogni bambino impara per natura in modo esemplare, guidato non dalla sua libera coscienza ma dalla fantasia artistica di Esseri divini.
La prima è l’arte del camminare: il bambino passa dal gattonare alla posizione eretta, e poi si mette a camminare. Ascoltando le parole piene d’amore che la lingua «materna» gli fa risuonare dentro, impara poi la seconda grande arte dell’uomo: quella del parlare. Infine, sul fluire di quelle parole che sono intrise di saggezza, che sono tutti pensieri divini cristallizzati, impara la terza divina arte che lo fa essere pienamente uomo: il pensare. È una cosa straordinaria!
Per diventare come bambini bisogna allora imparare – stavolta in modo libero, consapevole e tutto individuale – a camminare, a parlare e a pensare. Il camminare si trasforma per l’adulto in arte del movimento che lo rende capace di orientarsi nella vita, di decidere quale direzione prendere senza lasciarci trainare da nessuno, facendo del proprio cammino di vita un’opera d’arte in cui mette tutto il suo spirito d’iniziativa.
L’arte della parola è quella oggi forse più trascurata dagli adulti: difficilmente ci accorgiamo di quanto sia diventato sciatto il linguaggio quotidiano. È per lo più uno sproloquiare, e mostra tristemente il disamore che c’è in noi verso quella realtà d’infiniti ceselli che è la lingua materna.
L’adulto tende a perdere il gusto della lingua, e deve perciò ridiventare di sua volontà come un bambino: ciò significa riconquistare la gioia di assaporare il suono e il colorito delle parole, beandosene proprio come fa il bambino che con tutto il suo essere vive la meraviglia del parlare.
Certo, se ci accontentiamo di usare la lingua per quel tanto che serve a capirci sulle faccende materiali, il nostro dialogare resta privo di arte. Invece ognuno può imprimere al linguaggio il sigillo della sua individualità d’artista, esprimendo in modo unico e inconfondibile le cose che ha da dire. È lo stile che fa l’individuo: la lingua è la stessa per tutto un popolo, ma il modo di attingere a questa sorgente inesauribile, il modo di forgiare le parole, di tesserle l’una all’altra, può diversificarsi all’infinito indicando la misura di responsabilità che il singolo sente verso le cose che dice. Fammi sentire come parli e ti dirò chi sei.
Per far solo un esempio: un linguaggio italiano che venga intrugliato di parole inglesi fa piangere il cuore, perché uccide quell’artista della parola che c’è in ognuno di noi. Forse perché il destino mi ha portato a vivere un po’ in tutto il mondo, io ho sempre avuto un grande amore e tanta nostalgia per la bella lingua di Dante, che troppo raramente mi è concesso di parlare. Quand’ero a New York passavo giornate intere a studiare il vocabolario della lingua italiana!
E la terza arte del bambino adulto è il pensiero. Pensare creativamente è un’arte impegnativa, perciò è molto più facile pensare a vanvera, andar dietro alle fantasticherie che si affacciano alla mente, suscitate dalle impressioni esterne o dal giornale che si sta leggendo. Pensieri che rotolano e si accavallano per spinte automatiche, per luoghi comuni, per sentito dire, per associazioni prefigurate, per inerzia conoscitiva...
Molti non hanno oggi la più pallida idea di quanta gioia si possa provare nel sentirsi degli artisti del pensiero. È bellissimo anche interessarsi a come l’altro pensa, al timbro, alla tonalità del suo pensiero! Se è robusto, coerente, vivo, originale, mobile, oppure se è un pensiero confuso, nebbioso, disorganico – poco artistico, insomma. Come un bravo pittore sa bene quali colori abbiano davvero qualcosa da dirsi e quali no, così l’artista dei pensieri sa quali concetti vadano bene insieme e quali no. Dimmi come pensi e ti dirò chi sei.
I pensieri belli sono la bellezza della vita
Quando ci s’innamora del pensare, si capisce anche che non vi è arte più sublime di questa. Perché ogni altra arte – che sia del movimento, della parola, dei colori, delle note musicali... – sorge dalle intuizioni pensanti dell’artista. Cos’è che ha fatto di Beethoven un artista così grande? In ultima analisi i suoi pensieri, perché anche una melodia comincia dal pensiero. Una statua, un disegno, un’architettura sono in origine un’idea: non per nulla si dice «ideare qualcosa». Se Dante non avesse avuto alcuna idea da esprimere nella sua Divina Commedia, a che gli sarebbe servita la bellezza della lingua italiana? O tutta la carta e l’inchiostro di questo mondo? La sua opera è come un grandioso palcoscenico sul quale si muovono un’infinità di geniali intuizioni, una miriade di pensieri che illuminano tutti i misteri della vita. I dannati del suo Inferno, i beati del suo Paradiso, cosa sono se non creazioni immortali della sua mente?
L’arte che rende bella la vita è quella di cimentarsi ognuno a modo suo coi pensieri posti all’origine di tutte le cose. I pensieri di Esseri divini hanno creato il mondo, e quelli degli uomini son fatti per ricrearlo. E se il pensare divino è una sapiente creazione, quello umano dev’essere per l’uomo una bella ricreazione! Il materialismo oggi dilagante considera con spocchia l’arte del pensare, la tratta come una Cenerentola, perché non sa più che la sorgente di ogni realtà è lo spirito, è il pensiero che prende forma nella parola e prende corpo nelle azioni degli uomini.
La Divinità ha fatto saltar fuori il mondo dalle sue idee. Se il Creatore non avesse avuto l’idea del quarzo, del tulipano, della giraffa, della montagna..., noi non avremmo attorno a noi quarzi, tulipani, giraffe e montagne. E la ruota, il carro, i mulini, gli orologi, come sono nati? Dai pensieri dell’uomo! Per millenni l’umanità è vissuta senza ruote perché a nessuno era ancora venuta in mente quella bella pensata. E finalmente, a forza di trascinare pesi spaccandosi la schiena, nella mente di qualcuno è brillata d’un guizzo l’idea di quell’ingegnoso aggeggio, ed è stata una rivoluzione. E nonostante questo c’è ancora chi si permette di dire: i pensieri? Mah, in fondo lasciano il tempo che trovano.
Invece, la bellezza della vita sono i pensieri belli e la bruttezza della vita sono i pensieri insipidi. Un’altra bellezza e un’altra bruttezza non ci sono mai state. La vita di una persona è tanto bella quanto sono belli i suoi pensieri, e tanto uggiosa quanto è insulsa la sua testa. Il pensiero è la forma più profonda dell’amore, perché quando intuiamo qualcosa diventiamo una cosa sola con ciò che pensiamo. Quando penso a te il mio spirito s’illumina del tuo essere, e io divento uno con te. Quando ti amo ti sono vicino; quando intuisco il tuo essere sono una cosa sola con te.
I pensieri belli sono fatti per essere amati e goduti, e sono belli perché gettano luce sulla vita e sulle cose. Un pensiero buono mi dà gioia, mi dà lo slancio per andare avanti, mi fa superare anche gli abissi più tenebrosi: anche se il baratro che mi si spalanca davanti è orribile e la situazione sembra disperata, i miei pensieri mi possono sempre salvare. In essi posso trovare la forza di non mollare – che è una delle risorse più importanti nella vita. Solo pensieri intrisi di idealismo possono ridarmi il coraggio di andare avanti, da eterno innamorato della vita. Se no, sono perduto.
A volte diciamo: quella persona lì ha una grande forza interiore. E cos’è mai questa forza? È quella dei suoi pensieri, degli ideali belli che riempiono il suo cuore di coraggio. La materia è il punto morto della creazione, quello determinato da leggi fisse; lo spirito è il suo punto di forza, il punto di leva per ogni nuova creazione. Ogni spirito è fatto di pensieri.
Lo spirito dà vita, la materia conosce solo morte. E noi siamo arrivati al punto da pensare che la materia sia più reale e concreta dello spirito! Ma i conti non tornano, e allora ci ritroviamo sempre più tristi e rassegnati. C’è molto scoramento nel mondo d’oggi, in tanti c’è il vuoto perché mancano i pensieri belli, quelli che davvero ti fanno creare il paradiso in terra.
Lirica, epica e drammatica: tre arti per dar vita al sociale
In un ciclo di conferenze sul sociale4, Rudolf Steiner butta lì, come se niente fosse, alcune brevi riflessioni in cui aggancia i tre tipi tradizionali dell’arte della parola alle tre sfere del sociale.
Un ambito fondamentale della convivenza umana è quello della vita economica, dove si tratta di fabbricare, distribuire e mettere a disposizione di tutti gli strumenti materiali necessari per l’esistenza. La legge che regge l’economia, cioè l’arte che sa renderla davvero umana, è la solidarietà. È l’aiutarsi a vicenda, in modo che ognuno possa soddisfare al meglio i suoi bisogni – mangiare, bere, vestirsi, curarsi, avere un luogo dove abitare...– per potersi dedicare in tutta libertà alle creazioni del suo spirito, secondo i suoi talenti di artista.
La seconda sfera del sociale è quella dove ognuno trova il suo specifico da fare, perché solo l’individuo può sapere quali talenti tutti suoi ha da far fruttare a favore di tutti. È la vita culturale, artistica e produttiva dell’essere umano – Steiner la chiama vita spirituale – il cui carattere è polare rispetto alla vita economica.
Ora, qual è in una ditta il fattore più importante per prosperare? Ma di certo sono le idee, la capacità artistica e creativa di chi ci lavora! La ditta che avrà gli uomini e le donne con le idee migliori avrà più successo. E allora dove si tratta di dar spazio all’inventiva dei talenti individuali, la legge fondamentale non può essere la solidarietà, ma sempre e solo la libertà del singolo di creare secondo i suoi criteri. Ognuno dev’essere libero di decidere da sé che cosa sa e vuole fare per gli altri. Solo lui conosce il modo migliore d’impostare la sua attività, e ciò di cui ha bisogno per dare quel meglio di sé di cui tutti potranno poi godere.
Questi due movimenti artistici del sociale – la solidarietà verso i bisogni degli altri e la libertà nell’esercizio dei propri talenti – fanno fin troppo spesso a pugni tra loro. Se si sottolinea troppo la libertà – come tendono a fare gli imprenditori, i cosiddetti datori di lavoro – va a rotoli la solidarietà, e se si privilegia unilateralmente la solidarietà – come vorrebbero i cosiddetti lavoratori, socialisti e comunisti che siano –, va a ramengo la libertà individuale. Ne conseguono scontri e scioperi a non più finire.
In realtà questi due valori opposti devono vivere sempre in tensione l’uno con l’altro, perché ogni uomo è pieno sia di bisogni, sia di talenti. E questa sana tensione va allora gestita con un tipo di mediazione che dia ugual peso sia alla solidarietà sia alla libertà. Ecco allora il terzo fulcro del sociale: l’uguaglianza. È un’arte eccelsa quella di mirare all’uguaglianza di tutti gli uomini: è l’arte di armonizzare fra loro due fattori che tendono sempre a sbilanciare il sociale. Nello spirito di uguaglianza, ognuno ha uguale diritto di appagare i suoi genuini bisogni, ognuno ha uguale dovere di far fruttare i propri talenti a vantaggio di tutti.
La libertà, la creatività del singolo, non deve venir annacquata col ricatto della solidarietà. Ogni libera capacità creativa è però da parte sua unilaterale, perché se è genuina riguarda solo l’individuo che vuole esercitarla, e che sgomita per affermarsi, per potersi esprimere a modo suo.
Viceversa, la solidarietà non può nello stesso tempo occuparsi della libertà, proprio perché ha a che fare con la costrizione dei bisogni, con uno stato di necessità che induce a chiedere un aiuto dall’esterno. Una condizione, dunque, che è l’esatto opposto dell’attività libera e propositiva che si esercita nell’esprimere la ricchezza esuberante dei propri talenti individuali.
Ecco allora che la vecchia giustizia di cui abbiamo già parlato si rinnova proprio trasformandosi in quell’arte di mediazione che dice: qui si sta diventando troppo unilaterali dalla parte della libera iniziativa, e perciò bisogna bilanciare incrementando la reciproca solidarietà. E in un’altra situazione propone l’opposto. Ognuno di noi ha il dovere non solo di essere solidale con gli altri, ma anche di diventare produttivo per gli altri.
Premesso tutto questo, quel che c’interessa sottolineare in questo contesto è la singolare prospettiva artistica che getta luce su questi tre ambiti della vita sociale, traducendo in parole le loro differenze d’intonazione e di forma.
E allora si scopre che il tipo di linguaggio fatto apposta per esprimere la bellezza artistica della vita culturale, per descrivere quella miniera di talenti che è l’animo di ogni persona, è la lirica. Tutto ciò che vive nell’interiorità dei singoli come attitudine individuale, trova il suo timbro giusto nel canto che più d’ogni altro corrisponde al linguaggio dell’Io – quello lirico, quello che conia le parole e i pensieri a partire dalle conquiste dell’individuo.
La vita economica, invece, tutto ciò che vive nei processi segnati dal lavoro e dalla divisione del lavoro, può essere descritto in tutta la sua bellezza nella tonalità epica. L’epica ha l’andamento solenne del destino, il piglio austero dei bisogni ineluttabili, della natura che impone le sue leggi. L’epica sa disporre nell’orizzonte più ampio possibile tutta la complessa concatenazione degli esseri e degli eventi, per come essi sono nella loro essenzialità e per come chiedono di essere vicendevolmente accolti e sostenuti. Solo l’epica può cantare le grandi epopee che abbracciano la storia d’interi popoli.
La vita giuridica, infine, che vive del respiro ritmico che alterna diritti e doveri, dove si è chiamati a render conto dell’uguale dignità di ogni uomo – che ha pari diritto degli altri a esplicare i suoi talenti e a soddisfare i suoi bisogni –, è bella se viene espressa in chiave drammatica. Qui l’esperienza sociale è un continuo muoversi dall’io al tu, è insieme la parola e l’ascolto, il farsi avanti e il trarsi indietro. Sulla scena di questo mondo ognuno vuole far valere il suo diritto, e l’altro è lì che lo richiama al suo dovere. Il teatro è artistico quando rende artistica la piazza – il palcoscenico dell’esistenza, dove ognuno vuol vivere la propria dignità di uomo.
Drammatica è la sensibilità che ci vuole per perorare in modo convincente la causa della propria vita, concedendo all’altro di far lo stesso per la causa sua. «Tu non hai il diritto d’impedirmi di far questo e quest’altro!... Sta’ al posto tuo!» dice l’uno. «E no! Sei tu che hai il dovere di non farmi mancare questo e quest’altro...» risponde l’altro. Così si esprime l’interagire drammatico fra uomo e uomo. Se uno espone contenuti giuridici parlando in tono epico o lirico, si rende ridicolo, stona, perché la forma non si addice alla realtà che vuol esprimere.
Sono orientamenti di pensiero, questi, che mirano a rendere artistico il sociale in tutt’e tre le sue sfere. Tocca a ognuno lavoraci sopra per vedere se son veri o no, se corrispondono o non corrispondono all’esperienza che abbiamo della comunità umana.
È importante per esempio capire che se ho degli ideali, dei valori, delle mete da conseguire e ne parlo in tono drammatico come se fossero dei diritti, cioè una spinta propulsiva valida per tutti, amministrabile da una legge vincolante per tutti, io apro la porta alla dittatura, alla manipolazione dell’interiorità altrui, all’omologazione delle persone.
Ci vuole l’interiorità aulica della lirica quando l’individuo parla degli ideali che animano la sua libertà. La voce dell’Io è unica in ogni uomo, non cerca facili assonanze, non intende convincere o conquistare, non reclama e non recrimina, non sopporta né alleanze né dipendenze. È libera proprio perché si regge da sola, e cerca un linguaggio che onori la sua elegiaca unicità. Ma oggi il lirismo della vita culturale non trova cantori, anche perché nell’umanità moderna c’è il rischio che faccia l’effetto di un sonnifero.
L’economia, da parte sua, è il mondo delle gesta, delle grandi «imprese», delle opere appunto che da bravi imprenditori compiamo gli uni per gli altri, intessendo le nostre vite. Immaginiamo di cantare a voce alta l’epopea di una ditta: la lunga lotta dei lavoratori per passare dal ricatto alla solidarietà, tutte le vicende che convergono nel miglior servizio da rendere agli altri, raccontate in forma epica. Le imprese di una ditta come l’Olivetti potrebbero risultare non meno eroiche di quelle dell’Orlando Furioso!
E tutto ciò che è di natura giuridica cerca l’elemento drammatico, perché vive nel movimento continuo tra la libertà e la dedizione, tra il talento e il bisogno, tra il diritto e il dovere, tra la voglia d’essere lasciati in pace e la pietà che si vorrebbe per se stessi e che il mondo, a sua volta, chiede.
Lirica è la voce alta e vibrante del singolo che rivela il suo mondo interiore, epica è la voce bassa e cadenzata di uomini che lavorano insieme – e non sempre le due voci s’intendono. Drammatica dev’essere allora la voce che si leva nel mezzo per creare un ponte vivente, fatto di conoscenza e di amore, di forze della mente e di forze del cuore. Ogni dramma è un modo nuovo d’incontrarsi di ciò che è lirico e di ciò che è epico. Esprimendo liricamente i propri talenti, appagando epicamente i bisogni altrui, vivendo in modo drammatico la tensione fra i suoi e gli altrui diritti e doveri, l’uomo diventa un artista della vita sociale, un eterno innamorato delle infinite occasioni che gli vengono offerte per diventare sempre più umano.
Tre amori dispersi che vogliono riunirsi in me
L’evoluzione dell’arte è la storia di tre antichi amori che hanno finito per far divorzio. C’erano una volta la verità, la bellezza e la bontà, e si amavano a vicenda. Erano una cosa sola, come il maschile e il femminile all’inizio dell’evoluzione. Ai primordi dell’umanità, una cosa non poteva essere bella senza essere vera e buona, non poteva essere vera se non era anche buona e bella, e non poteva essere buona senza essere bella e vera.
Poi, col passare del tempo, bellezza verità e bontà si sono comportate come tre signore che prendono sempre più le distanze l’una dall’altra. Oggi la scissione fra queste tre vie dell’umano è compiuta, tant’è vero che la scienza moderna – che dovrebbe essere la ricerca del vero – non si cura né del bello né del buono. La religione – che vorrebbe essere la ricerca del buono – trascura ormai sia il bello dell’arte, sia la verità della scienza. E infine l’arte – che è la ricerca del bello – evita da un bel po’ di tempo sia il vero sia il buono.
Qualche voce si è levata qua e là per ridare un po’ di etica alla scienza, e siamo nei guai, perché la scienza rimbecca: ma che c’entra l’etica con me? Qualcun altro ha tentato d’indagare scientificamente i misteri del divino, e subito la religione si è risentita: non è importante che tu capisca, ha ripetuto per l’ennesima volta, anzi non ne sei proprio capace. Ciò che conta è la fede. Il che significa: il buono lo si può avere prescindendo dal vero. E se qualcuno poi si permette di dire: ma quest’opera d’arte io non la capisco..., gli si risponde: il bello è soggettivo, non c’è nulla da capire, perciò la tua perplessità dice semplicemente che questo quadro non ti piace. Puro estetismo.
Se è vero che la bellezza (l’arte), la verità (la scienza) e la bontà morale (la religione) sono andate ognuna per conto proprio, qual è il senso evolutivo di questa separazione? Il senso tutto positivo è che, trovandole divise, l’individuo ha la possibilità di rimetterle insieme, di rifarne l’unità come opera d’arte tutta sua. Il presupposto è che sia davvero innamorato di tutte e tre.
La riconciliazione reciproca fra la bellezza, la verità e la bontà si compie nella mente e nel cuore del singolo artista umano, e questa riunificazione costituisce l’esperienza più bella e più vasta che ci sia. La testa vuol pensare una verità che sia anche bella e buona, perché capisce che qualcosa è vero solo quando se ne può cogliere anche la bellezza e la bontà. Se una cosa non è buona per l’uomo, come fa a esprimere una verità sull’uomo? La verità sull’uomo non è altro che ciò che gli fa bene, che gli rende più bella la vita.
Nella sua mente e nel suo cuore l’individuo dice: voglio un’arte che si occupi anche della conoscenza oggettiva della realtà, che non ne dimentichi la sostanza morale; voglio una scienza che sappia gustare la bellezza e la bontà delle cose; voglio una religione che non predichi più il buono senza convincermi che è pure bello e vero. Non voglio più una realtà fatta a pezzi perché io stesso, altrimenti, mi sento a pezzi, e vivo l’angoscia di un mondo che mi appare brutto, insensato e cattivo.
È un salto qualitativo in avanti, questo, che solo l’individuo come sommo artista della creazione può compiere. Nessuno può unificare al posto mio l’arte, la scienza e la religione: o tornano a cercarsi e amarsi nella mia mente e nel mio cuore, o per me restano separate l’una dall’altra.
L’evoluzione è mossa dall’amore che è insito nella natura umana, un amore inesauribile che sa pensare la verità dell’universo da ogni orizzonte, che sa inondare di bellezza tutti gli esseri innamorandosene nel suo cuore, che sa trasfigurare il mondo intero facendolo risorgere con la volontà buona delle sue azioni.
«L’amor che muove il sole e l’altre stelle» ha creato per gli uomini la terra, ponendola al centro del loro universo. Un cosmo di saggezza, dai cui segreti nasciamo per trasformare ogni scintilla di sapienza divina in una fiamma di amore umano.
L’ombra della nostra solitudine è la più grande «lacuna dell’universo», l’antica ferita nel cuore di ogni uomo, ferita che si rimargina col balsamo della sua stessa linfa, quella che straripa e sovrabbonda alla ricerca di altri cuori.
Lasciarsi attraversare l’anima da ogni creatura che vive sulla terra è dirle: tu sei bella per l’infinita saggezza divina che è racchiusa in te, ma sei ancora più bella quando io ti porto via con me nell’universo nuovo che nasce dall’amore umano.
4 Rudolf Steiner, 6 conferenze tenute a Dornach dall’11 al 16 ottobre 1921, raccolte nel volume 339 dell’Opera Omnia, non tradotto in italiano.
A proposito di Pietro Archiati
Pietro Archiati è nato nel 1944 a Capriano del Colle (Brescia). Ha studiato teologia e filosofia alla Gregoriana di Roma e più tardi all’Università statale di Monaco di Baviera. È stato insegnante nel Laos durante gli anni più duri della guerra del Vietnam (1968-70).
Dal 1974 al 1976 ha vissuto a New York nell’ambito dell’ordine missionario nel quale era entrato all’età di dieci anni.
Nel 1977, durante un periodo di eremitaggio sul lago di Como, ha scoperto gli scritti di Rudolf Steiner la cui scienza dello spirito – destinata a diventare la grande passione della sua vita – indaga non solo il mondo sensibile ma anche quello invisibile, e permette così sia alla scienza sia alla religione di fare un bel passo in avanti.
Dal 1981 al 1985 ha insegnato in un seminario in Sudafrica durante gli ultimi anni della segregazione razziale.
Dal 1987 vive in Germania come libero professionista, indipendente da qualsiasi tipo di istituzione, e tiene conferenze, seminari e convegni in vari Paesi. I suoi libri sono dedicati allo spirito libero di ogni essere umano, alle sue inesauribili risorse intellettive e morali.

Quest’opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons. Salvo dove diversamente indicato, per i materiali presenti su questo sito vale la Licenza Creative Common “Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0”: è libera la riproduzione (parziale o totale), diffusione, pubblicazione su diversi formati, esecuzione o modifica, purché non a scopi commerciali o di lucro e a condizione che vengano indicati gli autori e, tramite link, il contesto originario.
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/