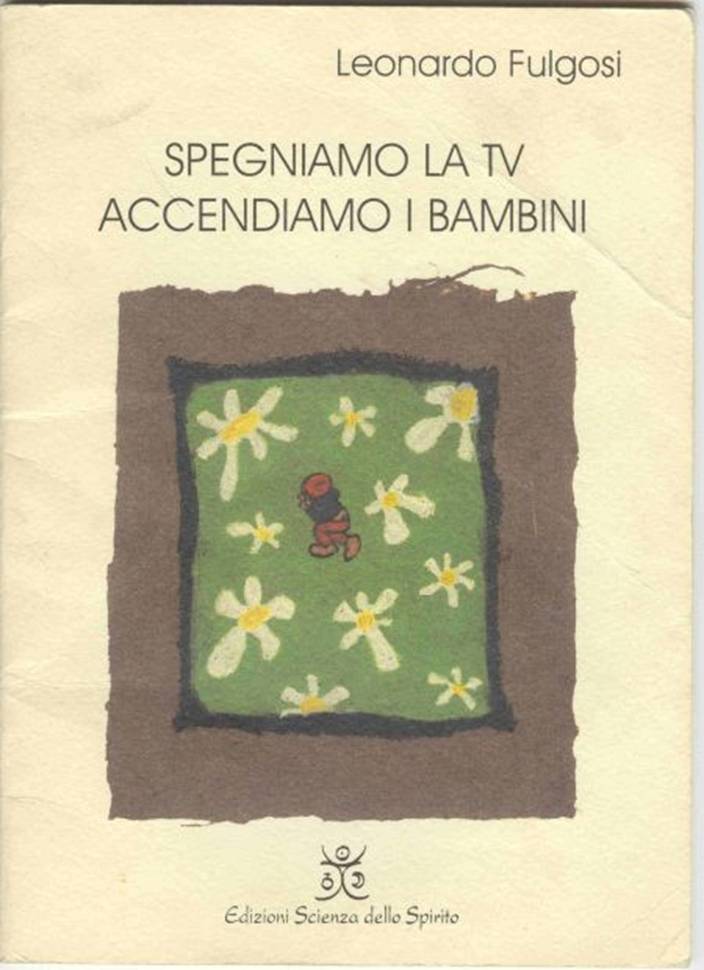
Leonardo Fulgosi
SPEGNIAMO
LATV
ACCENDIAMO
I BAMBINI
«DEMOCRAZIA ELETTRONICA» O NUOVE
DIPENDENZE?
DAVVERO LA TELEVISIONE PROMUOVE LA
CULTURA?
COME AVVENGONO LE PERCEZIONI
SENSORIALI
LE ALTERAZIONI DEL PROCESSO
PERCETTIVO DAVANTI ALLA TELEVISIONE
I BAMBINI STANNO COSÌ BUONI DAVANTI
ALLA TV! INIZIA L’INTOSSICAZIONE
@1998 - Edizioni Scienza
dello Spirito Tutti i diritti riservati
Via A. Serranti, 51
- 00136 - Roma Tel. - Fax. 0635401777
ISBN 88 - 860 - 12
- 9
Il dottor Leonardo
Fulgosi[1]
svolge la sua attività professionale di medico da più di trent’anni nel campo
della Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica, nate dall’impulso
dato alla pedagogia contemporanea dal filosofo austriaco Rudolf Steiner.
È
co-direttore del Centro Perceval di St. Prex (Losanna) e collabora
attivamente a livello internazionale con varie istituzioni quali comunità
terapeutiche, villaggi Camphill, scuole Waldorf. La scelta di dedicare la
propria attività alla cura e all’assistenza di bambini, adolescenti e adulti
disabili mentali è legata all’incontro e alla collaborazione con Karl König,
fondatore in Scozia nel 1940 della prima comunità Camphill e del successivo
Movimento Camphill, presente con diverse istituzioni in vari Paesi del mondo.
Tali
realizzazioni costituiscono una delle forme in cui la Pedagogia Curativa e
la Socioterapia Antroposofica si esprimono dando vita a comunità-villaggi,
scuole, scuole-internato, case-famiglia, laboratori integrati, ma anche a
seminari teoricopratici per la formazione professionale degli educatori e dei
terapeuti e a corsi speciali per medici.
L’attività del dott.
Fulgosi è anche rivolta - attraverso associazioni internazionali quali l’European
Cooperation in Anthroposophical Curative Education and Social Therapy - a
far conoscere il contributo e il valore scientifico di questa esperienza
educativo-terapeutica e a mettere in luce l’importanza sociale delle comunità
in seno alle quali vivono e lavorano insieme persone sane e persone disabili
Si
spera che questo generoso impegno possa contribuire a far nascere nuove
iniziative anche in Italia, dove solo recentemente si sono mossi i primi passi
con la fondazione del centro Casa Loïc a Capena, nelle vicinanze di
Roma.
I tanti anni di
lavoro dedicati a chi ha bisogno di cure nel corpo e nell’anima hanno portato
in particolare Leonardo Fulgosi ad una osservazione più attenta delle
molteplici problematiche di crescita interiore e sociale che riguardano anche i
bambini cosiddetti normali: da qui il suo interesse e la sua partecipazione
attiva verso ogni iniziativa pedagogica ed educativa che voglia comprendere lo
spirito del nostro tempo e dedicarsi ai nuovi compiti evolutivi dell’umanità.
Da
qui è nata anche l’idea di raccogliere in questo libretto alcune importanti
riflessioni scientifiche - tratte da due conferenze tenute a Roma da Leonardo
Fulgosi - su aspetti rilevanti e poco noti degli effetti della televisione, un medium
che sta ormai forgiando le nuove generazioni.
Rita Amadio Di Tanno
Presidente dell’Associazione di
Lingua Italiana
per la
Pedagogia Curativa
e la
Socioterapia Antroposofica
(via
Carducci, 10 - 00187 Roma)
Roma, maggio 1998
Oggi, quando vogliamo
descrivere nuovi fenomeni, introduciamo spesso delle novità anche in campo linguistico:
ogni settimana, se non proprio ogni giorno, per esprimere al meglio i concetti
di recente acquisizione coniamo nuovi vocaboli, nuove sigle. È interessante,
allora, rilevare che quando si parla di media elettronici - televisione,
videogiochi, computer, realtà virtuali ecc. - tutto viene riassunto sotto la
denominazione di «democrazia elettronica». In questo caso è evidente, però, che
stiamo davvero diventando maestri nel creare un linguaggio che esprime concetti
diametralmente opposti alla realtà dei fatti!
Si
sa già da tanto tempo - direi da quando sono state trasmesse le prime
interviste televisive - che in realtà i mass media sono forse i mezzi di
comunicazione meno democratici che esistano: e in particolare proprio la
televisione. Se è vero, infatti, che grazie a questo strumento centinaia di
milioni di persone possono essere raggiunte nello stesso secondo dallo stesso
messaggio, è anche vero che la decisione di diramare quei contenuti è nelle
mani di pochissimi. Quindi non si sa da che parte stia il concetto di
democrazia, che dovrebbe significare la sovranità attiva di tutti.
Quaranta
anni fa porre la televisione nella lista delle droghe sarebbe stato considerato
quasi un’eresia: io stesso, quando nel 1967 scrissi un articolo per la rivista
farmaceutica Weleda sulle tossicomanie nello sviluppo dei ragazzi,
suscitai molte perplessità perché avevo inserito la televisione al terzo posto.
Oggi, nella lista internazionale delle droghe, non solo la televisione compare
al terzo posto - dopo l’alcool e il tabacco -, ma già dal 1985 è considerata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la più pericolosa droga infantile,
propedeutica a tutte quelle dell’età giovanile e adulta. Perché?
Perché
rende dipendenti, è la semplice risposta. E ciò che rende dipendenti è tossico.
Si potrebbe obiettare che siamo dipendenti da moltissime altre cose, ma non per
questo le consideriamo droghe. È vero, ma qui bisogna fare una distinzione tra
le necessità e i bisogni primari legati alla vita e ciò che si può inserire come
fenomeno di dipendenza aggiuntiva. Ad esempio, il nostro corpo è composto per
il 78% di liquidi, principalmente acqua: per sopravvivere, perciò, abbiamo
giornalmente bisogno di bere. Sappiamo bene che il nostro organismo può
resistere per settimane e addirittura per mesi senza assumere cibo, ma è
assolutamente indispensabile l’apporto costante di liquidi. Nonostante questo,
non ci riteniamo dei «drogati d’acqua»! È la composizione del nostro corpo che
richiede acqua, è una necessità naturale della vita.
Ora prendiamo il caso
della caffeina o della nicotina: queste sostanze non sono necessarie alla vita.
Noi viviamo benissimo senza caffè e senza sigarette: non sono indispensabili
per pensare, per agire, per provare emozioni. Però siamo liberi di aggiungere
queste sostanze ai nostri processi di vita e, almeno inizialmente, le
controlliamo, le dosiamo: siamo in grado di assumerle solamente quando vogliamo
stimolare certe funzioni. Nel momento in cui questa assunzione esce dal nostro
controllo, e quantitativamente e qualitativamente entra a far parte dei bisogni
organici della nostra organizzazione fisico-animica, essa diventa al contempo
una necessità naturale e quindi coattiva, un’esigenza aggiunta. E diventiamo
dipendenti.
Ebbene,
la televisione ha mostrato fin dal suo primo apparire questa tendenza.
La prima emissione televisiva di informazione fu trasmessa il 30 aprile 1939
durante l’inaugurazione dell’Esposizione Mondiale di New York, ma ci si
lavorava da molto tempo, già dagli anni Venti. Erano stati allestiti stand dove
la gente poteva fermarsi e osservare in uno schermo primitivo - si
vedeva anche il tubo catodico! - ciò che le telecamere riprendevano all’interno
dell’Esposizione. Fu un evento di incredibile fascinazione perché insieme alla
trasmissione veniva data anche la notizia che era possibile acquistare questi
«tubi con schermo». Seguiva l’elenco dei negozi, davanti ai quali si andarono
formando nei giorni successivi lunghe file di acquirenti che noi europei potremmo
paragonare a quelle che si facevano in tempo di guerra per comperare il pane.
Di fronte al fenomeno
televisione che si è manifestato subito come estremamente potente e capace di indurre
all’assuefazione, è altrettanto forte e comune il convincimento positivo che
grazie ad esso si sia verificata un’enorme diffusione delle informazioni e che
perciò la cultura sia diventata per tutti più reale e più a portata di mano.
Più «democratica», insomma.
Su
quest’ultimo argomento, che sembra quasi ovvio, potremmo discutere per
settimane senza metterci mai d’accordo. Basti pensare che già nel 1991
Frederick Case pubblicò sul Seattle Times un interessante studio a
livello universitario sul rapporto che intercorre negli USA e in Canada fra la
televisione e la diminuzione dell’attività cerebrale, con conseguente calo
delle attività di lettura (libri e giornali). Poi, nel 1993, arrivò dagli Stati
Uniti uno studio statistico nazionale che rilevava come il 50% degli adulti
sapesse a malapena leggere e scrivere; inoltre si riscontrava che la stragrande
maggioranza dei bambini presentava problemi di dislessia e disgrafia, cioè una
profonda difficoltà a imparare a leggere e a scrivere.
È
strano come soprattutto nelle società cosiddette avanzate ci si culli
nell’illusione di vivere all’interno di una civiltà ad alto livello culturale e
non ci si accorga delle regressioni in atto, a volte dovute proprio agli
effetti del progresso scientifico. È noto, però, il modo di procedere della
scienza: dovendosi basare sugli esperimenti fisici e sull’indagine materiale,
essa produce nel presente, non può predire il futuro e fa statistiche sul
passato.
Come
funziona, per esempio, l’immissione di nuovi farmaci sul mercato? Si
sperimentano prima sugli animali e si teorizza il possibile effetto sull’uomo;
poi si prende un certo numero di cavie umane e, se non si riscontrano effetti
secondari (o la percentuale dei danni è così bassa da non reggere al confronto
dei vantaggi che ci si aspettano), il prodotto viene messo in commercio. Dopo
10, 15 o 20 anni si forma una coda scientifica al farmaco costituita da tutti i
dati raccolti attorno ai suoi effetti: se i danni provocati sono notevoli, il
farmaco viene ritirato.
Anche
riguardo al «prodotto televisione» siamo pieni di dati: io mi ricordo che a
metà degli anni ‘50, quando ero ancora studente, apparve in Francia uno studio
veramente interessante ed approfondito circa gli effetti della televisione
sull’organismo e sulla psiche della popolazione compresa fra i 14 e i 25 anni.
In particolare ci si interrogava sul perché le cosiddette «trasformazioni della
personalità» - dovute al desiderio di emulazione che gli idoli del cinema
avevano provocato nei giovani - non si verificassero affatto riguardo ai
personaggi televisivi. Sembrava che la televisione non lasciasse impronte: a
domande sulle foto di politici, statisti e volti vari che giornalmente
apparivano in televisione, difficilmente si otteneva dai ragazzi più di un:
«Sì, l’ho visto, ma non so chi sia». Alcuni personaggi venivano perfino confusi
fra loro. Se ne concluse che la televisione non portava all’identificazione col
personaggio, ma non favoriva nemmeno una corretta informazione.
Un
altro interessante studio sul fenomeno televisivo fu svolto e pubblicato alla
fine degli anni ‘70, in Australia, dai ricercatori Merrelyn e Fred Emery
insieme a un’équipe di psicologi, psichiatri, medici, educatori, pedagogisti e
pubblicitari. La ricerca fu condotta in modo intelligentissimo perché
non si basò su questionari del tipo: vi piace la televisione? quali programmi
preferite? ecc., ma fu condotta per anni incontrando porta a porta i
telespettatori e ponendo loro domande mirate a far luce sulla qualità della
vita del loro pensare, del loro sentire e del loro volere quando si
ponevano davanti alla televisione. Ne risultò che l’efficacia del messaggio
televisivo traeva la sua potenza dal vuoto dell’anima che essa stessa
provocava. In questo vuoto si inseriva il messaggio.
Da
questa ricerca fu molto colpito Jerry Mander, un economista americano che per
15 anni aveva creato spot pubblicitari televisivi ed era rimasto sconcertato
dalla facilità con cui la gente si entusiasmava all’acquisto dei prodotti da
lui stesso pubblicizzati: era entrato in crisi con la sua coscienza, non
riusciva più a dormire e voleva capire come diavolo potesse essere così facile
ingannare le persone. Jerry Mander, poi, pubblicò la ricerca dell’équipe
australiana nel libro Quattro argomenti per l’eliminazione della televisione
e abbandonò la sua professione di pubblicitario, nonostante fosse per lui
una fonte di notevole ricchezza.
A
distanza di oltre vent’anni da questi primi studi, dobbiamo aggiungere un altro
drammatico fatto: l’umanità, quasi in modo unitario, è ormai cresciuta
con la televisione. Vanno scomparendo le generazioni che non hanno avuto
un’educazione e una pedagogia fondamentalmente basate sui media elettronici:
oggi l’enorme maggioranza degli esseri umani subisce questo trattamento
formativo.
Su
uno di quei giornalini settimanali che pubblicizzano i videogiochi e che
vengono distribuiti gratuitamente mi è capitato di leggere un articolo di
alcuni psicologi che si ponevano la domanda: ci si deve allarmare di fronte al
giro d’affari dei videogiochi che ha superato di gran lunga quello del cinema e
si sta diffondendo su vastissima scala? E rispondevano: il risvolto economico
certamente esiste, ma niente panico! Questi videogiochi, infatti, stimolano la
capacità di operare con intelligenza, sono comunque buoni per le teste.
Come
dicevo prima, potremmo discutere lungamente su questi temi mantenendo idee e
opinioni diametralmente opposte.
Da
una parte si parla della necessità di ridurre le ore che i bambini trascorrono
davanti alla televisione, del dovere sociale di scegliere per loro programmi
adatti, senza scene di violenza, di sesso e così via: perfino il presidente
degli Stati Uniti Clinton ha promosso una campagna per mettere «sotto chiave»
la televisione in modo che i piccoli non la possano utilizzare.
Da
un’altra parte, però, questi movimenti d’opinione passano subito, hanno un
minuto di fiamma e poi si spengono senza risultati perché è impossibile
eliminare o controllare realmente la televisione: la televisione è
dappertutto. Anche là dove noi non intendiamo incontrarla, c’è: nel
traffico, agli angoli delle strade, nei supermercati, nelle banche, nelle
vetrine dei negozi, negli aeroporti, sugli aerei, sui treni, nei bar, nei
ristoranti, nella sala d’attesa del dentista... Non ce ne possiamo più disfare.
Tutto è basato sul sistema della «democrazia elettronica».
Eppure
qualcosa si può fare, si dovrebbe fare: non possiamo, come esseri umani capaci
di pensare, di sentire e di volere, non renderci conto che esistono aspetti
legati alla cultura dei media elettronici che operano effettivamente contro
l’umanità perché non ne favoriscono lo sviluppo ma, al contrario, la
defraudano, la debilitano, la incatenano.
Ma
da dove si deve cominciare? Io direi: cominciamo proprio dal bambino perché è
l’essere più fragile, più esposto, più in pericolo.
Due giorni fa è apparsa
sui giornali la notizia che in uno Stato americano tre bambini di sette, otto e
undici anni hanno violentato una bimba di tre imitando alcuni violentissimi
gesti visti in televisione. Notizie di questo genere sono sempre più frequenti
e sembrano impossibili.
La
mattina del 17 dicembre 1997, a Tokyo, nei reparti ospedalieri di pediatria
sono stati ricoverati più di seicento bambini in preda a crisi epilettiche. Di
fronte a questa strana «epidemia» inizialmente si è pensato ad una
intossicazione alimentare ma, procedendo all’analisi delle sostanze ingerite
dai bambini, non si è venuti a capo di nulla. Infine, è emerso il fattore
comune: la sera precedente tutti i ragazzini avevano guardato un programma
televisivo di cartoni animati, quelli tipici giapponesi estremamente elaborati
sul piano del colore e del movimento, capaci di risucchiare con prepotenza
l’attenzione di chi guarda. Gli psicologi, subito interpellati, non hanno
ravvisato però alcun nesso possibile fra questa esplosione di crisi epilettiche
e la semplice visione dei cartoni animati in TV. Due giorni dopo, altri settecento
bambini finiscono di nuovo in ospedale con gli stessi malanni e con gli stessi
precedenti televisivi: ormai la causa è chiara, ma rimane la difficoltà di
fondare scientificamente il caso.
Sul
piano della psicologia non si riesce infatti a dirimere la grande confusione
tra il valore formativo e informativo dei media elettronici cioè il loro
valore cosiddetto culturale, e i possibili effetti - che qui chiamerei
veramente «tecnico-meccanici» - dell’apparecchio stesso sulla fisiologia del
bambino.
Sappiamo
bene che il neonato apre all’ambiente circostante tutti i suoi sensi. Non ne
può fare a meno: egli vive delle sue percezioni sensoriali. Si potrebbe anzi
dire che più le sue percezioni sensoriali si ampliano e più ha la forza di
crescere. Noi tendiamo a privilegiare l’alimentazione quando pensiamo alla
crescita: c’è anche questo fattore, naturalmente, ma «il diventare grandi» non
riguarda solo il corpo, riguarda tutto l’essere. Riguarda il sentimento, il
pensiero, la volontà.
Quindi,
se vogliamo parlare in termini di psicologia, dobbiamo farlo in modo chiaro e
dobbiamo dire: il corpo e l’anima del bambino crescono in rapporto alla qualità
e alla quantità delle sue percezioni sensoriali. E a mano a mano che le
percezioni crescono, egli inizia ad amare il mondo e lo dimostra: comincia a
camminare, va incontro alle cose e alle persone, vuole toccare, vuole
sentire... La sua volontà entra sempre di più in movimento perché il bambino
non vede e tocca soltanto, ma vuole vedere, vuole toccare...
Una
delle più grandi scoperte nel campo della psicologia è stata fatta quando si è
osservato che il neonato incrocia per la prima volta gli occhi della madre non
solo perché è attirato dallo sguardo di lei, carico della sua volontà di essere
riconosciuta, ma anche perché il bambino stesso ha improvvisamente un’attività
più sveglia nel suo vedere e vuole incontrare lo sguardo della mamma.
Esiste una volontà nella percezione sensoriale del bambino che lo porta
a scoprire il mondo. E più il bambino cresce in questa scoperta e più ama il
mondo, e più ama il mondo e più si muove per andargli incontro.
La
verticalità della postura, lo sviluppo del linguaggio, l’associazione delle
idee, tutto è legato alla percezione sensoriale. Uno degli eventi più
straordinari di questo meraviglioso fenomeno è il processo dell’imitazione. Il
bambino imita. Se lo osserviamo bene, egli non ripete soltanto l’esteriorità di
un gesto che vede fare, ma lo coglie nella sua totalità vivente, imita cioè
anche «il gesto dell’anima» che lo sostanzia, lo suscita e l’accompagna. Egli
si inserisce completamente nelle cose che osserva nel mondo: quando imita il
canarino, o il cagnolino, o il papà, c’è dentro completamente. È così
che impara a conoscere il mondo.
Ora,
per renderci davvero conto di come questi processi avvengano, bisogna compiere
un piccolo passo nella fisiologia e approfondire un poco la comprensione di
quanto succede quando guardiamo, ascoltiamo o tocchiamo. È facile dire che
l’occhio vede perché le sue cellule nervose, colpite dalla luce, dai colori,
trasmettono queste sollecitazioni al cervello e ve le inscrivono. Oggi si parla
addirittura di «banche della memoria», di veri e propri compartimenti cerebrali
in cui tutte le impressioni sensoriali affondano per poi risorgere nel processo
della memoria. Ma che cosa succede quando andiamo da Roma a Firenze su un treno
Eurostar che viaggia a oltre duecento
chilometri l’ora e vediamo un mucchio di cose dal finestrino e poi, a
ripensarci, non ce le ricordiamo? Eppure l’occhio ha visto, non possiamo
negarlo.
Dunque
c’è qualcosa di più che non il solo stimolo ottico che si produce nel fondo
dell’occhio e che i nervi ottici trasmettono a quella porzione del cervello
dove comincia a distribuirsi e a «immagazzinarsi» ciò che poi chiamiamo
memoria. In effetti il vero processo è inverso e assomiglia un po’ al
fotografare. Noi diciamo: scatto una foto alla cupola di S. Pietro così mi
rimane il ricordo, una specie di memoria istantanea di questa bella percezione
visiva. Sì, i fatti sarebbero questi se la macchina fotografica fosse capace di
fare tutto da sola! Ma io devo prima guardare nel mirino, devo avere
un’impressione, valutare se l’inquadratura mi piace o no, se la luce batte
dalla parte giusta: ci rifletto, e solo dopo scatto la fotografia.
Fisiologicamente è questo che succede quando il nostro occhio vede, animato
dalla volontà di vedere. E noi, più tardi, siamo capaci di ricordare il veduto
perché la nostra anima ha partecipato alla percezione e l’ha accolta.
Riflettiamo
ancora su un altro esempio per meglio chiarire il processo percettivo normale:
andiamo a fare una passeggiata con una persona e vediamo degli alberi. Torniamo
a casa e cominciamo a descriverceli: forse per le nostre diverse capacità di
linguaggio, ma certo anche per il diverso modo di percepire, fatto è che questi
alberi nel racconto nostro e in quello dell’altro risorgono differenti. Se poi,
dopo un paio d’anni, ritorneremo nello stesso posto, ci accorgeremo di trovare
un luogo ancora diverso rispetto alle immagini che richiamavamo nella nostra memoria.
È sempre così con la memoria: non è mai identica a quello che ci ritroviamo
sotto gli occhi dopo qualche tempo. Può trattarsi di un quadro, di un
monumento, di un paesaggio: quando dalla nostra memoria rifacciamo il confronto
con la realtà troviamo alcune differenze. Questo è il segno che è intervenuto
un processo psicologico soggettivo a fare da intermediario nell’operazione di
inscrizione cerebrale di quelle percezioni, che poi diventeranno memoria. Le
differenze, insomma, ce le abbiamo messe noi.
L’essere
umano dunque, e in particolar modo il bambino, non è volto soltanto a subire la
percezione, ma vorrebbe in un certo senso costruirla: siccome ciò è impossibile
(perché tutte le percezioni ci toccano dal di fuori così come sono e quasi mai
le possiamo scegliere), allora egli edifica il modo di voler percepire attraverso
i fenomeni, va cioè incontro volitivamente alle percezioni stesse. È un
processo paziente, lungo, ripetitivo. E complesso: per esempio, noi non
possiamo mai separare nettamente un senso dagli altri sensi; tutte le vie
d’accesso sensoriale si incontrano e si combinano insieme in un intreccio
estremamente multiforme.
Quando
l’attenzione o l’intenzione volitiva che ho adesso descritto non accompagnano
il guardare - per esempio perché le immagini scorrono troppo velocemente, come
accade viaggiando sull’Eurostar -
siamo di fronte a un tipo di percezione non mediata che va a scaricarsi
direttamente nel sistema nervoso centrale e, conseguentemente, genera un altro
tipo di memoria, molto più profonda e molto meno cosciente, capace però di
riaffiorare all’improvviso in alcuni momenti particolari della vita. Ciò accade
anche quando guardiamo la televisione.
Per
meglio orientarci dobbiamo per prima cosa sapere come si forma un’immagine
televisiva: bisogna allora risalire al 1884, al tempo in cui Paul Nipkow, un
ricercatore di origine tedesco-russa, sperimentò per la prima volta la
scomposizione e la ricomposizione di un’immagine tramite impulsi luminosi. Egli
costruì e brevettò un dispositivo di trasmissione d’immagini: il disco
analizzatore. Era un disco perforato che ruotava rapidamente per decomporre
l’immagine in punti luminosi e scuri. Questi punti, convertiti in segnali
elettrici telegrafati ad un recettore, erano riconvertiti in punti luminosi e
scuri che ricostruivano l’immagine con l’aiuto di un secondo disco perforato,
sincronizzato sul primo. Era un procedimento primitivo, l’immagine era imperfetta,
ma il principio di scomporla in stimoli luminosi è il principio stesso della
televisione.
Sullo
schermo televisivo ci sono 625 linee orizzontali su cui scorrono numerosissimi
puntini di varia gradazione luminosa che vanno a formare quell’immagine che noi
crediamo di vedere nella sua unità, ma che nella realtà non esiste: non è come
la fotografia che ferma l’immagine imprimendola sulla pellicola, procedura,
questa, che sta alla base del meno dannoso cinema. Nella televisione non c’è
pellicola! Le immagini televisive sono prodotte continuamente dal movimento
velocissimo del pennello elettronico (un fascio di elettroni) che percorre per
25 volte al secondo tutte le 625 linee «scrivendo» puntini fluorescenti di
diversa intensità sullo schermo, a seconda delle informazioni di lettura che
riceve, tramite l’antenna, dalla centrale di emittenza. La televisione ad alta
definizione ha addirittura 750 linee, e quindi il pennello procede a una
velocità ancora maggiore per costruire le 25 immagini al secondo.
Ma
perché proprio 25 al secondo? Per riuscire, come si dice in ottica, ad
«ingannare» l’occhio. Infatti l’occhio umano è capace di registrare sulla
retina soltanto 16 immagini al secondo: se ne riceve di più si verifica quel
fenomeno che conosciamo sotto il nome di «persistenza delle immagini sulla
retina». Ciò vuol dire che sia l’interezza delle immagini televisive sia la
continuità del loro movimento[2]
sono illusorie e sono dovute al fatto che noi trasciniamo sulla retina le
impressioni luminose ricevute prima e ve ne accavalliamo altre sopra mentre il
sistema nervoso centrale, che è completamente ricettivo e non reattivo,
incamera le immagini ricostruite dall’occhio. Se così non fosse ci accorgeremmo
di avere davanti soltanto degli sfavillii.
Noi
stessi, come adulti, non possiamo seguire con la coscienza questo processo:
figuriamoci un bambino. Non solo, ma nel bambino si aggiunge il pericolo di
alterare le basi stesse del processo conoscitivo umano. Infatti, se noi
osserviamo attentamente il modo di apprendere dei bambini, vediamo che essi
accompagnano sempre col movimento qualunque stimolo arrivi al loro sistema
nervoso centrale. Affinché una rappresentazione, un’immagine, un’idea, un gesto
possano diventare per il bambino un vivo patrimonio conoscitivo devono
ricevere, potremmo dire, il timbro caldo del suo sangue.
Ogni
insegnante sa bene che, se pretende che i bambini stiano fermi e seduti ad
ascoltarlo per ore ed ore, non otterrà un bel niente: i bambini vogliono
provare quello che si dice, vogliono sperimentarlo muovendosi. Se noi chiediamo:
dov’è il nord?, non si metteranno quieti quieti a pescare nella memoria chissà
quale indicazione ma cominceranno a muoversi, andranno alla finestra,
cercheranno il sole e gesticolando di qua e di là troveranno e ripercorreranno
la direzione nord. E questo vale per qualunque altra acquisizione cognitiva.
Ora,
è proprio il movimento quello che viene paralizzato dalla televisione che,
infatti, non stimola il processo conoscitivo ma, al contrario, richiede
passività affinché quella cascata di stimoli possa entrare il più facilmente
possibile e imprimersi nel sistema nervoso centrale. Il bambino, che è ancora
vergine nella sua capacità visiva, in un primo momento comincia a vedere queste
miriadi di stimoli luminosi, simili a scintille, e ne è attratto, si avvicina
per toccarle; poi, però, viene sopraffatto dal messaggio che esse portano con
sé: «Lasciati andare, lasciati andare, e noi penetreremo più facilmente dentro
di te. Lasciati andare, qui pensiamo a tutto noi... ». Il bambino, piano piano,
lascia cadere la sua spinta volitiva e comincia a stare fermo, immobile,
ipnotizzato davanti allo schermo. Ecco realizzarsi quel vuoto dell’anima che
avevano scoperto i ricercatori australiani! Ogni naturale atteggiamento di
«dedizione percettiva», di attività amorevole verso le cose deve essere
cancellato se vogliamo porci nel «giusto» modo davanti alla televisione. Chi
non ci riesce si annoia o si irrita, e se ne va: purtroppo, sono molto rari,
oggi, questi personaggi così audaci!
Sono
stati fatti infiniti studi fisiologici sulla fissità degli occhi,
sull’allargamento delle pupille, sulle contrazioni dei muscoli e così di
seguito: siamo tutti d’accordo che effettivamente l’occhio deve adattarsi per
sostenere il processo elettronico della televisione. Non mancano nemmeno i
risultati delle molteplici sperimentazioni circa gli effetti delle attività
elettriche sulle nostre cellule nervose cerebrali: si è visto che si verifica
una inibizione della vigilanza nervosa con conseguente assorbimento passivo
della percezione sensoriale. Però ci fermiamo qui, non ci domandiamo che cosa
tutto questo comporti per l’anima.
Molte persone,
interpretando erroneamente i fatti, pensano che la televisione rilassi e abbia
su tutti, bambini compresi, una benefica azione distensiva. Invece questa
passività indotta, questo malsano e prolungato sonno nella testa, impedisce al
bambino il sano alternarsi della graduale capacità di organizzarsi a livello
del pensiero con la graduale capacità di organizzarsi a livello dell’azione.
Quindi, come ben sappiamo, dopo ore di televisione (che, lo ripeto, non
richiede forze di concentrazione, ma di passività) il bambino «si scatena»: può
accadere a scuola, al supermercato, in casa, ovunque. La paralisi della sana
vita sensoriale richiama di necessità, per la nota legge del pendolo,
l’iperattività inconsulta.
Questi
effetti dannosi della televisione hanno portato già da anni alcuni studiosi
americani a leggerli come i primi sintomi della «intossicazione da
televisione»; ne seguono poi altri quali l’abbassamento delle forze di
attenzione e di concentrazione, l’apatia e infine la perdita dell’appetito.
L’unico impulso crescente nel bambino in questa fase di intossicazione è quello
di voler ulteriormente vedere e ancora vedere la televisione.
In
America esistono apposite cliniche per la disintossicazione da televisione. I
vari metodi seguiti, che danno quasi sempre buoni risultati, partono
dall’eliminazione totale dell’elemento intossicante. Inizialmente si incontrano
grandi difficoltà perché il bambino manifesta vere e proprie crisi di
astinenza: è rimesso allora alla preparazione pedagogica e all’impegno
educativo di chi segue questi bambini il compito importantissimo di fornire
loro una quantità sufficiente di stimoli sensoriali che siano artistici,
costruttivi, pieni di fantasia. Può confortarci il sapere che, al massimo nel
giro di sei mesi, il bambino dimentica completamente la televisione, non la
cerca più.
Ma, per fortuna,
non è indispensabile ricorrere alle cliniche per recuperare i ragazzini alla
vita reale: esistono un’infinità di altri mezzi. In Canada, per esempio, in una
scuola Waldorf qualcuno ha inventato una scatola con uno schermo di carta opaca
sul quale far muovere delle ombre colorate e tentare così di attivare in modo
nuovo l’attenzione dei tanti bambini da disintossicare. Dopo aver raccontato
una fiaba o una storia, si fa un breve stacco musicale (suonato dal vivo, e non
registrato!) e poi, nel silenzio, la storia si svolge di nuovo attraverso il
movimento delle ombre colorate. In tutto questo c’è una forte azione
terapeutica: innanzi tutto la storia è stata raccontata prima e dunque si
configura un esercizio per la memoria che può così accompagnare la visione; le
ombre colorate, poi, stimolano una percezione non alterata e i processi
organico-fisiologici tornano al loro posto.
Non
solo: alla fine della rappresentazione i bambini corrono tutti dietro alla
scatola per vedere chi c’è e trovano la maestra, trovano le sue mani! Del
resto, anche davanti a una televisione vera i bambini piccoli, almeno le prime
volte, vanno a guardare dietro per vedere chi è che combina tutto quel fracasso
di suoni e di luci. E questa non è una ingenua curiosità da bambini, ma è
proprio la manifestazione pura dell’umano: tutti gli esseri umani di fronte a
un fenomeno, anche al più straordinario e mozzafiato, vogliono andare a vedere
«che cosa c’è dietro» perché questo gesto fa parte del mistero della scoperta
delle cose.
Quindi
si possono apportare al bambino in astinenza da televisione molte alternative
belle, capaci di stimolare immediatamente la sua attività animica, la sua
psiche: piccole rappresentazioni teatrali, per esempio, dove un buon insegnante
potrebbe artisticamente, con delicatezza e levità, perfino aiutare il bambino a
rivivere alcune scene televisive che lo hanno intossicato, e liberarsene. Il
bambino, in fondo, è semplice, sa nutrirsi istintivamente del bello, ne è
attratto, cresce grazie ad esso e inizia piano piano a fare delle distinzioni
fino a che la televisione arriva a perdere la sua attrattiva. Ma è chiaro che
questo comporta impegno, inventiva e dedizione da parte dei genitori e degli
insegnanti ai quali spetta la proposta di ogni nuova attività salutare.
Voglio
ora soffermarmi su un altro effetto della televisione, molto più grave
dell’iperattività e dell’eccitazione prima descritti, e che ha a che fare con
tutti quegli stimoli che passano al di là della barriera psichica, cioè al di
là della percezione mediatrice dell’anima, e si vanno a imprimere direttamente
nelle banche dati della memoria per poi riaffiorare in momenti particolari,
senza che l’anima cosciente possa frenarli o orientarli.
Questi
momenti particolari possono essere periodi di stress, situazioni di pericolo,
oppure di inerzia e indebolimento delle forze volitive, tutti stati che
sappiamo bene non essere in se stessi patologici o anormali, ma far parte del
quotidiano scorrere dell’esistenza. Se però, in questi momenti, nei recessi
della memoria c’è una folla di percezioni sensoriali incoscienti che l’anima
non sa riconoscere perché il loro passaggio non è stato accolto, a suo tempo,
dalle forze del sentimento, del pensiero e della volontà, queste percezioni
ritornano come impulsi coattivi all’azione.
In
fisiologia ci siamo accorti da molti anni che questo meccanismo fenomenologico
è alla base di tante azioni criminali compiute da adolescenti: essi dichiarano
infatti di non ricordare più quale sia stato lo stimolo iniziale e non sanno
descrivere come i fatti si siano succeduti. Dunque questi gravissimi problemi
risalgono all’infanzia: noi pensiamo che attraverso i programmi televisivi si
possa imparare e invece non è vero, perché vengono impresse conoscenze ed
emozioni in modo incontrollato, senza che lo spettatore sia attivo e lo voglia.
È un procedimento simile a quello che serve a imparare le lingue durante il
sonno: la fenomenologia è la stessa.
Naturalmente i tanti
dati scientifici che ormai abbiamo a disposizione sugli effetti dei media elettronici
fanno sorgere molti interrogativi nell’intento di capire che cosa sia in gioco
a livello mondiale: si possono trovare ragioni di potere, di antidemocrazia,
mire all’uniformismo, al conformismo e così via. Tutti mali molto gravi, certo,
perché rappresentano un attacco alla libertà individuale e minano l’identità di
ciascuno di noi: però sembra ancora possibile reagire se li osserviamo come
diretti alla manipolazione dell’adulto affinché compri certe cose, voti quel
partito, approdi a quell’opinione, decida in quell’altra direzione...
Ma
ciò che mi sembra infinitamente più grave è che dietro a tutto questo ci sia un
attacco diretto all’infanzia: troppe cose mostrano, in questi ultimi
decenni, che si lavora proprio contro l’infanzia, contro questo scomodo e
sempre più incompreso periodo della vita dell’uomo che non è più difeso e
nemmeno accompagnato da chiari principi pedagogici ed educativi.
Perché
si è scelto proprio il mezzo televisivo per cancellare l’infanzia? Nel 1977 fu
fatta un’intervista a Lord Grave (Newsweek, 18 aprile), l’allora
presidente della rete televisiva britannica, che, naturalmente, cominciò a
parlare nei termini migliori della storia passata e delle prospettive evolutive
di questo mezzo di comunicazione. Ad un certo punto il giornalista gli domandò:
«Qual è, presidente, il più importante contributo che secondo lei la
televisione ha dato alle culture della nostra epoca?». La risposta fu
terribile: «È chiarissimo quale sia il contributo: la missione educativa della
televisione. I bambini sono oggi sei volte più brillanti di quanto non fossero
i loro coetanei vent’anni fa. Questo è il grande risultato della televisione: i
bambini imparano a parlare la lingua inglese come ognuno dovrebbe parlarla e
diventano velocemente adulti. Adesso è possibile conversare in modo critico e
intelligente con un bambino di otto anni. Vent’anni fa ciò era impossibile,
perché i bambini erano bambini. E questo sarà di grande beneficio per il
futuro». Dunque siamo di fronte a un intento dichiarato e non si ha nemmeno il
pudore di nasconderlo.
La
televisione è entrata a far parte della cultura ufficiale e, come ho già detto,
non possiamo pretendere di eliminarla o di annullarne gli effetti. Sarebbe una
battaglia persa fin dall’inizio perché ci siamo dentro tutti, anche senza
volerlo. Ma proprio da qui è possibile cominciare: dal renderci conto in quante
cose noi siamo legati e collegati al fenomeno dei media elettronici. È
un’illusione anche credere che basti non possedere la televisione o il computer
per tirarsi fuori da questi processi epocali: la nostra vita è comunque immersa
e organizzata in questa rete. È però profondamente importante rendersene conto:
è questo il vero inizio di emancipazione, di liberazione, e va di pari passo
con la scoperta consapevole dei meccanismi d’azione dei media, tutti da
individuare, da riconoscere e da seguire nei loro diversi momenti, nei loro
effetti più vari.
Esistono
cose che si possono fare per proteggere l’infanzia e consentirle di continuare
ad essere infanzia. Cominciamo col chiederci: perché mettiamo un bambino di
uno, due, tre anni davanti alla televisione? Qual è lo scopo? Perché si
diverte? Perché così sta buono e ci lascia in pace? Se sapessimo fino in fondo
che cosa succede quando un bambino di tre anni è completamente preso e
imprigionato dalle emissioni dello schermo non lo lasceremmo lì davanti. Se
vedessimo un bambinetto ubriacarsi o prendere la droga faremmo del tutto per
impedirglielo: dovremmo fare la stessa cosa quando si siede per guardare i
programmi televisivi.
Né
vale qui il discorso che facevamo prima per l’adulto e che dice: tanto siamo
immersi nei media e se mio figlio non vede la televisione in casa la
vedrà dagli amichetti, dai nonni, al Luna Park... D’accordo, è vero, ma
cominciamo con l’evitargli l’intossicazione primaria che è quella di quando
trascorre una, due, tre ore davanti alla televisione, regolarmente, tutti
i giorni e per interi anni finché gli diventa indispensabile alla vita.
Ricordiamoci di quanto abbiamo detto delle sigarette, del caffè, del
bicchierino di alcool: tante cose sono pericolose e possono portare all’intossicazione,
ma finché l’essere umano le controlla non si arriva alla dipendenza,
all’assuefazione. Ma per il bambino queste considerazioni non hanno valore. È
impossibile e insensato pretendere da lui il controllo: il bambino cade nei
processi di dipendenza e di intossicazione molto, molto più velocemente
dell’adulto. E allora siamo noi genitori, noi educatori, noi adulti a dover
agire al posto suo.
Il
bambino non ha bisogno della televisione né per la sua cultura né per la sua
crescita. Come non ha bisogno delle sigarette, del caffè, del bicchiere di vino
e di tutto quello che nella vita imparerà a conoscere prendendone in mano la
processualità e le conseguenze. Il bambino deve essere protetto, seriamente
protetto dalla televisione perché quando crescerà e avrà sette, otto, dodici,
quattordici anni quella ressa di ricordi innaturali invaderà la sua vita e non
saprà dove metterli e come gestirli, perché la sua anima non li conosce, non li
ha mai vissuti né sperimentati, e premeranno come incontrollabili impulsi ad
agire. La «democrazia elettronica» ha creato dei criminali di otto anni ed è
talmente «democrazia» che la vediamo impiegare il suo tempo a trovare il modo
di trattare queste tragedie non previste dalla legislazione e a dibattere
sull’opportunità della prigione, della rieducazione o della morte. A otto anni.
È
questa la democrazia? Democrazia è quando si crea l’opportunità sociale di
aiutarsi reciprocamente a conoscere le cose e a decidere di se stessi in
libertà e per il meglio. Ci aiuta la televisione a fare questo quando ci invade
con i suoi flussi di percezioni visive della cui qualità irreale, per dato
scientifico, noi non ci dobbiamo accorgere? Il bombardamento di quelle
scintille ci sfugge perché è stato pensato proprio per oltrepassare tutti i
limiti della nostra fisiologia: e dunque non è mai troppo ripetere che non sono
soltanto i contenuti dei programmi ad essere in questione, ma è la tecnica
stessa ad essere pericolosa. Nelle nostre case è in atto un processo di
usurpazione della fisiologia di ciascuno di noi.
Finché
siamo in grado di preservare la sana funzionalità fisiologica possiamo ancora
educarci, possiamo evitare i danni: ma quando siamo intossicati e abbiamo
bisogno di aiuto e ci troviamo in mezzo a generazioni di esseri umani che non
ci possono aiutare perché sono anch’esse intossicate e hanno a loro volta
necessità di aiuto, allora il problema diventa davvero grande. Coinvolge tutti.
Accorgiamoci,
allora, che la difesa dell’infanzia interseca anche un’altra figura debole
della società moderna: l’anziano. Difendere l’infanzia significa anche
restituirle un dialogo prezioso: quello con i nonni.
Che
cosa c’entra, qui, la televisione? C’entra. Anziani e bambini sono coloro che
dedicano più tempo alla televisione e ciò li priva di un intimo e bellissimo
processo animico che, fino a qualche decennio fa, ancora esisteva: quello di
incontrarsi attraverso il racconto e l’ascolto. Dico questo non per rinverdire
vecchie nostalgie patriarcali, ma perché rientra nei ritmi sani della vita che,
come il bambino ha bisogno di imitare i gesti di chi gli vive accanto e
prendere da essi anche l’anima che vi trova dentro, così l’anziano ha bisogno
di trasfondere alle nuove generazioni i risultati animici della sua intera
esistenza.
Quando
il nonno racconta la sua vita ai nipoti accade come un trapasso di forze
vitali: quelle stesse forze che il bambino deve promuovere in sé perché si apre
al mondo e vuole crescere e che il nonno, invece, deve piano piano lasciare per
«alleggerirsi» nel cammino verso la conclusione della vita. Il vecchio assolve
per gli altri un compito sociale e per sé un compito evolutivo quando col
racconto delle sue memorie trasferisce ai nipoti il succo prezioso degli eventi
della sua vita. Infatti soltanto il bambino è in grado di cogliere ciò che
veramente conta in questi racconti: non la storia in sé, non il succedersi
logico dei fatti ma ciò che in essi ha forgiato le forze dell’anima del nonno,
l’essere del nonno.
Credo
di non aver evocato allarmismi fuori luogo in questo breve sguardo sui mali
legati alla televisione: la realtà richiede ovunque e con urgenza di
svegliarci. Le nostre giornate sono piene di fatti collegabili con i disastri
della «democrazia elettronica», anche se non compaiono sui giornali e non se ne
vedono subito i nessi: in Italia non meno che in Germania, o in Inghilterra o
in Francia. Salvare i bambini da questo attacco contro le forze evolutive
significa preparare un altro avvenire per l’umanità: dobbiamo lasciar crescere
le nuove generazioni nei loro primi sette anni e poi ancora fino ai quattordici
evitando che la loro esistenza sia infestata da questi fenomeni che violano la
coscienza, la vita dell’anima.
Chi
ricorda e vuole ricordare è in realtà la nostra anima: tulle le memorie che sorgono
incontrollate la disturbano. Sappiamo bene che cosa ci succede quando abbiamo
un piccolo incidente, un piccolo disguido che accade all’improvviso, senza che
la nostra coscienza sia in grado di seguirlo nelle sue fasi: la percezione lo
assorbe creando uno stato di choc, piccolo o grande che sia. Ci sono delle
memorie che continuano a ritornare e non ci fanno dormire per due notti, per
tre notti. Eppure tutto ciò è niente in confronto alle percezioni sensoriali
continue e costanti che attraverso i media elettronici tempestano la nostra
vita psichica. Non dovremmo meravigliarci di tutte le sindromi di angoscia,
ansietà, depressione che afferrano con sempre maggiore frequenza anche i
bambini e gli adolescenti.
E,
riferendoci ai soli contenuti dei programmi, non possiamo consolarci dicendo:
ma la vita a volte è molto più violenta e cruda della televisione. Perché
dobbiamo tanto preoccuparci se i bambini assistono a scene di violenza: lì,
almeno, sanno che non sono vere! E invece i bambini non sanno proprio niente:
questo è il punto. Non sanno che tipo di emozione o di rappresentazione è
penetrato nella loro interiorità, non possono chiedere nulla ai protagonisti
del film: vedono uragani e non sentono né il vento né il freddo, vedono incendi
e non sentono il calore del fuoco, vedono gente che scappa disperata e un
secondo dopo vedono qualcuno che passeggia tranquillo in una stanza perché
l’incendio era solo un flashback... Di fronte ai drammi veri della vita c’è
sempre un interlocutore, c’è sempre un amico o un nemico in carne ed ossa, ci
sono sempre le leggi vere della natura. Anche negli «innocenti» cartoni animati
- quali possono sembrare le storie di Tom e Jerry o le avventure di Paperino
- la violenza affonda nell’inconscio della vita psichica del bambino.
E ancora, tornando per un
attimo al tema della pubblicità, spesso ho sentito dei genitori ritenere
geniali e divertenti certe trovate surreali o grottesche che spesso distinguono
alcuni «spot d’autore»: ma un bambino piccolo che vede uscire una mucca da un barattolo
di latta o vede un dentifricio con dentro le isole dei Caraibi o vede un morto
ammazzato che esce fuori dalla bara per infilarsi l’ultimo modello di jeans,
questo bambino qui non sa distinguere la realtà dalla finzione; e quando, dopo
qualche anno, si accorgerà di fare strani collegamenti fra le cose o si sentirà
spinto ad agire in un certo inspiegabile modo, non saprà risalire al perché.
Vorrei
concludere, perciò, con una «prescrizione» di un pediatra dell’università di
Zurigo che nel 1970, all’apparire dei primi casi patologici legati
all’intossicazione da televisione, diceva: «Per i bambini da zero a sette anni
la televisione deve essere proibita; dai sette ai quattordici non ne hanno
bisogno; dai quattordici in poi scelgano loro». Solo da questa età è possibile
scegliere, e solo se non si è stati intossicati fino a quel momento.
In memoria del dott. Leonardo Fulgosi[3] 1935-2021
Maggio 2025

[1] Il dottor Leonardo Fulgosi ha passato la soglia il 27 settembre 2021.
[2] Per ottenere l’illusione delle immagini in fluido movimento, anche il cinema deve ingannare l’occhio: ma in questo caso bastano 18 immagini al secondo perché non si pone anche il problema dell’inesistenza dell’immagine completa.