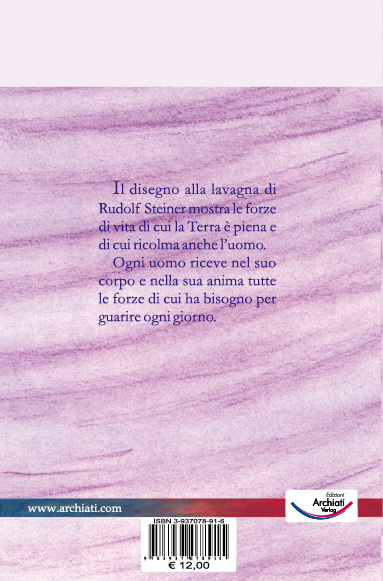Prefazione alla terza edizione
Queste pagine parlano di problemi di vita che ci riguardano molto da vicino. Chi di noi non si confronta con la realtà della paura, dell’aggressività, della depressione e dei più vari stati patologici?
Gli esseri umani si trovano oggi alle prese con malattie del tutto nuove e, al contempo, è sempre più forte l’esigenza della cultura materialistica che vorrebbe farle sparire tutte.
Viene proposta in queste pagine – che sono tratte dal dialogo diretto con molte persone in occasione di convegni e seminari – una nuova visione dello stato di malattia, di vederlo e viverlo cioè come un’occasione di crescita tutta positiva per lo spirito e l’anima umani. Vivere la positività della sofferenza, togliendole gli aspetti di tragicità, ingiustizia e mortificazione, è possibile quando si considera l’uomo nella sua interezza. Lo spirito di ogni uomo, il suo Io, liberamente cerca lo stato di malattia come una lotta tutta positiva che lo rafforza; se la sua anima vive da “paziente”, cioè senza insofferenza, il processo verso la guarigione, allora anche il corpo si risana.
Una moderna scienza della realtà dello spirito consente di vagliare l’ipotesi che la malattia non sia una “disgrazia”, ma la scelta consapevole che ognuno di noi fa ad un livello più ampio della sua coscienza – quello dello spirito, appunto. In questo modo esercita la propria sovranità libera e creativa nella vita, a cui restituisce la dimensione terapeutica, espressione di conoscenza e di amore verso sé e verso gli altri.
Primo Capitolo
la malattia:
un invito a inventarsi la guarigione
L’uomo è fatto solo di corpo e anima,
o c’è anche lo spirito?
Ogni essere umano fa più volte nella vita l’esperienza della malattia e della sofferenza, ma anche quella della terapia e della guarigione. Già ai primordi dell’evoluzione è stato chiesto a Caino: “Dov’è tuo fratello?”, e Caino ha risposto: “Sono forse io il custode di mio fratello?”. In queste parole rivolte al primo “omicida” è racchiuso il mistero del dolore che gli esseri umani si provocano a vicenda. Ma anche la possibile terapia, propria del convivere quotidiano, dove ogni uomo è chiamato ad aiutare il fratello, ad essere cioè terapeuta. Il cosiddetto “sociale” è il contesto curativo in cui tutti ritroviamo ogni giorno la salute, ma è anche quello che ci fa ammalare in modi sempre diversi e insospettati.
Vanno quindi ampliati gli orizzonti d’indagine sulla realtà della malattia e della terapia. A questo scopo è molto interessante considerare non solo la realtà del corpo dell’uomo, ma anche la componente animica e quella spirituale dell’uomo.
La dimensione fisica è praticamente la sola a cui oggi ci si rivolge, benché negli ultimi tempi l’intento terapeutico, grazie alla psicologia e all’arte, stia prendendo sempre più sul serio la realtà dell’anima. Ma la terza grande dimensione umana, quella dello spirito vero e proprio, viene ancor oggi quasi del tutto ignorata, o tutt’al più identificata con la sfera dell’anima.
Eppure, la distinzione tra anima e spirito non è meno importante di quella tra anima e corpo. Nella cultura occidentale, a partire dal Medioevo, non si è più parlato della “tricotomia” di corpo-anima-spirito – ancora chiaramente presente negli scritti di Platone o di Paolo di Tarso –, ma solo della “dicotomia” anima-corpo. La scienza moderna, psicologia compresa, non ha fatto altro che recepire questo dogma cattolico secondo il quale l’uomo è costituito soltanto di corpo e di anima. La scienza naturale, poi, ha messo in dubbio anche la realtà autonoma dell’anima, considerando reale e causante solo il corpo. Ha ripetuto così nei confronti dell’anima ciò che la Chiesa aveva fatto prima nei confronti dello spirito.
La psicologia moderna è però più che mai in grado, a partire dalle sue stesse premesse, di adempiere all’immane compito culturale della riscoperta dello spirito, proprio grazie a un approfondimento dei fenomeni dell’anima che indaga, e nei quali opera.
Il punto di partenza potrebbe essere proprio una più spregiudicata riflessione sulla classica polarità paziente-terapeuta, con tutti i suoi risvolti a volte anche drammatici. Il paziente si pone strutturalmente in posizione di passiva ricezione di chi è “malato” e il terapeuta assume il ruolo attivo di colui che cura. È importante notare le implicazioni di questa polarità fondamentale.
Se noi chiamiamo “anima” l’esperienza che l’essere umano fa di sé quando vive da “paziente” – paziente viene da patire in quanto opposto ad agire –, non dovremmo chiamare ugualmente “anima” ciò che ne è l’opposto. Se il paziente è un puro essere animico in quanto è divenuto profondamente passivo, dipendente, la cura gli può venire solo da un essere che viva nel polo opposto, in quello dell’attività e della creatività. Questo polo opposto all’anima è stato da sempre chiamato “spirito”.
Se lo psicologo vivesse come il paziente nel puro mondo dell’anima, invece di curare raddoppierebbe la malattia, perché questa consiste proprio nel fatto che il paziente si è ridotto ad essere solo paziente-passivo. Una cultura che ritenga l’uomo costituito solo di corpo ed anima, lo condanna ad essere un eterno paziente, perché lo ritiene capace solo di subire la vita e gli eventi in cui si trova.
Il vero avvenire di ogni terapia risiede allora nello sforzo di comprendere la polarità che c’è tra il puro vissuto passivo e il cosciente prender attivamente posizione. L’anima è la risonanza interiore di tutte le esperienze vissute; lo spirito è la capacità attiva di capirle per intervenirvi liberamente e sensatamente.
Chiamare tutt’e due i mondi semplicemente anima, significa considerare due realtà opposte come se fossero la stessa cosa. Vuol dire considerare l’elemento curante alla stregua di ciò che ci fa ammalare. L’uomo è malato quando diventa interiormente passivo (quando si riduce ad anima), e vive la salute nella misura in cui diviene interiormente attivo (quando si apre allo spirito). Vedremo in seguito che il vero significato della parola paziente non sta ad indicare colui che subisce la malattia, ma colui che agisce in modo contrario all’insofferente. Chi esercita attivamente la pazienza non rifiuta il suo stato di disarmonia. E questo è un lavoro tutto spirituale. Essere un paziente nella realtà fisica è quindi la migliore occasione per diventare un agente nella propria interiorità spirituale.
La distinzione fondamentale tra l’essere attivi (spirito) e l’essere passivi (anima) porta con sé altre distinzioni non meno importanti. Il mondo dell’anima è puramente personale e soggettivo, in fondo non comunicabile. Solo ciò che è oggettivo può essere condiviso e può creare relazione. Vivere nell’anima vuol dire vivere chiusi in sé – nel mondo delle proprie emozioni e dei propri sentimenti –, e vivere nello spirito vuol dire comunicare con gli altri in base a un mondo oggettivo che è comune a tutti.
Se chiamiamo anima l’essere umano che vive nei sentimenti ed è in balìa di essi, non possiamo chiamare altrettanto anima l’essere umano che li signoreggia e li trasforma. L’umanità moderna ha dimenticato lo spirito perché l’ha trascurato fino all’inverosimile, lo ha reso così rachitico da non vederlo più. L’ha fatto quasi sparire per poi dichiarare comodamente che non c’è.
La vera terapia al livello dell’anima umana consiste nel risvegliare lo spirito che la nostra cultura ha reso sempre più insonnolito. Il mito della vita comoda è una forte dose quotidiana di sonniferi per lo spirito. Vero terapeuta dell’anima umana può essere solo colui che conosce la forza evocatrice ed educatrice dello spirito. La voce solare e la forza solerte dello spirito suscitano nell’anima ciò che in lei è già implicito. L’anima umana è nel suo essere stesso potenzialità allo spirito, anelito inarrestabile verso lo spirito. La passività interiore che sappia riconoscersi come tale, non può voler restare così.
L’animale è un essere di natura ma non si può dire che sia animicamente passivo, perché non è capace di diventare attivo. L’uomo, invece, ha creato con il pensare il concetto di passività – distinguendolo dall’attività – proprio perché è realmente capace di interiore attività. Se l’azione creatrice non facesse parte del suo essere non la potrebbe neppure pensare, non ne potrebbe neppure parlare.
Solo lo spirito può guarire l’anima. Ammalarsi è ridursi al puro vissuto animico, è sentirsi effetto di infinite cause senza riuscire a diventare a propria volta causa di infiniti effetti. Il paziente è allora un vero e proprio caso di “psicopatia” che va in cerca, nel suo Io vero e profondo, di un’autentica pneumatoterapia, cioè di una terapia che parta dal suo stesso spirito (pnèuma, in greco).
Stando però alla prassi terapeutica oggi in vigore, con un po’ di coraggio e di spregiudicatezza ci tocca dire: il paziente va dal medico perché, vivendo se stesso come passivo e dipendente, cerca un ulteriore rapporto di dipendenza che lo confermi nella sua pigrizia, e lo culli nell’illusione di poter continuare così. Ma la sola cura vera potrà consistere nell’amorevole rifiuto di questo rapporto di gestione dal di fuori, che raddoppierebbe la dipendenza e renderebbe il cosiddetto paziente ancora più inerte, esponendolo a successive depressioni sempre più sofferte.
La distinzione tra anima e spirito non è allora una pura questione di terminologia, ma indica la capacità di cogliere nell’uomo altri due mondi reali, oltre a quello fisico. Questi sono talmente diversi l’uno dall’altro da sollecitare un continuo movimento che li pone in interazione fra loro. Invece, la malattia cronica della nostra cultura materialistica consiste nell’immobilità interiore, nel dogma che decreta: lo spirito non esiste.
L’anima desidera sbarazzarsi della malattia proprio perché in essa incontra la sfida che le offre lo spirito a diventare sempre più attiva. Lo spirito, invece, desidera procurarsi la malattia, proprio perché la lotta contro di essa genera forze tutte positive nell’interiorità dell’uomo.
La prospettiva di un’ulteriore evoluzione della moderna psicologia che sappia aprirsi alla dimensione specifica dello spirito, consente anche una nuova interpretazione della polarità fra conscio e subconscio. La psicoanalisi ha fatto e fa tuttora molto per aiutare l’essere umano a sollevare nella regione chiara della coscienza i molti strati del proprio essere ancora oscuri. Resta però un problema di fondo irrisolto quando lo psicoanalista, o lo psicologo o lo psichiatra, parlano di subconscio: è il fatto che essi ne parlano “consciamente”. Quindi l’oggetto del loro discorso non è per natura inconscio, ma semplicemente non ancora noto alla coscienza della persona che hanno davanti.
La coscienza umana ha potenzialmente la capacità di scandagliare tutto il reale. Nulla è per essenza non conoscibile al pensare umano. Quel che a un certo gradino evolutivo non è ancora conscio, può diventarlo in un tempo successivo. Importante è allora che io comprenda che ciò che la mia coscienza ordinaria oggi ancora non abbraccia non è “sotto” bensì “sopra” di essa. Esiste una coscienza superiore, che è quella del mio Io vero, che io tendo a reprimere non in basso, ma in alto, impedendole di scendere per via ispirativa a illuminare la mia coscienza ordinaria.
Il sovraconscio è il polo opposto del subcoscio vero e proprio, è per la mia anima la sfera specifica dello spirito. In quanto spirito io divento l’architetto attivo e creatore di quel karma (o destino) che prevede tante prove (e perciò anche tante malattie), proprio per concedermi tante occasioni di crescita.
Il subconscio è invece il regno dell’istintuale puro, è il dato cieco di natura – la sfera del corpo – che opera in me e di fronte al quale io sono impotente, perché non partecipo in alcun modo alla sua creazione e al suo funzionamento.
L’anima – che altro non è se non la coscienza ordinaria – oscilla fra il subconscio e il sovraconscio, e può aprirsi verso tutt’e due le direzioni. Verso il basso si involve, accrescendo la sua condizione di dipendenza e passività, verso l’alto si evolve, illuminandosi dei contenuti di una coscienza superiore.
Il compito culturale della psicologia non consiste solo nel sollevare a coscienza l’esistenza degli istinti inferiori, o di tutto ciò che l’uomo reprime facendolo ricadere allo stato di inesorabile natura, ma consiste più ancora nel far discendere dall’alto i contenuti di coscienza dell’Io sovraconscio che vede la positività di ogni evento di vita.
Come può essere terapeutico per l’anima venire esposta solo al subconscio, di fronte al quale essa è per natura impotente? Un incremento di coscienza in quella direzione non può che intensificare nell’uomo la paura. L’anima diventa così più consapevole del suo lato di impotenza, si trova cioè scaraventata in ambiti ancora più minacciosi, cioè prima sconosciuti, di questa sua stessa impotenza. Il risultato finale è, nel migliore dei casi, un rimestare rassegnato o cinico in ciò che ineluttabilmente sembra condizionare e dominare la vita dell’uomo. Sono sempre più numerosi gli psicologi che riconoscono questo limite assoluto della psicologia del subconscio.
Ben altrimenti stanno le cose quando l’anima si volge nella direzione opposta, quella dello spirito, per far “calare” nella coscienza tutti i regni dell’umanamente possibile. Qui l’anima non incontra più le sue impotenze, ma impara a conoscere tutto ciò che può e che prima non sapeva di potere. Ed è questa è la vera terapia, la vera guarigione. L’anima umana scoppia di salute quando vive l’eco gioiosa e riconoscente delle infinite conquiste e creazioni rese possibili al suo spirito.
Chi si ammala e chi guarisce: Il corpo o l’uomo intero?
L’indagine sulla realtà complessiva dell’uomo non è semplice: si deve sempre far riferimento alla triade fondamentale corpo-anima-spirito, per affrontare in modo esauriente i processi di malattia e di terapia. Inoltre, ogni parte costitutiva dell’essere umano ha le sue leggi specifiche.
Ciò che è corporeo e visibile è sempre l’espressione, a livello di risultato e di conseguenza, di ciò che prima è stato vissuto nell’anima. Lo stesso possiamo dire dell’anima nei confronti dello spirito: il vissuto animico è il risultato, l’effetto di ciò che prima è stato creato dallo spirito. Guardando dunque le cose dal punto di vista di causa e effetto e chiedendoci dove siano le cause prime, dovremo rispondere: esse sono sempre nello spirito.
Lo spirito è per natura causante, nel mondo della materia ci sono solo effetti. La materia è da un lato il risultato, dall’altro lo strumento delle creazioni dello spirito. Allo spirito è immanente la capacità di creazioni dal nulla, cioè di creazioni che non siano a loro volta l’effetto di una causa precedente. Un essere spirituale capace di pensiero autonomo, intuitivo e di volontà propria crea “dal nulla”. L’anima è già effetto di ciò che avviene nello spirito, e il corpo è un doppio mondo di conseguenze, è il precipitato sia di ciò che avviene nell’anima, sia di ciò che crea lo spirito.
Senza dubbio gli eventi corporei possono di riflesso influire sia sull’anima, sia sullo spirito: ma sono influssi derivati, questi. È importante distinguere chiaramente tra cause prime e cause seconde (o di riverbero): il corpo ha la possibilità di agire sull’anima e sullo spirito unicamente in base a ciò che in esso sorge dapprima quale risultato di eventi animici e spirituali. In questo senso abbiamo senz’altro una causazione reciproca tra spirito, anima e corpo, ma solo l’operare dello spirito è primigenio e originario.
Stando così le cose, ne scaturisce per ogni impegno terapeutico una prima conseguenza molto importante: l’intervento sul corporeo è una terapia al livello degli effetti, e perciò a corta scadenza; l’intervento sulla realtà dell’anima è a media scadenza; l’intervento sullo spirito è una terapia al livello delle cause prime, e perciò a lunga scadenza. Quando lavoriamo sullo spirito ci vuole più tempo per cambiarne la compagine, così che la sua azione si trasfonda poi nell’anima e dall’anima passi nel corpo.
Ciò vuol dire al contempo che è ben legittimo l’intervento medico e farmacologico a livello del corpo per risolvere i problemi specifici del corpo. E non solo è legittimo, ma necessario qualora la realtà corporea – in seguito a ciò che è avvenuto prima nello spirito e nell’anima – sia talmente compromessa da non consentire un libero e diretto agire sulla realtà dell’anima e dello spirito. Il lavoro del medico, se fatto con spirito di amore verso l’essere umano, è pura “magia bianca” perché è un intervento dello spirito sulla realtà del corpo, senza interazione di coscienza. Non si può interpellare il corpo per chiedergli se è d’accordo che gli si faccia questo o quest’altro.
Però l’azione sul corpo, in ultima analisi, non può di per sé guarire l’essere umano; se è fatta bene, ottiene il risultato di ridare all’anima e allo spirito un sostrato corporeo che consenta di riprendere l’attività animica e spirituale vera e propria. Non più e non meno di questo si raggiunge con la medicina che si riferisce direttamente al corpo. Guarito il corpo, non è ancora guarito l’uomo. Se teniamo conto anche dell’anima e dello spirito, anche il concetto di guarigione muta profondamente.
Se noi, sistemato il corpo, lasciassimo l’anima e lo spirito in tutto e per tutto com’erano prima della malattia corporea, cosa succede? Che la compagine animico-spirituale deve di nuovo cercare la malattia.
Molti pensano che le malattie vengano per caso. Ma “il caso” è soltanto una lacuna nel pensiero umano. Quando l’uomo non sa il perché e il percome di qualcosa dice: è per caso. Il motivo per cui lo spirito umano consciamente e liberamente vuole e crea una malattia è tutto ciò che si ripromette di divenire proprio grazie alla lotta contro quella stessa malattia, in vista del suo superamento. Se lo scopo dello spirito fosse semplicemente quello di eliminare la malattia, essa non avrebbe motivo di sorgere. Per lo spirito si tratta sempre di uno specifico sviluppo reso possibile solo da una ben precisa malattia.
La terapia artistica in tutte le sue forme è per eccellenza la terapia dell’anima. Intende essere un balsamo, una cura per ciò che esiste nel mondo dei sentimenti, aiuta a ristabilire l’armonia interiore, a riscoprire la creatività, a dare slancio alla vita. È terapia dell’anima anche la psicoterapia propriamente detta in tutte le sue forme, fra cui la nota psicanalisi. Ho già accennato al fatto che, là dove questa tocca il suo limite, e lo ammette, dovrebbe, come dicevo, aprirsi verso la realtà vera e propria dello spirito.
Come la sostanza materiale del farmaco agisce sul corpo, così l’esercizio dell’arte e la psicologia operano in modo terapeutico nella realtà dell’anima. L’anima guarisce quando riscopre attraverso l’arte il senso della vita; però, prima o poi, ci si rende conto che curare solo l’anima non basta. Si ottiene un sollievo di natura effimera, perché nessun fenomeno dell’anima è in sé costante o duraturo. Ogni vissuto animico è passeggero, è fuggevole – nessuna gioia dura per sempre, come nessuna tristezza e nessun dolore –, mentre ciò che è spirituale ha il carattere della durata, della costanza. Ciò che è oggettivamente vero e buono oggi sarà vero e buono anche domani, come lo è stato ieri.
La terapia più profonda e duratura non può essere che una vera e propria arte e scienza dello spirito. Sarà una terapia a lunga scadenza, a lungo respiro; ma nel corso del tempo, dallo spirito si risanerà l’anima e risanando davvero l’anima si potrà infondere sempre più salute anche al corpo. Il grande avvenire del lavoro terapeutico nell’umanità consisterà proprio nel compiere questo salto qualitativo. Come dal campo medico, che si occupa prevalentemente del corpo, si è passati sempre più a prendere sul serio anche l’anima, così il prossimo importante traguardo sarà quello di considerare tutto ciò che facciamo nel nostro spirito come una terapia a lunga scadenza che agisce su un’intera vita e mira ad una salute duratura nell’anima e nel corpo.
La bella differenza tra “essere” sani e “diventare” sani
Può sembrare sorprendente, ma a pensarci bene, più che di essere sano, l’uomo gode di diventare sano.
Essere sano significa in fondo non aver nulla da fare; se la salute fosse un costante dato di fatto, dato sempre per scontato, non avremmo nessun compito terapeutico. In una visione integrale dell’uomo, la malattia non sorge mai per caso o per determinismo di natura, ma sempre in base a una libera scelta dello spirito. È l’Io vero, della persona ammalata che vuol vivere lo sforzo che ci vuole per ridiventare sano. Nessuna malattia viene subita controvoglia dall’Io vero, ognuna è da lui liberamente voluta. È solo alla coscienza ordinaria (all’anima) che sembra di dover subire lo stato patologico, e quando fa questo vive nell’illusione, si pone in contraddizione col proprio essere più profondo.
È come quando si gioca: il senso del gioco non è nel suo terminare, ma nell’esercizio stesso del giocare. In modo analogo, il senso vero di una malattia non è che sparisca al più presto, che si cessi di fare i conti con la difficoltà, ma è proprio lo sforzo di occuparcene. Quando un essere umano vive una malattia il suo spirito vuole lottare con essa. Cerca l’esperienza interiore che può essere fatta solo grazie allo sforzo dovuto alla malattia. Quando poi la malattia è finita, è finito anche il vantaggio che porta. L’intento era di vivere ciò che avviene durante la malattia stessa. E perciò lo spirito umano vuol ricominciare da capo per restare sempre nell’esperienza del guarire in mille modi diversi.
Il compito degli eventi della vita è allora quello di provocare continuamente nuovi squilibri, anche nel campo della salute. Non sia mai, si dice lo spirito umano, che in ambito terapeutico io non abbia più nulla da fare! E se la realtà mi propone sempre nuovi impegni terapeutici il compito della mia libertà è quello di svolgerli con altrettanta fantasia e creatività, perché l’importante è proprio ciò che io divengo grazie a questo incessante dinamismo della vita.
In tempi di materialismo, in base al dogma della vita comoda, tanti pensano che il bene di una malattia sia di averla dietro alle spalle, di averla eliminata. Anzi, meglio ancora sarebbe se non fosse mai spuntata. Ma se la malattia scompare e io sono rimasto tale e quale, questa stasi interiore è peggiore della malattia stessa. Il mio spirito si vedrà indotto a ricercarla di nuovo e in dose rincarata, visto che quando si è presentata lieve non è servita a nulla.
Se riusciamo a vedere le cose in questa prospettiva, sorge in noi la gioia di affrontare la malattia o la sofferenza quale invito a lottare per guarire, e alla fine ci diremo: ho conseguito nuove forze interiori grazie al lottare contro questa malattia.
Con il progresso della medicina molte malattie sono oggi scomparse. E proprio qui si pone una domanda di fondamentale importanza: cosa succede quando un’individualità s’incarna con l’intento di fare i conti con una specifica malattia, e proprio quella malattia è stata debellata dal progresso della scienza medica?
Questo spirito umano dovrà cercare per altra via la propria evoluzione, fermo restando che quella specifica malattia sarebbe stata l’occasione migliore. In ogni individualità spirituale la volontà di percorrere il proprio cammino è irremovibile, non muta; altrimenti verrebbe messo in forse il senso stesso della vita. Non potendo affrontare una certa malattia, lo spirito dovrà cercare un’esperienza sostitutiva, la più adatta possibile.
Ma se questo sostituto non c’è, se l’io normale non lo cerca, che cosa avviene? Avviene che quest’uomo sentirà nell’anima un senso di vuoto. E se non sarà abbastanza evoluto da rendersi conto d’avere un’anima “disoccupata”, o se addirittura vivrà col convincimento che la vita è migliore quando è più comoda, la vacuità interiore inevitabilmente gli porterà malattie psichiche che nel corso del tempo indurranno a loro volta delle malattie nel corpo. Un’esistenza facile facile non è mai voluta dall’essere vero di ciascuno di noi. E, a scanso di moraleggiamenti, tutti possiamo verificare che una vita che rende sempre più gradevoli le condizioni esterne – secondo le comuni idee del materialismo –, nel contempo influenza l’anima in maniera opposta. L’anima si sentirà insoddisfatta perché le viene tolto ogni sprone a lavorare su se stessa, a trasformarsi e progredire. Sentirà la mancanza di tutte quelle conquiste interiori che si possono fare unicamente quando la vita è tutt’altro che esteriormente comoda.
L’importanza del “processo” di guarigione nei Vangeli
In una cultura che bene o male vuol ancora chiamarsi cristiana, può giovare gettare uno sguardo ai testi sacri del cristianesimo, a proposito di quanto stiamo dicendo. Come affronta il Cristo la realtà della malattia e della terapia? In tutte le lingue egli viene chiamato il grande Risanatore, il Guaritore: il Cristo è il Grande Terapeuta dell’umanità – così si afferma da duemila anni –, e ogni azione terapeutica trova il suo senso in riferimento a questo evento curativo complessivo dell’umanità.
La prima cosa sconcertante che risulta da una lettura spassionata dei Vangeli è proprio il fatto che il Cristo respinge ogni tentativo di attribuire a sé il ruolo decisivo nelle guarigioni che vengono descritte. Nell’operare del Cristo, che guarisce l’umanità in quanto evoca tutte le forze risananti ingenite all’essere umano, non è previsto che le guarigioni avvengano per pura opera sua. Altri, contemporanei del Cristo, per esempio Apollonio di Tiana, hanno compiuto opere taumaturgiche e terapeutiche ben più spettacolari delle sue.
Al Cristo non interessa la guarigione avvenuta, ma il processo di trasformazione interiore che si attua nell’uomo grazie all’interazione con la realtà della malattia. Dopo ogni guarigione, il Cristo dice: “La tua fede ti ha salvato”, la tua pistij (pìstis) è l’elemento terapeutico. Ed era dentro di te, non fuori. Ciò che ti rende sano è la forza tua di andare avanti quando ti cimenti con tutte le difficoltà che bussano alla tua porta.
Al paralitico che da trentotto anni giaceva presso la piscina di Betesda (Gv 5) il Cristo chiede: “Vuoi diventare sano?”. Sembrerebbe una domanda retorica, una domanda inutile! Invece la domanda del Cristo è quanto mai significativa: “Ti sei reso cosciente della volontà che c’è nel tuo vero Io di mettere in moto una trasformazione interiore grazie a questa malattia? Ti è chiaro cosa tu vuoi divenire proprio nel lottare contro questa malattia?”.
Prendiamo ancora, tra i molti altri, l’esempio dei dieci lebbrosi (Lc 17). Tutti e dieci vengono “curati” dal lato del corpo fisico ma uno solo, uno straniero, ritorna a ringraziare. Il libero processo interiore in grado di comprendere che il risanamento del corpo è dovuto alla forza incipiente dell’Io che il Cristo vuole ridestare in ogni essere umano, avviene in uno solo. E a quest’uno soltanto il Cristo dice: “La tua fede ti ha salvato”, ti ha reso sano nell’anima; uno solo, parallelamente all’evento corporeo, comincia a rendersi conto che ogni cammino terapeutico è un cammino di crescita interiore dovuta alla forza cristica dell’Io, che va perciò ringraziata.
Se anche agli altri nove è stata offerta, grazie al fatto corporeo, la possibilità di questo cammino interiore, ma i passi non sono stati compiuti, che cosa consegue? Consegue che gli altri nove dovranno ricominciare la malattia da capo, perché il loro spirito l’aveva cercata proprio per compiere il cammino interiore che soltanto il decimo ha percorso. Finché l’anima e lo spirito non si trasformano, eliminare una malattia a livello fisico non serve a nulla.
Il Cristo cura unicamente trattando l’essere umano da Io a Io, da spirito a spirito, gli interessa renderlo consapevole dei motivi positivi per cui si è scelto una data malattia. Perciò non cura tutti, senza distinzione, ma soltanto specifiche persone secondo un criterio di scelta. Egli è in grado di vedere quali esseri umani, grazie alla lotta contro la malattia, conseguono anche una trasformazione interiore. Questo processo positivo costituisce il criterio di legittimità della guarigione corporea.
La forza terapeutica dell’amore
Un’affermazione che ricorre in varie culture e religioni è che terapeutico in senso vero è solo l’amore, che soltanto le forze d’amore sono in grado di rendere sano l’essere umano. Cosa vuol dire, allora amare una persona malata? Vuol dire imparare ad amare la sua malattia. L’intento di eliminare al più presto la malattia non è amore, perché si oppone alla volontà dell’altro che l’ha fatta sorgere per lottare con essa.
Se voglio amare il malato devo sforzarmi di amare la sua malattia così come il suo spirito la ama. Devo cogliere il significato positivo del comparire della malattia, non del suo scomparire. In altre parole, un terapeuta diventa terapeuta nel momento in cui ha la forza morale interiore di volere la malattia come la vuole il paziente: come occasione di crescita interiore.
Dobbiamo allora volere che la malattia permanga o che termini? Né l’uno né l’altro. Volere che una malattia resti è non volere nulla, perché il volere si riferirebbe solo al corporeo e interiormente non si procederebbe. D’altro lato, volere semplicemente che sparisca significa, come già accennato, volere l’opposto di ciò che lo spirito del malato si propone. Tra questi due estremi c’è la decisione di volere la lotta contro la malattia, il divenire interiore di cui la malattia offre l’occasione.
Cogliere la positività del lottare contro la malattia significa vincere quell’atteggiamento fondamentale dell’uomo moderno che è l’insofferenza. L’uomo odierno soffre infatti il doppio di quanto sarebbe sufficiente: soffre perché non c’è vita senza sofferenza, e raddoppia perché non vuol soffrire, perché rifiuta ogni sofferenza in base alla sua insofferenza. Il dogma in fondo disumano dell’edonismo ad oltranza ha decretato che una vita senza sofferenza è una vita felice. Ha identificato la sofferenza con l’infelicità. Francesco d’Assisi era invece ancora in grado di essere felice proprio grazie alla sofferenza e diceva: “Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto”.
Quando l’uomo soffre di soffrire, si ribella contro la sofferenza diventando insofferente e impaziente, perché non sa più quanto egli deve alla sofferenza. La grande terapia dell’umanità attuale può risiedere allora soltanto nella forza morale di cogliere la positività di ogni tipo di sofferenza. Ciò vale sia per il paziente, sia per il terapeuta. Il senso vero di ogni malattia è la sua positività per l’evoluzione interiore del malato; essa va colta dapprima conoscitivamente per poterla poi realizzare volitivamente.
La negatività di una malattia non risiede mai nel fatto che ci sia, ma nell’incapacità dell’uomo di farne il meglio, il che avviene quando la si considera un incomprensibile e nocivo intralcio alla vita. Le forze dell’amore, in quanto forze terapeutiche, consentono all’amico, al famigliare o al terapeuta di una persona malata, di amare e confermare la scelta del suo spirito che ha fatto sorgere proprio quella specifica malattia. Tali pensieri generano forze terapeutiche di gran lunga più efficaci che non qualsiasi medicina, però vanno realmente pensati, vanno vissuti, vanno quotidianamente coltivati. Le forze di guarigione sono sempre forze di positività e scaturiscono dai pensieri. Nessuno che non ami con la mente può amare col cuore.
Il coraggio di guarire
Come si concilia la terapia o l’aiuto offerto dalle persone care con la libertà di chi attraversa una malattia? Aiutando l’altro ledo forse la sua libertà? Se questa malattia non fosse destinata a venire superata, se questa individualità si fosse ripromessa di morire grazie alla malattia, è lecito a me, in quanto medico, eliminare questa possibilità? Questa domanda è il risultato di un errore di pensiero perché mette al centro un ipotetico esito della terapia. In quanto terapeuta o amico di chi soffre non mi riguarda se questo essere umano in ultima analisi guarirà o non guarirà; ciò fa parte della sua libertà e del suo destino. Il mio compito è far di tutto per aiutarlo, durante il decorso della malattia, a far sprigionare da sé il massimo di forze interiori. Ciò può avvenire unicamente se il malato fa tutto quel che gli è realmente possibile per vincere la malattia e per ristabilire la salute. Se poi, una volta compiuta questa lotta, il suo Io si sia proposto di morire o non morire, questo riguarda soltanto lui.
La malattia è voluta sempre per poter nel modo migliore lottare contro di essa in vista delle forze che solo l’esperienza specifica di una certa prova è in grado di generare. L’aiuto altrui, in quanto accompagna e incoraggia la lotta, la trasformazione interiore che avviene di giorno in giorno proprio grazie alla malattia, non si pone mai contro la volontà libera – contro il karma – dell’Io superiore dell’altro. Anzi, ogni essere umano che tralasci di dare questo aiuto viene meno al suo compito di fratello e se è un terapeuta, in quanto karmicamente congiunto con un’individualità che viene proprio da lui per essere aiutata, doppiamente viene meno al suo compito: in quanto essere umano e in quanto terapeuta.
Questa legittimità assoluta dell’aiuto a lottare contro ogni tipo di malattia fa sorgere in coloro che sono vicini al malato la volontà terapeutica vera e propria, che è una delle espressioni più belle e profonde dell’amore. Un terapeuta che non voglia l’evoluzione in positivo del suo paziente non potrà avere su di lui un influsso risanante. Il coraggio curativo è una forza morale che sorge quando il terapeuta o l’amico giungono a volere con la massima intensità, insieme con lo spirito del malato e non meno fortemente di lui, il cammino interiore che è reso possibile unicamente grazie alla lotta contro questa specifica malattia.
Ma vediamo ora il processo terapeutico anche dall’altro lato: quand’è che una malattia si prolunga oltre il necessario? Quando noi ci ribelliamo, quando noi non l’accettiamo. Allora nasce una sorta di schizofrenia, una vera contraddizione interiore tra l’Io superiore e l’io inferiore. L’opposizione dell’io normale che non vuole la malattia e perciò rifiuta la lotta, costringe l’Io superiore a tenerlo in essa ancora più a lungo nella speranza che, prima o poi, la coscienza ordinaria comprenda che lo scopo tutto positivo della malattia è l’evoluzione interiore che essa rende possibile.
Meno una malattia è coscientemente accolta e più lunga dovrà essere, perché l’uomo omette di farne ciò che si è proposto nel suo Io superiore. Più invece egli si adopera a comprenderne il lato positivo e a realizzare l’evoluzione che ne è connessa, più si creano i presupposti per non farla durare più del necessario. In altre parole, una malattia dura per tutto il tempo che viene rifiutata e cessa nel momento che ci aiuta a crescere.
Le malattie in relazione all’uomo completo
Qual è il significato delle malattie cosiddette croniche, ritenute praticamente inguaribili? Essendo la malattia cronica di durata massima, dobbiamo considerarla in rapporto con l’elemento di massima costanza nell’essere umano, cioè con lo spirito, con l’Io. In ogni malattia cronica si esprime un aspetto dell’Io; di fronte ad essa perciò veniamo indotti in senso massimo a lavorare sullo spirito. È questo il motivo per cui una malattia cronica non si può superare dall’oggi al domani. Nella misura in cui, però, un essere umano lavora sull’Io superando i tratti negativi che hanno reso necessaria questa sofferenza cronica, la malattia può essere risolta, anche nell’arco di una stessa vita.
Rudolf Steiner indica nella sua scienza dello spirito alcune leggi ben precise sui rapporti tra le varie malattie e gli elementi costitutivi dell’essere umano, nonché sul periodo di lunga, media o corta scadenza di una terapia. Egli distingue cinque tipi fondamentali di malattie. Ne richiamo qui solo alcuni aspetti essenziali:
1. Le malattie croniche sono, come or ora accennato, in diretto rapporto con l’Io, e di conseguenza con l’essere del sangue. Esse sono ereditabili (grazie al sangue). Per una terapia, nella misura in cui sia possibile, è di massima importanza l’intero ambiente umano e naturale in quanto abitacolo karmico dell’Io. Vanno considerate, dunque, sia le relazioni umane sia gli aspetti di natura, in particolare quelli climatico-geografici. Inoltre è basilare proprio in questo campo ogni vera terapia di tipo psichico, in particolare quando riesce a svolgersi tramite le forze della gioia.
1. Le malattie acute provengono da irregolarità del “corpo astrale” – cioè dall’anima vera e propria – e si esprimono in scompensi del sistema nervoso. Per una terapia è di fondamentale importanza la dieta, l’attenzione a tutto ciò che l’essere umano ingerisce e assimila in base alla nutrizione.
2. Le malattie in parte croniche e in parte acute sono in diretto rapporto col funzionamento del sistema delle forze vitali – chiamato “corpo eterico” –, il cui correlato fisico è l’intero sistema ghiandolare. Per la terapia vanno qui usati farmaci specifici presi dal mondo vegetale e minerale.
3. Le malattie infettive sorgono in base a disordini nello svolgersi del destino (karma) i quali si ripercuotono sul corpo fisico nel suo rapporto col mondo materiale. Qui ci vuole una terapia di tipo “karmico”, volta in particolare ad armonizzare o cambiare le cause esterne.
4. Le malattie karmiche vere e proprie sono quelle le cui cause provengono dalle vite precedenti, e sulle quali non si può in alcun modo influire dal di fuori. Queste malattie corrispondono a mete specifiche che l’Io si propone di conseguire ancora prima di nascere. Nel corso dell’intera evoluzione, di vita in vita, l’Io distrugge una dopo l’altra tutte le componenti del corpo fisico con l’intento di ricostruirle grazie alle proprie forze conoscitive e volitive, libere e individuali. Infatti solo il lavoro di ricostruzione di tutto il corporeo, a partire dalle forze della libertà individuale, conferisce all’Io facoltà e capacità del tutto individualizzate.
Da questi brevi accenni, che si possono dapprima considerare come ipotesi di lavoro, risulta che la volontà positiva e ben precisa che si esprime nel far sorgere una data malattia mira a tutte quelle specifiche e multiformi attività animiche e spirituali che vengono compiute nel corso della guarigione. Una malattia polmonare (per esempio l’asma) è una distruzione – pur parziale – delle forze specifiche plasmatrici dei polmoni. Queste forze rappresentano un complessissimo mondo: in senso reale è partecipe tutto il macrocosmo al formarsi e al sano funzionare dei polmoni. Grazie alla malattia l’Io si propone di ricompiere lui stesso – con libera partecipazione conoscitiva e volitiva che sorge proprio grazie alla sofferenza per la privazione di certe specifiche forze di salute – tutti quegli infiniti atti che ancora prima della nascita egli aveva compiuto in compagnia degli Esseri spirituali, e in piena dipendenza da loro, nel compaginare l’archetipo sovrasensibile dell’organo in questione, in tutto il suo contesto reale di forze.
Ogni guarigione è allora un’imitazione umana – perciò più libera e individuale, e di conseguenza moralmente più rilevante per l’uomo – degli atti di plasmazione divina che hanno creato i vari organi nonché l’organismo intero. La guarigione, riferendoci a quanto abbiamo detto all’inizio in relazione al subconscio, è il modo veramente umano e diretto di acquisire a poco a poco cognizione di quanto è connesso con la sfera della natura, di portare a coscienza il subconscio.
Una salute riconquistata vincendo la malattia è più umana di una salute divinamente architettata una volta per tutte, semplicemente regalata e passivamente accolta. Le conquiste della libertà portano così a compimento l’opera della cosidetta grazia divina. Il senso della grazia divina è la libertà. Una grazia che non volesse la libertà umana sarebbe per l’uomo una deplorevole disgrazia.
Perché sono nato così? Chi mi ha fatto come sono?
Una persona ha problemi animici di tipo vario e, grazie a un certo tipo di anamnesi, essi si palesano presto come effetti di cause che vanno cercate, poniamo, nella primissima infanzia. In base a questa diagnosi la psicoanalisi mette in moto una terapia di tipo personale. Il terapeuta intende entrare in rapporto con l’inconscio specifico del paziente per portarlo a coscienza, eliminandone così la manifestazione patologica che consiste essenzialmente nell’ignorare le cause remote dei fenomeni animici attuali.
A questo punto si pone la necessità di approfondire il concetto stesso di causa. Il fatto che l’uomo sappia distinguere col suo spirito tra causa ed effetto, sta a dire che egli non può essere solo effetto: se così fosse, non potrebbe sorgere in lui il concetto di causa. Ora, il fatto che le cause prime e determinanti di una patologia psichica vengano viste in fatti accaduti nell’infanzia, non cambia nulla sull’affermazione implicita che l’uomo è in tutto e per tutto effetto. Sia che si veda la causa delle sue condizioni animico-corporee in un creatore, sia che le si veda nella corrente ereditaria, sia che le si imputi a quanto accaduto nell’infanzia, resta il fatto fondamentale – così fondamentale che nemmeno ci si rende conto di metterlo alla base di tutto come assioma indiscusso – che l’essere umano così viene visto in tutta la sua realtà come effetto di qualcosa che non è lui stesso a causare.
Prendere coscienza di questo fatto vuol dire al contempo conoscere l’origine più profonda di ogni atteggiamento sia depressivo, sia aggressivo. Vivendosi, pur inconsciamente, come puro effetto, l’essere umano o si ripiega su di sé nella depressione o si ribella diventando violento. E questo perché? Il suo motivo è che non può accettare l’affermazione che lo condanna ad essere un puro effetto, per il semplice fatto che in realtà non lo è. È allora compito di un’osservazione più attenta dei fenomeni animici il chiedersi se sia oggettivo il ricercare le cause prime retrocedendo nel tempo fino alla primissima infanzia. La domanda che a questo punto potrebbe sorgere è: perché ci si ferma lì? Perché non si va ancora oltre, ai tempi anteriori al concepimento e alla nascita?
Di fronte a questa domanda l’uomo occidentale resta per lo più interdetto. Da molto tempo infatti l’Occidente pensa che l’essere umano non esista prima della nascita. La religione gli ha detto che Dio crea l’anima in concomitanza col formarsi del corpo, e la scienza – che ha lasciato Dio da parte – ha mutuato dalla teologia la stessa affermazione di fondo: la realtà animica, supposto che ci sia, non esiste prima che vi sia il corpo, sorge parallelamente ad esso ( in base al noto “parallelismo psico-fisico”).
È nostro compito a questo punto non dare per scontata proprio questa affermazione implicita ma fondamentale perchè gravida di conseguenze.
Se ci rivolgiamo per esempio a Platone, per lui è scontato l’opposto, e cioè che l’uomo preesiste al sorgere del suo corpo. Secondo lui, conoscere vuol dire ricordarsi di ciò che già si sapeva prima di nascere. Fu il suo discepolo, Aristotele, a non parlare più della preesistenza: egli fu il primo a considerare l’anima la forma del corpo, e che può quindi esistere unicamente in rapporto col corpo. Il cristianesimo ha poi recepito da Aristotele quest’affermazione fondamentale, senza metterla in questione.
Chi ha ragione, allora, Platone o Aristotele? Paradossalmente hanno ragione entrambi. Platone parla di preesistenza, ma si comprende che non ha un’esperienza personale e diretta. È un’affermazione che egli prende da una lunga tradizione, soprattutto misterica. Aristotele decide allora di parlare unicamente di quella realtà animica della quale ha esperienza diretta, cioè dell’autocosciente vero e proprio. Questo tipo di realtà animica è possibile solo grazie al corpo. Questo tipo di autocoscienza psichica sorge in realtà con la corporeità e non né prima della nascita né dopo la morte.
E qui si prospetta quella che io chiamerei la seconda grande missione della psicologia moderna, se vuole aprire le porte verso un futuro davvero fecondo per l’uomo. La sua prima grande missione, l’abbiamo già accennato, è quella di riconquistare lo spirito in quanto realtà del tutto diversa da quella psichica, proprio a partire da una giusta lettura dei fenomeni dell’anima. La seconda grande missione sarà quella di varcare, nella sua ricerca delle cause prime, la soglia dell’infanzia e della nascita per riscoprire la preesistenza dell’essere umano, in quanto spirito che esiste anche indipendentemente dal corpo.
Questo coraggio conoscitivo terapeutico genererà la forza morale di andare poi fino in fondo e di porre quella domanda cruciale che l’occidente da duemila anni ha represso, la domanda che chiede: l’uomo vive davvero una volta sola? Oppure s’incarna ripetutamente, come per Platone era ovvio che fosse?
Il primo passo da compiere in questa direzione è quello di dirsi che la scienza moderna, come ha direttamente mutuato dalla teologia l’assioma della non preesistenza, così ha fatto riguardo all’affermazione che si vive una sola volta, senza nemmeno tematizzarla o porla in questione. L’urgente compito, soprattutto della psicologia attuale, è quello di mettere in questione questo dogma perché sono troppi i quesiti che trovano una soddisfacente risposta solo nella prospettiva della reincarnazione. Gli esseri umani vengono sempre più costretti da un lato alla depressione rassegnata, in qualche caso fino alla disperazione, e dall’altro alla violenza distruttrice, se non riescono a collocare la totalità della vita, con tutti i suoi enigmi, in un contesto più vasto di ripetute vite che li possa sciogliere.
Se l’uomo conosce e riconosce dentro di sé unicamente quella realtà psichica che sorge col corpo e dal corpo dipende in tutto e per tutto, egli deve dirsi, se è coerente, di essere in tutto e per tutto un effetto delle leggi e delle forze della materia. Proprio questa conseguenza logica e onesta gli toglie ogni illusione di libertà, cioè di indipendenza creatrice nei confronti del mondo fisico.
Se questo pensiero fosse conforme alla realtà l’uomo dovrebbe gioirne sapendo di vivere nella verità oggettiva. Invece, proprio in base a questo convincimento che è il cardine del materialismo moderno, l’umanità vive le conseguenze devastanti di un dogma falso, di un gravissimo errore di pensiero.
L’uomo moderno dovrà prestare attenzione ad un’affermazione di base della scienza dello spirituale che dice: la realtà dell’anima è tutto ciò che l’essere umano vive nella sua interiorità grazie all’interazione col corpo. L’animico vero e proprio è dunque per natura dipendente dal corpo e non può essere causante perché è sempre al contempo anche “causato”, cioè determinato e condizionato dal corpo. La realtà dell’anima, il vissuto animico, sorge in realtà col sorgere del corpo e non può esistere prima del concepimento o della nascita né dopo la morte.
Ma l’essere umano non è solo anima. Egli ha un corpo, ha un’anima, ma è uno spirito. L’anima è sia causa sia effetto nei confronti del corpo e non può essere, perciò, causa prima o pura; lo spirito è invece causa prima, causa pura perché non è a sua volta effetto. È lo spirito a decidere della realtà sia dell’anima sia del corpo nella loro reciproca dipendenza. Ogni spirito umano, in quanto Io del tutto unico e individuale, è la causa creante e libera sia dell’anima che del corpo, perché è indipendente da entrambi. Esiste, in quanto spirito, sia prima della nascita sia dopo la morte del corpo.
Questo pensiero, pensato fino in fondo, porta alle ripetute – benché non infinite – vite terrene di ogni spirito umano, come legge fondamentale dell’evoluzione sulla terra. Più un uomo fa l’autoesperienza reale di essere uno spirito libero e creatore, più è capace di prendere in mano la propria vita, il proprio destino e assumerne la piena responsabilità morale.
La depressione e la violenza sempre più diffuse nell’umanità moderna rappresentano la sana reazione dell’uomo che non vuole e non può darwinisticamente essere ridotto al livello animale. “Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtude e conoscenza” leggiamo in Dante. L’essere umano non è, come l’animale, un puro essere di natura, in tutto e per tutto determinato, bensì ha in sé la capacità di esercitare la sua forza libera e creatrice, di viversi sempre più pienamente come spirito.
Una cultura che ritrovi il coraggio di interrogarsi sulla preesistenza e sulle ripetute vite terrene sarà meno dogmatica e miope di una che da sempre ignora e considera tabù questi quesiti. Tematizzare sia l’uno sia l’altro quesito non equivale però a volare a conclusioni opposte, altrettanto dogmatiche. Significa avere il coraggio di portare con sé queste domande, vivendone tutte le vaste implicazioni nel contesto della vita quotidiana. Solo una disamina fenomenologica, la più esauriente possibile, dei risvolti esistenziali di queste nuove “ipotesi di lavoro”, potrà portare all’intimo convincimento di non essere ancora una volta di fronte a un dogma, ma al risultato di un lungo e responsabile cammino conoscitivo, condotto con coscienza pienamente desta.
Nelle considerazioni che seguono, certi fenomeni verranno considerati dal punto di vista della reincarnazione e chi legge non deve dare per scontata quest’affermazione ma considerarla dapprima come un’ipotesi di lavoro, per vedere che cosa ne segue per la vita. La via al convincimento interiore è del tutto individuale e nessuno può in realtà “convincere” di alcunché un altro dal di fuori. Ogni convincimento vero nasce solo da un lavoro di pensiero proprio, di natura del tutto libera e individuale.
Segono qui solo alcuni cenni sulla differenza tra il considerare l’uomo come costituito solo di anima e corpo – che nella loro dipendenza reciproca possono vedersi come un piccolo mondo a sé stante –, oppure come per di più un essere spirituale.
Accompagnamo con la pena nel cuore le malattie e le sofferenze dei bambini, quelle che, di fronte al pensare comune, appaiono le più ingiuste e le più difficili da accettare. Però, nella prospettiva della reincarnazione, tutto ciò acquista un significato nuovo: l’importante diventa ciò che l’Io vero, lo spirito eterno del cosiddetto “bambino” – che è ben adulto perché ha millenni di evoluzione alle spalle – sta vivendo e conquistando grazie alla malattia e alla sofferenza dovuta proprio al vivere nel corpo, senza nemmeno il bisogno della partecipazione a livello della coscienza normale che il “bambino” ancora non ha.
Lo stesso vale anche per tutte le sofferenze che vivono i cosiddetti handicappati mentali, il cui significato sfugge alla coscienza ordinaria – che in essi non c’è – ma può essere solo sovracosciente, voluto e vissuto dalla coscienza dell’Io superiore.
L’uomo è un essere spirituale in reale comunione con tutti gli esseri del cosmo, mai separato o a sé stante. Per curare certe malattie dell’anima spesso accade che una persona venga mandata lontano dal suo ambiente in una casa di cura. Ma l’anima si ammala proprio perché nei rapporti che ha con le persone con le quali vive c’è qualcosa che non va, e che andrebbe messo in ordine. E quale cura gli viene data? Quella di allontanarla e così estraniarla ancora di più dalla realtà che il suo spirito vorrebbe meglio conoscere, e alla quale vorrebbe lavorare per migliorarla. Invece di aiutarlo a lavorare sulla sua situazione – superando così in maniera non illusoria la “malattia” – lo strappiamo dal suo contesto di vita – che è il rapporto del suo spirito con altri spiriti umani – sottraendogli ogni possibilità di lavorare a migliorarla. Questo modo di procedere è il corrispettivo animico del volere lo “sparire” della malattia al livello corporeo, anziché volere la giusta interazione con essa.
In tempi di materialismo la psicologia stessa viene spesso indotta a considerare i fatti animici come racchiusi in una specie di scatola ermetica che ognuno porta con sé, e che rimane immutata anche se ci spostiamo di trecento chilometri dal nostro ambiente quotidiano. Ma i rapporti karmici, le forze di simpatia e antipatia, gli influssi reciproci passati e quelli volti al futuro, tutto ciò che lega questa persona malata con le altre individualità karmicamente congiunte con lei, sono forze reali, sono realtà spirituali oggettive! In che cosa consiste allora il citato intervento terapeutico che allontana il malato dalla sua realtà karmica e lo mette in una casa di cura? Consiste nel considerarlo come una pura realtà psicosomatica, come lo è anche l’animale, isolato, a sé stante, senza karma. È come se, per “curare” una pianticella danneggiata che non riesce a crescere bene, la sradicassimo dalla terra per farla crescere nell’aria.
Come può avvenire una guarigione quando io tolgo al cosiddetto “malato” la possibilità di mettere ordine nei suoi rapporti karmici, portandolo via proprio da quelli? Tutto ciò che è spirituale è per l’uomo d’oggi irreale. Anche nel caso di un cosiddetto malato di mente si escogita spesso una presunta cura individuale per una realtà che è eminentemente sociale. Come nella terapia psicoanalitica spesso s’incentra l’attenzione sui fatti animici e ci si irretisce in essi ignorando la realtà oggettiva e universale dello spirito, così nell’isolamento in case di cura si strappa non meno spesso l’essere umano dal suo “ambiente naturale e spirituale”, illudendosi di avere ugualmente di fronte l’individuo completo per il fatto che ha portato con sé, con la valigia, anche il suo corpo e la sua anima
Secondo Capitolo
AGGRESSIVITÀ E DEPRESSIONE:
l’altalena della vita
Il significato tutto positivo della malattia
Nessun uomo, nel suo essere più profondo, vuole la stasi interiore, la comodità o la passività. Anche la malattia trova il suo significato positivo della lotta contro di essa.
Gli uomini a volte si chiedono: “Ma che cosa ho fatto per meritarmela?”. È una domanda con cui ci si ribella alla “malasorte”, ma la parola “meritare” è molto bella, perché davvero una malattia si può ricevere soltanto se la si è meritata. Uno dei motivi del suo insorgere, infatti, deriva dalla necessità di pareggiare le unilateralità del nostro passato, recuperando ciò che è stato omesso o facendo meglio quel che prima è stato fatto poco bene.
Va allora approfondito il concetto stesso di omissione. Essa è l’occasione offerta dalla vita ma da un lato, non da noi afferrata. É la cosa più normale di questo mondo, perché una vita senza unilateralità, cioè senza realtà tralasciate magari per dare la precedenza ad altre, non sarebbe possibile. L’evoluzione nel tempo ci offre nel suo insieme la possibilità di conseguire tutte le dimensioni dell’umano, ma una dopo l’altra. Se le potessimo conseguire tutte insieme non ci sarebbe lo scorrere del tempo.
In questo modo avremmo già l’umano e non ci sarebbe possibile conquistarlo liberamente di pensiero in pensiero, di azione in azione. Qui è la differenza più importante tra lo scorrere del tempo e il durare nell’eternità, tra la dimensione dell’umano e quella del divino. La legge fondamentale del vivere nel tempo è il succedersi delle cose una dopo l’altra per consentire l’esercizio della libertà di conquista e di scelta; la legge fondamentale del divino è la compresenza, nella durata, di tutte le dimensioni dell’essere.
Nessun uomo può essere perfetto nel senso di “finito”. La sua perfezione specifica consiste proprio nell’incompletezza strutturale che consente l’inarrestabile dinamismo del divenire. Si tratta solo di vedere quali aspetti dell’umano ognuno abbia privilegiato nel passato e quali si proponga di conseguire o recuperare al presente, concentrandosi su di essi e riservandone innumerevoli altri per il futuro.
Supponiamo che uno voglia conseguire la virtù del coraggio. Un coraggioso deve essere unilaterale, perché se volesse essere al contempo un mansueto, un mite, non sarebbe né l’uno né l’altro. L’acquisizione del coraggio porta con sé, come risultato, un anelito verso l’altro lato, quello della mitezza, appunto. Sorgerà allora in una tale individualità il desiderio karmico di compensare questa unilateralità col suo lato opposto. Il concetto di recupero acquisisce in questo modo un significato tutto positivo. Le cose che in un dato tempo si omettono perché si dà la precedenza ad altre vengono più tardi “pareggiate”, nel senso che ora tocca a loro venir messe in primo piano.
La reincarnazione significa proprio questo: un’esistenza trascorsa come maschio è una unilateralità su tutta la linea, perché non permette, per tutta una vita, di vivere con animo femminile, con qualità di pensiero femminili, la natura e la relazioni fra gli esseri umani... Il sesso non si può “compensare” nell’arco di un’esistenza. Il maschile e il femminile sono configurazioni totalizzanti, e l’alternanza è possibile soltanto da una vita all’altra.
Tutti gli eventi della vita, anche quelli felici, sono sempre “pareggi” di inevitabili unilateralità del passato. E dunque anche la malattia. Perciò la domanda da porre non è: “Che cosa ho fatto di male perché adesso mi debba capitare questa malattia?”, ma: “Quale dimensione dell’umano mi rende possibile aggiungere a ciò che ho già acquisito nel passato?”.
Segue da tutto ciò che il vero significato di ogni evento è la prospettiva che esso apre verso il futuro. Un’individualità può scegliere una malattia senz’altro anche in base a un’omissione del passato, ma l’importante è sempre ciò che essa si ripromette di positivo per l’avvenire. L’Io spirituale ha sempre in vista la sua missione da svolgere verso il futuro.
Supponiamo che uno spirito umano abbia da compiere una missione importante per tutta l’umanità: essa richiederà forze specifiche di amore, di sacrificio, di attività impegnativa a servizio degli altri. In vista di questo progetto, sarà forse necessario passare, ad esempio, attraverso una lesione della corporeità che durerà per tutta una vita, e la cui “causa”, cioè il motivo vero, è dunque tutto nell’avvenire.
L’Io superiore di un essere umano che noi chiamiamo handicappato può aver deciso, per questa vita, di non afferrare la corporeità nel modo che noi consideriamo normale – e che, in fondo, è intriso di egoismo – ma di non avvalersene del tutto. Oltre al sacrificio che fa crescere questa individualità grazie alla sua “rinuncia”, vengono indotte anche le persone a lei congiunte a suscitare dentro di sé forze di dedizione e di amore non comuni, che potranno pienamente esplicare in futuro.
Senza la prospettiva della reincarnazione sono tanti i fenomeni che non si possono capire, che non hanno senso. Tutte le nostre riflessioni ci riportano al pensiero che, sia per il terapeuta sia per il paziente, l’importante è non opporsi alla malattia, ma volerla e amarla nel suo significato positivo di crescita in vista dell’avvenire.
L’altalena tra aggressività e depressione
Aggressività e depressività costituiscono una polarità di forze che interagiscono fra loro, e che sono entrambe necessarie per l’evoluzione. Sono anch’esse due unilateralità, il loro reciproco pareggio è in atto in ognuno, sempre e ovunque, e costituisce il dinamismo stesso della vita.
Un uomo del tutto senza aggressività o senza depressione cesserebbe di essere uomo. Si può dire che la differenza tra l’uomo e l’animale è che l’animale non è in grado né di essere aggressivo in senso vero e proprio, né di deprimersi. Se diciamo che il leone è aggressivo in quanto agguanta la preda e la dilania, usiamo delle metafore antropomorfiche, perché l’istinto di natura non è deliberata aggressività: si impone per natura, appunto. Si può essere veramente aggressivi soltanto avendone almeno un barlume di coscienza ed essendo capaci di domare l’aggressività.
L’aggressività sorge dove c’è un’esuberanza, un troppo di forze; mentre il troppo poco caratterizza la depressione. Questa possibilità del troppo e del troppo poco fa parte della libertà. L’aggressività e la depressione sono in questo modo le due forze portanti dell’evoluzione umana.
L’umanità si separò fin dai primordi dal grembo divino e questo emanciparsi per diventare autonomi esprime la prima legge fondamentale del divenire. I grandi miti (di Osiride, di Dioniso) parlano di un’umanità inizialmente unitaria e che poi si è frantumata. Ciascuno di noi è un frantume, come un atomo in sé conchiuso, dell’umanità originaria. Se ciò non fosse avvenuto, se ciascuno di noi non avesse conseguito una certa autonomia nel suo io, non ci sarebbe libertà, l’esperienza di essere un io autonomo.
Il processo di separazione dal grembo originario, dalla matrice cosmica, comporta di necessità l’esperienza dell’aggressione, esprime un atteggiamento originario di repulsa. In piccolo, nella ricapitolazione dell’evoluzione che si fa in ogni vita, l’adolescente, verso i tredici quattordici anni, riconferma il taglio ombelicale fisico nella dimensione psicologico-spirituale per acquistare la propria autonomia di pensiero e di azione. Conseguire una propria indipendenza senza aggressività non è possibile, perché si può diventare autonomi soltanto respingendo ogni gestione e conduzione dall’esterno.
L’aggressività è allora una forza moralmente né buona né cattiva in sé, ma semplicemente necessaria. Esubera, diventa eccessiva e perciò nociva (e dunque moralmente “cattiva”), quando chi respinge ogni gestione estrinseca si vuole imporre, a sua volta, sugli altri. Ed è questo troppo che noi chiamiamo normalmente aggressività, ma va ben riconosciuta la necessità anche di questa forza che fa aspirare sanamente all’indipendenza, senza tollerare manipolazioni.
In questo senso, senza una sana aggressività nessuno può diventare veramente autonomo e davvero umano; si tratta di vedere, in che modo questa forza diventa negativa. Presa nel suo significato positivo, l’aggressività è la forza dell’affermazione di sé, di cui fa parte anche la giusta autodifesa. Già Aristotele, considerava il “buono” come un giusto equilibrio fra estremi, riconoscendo nella “giustizia” di Platone la virtù di ogni virtù, il giusto mezzo fra il troppo e il troppo poco.
L’altra forza fondamentale, non meno necessaria per ogni crescita, è la depressione. È il contraccolpo necessario dell’aggressività: si richiamano a vicenda così come il pendolo, oscillando da un lato, al ritorno non si ferma al centro ma va dall’altra parte. C’è un’osmosi continua di forze tra aggressività e depressione, l’una evoca l’altra. In posizione aggressiva io vivo la mia forza egoica come necessaria per la mia evoluzione, e respingo le ingerenze altrui; nella fase depressiva vivo la forza egoica degli altri che respingono i miei tentativi di manipolazione. Io non posso vivere senza il mio egoismo e gli altri non possono vivere senza il loro. Quando respingo gli altri per affermare la mia autonomia, essi mi vivono come aggressivo; quando sono gli altri a respingere me, essi vivono la loro aggressività e io trascorro una fase depressiva.
Se l’aggressività in quanto tale è la forza primigenia dell’autoaffermazione, cioè l’anelito all’autonomia, la depressione è nella sua realtà più profonda l’anelito alla comunione. In fondo, che cosa vuole una persona depressa? Vuole la comunione, perché proviene dall’esperienza fondamentale della solitudine. Io sento solitudine quando gli altri nella loro aggressività “non mi vogliono”, ma gli altri hanno il diritto di non volermi perché hanno essi pure il diritto alla loro aggressività, alla loro autonomia. Quando mi sento depresso sto in fondo subendo la forza di autoaffermazione dell’altro, che mi fa sentire solo. Questo accende in me il desiderio di comunione.
Autonomia di ognuno e comunione fra tutti, sono i due valori fondamentali dell’evoluzione umana. Si tratta di ristabilire sempre nuovamente il giusto equilibrio tra queste due autoesperienze; nessuno può vivere senza autonomia, nessuno può vivere nella solitudine. Di fronte a queste due forze fondamentali e alla loro molteplice interazione che genera il dinamismo vero e proprio dell’esistenza, sono possibili due atteggiamenti interiori, essi pure fondamentali.
C’è chi ritiene che sarebbe meglio se aggressività e depressione non ci fossero, che sia l’aggressività sia la depressione fossero per natura negative o nocive. In ultima analisi ciò vuol dire: sarebbe meglio se l’essere umano non fosse in evoluzione. Se vogliamo l’uomo lo dobbiamo volere in cammino: sia con la capacità di autonomia, cioè di separazione, sia con la forza di reagire contro l’aggressività altrui con la depressione, esperendo la solitudine. Per trovarsi a suo agio nella solitudine dovrebbe terminare di essere uomo. L’abisso che più sconvolge nei riguardi della depressione è la paura di non trovare più in sé le forze di reazione, cioè un anelito sufficientemente forte verso la comunione.
Vero terapeuta, vero amico è colui che nutre in sé il convincimento profondo che un tale abisso ultimo non sia possibile. L’amico del depresso si proibisce il pensiero che l’altro possa accettare la solitudine in modo definitivo e irrevocabile.
Un uomo che non voglia più uscire dalla sua depressione non esiste. Ciò per il fatto che il suo vero spirito, non è mai in realtà né solo né depresso. Depressa può essere solo la coscienza ordinaria, proprio in base al fatto che non riesce a cogliere la positività anche della sua depressione. Pensare questo pensiero è allora il compito dell’amico o del terapeuta, perché questo è ciò che pensa lo spirito stesso del depresso, e il problema sta proprio nel fatto che nel suo io normale egli non riesce più a pensarlo.
Il terapeuta gli porta incontro la forza risanatrice e risanante di questa presa di coscienza: “Il tuo Io superiore, anche se tu lo volessi, non può voler restare in un isolamento definitivo. Nel tuo Io vero tu desideri vincere la depressione e rituffarti nella comunione universale con rinnovate forze di amore”. Il terapeuta riceve questo pensiero dall’Io superiore dell’altro e lo porta incontro al suo io inferiore, alla sua coscienza ordinaria: e questa è la vera terapia. Al depresso viene detto: hai scelto tu stesso liberamente questa fase depressiva perché solo se c’è hai la possibilità di superarla e di acquistare così nuove forze nel tuo animo.
Un altro atteggiamento di fondo nei confronti dell’aggressività e della depressione è quello di gioire del fatto che queste forze ci siano, avendo compreso che l’arte della vita consiste nell’interazione sempre vivace tra questi due poli. La vita fa sorgere sempre nuove unilateralità per darci di risolverle in modi ogni volta diversi. Il positivo delle unilateralità non sta nel non averle, perché se non ci fossero non ci è nulla da fare, e questa sarebbe la cosa più brutta che ci possa capitare.
La positività delle forze di aggressione e di depressione consiste nella possibilità che ci danno di lavorarci sopra, soprattutto quando diventano estreme, e di correggerle con la forza opposta. Entrare nell’unilateralità non è in sé un problema: problematico è restarci dentro rifiutando il dinamismo che ci vuole per ritornare indietro. Schiller, nelle sue Lettere sull’educazione estetica del genere umano, dice che l’uomo è sommamente umano quando gioca, non quando finisce di giocare. È continuamente da vincere il pensiero sbagliato che depressione e aggressività siano in sé negative. Un essere umano che non oscillasse tra aggressività e depressione sarebbe interiormente morto, e questo non sarebbe di certo il meglio.
Ponendo le cose in questo modo superiamo pesanti moralismi che ci trasciniamo da secoli: le forze della depressione e dell’aggressività vengono viste come il materiale plastico più prezioso che vi sia, messo a disposizione di un geniale artista perché lo modelli in molteplici creazioni. Sorge allora una profonda gratitudine verso questa polarità primigenia di forze che ci offre il da fare quotidiano. Il bene morale è l’arte stessa della vita, l’arte di maneggiare tutte le nostre forze di aggressività e di depressione in modo artistico.
L’aggressività nasce di fronte a un male che c’è
Una riflessione di natura un po’ più filosofica sull’aggressività e sulla depressione potrebbe prendere le mosse da un assunto fondamentale: l’essere umano diventa aggressivo di fronte a ogni male che trova, e diventa depressivo di fronte a ogni bene che non trova.
L’atteggiamento aggressivo implica sempre una qualche indignazione di fronte a qualcosa che non va bene: quando l’altro vuol manipolarmi o quando vedo un’ingiustizia o un sopruso nei confronti di altri vado in collera, divento aggressivo perché mi ribello contro qualcosa di non giusto. L’aggressività ha sempre a che fare con la presenza di un qualche male. Questo male non deve essere necessariamente oggettivo: è importante che venga vissuto come un male, suscitando così ira o collera – aggressività appunto.
Collegando questo pensiero a quello svolto prima scopriamo qualcosa di nuovo. Dicevamo che l’aggressività diventa negativa, cioè nociva per l’essere umano, solo nella misura in cui va oltre la giusta misura, ledendo la libertà altrui. Ora chiediamoci: quando diventano per me “di troppo”, cioè eccessivamente unilaterali e deleterie, la ribellione e l’aggressività nei confronti di ciò che mi appare come un male? Lo diventano quando io vedo il male solo fuori di me, unicamente negli altri. Allora aggredisco l’altro costringendolo a difendere giustamente la sua autonomia.
Potendo io invece combattere il male solo dentro di me, solo qui ho la possibilità di vincere la mia aggressività nei confronti del male. L’ira iniziale di aggressione rivolta all’esterno si trasforma da sé in sana depressione, nel momento in cui guardo me stesso e mi vedo anch’io del tutto imperfetto. Non così invece di fronte al male fuori di me: se vedo unicamente quello, mancandomi ogni controforza di sana depressività, divento sempre più unilateralmente aggressivo. L’espressione estrema di questa aggressività è l’omicidio, così come il suicidio è in un certo senso l’espressione estrema della depressività.
A ben riflettere, ognuno di noi dovrebbe dirsi: il male fuori di me non mi riguarda. Quel che è fuori di me è sempre e solo, per me, un dato di fatto e considerandolo come un male moraleggio inutilmente. Quel che è un male per l’altro – cioè un compito evolutivo che lui omette –, non può essere un male per me – cioè una omissione mia. Una situazione di vita che mi ponga a contatto, per esempio, con una persona estremamente egoista, mi autorizza a dire che è un male morale il suo egoismo? No: lei lo potrà considerare come un male morale, essendo il suo; per quanto riguarda me, il suo egoismo è un dato di fatto oggettivo non meno di un tramonto o di un temporale.
L’aggressivo in eccedenza vede allora il male fuori di sé e vuole combatterlo, sbaragliarlo; la cura per questa “esuberanza” di aggressività sta allora tutta nel vedere il male morale sempre e solo dentro di me. Allora divento “aggressivo” nei confronti di me stesso, e imparo che la lotta contro il male dentro di me rappresenta il senso positivo dell’esistenza. È una lotta quanto mai salutare, se condotta in modo giusto.
Ecco trovata la cura dell’aggressività: riconoscere e vincere sempre nuovamente la propria tendenza a smascherare, ad assalire e a sbaragliare il male che si trova all’esterno. Quando io voglio “smascherare” il male esterno a me sono troppo aggressivo nel pensiero, quando lo voglio “assalire” sono troppo aggressivo nel sentimento, quando lo voglio “sbaragliare” sono troppo aggressivo nelle mie forze di volontà. In tutti e tre i casi divento troppo aggressivo perché invece di cambiare me voglio cambiare l’altro, e questa stessa aggressività mi ritorna contro grazie alla sana reazione dell’altro, paralizzandomi. Questo mi aiuta a comprendere che la sede del male è dentro di me, lì il male ridiventa umano perché ci posso davvero lavorare sopra.
Nei confronti di me stesso l’aggressività si esprime allora in chiave del tutto positiva di lotta interiore, di vittoria su me stesso. Senza una giusta e sana misura di aggressività nei propri confronti non riuscirà mai nessuno a vincere i lati negativi del proprio egoismo. La “grinta” rivolta verso noi stessi ci fa dire: nella vita non posso forzare gli eventi, non posso costringere gli altri a cambiare. Non ha senso scagliarmi contro ciò che io giudico come male nella vita altrui, moraleggiando e pretendendo dall’altro il compito di ciò che posso fare solo io in prima persona.
Questo pungiglione volto verso se stessi è la riconquista quotidiana della calma interiore, è la capacità di accettare gli altri così come sono, sapendo che soltanto quando trasformo me stesso trasformo al contempo il mondo, e in modo sommo. Se invece voglio prima cambiare il mondo (cioè rivolgo il pungiglione verso l’esterno) senza mutare me stesso, non succede nulla. Anzi, le cose peggiorano perché il mondo esterno invece di cambiare rintuzza la mia aggressività, e ciò mi rimanda verso la depressione.
La depressione sorge di fronte a un bene che non c’è
Come l’aggressività nasce in presenza di un qualche male, la depressione è una reazione alla mancanza di un bene. La depressione nasce sempre di fronte a un vuoto. Il depresso è colui che sottolinea il negativo, che guarda ai buchi, alle lacune della vita invece di sottolineare il positivo e orientarsi verso la pienezza. Il depresso elenca tutte le porte che si chiudono e non vede quelle che si aprono. La grande cura della depressione è allora la positività, che non si può prendere dalle cose del mondo, ma si può solo generare nello sguardo che si posa sugli eventi del mondo. La positività risiede tutta nel nostro modo di vedere la vita. Il mondo è pieno sia di positività che di carenze perché in nessun posto, in nessuna persona, in nessun evento c’è tutto o nulla. Ci deprimiamo quando ci concentriamo su ciò che manca, perché ciò che c’è non ci dice più nulla.
L’amico o il terapeuta di una persona depressa deve sapere che non convincerà mai con argomenti teorici il depresso a guardare ciò che è positivo, perché il depresso proprio non lo vede. E non lo vede perché, nella fase depressiva, la sua coscienza ordinaria si rifiuta di vederlo, altrimenti non sarebbe depresso. Come si risolve, allora, il problema? Si risolve, o per lo meno si pongono le basi per una soluzione, con l’osmosi karmica dell’essere l’uno per l’altro, proprio grazie al rapporto di amicizia o di terapia.
L’amico – muovendosi nella sfera del pensiero che non lede la libertà dell’altro – pensa i pensieri positivi che il depresso non riesce a pensare da solo. E il pensiero fondamentale da pensare è che non esiste mai una situazione in cui tutte le porte siano chiuse. Forse lo è la morte? Nemmeno, perché con essa si chiudono, sì, tutte le porte dell’al di qua, ma si aprono tutte quelle dell’aldilà! Una situazione dove in assoluto tutto fosse “chiuso” sarebbe la fine del mondo. Ma la fine del mondo non è mai venuta da che mondo è mondo.
Un pensiero, in particolare, va riportato al centro della coscienza: più importante di ciò che non è possibile è ciò che è possibile. Cosa fa infatti il depresso? Guarda a ciò che non gli è possibile. E perché lo fa? Per inerzia, per trovare una scusa e non far nulla. È come l’intento di cambiare l’umanità: ciascuno vorrebbe volentieri migliorare l’umanità perché in fondo sa che non è possibile, e quindi ha subito la scusa per non far nulla e può dire: «Visto? ci ho provato ma non funziona, è inutile!» Se invece gli viene la voglia di cambiare se stesso, allora le cose cambiano, perché ciò è possibile! E la scusa non c’è più.
La cura della depressione è allora la decisione di concentrarsi su ciò che è possibile. Per volerlo, per realizzarlo. Questa determinazione c’è nel profondo di ogni essere umano. L’amico può rafforzare il pensiero e la volontà dell’Io vero di colui che è depresso pensando e volendo lui, fortemente, tutto ciò che è positivo in quanto realmente possibile.
In fondo si tratta, da parte di chi accompagna la persona depressa, di non desiderare lo sparire della sua depressione, perché così facendo la vedrebbe come qualcosa di negativo. Si tratta invece di conferire la prima forza necessaria, quella che fa vedere la depressione come un compito positivo, come una sfida, una occasione di crescita.
Ricompare qui riferito alla depressione ciò che abbiamo detto della malattia. Pensare che sarebbe meglio che la depressione non ci fosse è renderla ancora più necessaria. Se c’è, è bene che ci sia perché solo così è possibile la crescita interiore che si vive unicamente con la lotta contro la depressione stessa.
L’altro pensiero è che nessun essere umano vuole restare eternamente nella fase di depressione, perché è nel dinamismo di ogni polarità risalire verso il polo opposto, verso l’esuberanza delle forze di aggressività. Come la malattia viene voluta dall’Io vero per poter lottare contro di essa e vincerla, così la depressione viene cercata per poter lottare contro di essa e per vincerla. È grazie a ciò che vive grazie alla lotta che l’essere umano progredisce.
Si tratta allora di un continuum di forze che vanno dall’aggressività alla depressività. L’importante è non moraleggiare, non pensare che una depressione che duri mesi e mesi sia qualcosa di negativo in sé e per sé. Non è questo che importa. Importante non è quanto duri la depressione ma è il modo di viverla, cioè che cosa la persona diviene interiormente grazie alla lotta con la depressione, per quanto lunga essa sia.
Il pendolo tra aggressività e depressione
nei diversi archi di tempo
Consideriamo ora la polarità esistenziale delle forze di aggressione e di depressione, sotto alcuni aspetti fondamentali relativi sia al corso intero della vita, sia all’evoluzione globalmente intesa, sia al quotidiano.
Se è vero che l’esperienza della libertà è la capacità di ricostituire equilibri sempre nuovi muovendosi artisticamente tra questi due poli dell’esistenza, qual è la cosa più importante perché ciò possa avvenire? È che sorgano sempre nuovi squilibri! Compito della realtà fuori di me è sempre quello di fornire disarmonie. Per fortuna! Se io mi auguro che la vita la finisca una buona volta di cambiarmi le carte in tavola scompigliandomi le cose, non ho capito nulla! Il compito degli eventi, degli altri, del mondo esterno, è proprio quello di procurare tutti i possibili sbilanciamenti dentro di me, affinché io abbia la fortuna e la gioia di poterci lavorare, nell’esercizio sovrano della mia libertà. La legge della vita è la legge del pendolo, del gioco, della creazione artistica, dell’interminabile trapasso di forze tra la posizione aggressiva e quella depressiva.
Prendiamo il corso della vita: c’è un tempo, quello della gioventù, dove prevalgono le forze dell’aggressività. Un giovane depresso sarebbe un vecchio prematuro. Proprio perché il compito della prima parte della vita è quello di affermarsi e spiccare, deve esserci un’esuberanza di forze proprie, che gli altri non possono che considerare aggressive. In base all’esplicarsi delle forze individuali si pongono i presupposti (visto che insistendo a dare colpi se ne ricevono anche!) per il desiderio di tirarsi un po’ indietro, nella seconda parte della vita. Si comincia allora a fare di meno e a riflettere di più, a pensarci su due volte prima di fare qualcosa, e piano piano si fa posto agli altri.
Questa maggiore saggezza che si accompagna al crescere dell’età, il non riuscire più a imporsi sempre e subito, porta l’impronta della depressione. Un essere umano che avesse in età adulta soltanto l’esuberanza delle forze vitali sarebbe un bambinone, conoscerebbe soltanto l’aggressività e non la depressione, gli mancherebbe un aspetto fondamentale dell’umano. Il karma dell’aggressività della prima parte della vita è la maggiore depressione della seconda.
Si potrebbe osservare questo processo anche nella psicologia dei popoli. Quando un popolo esubera di forze vitali giovanili, mostra aggressività nella vita sociale volta alla sopravvivenza, all’edificazione elementare delle strutture, poi all’allargamento dei confini, alla sfida col territorio e con i popoli limitrofi. Si crea così una cultura di forte pragmatismo e di volitività. Un popolo più avanti nei processi di coscienza diventa maggiormente riflessivo e depressivo, approfondisce e articola le problematiche, genera una cultura filosofica e introspettiva piuttosto che di conquista.
Il depressivo è una persona maggiormente in grado di vedere la complessità delle cose; l’aggressivo parte in quarta e non si pone tanti problemi. Il depressivo prima di partire ci pensa dieci volte, e poi magari non parte! Ma vanno bene tutti e due: ci vuole l’uno e ci vuole l’altro, e in fondo la sapienza della vita consiste nel sapere quando va meglio un atteggiamento e quando l’altro, è l’arte di saper giocare sia con l’uno sia con l’altro stato interiore. Non è un buon artista colui che sa suonare solamente nella tonalità maggiore: la musica comprende in sé anche la tonalità minore. L’aggressività è il tono maggiore, la depressione è il tono minore. Goethe dice: non c’è genio senza malinconia. Senza malinconia può essere un guerriero, non un genio. L’aggressivo vuole fare – e fa bene. Il depressivo vuole pensare – e fa altrattanto bene. E se nell’altalena della vita si riesce a fare nella giusta dose tutt’e due le cose, ancora meglio!
Anche nell’evoluzione complessiva dell’umanità possiamo individuare una conduzione diversa prima e dopo della grande svolta. La prima metà dell’evoluzione non poteva che essere in chiave di prevalente aggressività, mentre nella seconda metà l’umanità tenderà a diventare sempre più “depressiva”. Deve svolgere il compito di pareggiare quella somma infinita di “solitudine”, sorta in ognuno come risultato complessivo dell’egoismo che è stato necessario per conseguire l’autonomia individuale.
Parlando di Ettore – l’eroe che nell’Iliade si presenta deciso e aggressivo, come una forza vulcanica che non si pone mai in questione –, Rudolf Steiner dice che dopo la grande svolta della storia la stessa individualità si ripresenta nel personaggio di Amleto, l’eterno indeciso. “Essere o non essere, questo è il problema...”, si chiede. L’esuberanza aggressiva e sicura di sé di Ettore si trasforma nell’interminabile depressione di Amleto, l’eterno incerto. L’umanità giovane, l’umanità matura. Quali mirabili compiti vengono qui dischiusi per il pensiero umano!
Il pareggio karmico dell’aggressività che si trasforma in depressione è anche la legge dell’evoluzione nella sua totalità, è la legge dell’esistenza umana, ed è anche la legge fondamentale della vita quotidiana. Ogni più piccolo colpo riceve in archi di tempo anche brevi il suo contraccolpo. Si tratta di osservare con attenzione sottile sempre più sottile questo oscillare nelle sue manifestazioni più concrete. Soprattutto il terapeuta deve sviluppare il cosiddetto occhio clinico per vedere come ogni piccola aggressività porti già in sé in forma latente una pur piccola depressione, e come ogni piccola depressione si risolva in una corrispondente aggressione. Nessuna depressione si può vincere senza diventare almeno un po’ aggressivi. Quando per esempio l’altro vuol aver ragione a tutti i costi o vuole da me quel che io non voglio, mi costringe a difendermi in qualche modo. E che cosa avviene in me quando mi dà senz’altro ragione...?
Il pareggio tra essere aggressivi e depressivi
Il dinamismo di natura interiore di questa polarità consiste nel fatto che ciò che si manifesta esteriormente è in un certo senso opposto a ciò che si vive dentro. In altre parole: l’essere umano non è mai o solo depresso o solo aggressivo, ma vive sempre, se pure in dosi omeopatiche, entrambi gli atteggiamenti. È proprio il convincimento che sia così, a farci comprendere che l’uomo non deve mai ricevere dal di fuori le forze che riequilibrano le sue unilateralità, ma che le porta già dentro di sé.
Il rapporto tra esterno e interno può esprimersi in termini di latenza e di manifestazione: l’aggressivo è depresso in latenza, il depresso è aggressivo in latenza. Questa polarità è in fondo quella aristotelico-tomistica di potenza e atto.
Da che cosa sorge la potenzialità di depressione in un individuo aggressivo? Dal suo agire stesso: se sta rompendo il muso a tanti, potenzialmente pone anche le basi perché glielo rompano di rimando! Quindi in potenza, è tendenzialmente un depressivo. Si tratta di un dinamismo e di un’osmosi di forze che non sono mai statici: l’attuazione di una forza porta con sé la potenzialità di evocare l’altra. Ogni forza è la potenzialità del suo opposto, e lo attrae.
La depressione e l’aggressività vanno viste come un continuum di forze, non come due realtà statiche e opposte l’una all’altra. Le due esperienze estreme sono due realtà a sé stanti soltanto se le fisso in due fotogrammi e ignoro il movimento intermedio. Queste due foto istantanee corrispondono al tipico processo di astrazione del pensiero scientifico moderno che tende a isolare i fenomeni dal loro contesto vivente. Quando la realtà viene colta nella sua interezza si comprende che l’un polo rimanda dinamicamente verso il polo opposto.
L’aggressività e la depressione vengono congiunte fra di loro dal movimento continuo delle forze dell’anima, che entrano l’una nell’altra come le onde del mare. L’esperienza di essere aggressivo porta in sé dinamicamente l’attrazione irresistibile verso il polo opposto della depressione. E viceversa.
Tali considerazioni sono importanti per vincere la paura che sorge soprattutto di fronte a una fase depressiva molto prolungata e profonda. Qui può sorgere il dubbio esistenziale che le forze di risucchio verso l’altra sponda forse non esistano veramente, proprio perché tardano a manifestarsi. Solo colui che sa con certezza assoluta che queste forze ci sono, che non ne dubita affatto è in grado di contare veramente su di esse, confermandole con i suoi pensieri di fiducia e così rafforzandole. Colui invece che dubita non può far scomparire queste forze positive che rimandano all’altro polo, perché queste ci sono e restano. È però in grado di indebolirle, e proprio questo può contribuire profondamente all’aggravamento della situazione, nel senso di un ritardo o di una fatica maggiori nel superamento della depressione.
Perfino il suicida non si toglie la vita per il fatto che gli siano davvero mancate le forze positive, quelle capaci di superare ogni depressione. No, esse oggettivamente c’erano in lui e sarebbero anche state sufficienti a salvargli la vita. Ma è successo che questa persona in estrema difficoltà e coloro che le sono stati vicini hanno ignorato quelle forze reali e hanno omesso di evocarle non avendo contato su di esse.
La responsabilità morale nei confronti della positività intrinseca dell’essere umano, anche nei momenti più difficili della vita, riguarda ogni rapporto di terapia e di vera amicizia. Se questo rapporto è autentico, il terapeuta o l’amico sanno bene di far parte profondamente del karma, della vita di colui che soffre, e comprendono che proprio per questo egli si aspetta da loro – anche se non consciamente –, la fiducia più assoluta e la convinzione profonda e incrollabile che ogni Io vero viene alla vita per viverla nella sua totalità e pienezza, non per togliersela! Quando il terapeuta stesso, o l’amico, cominciano ad aver paura che il depresso si tolga la vita, con questa paura gli paralizzano la volontà positiva di vivere che nel suo Io vero c’è e che sarebbe necessario rafforzare per evitare il suicidio. L’ultima ragione per esistere, prima di uccidersi, è la fiducia terapeutica, cioè ricostituente, nell’essere umano stesso. Perciò questa fiducia non dovrebbe mai venir meno nel terapeuta e nelle persone care.
Dobbiamo ben distinguere tra non avere forze a disposizione, oppure averle senza farne uso. Quando un essere umano si toglie la vita si tratta sempre del secondo caso, mai del primo.
E possiamo anche comprendere che il dinamismo unitario e continuo delle forze dell’anima è per sua natura tale che più una posizione diventa unilaterale ed estrema e più diventa tanto insostenibile quanto insopportabile. Insostenibile perché ingiustificabile al livello del pensiero, insopportabile al livello di comportamento nel contesto armonico della vita. L’insostenibilità e l’insopportabilità – per sé stessi e per gli altri – della depressione e dell’aggressività estreme mostrano la non meno forte e oggettiva tendenza oggettiva a uscirne fuori. Questa spinta non è un’astrazione: è un dinamismo di forze animiche realissime che tendono per natura, e nel loro insieme, alla salute dell’anima. Solo che questa salute non consiste mai in una stasi – che sarebbe la morte dell’anima – ma in una vera e propria incessante altalena tra le forze della simpatia e quelle dell’antipatia.
Il linguaggio esoterico esprime questa realtà dell’anima col termine tecnico di pareggio karmico: il pareggio karmico dell’aggressività è la depressività, e viceversa. Ogni forza chiama in campo “per forza” la sua controforza. Il karma dell’uomo, di regola, è di diventare in una vita successiva una donna, e viceversa. Ognuno desidera diventare ciò che ancora non è, e il desiderio è fatto di forze reali che lo portano dinamicamente verso ciò che ancora gli manca. Questa “legge del karma” è in fondo la legge della fiducia nella totalità delle forze dell’anima, perché esse sono affidabili in senso assoluto.
Il troppo, il troppo poco e il giusto mezzo in Aristotele
Alla luce del nostro tema si possono riconsiderare le tre virtù che Aristotele ha ripreso da Platone, con la giustizia (quarta virtù platonica) che tutte le presuppone, tutte in quanto virtù del giusto mezzo. Le tre virtù sono la saggezza, il coraggio e la temperanza.
Quando diventa aggressiva la saggezza e quando depressiva? Il cammino verso la verità diventa depressivo nell’ottusità che sfocia nell’agnosticismo, nel relativismo, nella rinuncia a ogni ricerca di verità e nello scoraggiamento; diventa aggressivo nei confronti della verità nell’esaltazione che sconfina nel dogmatismo, nel settarismo, nel fanatismo. La saggezza vera è la forza di ritrovare sempre un equilibrio tra la deflazione del disinteresse e della rassegnazione e il voler agguantare, ghermire con violenza i misteri dell’esistenza.
La virtù del coraggio si vive nel ritrovare costantemente l’equilibrio tra la codardia, la tapineria (depressività del coraggio) e la temerarietà, l’avventatezza (che rappresentano l’aggressività, il troppo del coraggio).
La temperanza è la virtù che ricerca il pareggio tra l’aggressività dell’ascesi, della macerazione (che è una posizione di estrema violenza nei confronti della propria corporeità, per costringerla a dare anche quello che non può dare) e la dissolutezza, il lasciarsi andare, cioè la depressione nei confronti del proprio corpo.
Proprio considerando la dinamica intrinseca delle virtù platonico-aristoteliche vediamo che il giusto mezzo non è uno stato (statico), ma è l’espressione della tensione dinamica innata in ogni posizione unilaterale a ricercare ciò che le manca. In questa tensione, che l’essere umano può sia assecondare sia ostacolare, risiede la vera salute.
Terzo Capitolo
IL MATERIALISMO D’OGGI:
grande malattia o grande terapia?
Il materialismo del nostro tempo può essere considerato come una malattia. Vogliamo farne una diagnosi individuando alcuni sintomi fondamentali e chiedendoci, in chiave terapeutica, quale cammino positivo sia reso possibile proprio grazie alla lunga lotta contro la malattia culturale del materialismo.
La prospettiva metodica di tutte le considerazioni già espresse è che ogni malattia va considerata come un’occasione di crescita. Proprio l’osservazione di questo fenomeno culturale del nostro tempo ci servirà da un lato ad applicare il metodo in tutti i suoi aspetti, dall’altro a verificarlo nel modo più esauriente.
Prendiamo le mosse dall’affermazione fondamentale che il materialismo non è in sé una cosa buona o brutta, che sarebbe cioè un grave errore ritenere che sarebbe meglio se non ci fosse. Ci chiediamo invece subito: quali dimensioni dell’umano si possono conseguire solo grazie al fare i conti con la realtà del materialismo?
La pranoterapia e i diversi tipi di forze “eteriche”
Come preludio alle riflessioni sul materialismo vorrei proporre alcuni pensieri che Rudolf Steiner sviluppa riguardo al mesmerismo detto anche biomagnetismo. Cito questo fenomeno come un esempio del modo di affrontare la mentalità materialistica, oggi in voga, soprattutto per ciò che riguarda i rapporti fra esseri umani nei loro aspetti più profondi.
Esistono persone che hanno facoltà terapeutiche particolari, capacità taumaturgiche o curative grazie alle quali, per una specie di osmosi, possono trasfondere certe forze ad un altro essere umano. Queste forze non sono di natura fisico-sensibile – tali cioè da potersi rilevare esteriormente – ma sono forze invisibili che agiscono a livelli molto più sottili. Vengono chiamate forze magnetiche e sono di natura passeggera, non duratura: soltanto alcuni individui ben le posseggono, e anche costoro solo per un certo periodo. Poi col tempo scompaiono.
L’essenza del fenomeno consiste in questo: il mesmerizzatore, o pranoterapeuta, ha la capacità di rafforzare il proprio corpo astrale (cioè la propria anima), di far fluire dentro al proprio corpo eterico queste forze astrali e poi, magnetizzando il corpo vitale-eterico del paziente, di farle affluire anche in esso.
Se il malato avesse la capacità di generare lui stesso nel proprio corpo eterico, a partire dal proprio corpo astrale, cioè dalla propria anima, le forze risananti di cui ha bisogno, esse non resterebbero forze inferiori di natura magnetica o galvanizzante, ma forze libere di chimismo eterico, di alchimia eterica che l’Io gestisce liberamente.
Richiamiamo, per capirci meglio i diversi tipi di sostanza eterico-vitale che Rudolf Steiner distingue: l’etere del calore, l’etere della luce, l’etere chimico e l’etere vitale.
1. L’etere del calore è quello che fa da ponte fra la sostanza eterica del cosmo e la sua manifestazione nei fenomeni della natura. Il calore eterico dell’entusiasmo e dell’amore si riflette, al livello inferiore della natura, nel calore termico. Nella subnatura (o sottonatura) esso si esprime come forza di gravità che fa parlare di “massa” e di “peso” che hanno le cose. Ogni aumento di pressione fa aumentare la temperatura.
2. L’etere della luce si riflette nell’aria, nella luce del sole, e al livello di subnatura si manifesta come elettricità. La sua sostanza eterica vera e propria è fatta di pure forze di pensiero. La luce del pensiero illumina il mondo sovrasensibile – analogamente alla luce del sole che illumina le cose visibili – e rende possibile la percezione sovrasensibile al livello della visione estasiante, ma anche di una “immaginazione” che lascia del tutto liberi, nella quale il pensare stesso diventa vivente, seguendo le incessanti metamorfosi di tutto ciò che è vivente.
3. L’etere del suono (o chimico o dei numeri) si riflette nei fenomeni chimici dell’acqua e al livello di subnatura, dove questa affinità chimica degli elementi viene come imprigionata o coatta, abbiamo il magnetismo. Nella sua realtà eterica è la forza di coesione e di armonia fra i vari esseri e si esprime nelle “affinità elettive” che vanno dall’armonia pitagorica delle sfere, ai rapporti numerici dei cicli evolutivi e delle frequenze d’onda più svariati.
4. L’etere della vita si riflette nella Terra là dove sorgono organismi viventi organizzati in unità: a livello di subnatura, quale controparte dell’etere di vita, c’è la disgregazione totale e irreversibile della materia che noi osserviamo incipientemente a livello di energia atomica, di radioattività, ma anche di ogni fenomeno di morte come conseguenza del ritrarsi dell’etere della vita dall’organismo.
L’etere di vita in quanto tale è l’intuizione pensante creata da Esseri spirituali di ogni organismo vivente nella sua unitarietà vitale: per esempio la rosa, o il leone. Questa sostanza eterica – unitaria ma al contempo estremamente articolata e organizzata – è quella che struttura poi il sostrato materiale secondo le sue linee di forza che tendono a specifiche forme.
Tutti e quattro i tipi di etere possono quindi esprimersi a tre livelli: nella realtà eterico-vitale stessa, nella natura e nella subnatura. L’etere puro rappresenta il primo livello del mondo soprasensibile – la cosiddetta “quintessenza” o “materia prima” degli antichi e degli alchimisti medievali. Esso diventa sensibile intridendosi di materia, che è la materia dei quattro elementi fisici: fuoco, aria, acqua, terra – detta perciò “materia seconda”, percepibile ai sensi corporei. L’etere che lavora dentro l’elemento materiale lo plasma in mille modi, facendo sorgere tutte le creazioni della natura a noi note.
La natura ha però la possibilità di snaturarsi divenendo sottonatura (o contronatura) soprattutto in base all’interazione con l’essere umano. La natura diventa subnatura o contronatura nella misura in cui le quattro sostanzialità eteriche perdono la possibilità di plasmare liberamente a loro immagine il sostrato materiale, in quanto questo impone ad esse le proprie leggi di non libertà e di determinismo. Queste si esprimono nella gravità – mentre l’etere è pura forza di levitazione –, nell’elettricità, nel magnetismo e nella radioattività di disintegrazione totale, come forza direttamente opposta all’etere di vita creatore di organismi unitari viventi.
Il fenomeno culturale del materialismo può essere visto come il correlato animico-spirituale del progressivo decadere della natura a subnatura, anche per il fatto che l’essere umano ha sempre la possibilità di liberare l’eterico dalla materia per viverlo a livello puramente sovrasensibile.
Il magnetismo è in un certo senso l’opposto dell’etere chimico: è una sorta di parentela forzata tra elementi. Se il paziente fosse capace di risanare il proprio corpo eterico a partire dal proprio corpo astrale, riceverebbe una cura in base all’etere chimico, in base alle forze alchemiche viventi: mancando questo, il mesmerizzatore o pranoterapeuta gli fa confluire forze che operano in lui magneticamente e sostituiscono per un certo tempo il chimismo che non è ancora in grado di gestire da solo.
Queste forze biomagnetiche non devono perciò volersi sostituire per sempre al processo naturale, ma soltanto per quel tempo necessario a ridare autonomia al malato. Ciò spiega perché queste forze siano di natura passeggera: colui che le possiede deve comprendere che il suo compito è far di tutto per rendersi superfluo. Si può legittimamente operare con queste forze soltanto con l’atteggiamento interiore della dedizione e del sacrificio di sé per l’altro.
Perciò Rudolf Steiner aggiunge: il mesmerizzare non dovrebbe mai essere praticato come una professione, cioè a scopo di lucro, perché in questo modo diventerebbe la fonte di sussistenza del terapeuta che così lavorerebbe per sé, e non unicamente per l’altro. Snaturerebbe in questo modo il fenomeno il cui andamento giusto è proprio quello del ritrarsi, del ridestare l’autonomia dell’altro.
Se questo fenomeno di terapia non può diventare una professione duratura e redditizia, significa che presuppone nell’umanità una mentalità di altruismo: nella fase in cui un essere umano viene karmicamente chiamato a prodigare agli altri queste forze biomagnetiche, verrà sostentato dalla comunità che lo solleverà dal dover guadagnare. E quando le forze verranno meno – perché questo momento verrà e lo si deve volere – il mesmerizzatore dovrebbe avere la forza morale di abbracciare un lavoro vero come fanno tutti gli altri.
È nella natura di queste forze, dunque, di operare come le forze pedagogiche del maestro: un buon maestro è colui che fa di tutto per non creare dipendenza, cioè per rendersi nel corso del tempo superfluo. E ciò vale anche per un buon terapeuta.
Rendersi superfluo in quanto terapeuta significa in fondo impostare il rapporto con il paziente concependosi già in partenza non come un terapeuta, ma come un essere umano normale che si sforza al di sopra di tutto di amare l’altro nella sua normalità e autonomia. Quel che inficia il rapporto terapeutico è il fatto di concepirlo per natura diverso dagli altri rapporti. Il paziente viene per lo più cercando un rapporto speciale: ma proprio per questo è malato. La cura dovrebbe consistere nel rifiuto da parte del terapeuta di stabilire con il paziente una relazione diversa dal sano interagire fra uomini, che fa leva sulle forze karmiche positive che operano in ogni incontro umano.
Il dogma del materialismo:
«L’uomo è un animale superiore»
Da queste riflessioni possiamo trarre una duplice prospettiva per l’approfondimento del materialismo stesso. La prima si riferisce al fatto fondamentale che ogni persona umana è un essere spirituale che va conosciuto anche nei suoi elementi costitutivi soprasensibili; la seconda è il fatto che ciò che è materiale – per esempio il pane quotidiano che ci nutre – non può costituire mai lo scopo della vita, bensì il suo strumento. Il corpo è lo strumento dello spirito, non viceversa.
Veniamo ora al fenomeno vero e proprio del materialismo e prendiamo in esame quelli che vorrei chiamare i suoi due dogmi fondamentali: l’uno di carattere maggiormente intellettuale e l’altro di carattere maggiormente volitivo o morale.
Il dogma della scienza materialistica moderna in chiave conoscitiva afferma che l’essere umano è un animale superiore. È l’assunto basilare della teoria evolutiva di Darwin ed è l’origine anche della prassi materialistica del nostro tempo.
Che cosa c’è dietro quest’affermazione che è diventata la convinzione di milioni e milioni di esseri umani così da sembrare ormai scontata? Compito del pensiero è chiedersi se veramente non ci sia una differenza di principio tra l’essere umano e l’essere animale. Se non siamo in grado di evidenziare con tutta chiarezza la sfera specifica in cui l’umano esula completamente dall’animale, non saremo in grado di superare questo dogma del materialismo, né di confutarlo.
Che l’uomo contenga in sé tutto ciò che c’è anche nell’animale non possiamo che confermarlo: ma il riconoscere in lui anche la dimensione animale non significa aver spiegato tutto dell’umano. Quando abbiamo individuato l’animale nell’umano, che cosa ci vieta di scendere anche gli altri gradini? Visto che nell’uomo ci sono tutti i processi di crescita e nutrimento presenti nella pianta, l’essere umano può essere visto come una “pianta superiore”. E continuando oltre: visto che l’uomo ha in comune col minerale tutti gli aspetti che sono propri dell’anorganico, allora è anche un minerale superiore.
Che cosa è successo nella corrente scientifica del darwinismo, con le successive variazioni alla fine del secolo diciannovesimo e poi per tutto il secolo ventesimo? Si sono paragonati infiniti aspetti della vita animale al modo di comportarsi dell’essere umano e si sono trovate innumerevoli comunanze.
La domanda però è: c’è forse nell’uomo un’altra sfera specificamente umana, non compresa nell’animale? Aristotele e Tommaso d’Aquino ci dicono: se noi cerchiamo lo specifico umano non ci serve a nulla paragonare l’essere umano con l’animale, perché così evidenziamo soltanto l’animale nell’uomo. Dov’è l’uomo in quanto tale? Lo specifico umano, se c’è, sarà unicamente ciò che ognuno di noi non ha in comune con l’animale. Essendo partiti dall’assunto che l’uomo è un animale superiore, si è sottolineata in modo unilaterale l’animalità in lui e si è disatteso di ricercare proprio il non-animale in lui.
Specificamente umana, perché del tutto assente nell’animale, è la capacità di libertà, la facoltà creatrice dello spirito umano. L’uomo è costituito, nell’individualità del suo Io, in modo tale che può avverare in base a creazione propria, giorno dopo giorno, tutte le dimensioni dell’umano, cioè tutte le dimensioni della libertà. Ma la libertà non si realizza per automatismi, non è un dato di natura. Dev’essere perciò possibile anche omettere nel corso dell’evoluzione ciò che è specificamente umano. Deve esserlo, altrimenti non saremmo liberi.
L’evoluzione dell’uomo consiste nella duplice possibilità di realizzare lo specifico umano – la libertà – o di ometterlo. Che l’uomo divenga nel corso del tempo sempre più come un animale è una possibilità evolutiva reale: basta omettere giorno dopo giorno tutto ciò che è specificamente umano. Certo, non basta una vita sola per far questo, e perciò va considerata seriamente anche in quest’ottica l’ipotesi delle ripetute vite terrene. Nella consequenzialità dell’essenza stessa della libertà la realtà specifica dell’uomo deve anche essere perdibile, altrimenti non sarebbe un fatto di conquista libera. E ciò richiede un’evoluzione nel tempo molto lunga.
L’Apocalisse, che porta i fenomeni evolutivi fino all’ultima conseguenza, parla dell’abisso ultimo dell’evoluzione nei termini della “Bestia”. L’essere umano che abbia omesso totalmente la realizzazione di ciò che è oltre l’animale decadrà al livello animale. La “Bestia”, cioè l’uomo-animale, è l’abisso dell’evoluzione in negativo – per omissione – della libertà umana. Nel darwinismo l’uomo è visto come animale già in partenza, e in chiave positiva o per lo meno neutra.
Ma perché mai, verrebbe da chiedere, si afferma che l’uomo è un animale “superiore”? Nella sua realtà animale l’uomo è proprio un essere inferiore, perché gli animali, a differenza dell’uomo, sono armonici nella loro animalità. Sono guidati dall’istinto – impronta della saggezza divina che agisce in loro senza che ne abbiano autocoscienza a livello individuale. L’essere umano, invece, quando si comporta come un animale, crea un’infinità di problemi. Dov’è allora la “superiorità”?
O la superiorità dell’uomo risiede nello specifico umano, che manca nell’animale, oppure, se restiamo nell’assunto che l’uomo è un animale e si comporta davvero come tale, allora è un animale decisamente inferiore, non superiore. Dal punto di vista del pensiero l’assunto è perciò pensato male: l’aggettivo “superiore” rivela un moralismo, un preconcetto discriminatorio nei confronti degli animali che non si accorda con i fatti oggettivi. O diciamo che l’uomo è un animale che crea molti più problemi degli altri animali, oppure ci tocca dire che lo specifico umano consiste in ciò che l’animale non può avere.
Di fronte a questa interpretazione dell’uomo che il materialismo dà per scontata, c’è una reazione aggressivo-depressiva dell’uomo stesso che si può vedere anche in base ai temperamenti. Il flemmatico e il melanconico reagiscono per lo più in tono depressivo; il sanguinico e il collerico maggiormente in tono aggressivo. Proprio nel materialismo troviamo le origini più profonde, e in un certo senso culturalmente comuni, dell’aggressività e della depressione, come karma dell’umanità del nostro tempo. La depressione è l’infinita tristezza che sorge nel vedere se stesso ridotto come uomo ad animale; l’aggressività è la rabbia per lo stesso motivo. Ambedue hanno la loro radice nel fenomeno culturale complessivo del materialismo che permea tutto il vivere degli uomini d’oggi.
Il totalitarismo del materialismo:
vivere di brame per soddisfare infiniti bisogni
Il secondo dogma del materialismo è il risvolto pratico del primo: è il dogma della vita comoda. Lo potremmo formulare così: la vita comoda è una vita felice, dunque più vengono appagati i bisogni materiali e più l’uomo è felice. La teoria dell’animalità dell’uomo diventa qui prassi di vita.
Con il termine “bisogno” indichiamo una forma naturale del volere che si esplica come richiesta e non ha, quindi, carattere propositivo. Il bisogno nasce dalla sfera del corporeo, nella triplice distinzione che ne fa la scienza dello spirito: corpo fisico (bisogni legati all’istinto: fame, conservazione della vita, ecc.); corpo eterico (bisogni più interiorizzati, ma ancora incoscienti, legati all’inclinazione, alle abitudini, al temperamento, alle tendenze: bisogno di un ambiente, di uno specifico clima, di una forma e di un ritmo di vita, ecc.); corpo astrale o anima (bisogni ancora più interiorizzati, non costanti come quelli legati al fisico-eterico, e coscienti: sono le brame) che sorgono dalle simpatie e dalle antipatie.
Proporzionalmente all’evoluzione individuale, ogni essere umano potrà afferrare con la forza dell’Io le forme corporee del volere e orientarle verso l’animico e lo spirituale. Caratteristica fondamentale dei bisogni, nelle loro più varie espressioni, è che indicano sempre una dimensione di necessità, di non libertà, e la loro soddisfazione può provenire soltanto dall’esterno, proprio dalla sfera eminentemente libera degli altri esseri umani: quella spirituale dei talenti, dove la volontà entra liberamente nella forza pensante e diventa capace di creatività, di donazione.
Se ci chiediamo, anche in chiave terapeutica, dove si mostri nella vita quotidiana la soglia della libertà che differenzia l’essere umano dall’animale, è indicativa, come orientamento di fondo, la distinzione importante fra talenti e bisogni. È anche questa una delle grandi polarità dell’esistenza. Ognuno di noi ha tanti bisogni, l’appagamento dei quali è il presupposto per l’esplicazione dei suoi talenti. L’animale, invece, ha soltanto bisogni, manca totalmente di talenti: quando ha appagato tutti i bisogni del momento è a posto, non ha facoltà individuali da esplicare. Anche il meraviglioso operare delle api non è un talento della singola ape, ma è la perfezione istintuale della specie che si manifesta in quelle abilità che ripetono sempre se stesse. L’ape “ha bisogno” di fare il miele: se non lo facesse, non sarebbe ape, e se è ape non può che fare miele.
Il dogma del materialismo, che interpreta l’essere umano come un animale, deve vedere la felicità nell’appagamento di tutti i bisogni. L’uomo d’oggi conosce così quasi unicamente l’ipnosi dei bisogni e va a caccia del loro appagamento. Si muove molto poco nella sfera dei talenti e della gioia che proviene dalla loro esplicazione. Cerca la felicità nel polo opposto. Invece, un uomo che riuscisse ad appagare tutti i suoi bisogni senza “bisogno di altro” dovrebbe viversi come un animale, e ciò lo renderebbe sommamente infelice.
In che cosa consiste, allora, la polarità tra bisogno e talento? Il bisogno, nell’uomo, vuole essere appagato e cessa di esistere dopo il suo soddisfacimento. Prendiamo l’esempio della fame: che cosa avviene quando io mangio? Assopisco il bisogno fino a farlo sparire. Il talento ha invece la dinamica opposta: là dove viene esplicato rinvigorisce, diventa sempre più genuino e più forte! Il pittore che dipinge vuole che il suo talento si sviluppi sempre di più, si avveri ancora e ancora accrescendosi; e lì fa sua la gioia della vita, la felicità specifica dell’uomo. Più il bisogno è forte e più si è infelici, più il talento è forte e più si è felici.
L’ossessione materialistica che prende in considerazione quasi esclusivamente i bisogni, e in base alle leggi tiranniche del mercato li moltiplica inventandone sempre di nuovi – anche se non sono reali, importante è che corrispondano ai prodotti da vendere – ha portato gli uomini a disattendere quasi totalmente la sfera specificamente umana dell’esplicazione dei talenti.
Come distinguo, in concreto, un bisogno da un talento? I bisogni di una persona sono tali in quanto possono essere appagati soltanto dagli altri: è questo il criterio fondamentale di distinzione. Quando io dico: “aiutami!”, ho a che fare con un bisogno; quando io dico: “lasciami in pace, faccio meglio da solo!”, ho a che fare con un talento. I bisogni di una persona possono essere appagati soltanto dagli altri, altrimenti non sarebbero bisogni, bensì talenti. Un talento, invece, fa dire a una persona: “non intromettetevi, perché io questa cosa la so fare meglio di voi!”Allora è un talento.
Prendiamo Dante che scrive La Divina Commedia: è un essere umano che vive un bisogno o un talento? Mentre plasma i suoi pensieri, le sue intuizioni, esplica un talento. Sta scrivendo, non ha bisogno degli altri, sa lui quali pensieri devono venire espressi, a quali immagini vuol ricorrere per comporre la scena...
Ma ecco che improvvisamente finisce l’inchiostro! In quel momento preciso c’è un’inversione da un Dante “talentato” a un Dante “bisognoso”! Fino a un secondo prima viveva l’esplicazione dei suoi talenti e voleva essere lasciato in pace, adesso chiede aiuto. Se Dante sapesse meglio di altri come si fabbrica l’inchiostro e avesse nella stanza vicina il suo laboratorio, andrebbe ad esplicare un altro talento e non si sentirebbe bisognoso.
La polarità bisogni-talenti funziona così: gli altri mi aiutano ad appagare i miei bisogni perché hanno i corrispettivi talenti, e nelle sfere in cui io sono creativo esercito i miei talenti, che appagano i bisogni altrui. La malattia del materialismo consiste nel fatto che gli uomini oggi conoscono e vivono quasi unicamente l’appagamento di bisogni in questo modo. Sono solo e sempre bisognosi!
A questo punto viene spontanea la domanda: se io dipingo un quadro lo faccio anche perché ho bisogno di soldi, no? Dipingere un quadro è allora l’esplicazione di un talento o è l’appagamento di un bisogno? È possibile sia l’un atteggiamento interiore, sia l’altro. Se però io penso di trovare la felicità dipingendo unicamente o principalmente per avere soldi mi illuderò di trovarla, perché avrò di me l’esperienza del bisognoso, non del creatore. Perciò i veri artisti hanno preferito morire di fame pur di non rinunciare alla felicità somma di creare per creare, di creare per esprimere con pieno godimento la propria stessa creatività. A uno che sappia cos’è la felicità non interessa la quantità dei giorni della vita: piuttosto pochi, ma pieni e belli. L’appagamento dei bisogni dovrebbe essere la base, la condizione necessaria per ciò che in noi è davvero umano, per la nostra fantasia morale e la nostra capacità pensante che ci consentono di vivere come individualità spirituali, piene di talenti che ci rendono creatori in tutti i campi della vita.
Se di fronte alla teoria del materialismo l’uomo vive la tristezza (depressione) e la rabbia (aggressione), quali sono le reazioni di fronte alla prassi del materialismo? In chiave di depressione sorge il fenomeno dell’insofferenza: la sofferenza viene respinta in base al falso convincimento che si è felici nella misura in cui la vita è facile. Eppure è vero il contrario: più la vita è comoda e più l’essere umano è infelice perché nella vita facile è un buono a nulla e non conclude nulla.
É l’antropomorfismo che ci porta a vedere ingegno creativo individualmente cosciente. Testimonia la nostra incapacità di comprendere fino in fondo l’individualità dell’Io umano. Non solo gli animali ne sono del tutto privi, ma dovrebbero per di più attivare in noi un senso di profonda responsabilità. Infatti la sofferenza fisica degli animali, soprattutto quella indotta dallo sfruttamento e dall’indifferenza da parte dell’uomo, non comporta per loro alcun passo evolutivo individuale.
Il privilegio di avere dei problemi da risolvere e che non permettono una vita facile e comoda è specifico dell’uomo. L’infelicità non sorge per la presenza della sofferenza, ma a causa del suo rifiuto. Questo rifiuto è un moralismo (“soffrire è male”) che sorge dalla povertà del pensiero e dalla letargia della volontà. L’uomo è felice quando accoglie liberamente il dolore trasformandolo in una crescita interiore. É infelice e depresso quando si ribella contro la sofferenza, perché al contempo rifiuta il dinamismo della sua umanità.
Se io capisco che una vita del tutto agevole non può farmi felice, non mi ribellerò di fronte alle difficoltà che la vita mi porterà incontro. Non c’è bisogno di andarsi a cercare la sofferenza: basta già per tutti quella che la vita ci offre. È l’atteggiamento interiore che va capovolto: la sofferenza non è “contro” l’uomo, bensì “per” l’uomo. È la sana via d’accesso a ogni conquista nuova che sia veramente degna dell’umano.
C’è poi anche una reazione aggressiva nei confronti del dogma della vita comoda: la ribellione interiore che si esprime in varie forme di violenza. Questa ribellione violenta vorrei illustrarla con un fatto realmente accaduto. A New York, mi trovavo in una comunità di italiani emigrati che si erano impegnati per tutta una vita ad appagare i bisogni materiali dei figli. Come un fulmine a ciel sereno nel giro di poche settimane decine di ragazzi e ragazze dai quattordici ai diciassette anni, dopo aver spaccato tutto quello che capitava loro sottomano per le strade e nei negozi del quartiere, sparirono andandosene di casa senza una parola di spiegazione ai genitori. I giovani rimasti dissero: voi genitori ci avete dato tutto materialmente. Rendendoci la vita comoda e facile ci avete derubati della forza di volontà, che è quanto di più prezioso ci sia al mondo. Avendo ricevuto tutto, non abbiamo mai avuto la possibilità di conquistarci nulla. Non siamo mai stati incentivati ad esercitare la volontà e adesso non abbiamo in noi la forza per coltivare le capacità necessarie alla vita... Immaginate la reazione dei genitori e dei nonni che si erano letteralmente ammazzati di lavoro per appagare i bisogni dei figli e dei nipoti!
Di che cosa ha “bisogno” allora l’essere umano? Di essere messo in grado di esercitare a pieno i propri talenti! Nessuno vuole appagati più bisogni di quelli che, di volta in volta soddisfatti, gli consentano di esplicare nel modo più soddisfacente i propri talenti. Uccidiamo l’essere umano quando moltiplichiamo artificiosamente l’elenco dei bisogni, disattendendo i talenti.
Se applichiamo questa disamina a una fabbrica, a una ditta, gettiamo subito una luce sui fenomeni che lì avvengono, perché la domanda che ci si deve sempre porre è: che cosa stiamo facendo, qui? Stiamo producendo per appagare dei bisogni (nostri!) o stiamo producendo per dare agli esseri umani la possibilità di esplicare i loro talenti? E noi, quali talenti esplichiamo nel nostro lavoro?
Effetti del materialismo sul corpo,
sull’anima e sullo spirito dell’uomo
Rudolf Steiner ha spesso riferito il fenomeno globale del materialismo alla triplice realtà dell’uomo fatto di corpo, anima e spirito. Ha coniato tre espressioni che possono fare da orientamento per approfondire i fatti. Nella vita improntata al materialismo si verificano tre processi:
Il corpo umano si animalizza sempre di più, cioè funziona sempre di più come il corpo di un animale.
L’anima umana si vegetalizza, acquisisce cioè sempre di più le leggi di sviluppo delle piante.
Lo spirito umano si mineralizza, tende cioè a conformarsi sempre di più al minerale.
La legge fondamentale del minerale è il determinismo, il meccanicismo: lo spirito umano tende, col materialismo, sempre di più alla meccanizzazione. Pensiamo ai computer: non rappresentano il grandioso tentativo di automatizzare i processi conoscitivi e spirituali dell’uomo? Se noi ci rappresentiamo in quale grado questa intelligenza programmata, meccanica, “infallibile”, cioè senza libertà, sta invadendo la vita quotidiana, possiamo chiederci: che cosa resterà di libero e di creativo nello spirito umano? L’intelligenza meccanizzata è davvero il risultato di una progressiva mineralizzazione dello spirito.
Questo fenomeno è anche una dimostrazione delle grandi capacità inventive dell’uomo. Non si tratta di condannare la tecnologia, ma di considerare anch’essa nella prospettiva della libertà di scelta tra l’asservire lo spirito alla legge deterministica della macchina o il servirsene per la propria ulteriore evoluzione.
Conseguenza del meccanizzarsi dello spirito è l’anima che si assopisce. Il sonno è la legge fondamentale del vegetale, la pianta è un essere “dormiente”. Quando noi dormiamo, che cosa rimane realmente nel letto? Ci sono soltanto il corpo fisico e il corpo delle forze vitali: l’anima e lo spirito se ne sono distaccati per vivere nei mondi animico-spirituali. Durante il sonno noi viviamo difatti a livello di pianta. Che cosa vuol dire allora che l’anima diventa sempre di più come una pianta? Significa che viene sempre di più resa dormiente e sognante.
E quali sono nel mondo d’oggi i sonniferi dell’anima? L’opinione comune, la televisione, i giornali: tutte le forme di delega di pensiero. Attraverso di esse viene tolta all’anima la capacità di “presenza di spirito”, di tenersi sveglia, la si mantiene assopita nella fiumana di ciò che le scorre addosso. Ma l’uomo è uomo proprio nella capacità continua di risveglio. E a che cosa può destarsi l’anima? Agli impulsi conoscitivi e amanti dello spirito. Il sonno dell’anima è la sua passività. Il risveglio dello spirito sta nel divenire interiormente attivi. Ciò che è corporeo rende l’anima sonnolenta, ciò che è spirituale la rende bella sveglia.
E in terzo luogo il corpo diventa, tramite la prassi di vita del materialismo, sempre più animale. Il culto del corporeo ci fa vivere in modo sempre più impellente gli istinti, le costrizioni delle forze di natura.
Una delle esperienze fondamentali del materialismo è la crescente impotenza dello spirito e dell’anima umani nei confronti della costituzione corporea. Se tutto ciò che nell’uomo proviene dall’istinto, dalle pulsioni naturali non viene illuminato e liberato dallo spirito, diventa sempre più prepotente, e l’essere umano avvera sempre di più il dogma materialistico della sua “animalità”.
L’attaccamento alla materia e
l’identificazione con essa
Il fenomeno del materialismo lo possiamo anche approfondire considerando il nostro rapporto col mistero della morte. Esso ci consente di evidenziare il contrasto fra l’interpretazione materialistica dell’uomo stesso e quella che ne coglie la realtà dello spirito. Il morire è la decisione dell’Io opposta a quella del nascere. Alla nascita lo spirito umano sceglie di ritornare ad abitare dentro un corpo di materia, alla morte sceglie di lasciare la fisicità per tornare nei mondi dello spirito.
Da dove provengono la profonda paura e l’avversione nei confronti della morte quando un Socrate, già 2500 anni fa – addirittura prima dell’evento del Cristo, prima di quella morte ideale che trasforma il morire in resurrezione –, diceva che la morte è il significato vero della vita?
Se non ci fosse nel nostro spirito un grande amore per l’evoluzione che è possibile soltanto sulla Terra, bisognerebbe essere angosciati quando si tratta di nascere, non quando si tratta di morire! Nascere significa infatti entrare nella materia, è la decisione di sacrificarsi, di accedere a un livello di coscienza offuscato rispetto a quando si è fuori della materia. Il materialismo ci porta invece a preferire la nascita alla morte. Se l’essere umano impara a riconoscersi come un essere spirituale, quale veramente è, accoglie con gratitudine anche l’avvicinarsi della morte.
L’attaccamento alla materia – che non ha niente a che fare col sano amore per la vita – ci porta ad identificarci col corpo, e ciò in seguito al mero appagamento dei bisogni suscitati dal mondo fisico. L’idea del dissolvimento del corpo genera allora la paura, il senso del nulla. Il materialismo è la paura della morte vista come sconfitta su tutta la linea.
Possiamo considerare anche il modo in cui il materialismo determina il nostro concetto di fedeltà nei rapporti umani. Ci porta a privilegiare, nella fedeltà, l’aspetto esterno, materiale: io ho esperienza dell’altro e vivo la sua realtà soltanto nella misura in cui egli è presente col suo corpo. Il superamento del materialismo sta nella capacità di incontrarci anche oltre il corporeo: solo così permettiamo il nascere di una nuova dimensione della fedeltà. La vera fedeltà risiede allora nel convincimento che una persona karmicamente congiunta con me non cesserà mai di esserlo. Entreranno sempre nuovi esseri umani a far parte della mia vita, del mio essere, ma nessuno che ne fa già parte può mai cessare di esserlo, perché il senso dell’evoluzione intera è di diventare tutti membri gli uni degli altri, vivendo in modo realissimo la comunione universale di tutti con tutti. È questo il compimento ultimo del karma di tutta l’umanità.
Una persona mi è congiunta in modo profondo e intimo e lo sarà sempre. Posso pensare che il dispiegarsi di questo rapporto ha attraversato secoli e forse millenni, mi convinco sempre di più che non ho una vita sola a disposizione, ma ne vivrò ancora altre in futuro. So che un legame non ha bisogno di testimoniare se stesso nel vivere sempre e unicamente la vicinanza fisica. La fedeltà, nella sua realtà più vera e profonda, sta nel volere sempre dentro di me, nel modo più forte possibile, il bene oggettivo dell’altro.
E se il bene dell’altro – cosa non sempre facile da appurare oggettivamente – dovesse consistere nel fatto che io per un certo periodo di tempo mi debba esteriormente tirare un po’ indietro perché la mia prossimità fisica non lo aiuta a crescere, o la sua non aiuta me, in che cosa consiste la fedeltà? Consiste in questo caso nel farci spazio a vicenda per quanto riguarda la vicinanza esteriore, per così attuare sempre ciò che aiuta l’altro nel suo cammino. Sarà questo un altro modo di vincere sia l’aggressività distruttrice che sorge quando ci manca la distanza necessaria nei confronti dell’altro, sia la depressione sterile che si vive quando non si coglie il compito positivo dell’assenza fisica della persona che si ama.
Astrazioni e illusioni del materialismo
Riflessioni analoghe possiamo fare anche sul nostro rapporto con la colpa e con i ben noti sensi di colpa. Il materialismo non guarda alla trasformazione interiore che avviene in un essere umano quando fa qualcosa, ma incentra l’attenzione sul risultato esterno e tangibile del suo operare. Siccome questo risultato non sempre è ciò che piace, non sempre è ciò che ci si aspetta, si parla di peccato, di colpa o di male. Identifichiamo la colpa con un risultato che differisce dalla nostra aspettativa.
Quando noi superiamo il materialismo dell’identificazione esteriore del bene e del male c’è soltanto una sola forma di colpa: è quella di avere omesso una qualche possibile evoluzione positiva del nostro essere. Il materialismo ci costringe a guardare la realtà secondo la materia, e perciò noi abbiamo bisogno di vedere il bene e il male nel risultato percepibile delle azioni. Ma il bene e il male non sono mai lì, sono sempre in ciò che avviene o non avviene nell’interiorità degli esseri umani.
Una persona ha messo dei capitali a disposizione per costruire una scuola o un ospedale: ha fatto qualcosa di bene? E chi lo sa!? Ha fatto qualcosa di materiale, di visibile, di identificabile. Che ciò sia bene o male è tutt’altra cosa. Bisognerebbe guardare a ciò che è avvenuto nella sua interiorità, bisognerebbe guardare alle sue intenzioni per sapere se è bene o se è male. Il criterio del bene e del male non può mai essere esterno: non ci sono azioni esterne per natura buone o cattive, quali il materialismo si illude di poter individuare.
L’unico criterio del bene e del male che sia a misura d’uomo è il criterio della libertà interiore. Moralmente buono è tutto ciò che rende l’essere umano sempre più libero; moralmente cattivo è tutto ciò che lo rende meno libero. Il criterio del bene e del male non sono le azioni nella loro materialità, ma è lo spirito umano nella sua libertà o non libertà.
Essendo questo criterio spirituale più complesso e del tutto individuale – perché ciò che rende un uomo più libero può fare schiavo un altro – si ripiega sul criterio più comodo del guardare alle azioni nella loro materialità. E così moraleggiamo su tutta la linea! Perché le azioni, nella loro esteriorità, non sono mai in grado di dirci se sono buone o cattive. Il superamento del materialismo grazie alla riconquista dell’interiorità costituisce per l’umanità di oggi un compito immane, sia per la conoscenza sia per la vita.
Se al volante della sua automobile, in condizioni di scarsa visibilità, una persona investe e uccide un suo caro amico, che cosa è avvenuto? Se noi crediamo che l’essenza degli eventi sia nella materialità, dovremmo rispondere: un omicidio. Se invece ci si dice che quella persona stava guidando per tornare a casa e proprio non ha visto l’amico attraversargli la strada, allora, che cosa è successo? Non certo un omicidio.
La realtà più concreta che ci sia è proprio lo spirito, sono i pensieri, le intenzioni! Il materialismo è in fondo la più grande astrazione che sia mai sorta nell’umanità. Senza lo spirito, la materia è la cosa più astratta che ci sia. La fisica stessa comincia oggi a dirci che la materia è il limite dell’esperibile umano: la cosiddetta materia è in realtà ciò che non è concretamente esperibile all’uomo. I pensieri sono sperimentabili, vivono in noi e suscitano dei sentimenti ben reali. Perciò sono concreti, perché operano realmente, fanno succedere qualcosa nel nostro essere. Ma la materia ci resta del tutto estranea. L’uomo d’oggi, in quanto materialista, vive l’illusione che la materia sia la realtà: oggettivamente egli è in questo modo l’artefice dell’astrazione, si pone fuori dalla realtà disattendendo lo spirito, che è la realtà più concreta e vivibile che ci sia nel cosmo intero. Una percezione diventa una realtà concreta solo quando il pensiero, col concetto corrispondente, mi dice che cosa è. Il superamento del materialismo è allo stesso tempo il superamento dell’astrazione per ritornare nella realtà concreta.
Lo spirito ignora se stesso, l’anima ha paura,
il corpo si disgrega – e sorge l’AIDS
Affrontare la realtà del materialismo nella prospettiva di una moderna scienza dello spirituale, porta all’approfondimento del fenomeno globale della paura. Il materialismo, ci siamo appena detti, ci fa guardare al mondo esteriore con pensieri illusori, ingannevoli, errati. Il carattere di illusione consiste appunto nel considerare la cosiddetta materia come se fosse una realtà, con la conseguenza che si è sempre meno capaci di vivere lo spirito come realtà vera. Il materialista pensa infatti: il mondo visibile è quello reale, lo spirituale è solo “pensato”, cioè tutt’altro che reale.
Che cosa ha a che fare tutto ciò con la paura? La paura sorge proprio dal non vivere più la realtà dello spirito. Quando il soprasensibile cessa di essere vissuto, l’essere umano non può far altro che avere paura. La paura della morte, per esempio, in che cosa consiste? Nel non sapere se e come si possa vivere senza materia. La paura esistenziale quotidiana – nel nostro tempo sempre più epidemica e che è l’origine più profonda di molte più malattie di quante immaginiamo – è l’effetto diretto del materialismo, che non conosce più la realtà spirituale del karma. La consapevolezza del karma, del destino, della Provvidenza che accompagna ogni nostro passo, è proprio l’opposto della paura: è la volontà cosciente del tutto positiva e ottimistica dell’Io vero che architetta i rapporti umani e tutti gli avvenimenti della vita, sempre in vista di una sua crescita in senso positivo.
La paura proviene dall’ignorare queste realtà spirituali portanti e tutte positive, e dal conseguente vivere eventi e persone come minaccia al proprio essere. Per l’Io vero non esistono minacce, esistono solo e sempre occasioni di crescita. Non ha mai paura che le cose vadano male, perché sa sempre come farle andar bene. Non ha paura di un terribile insuccesso sul piano esteriore, perché, quand’anche si verificasse, l’ha voluto liberamente e lietamente lui stesso per trasformarlo in grandi passi sulla via del cammino interiore. Non ha paura delle malattie, perché le malattie che sono venute e che verranno le ha tutte volute un Io saggio dentro di lui con l’atteggiamento di gratitudine per ciò che esse possono far sprigionare interiormente proprio grazie al loro carattere di sfida.
L’Io profondo che c’è in ognuno di noi non ha paura della solitudine, non ha paura di venire abbandonato dalla persona più cara perché sa che l’eventuale infedeltà esterna dell’altro sarà per lui un motivo in più per continuare a fargli compagnia, e restargli fedele. Solo non è colui che non riceve compagnia o attenzione, ma colui che non le sa donare. L’Io vero di ognuno sa che nell’intreccio di forze spirituali reali del karma non esiste mai la solitudine: spiritualmente siamo sempre uniti e in relazione gli uni con gli altri a tanti livelli e in infiniti modi.
L’AIDS è una malattia specifica del nostro tempo. Anche questo è un tema che meriterebbe un più ampio approfondimento. Una prospettiva metodologica fruttuosa per comprendere l’AIDS è quella di vederlo anch’esso come effetto della mentalità diffusa del materialismo.
É stato accennato al rapporto che c’è tra spirito, anima e corpo. Le cause prime vanno sempre ricercate nello spirito. La realtà animica è da un lato l’effetto di ciò che avviene nello spirito, dall’altro è la causa seconda di ciò che avviene nel corpo. La realtà del corpo è a sua volta l’effetto di ciò che avviene sia nello spirito sia nell’anima.
Il materialismo è un modo di pensare dello spirito umano, la paura è un’esperienza complessiva dell’anima, l’AIDS è una realtà preminentemente del corpo. Ciò che queste tre realtà hanno in comune (e che le rende interdipendenti a livello di causa ed effetto) è il loro carattere globale e assoluto.
Il materialista è uno spirito umano che in chiave di pensiero nega lo spirituale e rinnega così anche se stesso. Si annienta spiritualmente tramite la convinzione che lo spirito sia non-realtà. Questa autonegazione rappresenta una paralisi totale delle proprie facoltà spirituali. L’Io spirituale viene negato e viene negato il suo karma, cioè il suo campo spirituale di azione. Ciò fa sorgere nell’anima la paura: non una paura specifica o parziale, ma la paura indistinta ed esistenziale propria del nostro tempo. È una paura che a sua volta indebolisce le forze dell’anima nel loro insieme.
L’effetto finale sul corpo del nichilismo spirituale del materialismo e del vuoto animico della paura non può essere che un’inversione totale – una perversione essa pure complessiva – delle forze plasmatrici e vitali che costruiscono il corpo fisico. Ogni ricerca delle cause prime dell’AIDS nella compagine fisico-materiale di un qualsiasi virus è del tutto fuori strada. La domanda da porsi è: perché quelle stesse forze che in un uomo sano sono forze di salute vengono pervertite in forze di totale disgregazione e disfacimento?
La causa va ricercata nella duplice realtà dello spirito e dell’anima. L’autonegazione in quanto essere spirituale e il vuoto animico esistenziale devono esprimersi a livello di effetto ultimo nello sfacelo totale del corpo fisico. Il corpo fisico può venire costruito nella sua integrità organica unicamente da un essere spirituale che lo idea e lo vuole come strumento globale della propria evoluzione sulla Terra, e da un’anima che lo vive e lo ama come origine e strumento delle proprie esperienze karmiche nel mondo della materia.
Le forze dello spirito e dell’anima non sono tali che possano sorgere una volta per tutte per poi perpetuarsi grazie a una specie di automatismo, che è l’opposto della creatività dello spirito – la libertà. Esse vogliono venire riconfermate in ogni momento anche durante lo stato incarnato dello spirito umano stesso.
Il fatto che una malattia propria del nostro tempo come l’AIDS venga accompagnata da virus o microbi o bacilli specifici è solo un fatto di compresenza temporale. Il considerare l’uno come causa dell’altro è una decisione del pensiero, è un fatto di interpretazione conoscitiva dei fenomeni. I nessi fra i dati percepiti non possono essere a loro volta percezioni, possono essere solo pensieri. Il fatto che una percezione si presenti nel tempo prima di un’altra non vuol dire che deve esserne la causa. Proprio nel modo specificamente umano di causare abbiamo l’opposto: ciò che viene alla fine (lo scopo di un’azione) è la causa di ciò che nel tempo viene attuato prima come mezzo e percorso per raggiungere lo scopo prefisso.
Nel caso dell’AIDS sorge una particolare difficoltà a identificare virus concomitanti specifici proprio perché non si tratta di una malattia specifica o di tipo parziale, bensì di un’assenza generale della volontà spirituale e della gioia animica di rigenerare il corpo fisico come strumento della propria evoluzione umana sulla Terra secondo libertà. Questo vuoto animico-spirituale è la vera causa sia dei virus che dell’AIDS, in vista del quale i virus vengono voluti. Se il materialismo è la grande malattia dell’anima moderna esso è anche, stando a quanto dicevamo sulla malattia in genere, la grande provocazione a guarire ogni giorno che viene offerta all’uomo d’oggi.
Quarto capitolo
GUARIRE CON
la verità, la bellezza e la bontà
I tre elementi positivi per la salute dell’anima umana sono tre cammini interiori da sempre noti: la ricerca del vero, la creazione del bello, l’esercizio del buono. Uno dei pensieri fondamentali espressi finora è che se l’uomo fosse già perfetto in partenza, non gli rimarrebbe nulla come compito specifico della sua libertà.
La differenza tra l’uomo e l’animale consiste nel fatto che l’animale non ha la possibilità di mettersi in consonanza con il cosmo per libertà propria: lo è già in partenza, grazie al concorrere delle forze dell’istinto che sono all’opera nel suo essere. Soltanto un essere non automaticamente armonico ha la possibilità di ricreare sempre di nuovo lui stesso la propria armonia. La libertà presuppone allora in partenza una qualche “malattia”, una qualche imperfezione, affinché l’anelito alla perfezione possa essere opera propria dell’uomo, sua quotidiana conquista. Un uomo che volesse essere già del tutto “sano” non vorrebbe essere libero. Già i Greci avevano interpretato la vita come una continua terapia.
Il nascere è dunque l’inizio della grande convalescenza che è la vita stessa e che esiste per dare alla libertà l’occasione di instaurare, in forme sempre nuove, la salute quotidiana a tutti i livelli dell’essere, in tutti i campi della vita. Paradossalmente potremmo dire che una malattia del corpo sorge quando l’uomo, nella sua pretesa di comodità, si attende già bell’e fatta la salute non comprendendo che il compito di ogni giorno è quello di risanarsi, di vivere il processo vivace del diventare sani con rinnovata fantasia morale.
Quando omette l’esercizio della libertà nel suo spirito e nella sua anima l’uomo, a partire dal suo Io superiore, induce se stesso a evidenziare in modo chiaro il proprio cammino terapeutico concedendosi una malattia corporea specifica, che come tale non può venire ignorata, e che quindi gli impone di fare ciò che non è stato in grado di attuare per libero impulso. Se è vero che le conquiste della libertà non possono venirci date già precostituite, allora la vita è l’esercizio stesso della libertà, è l’attenzione dell’uomo sempre proteso verso l’edificazione della sua pienezza.
Guarire col pensiero
La prima grande forza risanatrice che è sempre a nostra disposizione è il pensare. Nell’esplicazione di questa facoltà vinciamo la solitudine che consiste nel non comprendere il nostro prossimo, nel non afferrare il senso della realtà e della vita. Ho già accennato che la solitudine non proviene mai dal fatto che gli altri lascino me da solo: essa sopraggiunge quando sono io a isolarmi dagli altri esseri perché non m’interesso a loro, oppure perché non li capisco. Vivo l’isolamento quando sono io stesso a strapparmi dalla comunione universale degli esseri. Il fatto che mi sia possibile isolarmi sta proprio a dirmi che la comunione non è scontata, ma è anch’essa una conquista quotidiana offerta alla libertà.
La terapia del pensiero, è la ricerca incessante del vero, l’anelito inarrestabile verso la verità. Nessuno può essere sano se non esercita quotidianamente la reintegrazione nella comunione universale che può avvenire unicamente attraverso il pensare. Esso coglie la verità oggettiva e intima delle cose nella quale tutti viviamo e che tutti ci avvolge. Con la forza creatrice del pensare l’uomo sa intuire spiritualmente l’essenza vera di tutti i fenomeni e di tutti gli esseri. Ogni isolamento dagli altri esseri non è che un peccato di omissione del pensiero, ed è all’origine di tante forme di malattia.
Ogni malattia è un modo diverso di “isolarsi”: un organo diventa malato quando si mette in opposizione al resto dell’organismo. Proprio perché la solitudine è l’origine di ogni tipo di malattia, il pensare, che ricostituisce la comunione con tutti gli esseri, è la panacea di ogni intervento terapeutico, è il farmaco più efficace e universale che si possa escogitare. Guarire l’uomo significa sempre aiutarlo a capire il senso positivo delle cose. Afferrando il significato della realtà, egli non ha più nulla da rifiutare o da non volere. Vede attorno a sé esseri e fenomeni che può affermare e confermare nella loro positività, perché essi tutti, a loro volta, affermano e confermano lui nella sua realtà unica e insostituibile.
Divenire sani significa essere capaci, nel pensare, di volere ogni essere e ogni evento così come sono, perché tutto ha un suo significato immanente e positivo. Divenire sani significa non voler nulla di diverso da com’è, perché si è capaci di trasformare tutto in bene trasformando ogni giorno se stessi. La fonte della salute umana è tutta racchiusa nella vivacità del pensare, che coglie la dimensione di crescita positiva di tutte le cose. La grande malattia dell’essere umano è l’ottusità mentale, il non avere domande o interessi, il non capire ciò che la vita gli offre. È depresso quando si stacca dalla comunione esuberante di tutto l’essere ed è poi costretto a reagire in modo aggressivo dando agli altri la colpa della sua stasi interiore.
Che cosa fa l’uomo in una giornata piovosa, uggiosa, quando non è possibile passeggiare in mezzo alla natura ed è obbligato a restare nella propria stanza? Può occuparsi di se stesso in quanto è un’individualità cosciente e autocosciente. A un animale non è concesso questo privilegio. Ma per non annoiarsi quando è in compagnia di se stesso bisogna che l’uomo impari a far sprigionare dalla sua interiorità mondi sempre nuovi. E questo avviene prima di tutto tramite il pensare.
L’uomo non è completamente immedesimato col divenire cosmico come l’animale che, proprio per questa immedesimazione, non ha coscienza di esservi dentro. L’uomo non solo vi è immerso consapevolmente, ma è per di più capace di discrepanza e quindi di malattia per poter vivere la terapia della libertà che ricostruisce nel ritmo di ogni giorno, e in modi sempre diversi, la comunione con tutti gli esseri.
L’uomo non può essere sano e felice lasciandosi trascinare dal divenire del mondo perché è un essere pensante, e può realizzare se stesso unicamente prendendo posizione in modo conscio di fronte ai fenomeni del mondo. Se non esercita questa somma facoltà del suo spirito si ammala, perché mortifica l’umano.
Ogni essere umano scende sulla Terra con la volontà assoluta di lavorare alla qualità della sua coscienza, alla qualità del proprio pensare. È un compito mai compiuto, ma sempre da svolgere. Proprio perché il pensare è molto impegnativo si vorrebbe poterlo sostituire con interventi più facili e immediati, che diano risultati subito; ma così facendo l’uomo passa da una delusione all’altra, perché la terapia del pensare non può essere sostituita da nessun’altra.
Parlando del pensare dobbiamo però dirci che c’è pensiero e pensiero. C’è un tipo di pensiero intellettualistico e astratto che l’umanità ha messo in primo piano negli ultimi secoli. Con esso è sorta da un lato la scienza moderna e dall’altro la tecnica, braccio destro della scienza. Questo pensiero – che ha radici tutte occidentali – ha in sé la caratteristica fondamentale di rendere l’uomo sempre più malato nell’anima perché non lo immerge nel profondo della realtà, bensì lo estrania da essa.
Lo scopo del pensiero scientifico moderno è infatti quello di padroneggiare la realtà, è quello di controllarla e sfruttarla. La scienza moderna non è sorta per conoscere amorevolmente l’essere intimo delle cose e dei fenomeni, ma per sapere che cosa se ne possa fare a proprio uso e consumo. Pensiamo all’elettricità: nessun fisico ci può dire che cosa sia, nella sua intima natura, ma tutti sappiamo come sia possibile avvalersene a proprio vantaggio.
E la Terra? La scienza moderna vuol sapere che cosa si può ricavare dalla Terra, non è interessata alla conoscenza dell’essere vero e profondo della Terra. È sorta in questo modo una scienza di soggiogamento della Terra e di tutti i suoi elementi. Anche l’ecologia è mossa essenzialmente dal timore utilitaristico che un eccessivo danneggiamento della Terra finisca per ricadere sull’uomo stesso.
Questa forma moderna di pensiero razionale e utilitaristico ha alienato l’uomo dalla natura, perché di ogni cosa lo porta a chiedersi: a che mi serve? che me ne posso fare? Ma proprio in questo consiste l’alienazione dell’uomo dalla natura. Qui è la sorgente di innumerevoli malattie che provengono dalla paura e dalla solitudine dell’uomo di fronte al mondo. Non la Terra ha lasciato solo l’uomo: è l’uomo ad essersi estraniato da lei mettendone a repentaglio la vita, e questo gli fa sempre più paura, lo rende desolato e rabbioso.
La comunione con le cose non si instaura asservendole ai propri scopi, ma quando, guardando una rosa, le chiedo: chi sei tu? col desiderio di diventare quel che lei è, col desiderio di provare nell’esperienza pensante una nuova forma di intima comunione con l’essere universale.
La grande malattia dell’uomo moderno è che brama il potere nei confronti del mondo senza essere capace di diventare lui stesso il mondo. La vera terapia sarà allora nell’esercizio della capacità creatrice del pensare, grazie alla quale l’uomo si metamorfosa intuitivamente all’infinito, entrando dentro l’essere di ogni cosa per contemplarla e viverla dal di dentro. Attraverso questa esperienza della verità e bellezza intrinseca e assoluta di ogni cosa, che consiste nella sua aspirazione a divenire sostanza spirituale del pensare umano, l’uomo si congiunge con tutti i pensieri degli Esseri divini creatori. E scopre che i loro pensieri sono divini perché sono belli e sono belli perché sono veri.
Esistono una caduta e una redenzione proprie del pensare. Esso è decaduto e decadente quando è passivo e calcolatore, quando serve soltanto a registrare e a dominare tutto ciò che è già stato creativamente pensato dagli Esseri divini. Il pensare viene redento nella misura in cui diventa creazione attiva e comunione mossa da amore. Quando il pensare da puramente scientifico diviene umanamente artistico, l’essere umano vive la sua chiamata divina ad essere un creatore. Scienza ed arte ridiventano sorelle dentro il cuore dell’uomo.
Guarire ogni giorno con l’arte
L’essere umano entra col pensiero nella bellezza intrinseca di tutte le cose e si rende conto che esse non esistono per un fine che le sopravanzi, ma che ogni cosa è per se stessa. Godere ogni cosa per se stessa, in quanto ha il suo scopo nella sua innata bellezza, è la terapia dell’arte. È il capovolgimento della tendenza a strumentalizzare le cose, atteggiamento antiartistico per eccellenza.
Quando io uso una cosa unicamente in vista dell’utile ne faccio uno strumento, non ne colgo e non ne vivo più il suo carattere intimo e sacro. Me ne servo e poi la butto via. Chi sa soltanto usare le cose per appagare i suoi bisogni è un povero bisognoso, eternamente posseduto e prigioniero delle sue brame. Chi invece cerca la comunione con le cose, gioendo della loro bellezza, fa sprigionare da sé tutti quei talenti di creazione che gli Esseri divini hanno espresso imprimendo la loro qualità di artisti sublimi a tutte le loro opere.
Artista vero è colui che si dice: le cose non sono “per me” ma sono “per se stesse”. E io sono per le cose, io sono fatto per diventare tutte le cose quali infinite espressioni del mio stesso essere divino. Nella comunione col loro intimo essere trovo la perfezione suprema sia della cosa contemplata sia del mio essere. L’esperienza artistica consiste nel non considerare nulla come strumento e nel cogliere ogni essere creato nella sua riposta bellezza, nella sua bontà intrinseca. Perché ha origine nel pensiero divino, tutto è espressione pura di creatività e di amore.
La divinizzazione dell’uomo è tutta racchiusa nella sua opera di artista che umanizza il mondo. Ogni piccola terapia va compresa come una partecipazione, come un passo sul cammino dell’uomo, che va ricostruendo l’essere di tutte le cose traendone la sostanza dal proprio amore per esse, rivivendo la creazione artistica divina che ha fatto sorgere, amandoli, tutti gli esseri della natura e che continua a regalarci infiniti colori di fiori e di tramonti.
Attraverso l’arte l’uomo celebra l’eterna resurrezione che lo fa passare da un pensare morto (quello astratto e intellettualistico) a un pensare vivente. Il pensare vivente è l’arte di tutte le arti. Anche nel nostro incontro con i colori o con i suoni o con le parole, ogni espressione artistica è una forma di creatività pensante. Alle sorgenti di ogni attività artistica c’è sempre un’intuizione creatrice che proviene da un pensare che nasce al contempo dalla mente e dal cuore, capace di coinvolgere anche gli arti perché vuole realizzarsi. È un pensiero che diventa così libero, così fertile e mobile da afferrare l’universo intero per ricrearlo in forme sempre diverse, vivendo così il modo in cui l’universo stesso feconda infinitamente l’essere umano.
C’è una bellissima conferenza di Steiner, da lui stesso in seguito pubblicata, col titolo: Goethe come padre di una nuova estetica, dove viene detto che l’artista è colui che aiuta la natura ad avverare i suoi sogni più belli e più grandi. Come? La natura vive d’infiniti esseri nei suoi tre regni delle pietre, delle piante e degli animali. Prendiamo ancora una volta la rosa a rappresentarli: che cos’è la rosa?
Noi la possiamo cogliere da due lati diversi: partendo dalla percezione sensibile e partendo dalla forza intuitiva del pensare. Goethe dice: cosa ho io quando guardo la rosa così come si presenta dal lato della percezione sensibile? Ho la rosa oppure ho una rosa? Ho semplicemente una rosa, e più tardi un’altra rosa e poi un’altra ancora... Come faccio a sapere che queste tre, quattro, cinque, duecento cose che vedo son tutte rose? Perché col pensare ho scoperto quel che è comune a tutte queste rose, nonostante ci siano moltissimi elementi di variazione (le foglie più piccole o più grandi, il colore diverso dei petali, l’altezza dello stelo...). Insomma, ci sono elementi essenziali che non devono mancare perché fanno parte dell’essenza della rosa e se mancano non ho più la rosa, e ci sono elementi accidentali, che variano da rosa a rosa, perché non fanno parte del suo essere, ma risultano dal suo rapporto con gli altri elementi del mondo.
La rosa “essenziale” non può manifestarsi senza nulla di accidentale, di effimero e fuggevole. In ciò consiste la grande malattia della natura, così intrisa di caducità che a livello visibile non può che nascere e morire sempre di nuovo, senza poter mostrare la sua vera essenza immortale, il suo essere divino e imperituro. Questa “malattia”, la natura l’ha accolta in sé, tutti i suoi esseri hanno accettato l’incantesimo nella materia come un sacrificio cosmico di amore per l’uomo. Grazie al fatto che la natura si presenta sempre in una mistura di sostanza e accidente, sorge per l’essere umano la libertà dell’artista: di ciò che è effimero gli viene offerta la percezione sensibile che gli consente di distinguere da pensatore ciò che è essenziale da ciò che è accidentale e di esprimere da artista anche l’essenza delle cose.
Il Verbo si è fatto carne, afferma l’inizio del Vangelo di Giovanni. Lo spirito creatore divino, nella sua intima essenzialità, si è intriso di accidentalità passeggera rivestendosi di materia così da offrirsi alla percezione sensibile dell’uomo e rendere possibile il guarire quotidiano che fa passare da ciò che è effimero a ciò che è eterno. Nell’esercizio dell’arte l’uomo è chiamato a liberare, a “guarire” tutte le creature, sciogliendole dall’effimero per farle risorgere in sé nella loro essenzialità divina, nel corpo risorto del suo stesso amore spirituale.
Goethe, nel suo modo di contemplare le piante, esercitava una terapia da artista nei confronti delle creature. Egli si chiedeva: perché la rosa, in Italia, dove fa più caldo, si presenta più vigorosa e con i petali e le foglie più dilatati, mentre al nord l’intera forma è più raccolta? E l’artista-scienziato sapeva rispondersi: la natura visibile non ha mai la possibilità di creare la rosa pura e semplice; non esiste in alcun luogo una rosa che presenti solo i tratti essenziali dell’idea, che sia libera di ogni elemento accidentale, perché l’essenziale della materia è l’accidentalità stessa. La vera rosa si può trovare solo nell’amore pensante e nel pensiero amante dell’artista umano-divino.
Anche Platone parlava della rosa vera come di una realtà sovrasensibile, parlava della rosa ideale, della rosa vera, in cui tutto è ancora archetipico, mentre in quella percepibile ai sensi il suo essere si offusca divenendo come un’ombra di sé. Nel momento in cui l’idea creatrice divina della rosa si intride di materia mettendosi in interazione con le sostanze del terreno, con la luce, il calore, i sali ecc., deve venire a tanti compromessi, deve subire variazioni, “accidenti”, che non fanno parte di ciò che le è essenziale.
L’essere umano che percepisce la rosa visibile dice: questa è una rosa che si presenta in un modo, quella in un altro, quell’altra in un altro ancora. Ma se questo stesso essere umano “redime” col suo pensiero la natura restaurandola nella sua purezza divina primigenia, vive come il grande terapeuta cosmico che entra in comunione intuitiva con l’essere intimo delle cose, che penetra nel cuore del mondo ripensando i pensieri degli artisti divini che hanno creato tutte le cose.
La natura anela da sempre a venire redenta dalla creazione artistica e amante dell’uomo. La creazione divina si è fatta “carne” (e con questo termine si intende tutto il corporeo) affinché il grande artista del mondo visibile che è l’uomo, la ritrasformi in un nuovo Verbo spirituale che sarà a immagine umano-divina.
Nella terapia del pensare l’uomo s’incanta nella contemplazione intuitiva e gioiosa dei pensieri divini che hanno dato vita alle cose del mondo. Nella terapia dell’arte egli disincanta il mondo incantato per amor suo davanti ai suoi occhi, gli dà una forma visibile che sia una diretta manifestazione dell’invisibile.
L’artista è dunque colui che compie la grande terapia del mondo. Egli entra con la vivacità del suo pensiero dentro la legge di forma e di metamorfosi intrinseca a tutte le cose, prende nelle sue mani tutte le forme, tutti i colori e tutti i suoni dell’universo per renderli eterni nelle sue creazioni d’arte.
Perché Michelangelo ha frantumato un primo tentativo del Mosè? L’ha guardato e ha detto: “No, questo non è ancora il Mosè: è solo un Mosè”. L’artista vuole ricreare la creazione divina ridonando a tutte le creature la loro bellezza primigenia, senza ombra di caducità. Vuol conferire al suo Mosè solo quei tratti che gli sono essenziali. “Mosè” è per lui l’essere umano sospeso tra due mondi, quello divino delle leggi eterne dell’evoluzione e quello umano troppo umano, giù in fondo alla valle col vitello d’oro, dove ci si perde in ciò che è passeggero dimenticando ciò che è eterno. L’essenza del Mosè è quella dell’uomo mediatore tra due mondi. Ci deve essere dunque, nel Mosè tutto essenziale e libero dagli accidenti, un dilaniamento interiore che cerca il risanamento, una componente d’ira, ma che sia un’ira al contempo piena di misericordia. Soltanto quando a Michelangelo è sembrato di aver messo nel marmo tutta l’essenza del Mosè, l’ha consegnato al mondo. E chiunque ancora oggi guardi questa statua dice: questo è Mosè. È l’Uomo che risana la ferita universale tra spirito e materia che riconcilia i due mondi nell’amore dell’artista umano che ama sia la Terra sia il Cielo.
L’artista vero è colui che “guarisce” tutte le cose rendendole essenziali e in questo compito di terapia universale guarisce se stesso poiché viene contagiato dalla salute divina insita in tutte le cose. Si rende conto che l’effimero ci è dato come compito della libertà, per venir conosciuto e trasfigurato artisticamente riportandolo al suo divino splendore. “Tutto l’effimero non è che un simbolo” scrive Goethe a conclusione del suo Faust.
L’artista umano è il divino terapeuta della natura perché sa vedere lo spirito in ogni cosa, sa vedere tutta la natura intrisa di verità spirituale. E la ricrea a immagine del suo spirito creatore e amante, non può guardare alcuna cosa senza vederla spiritualmente e, in quanto artista, la sua grande fortuna è di non poter concepire alcuna realtà spirituale senza volerla rendere visibile.
Artista è l’uomo veramente incarnato, perché per lui non c’è realtà spirituale vera che non sia anch’essa incarnata. L’artista non vuole nulla di puramente spirituale e non vuole nulla di puramente materiale. L’arte umana umanizza così lo spirituale incarnandolo, e guarisce la creazione materiale spiritualizzandola.
Guarire praticando la religione dell’uomo
La redenzione del pensare – che supera l’estraniazione dall’essere vero delle cose entrando in comunione con esse –, e la creazione artistica – che coglie la bellezza delle creature rivelandone in modo visibile l’irradiazione interiore –, sono le due terapie del vero e del bello, e sono così anche il sommo bene per l’uomo e per tutta la creazione. L’esperienza del vero e del bello è nello stesso tempo l’esperienza del buono. L’uomo è buono come pensatore, è buono come artista.
La scienza e l’arte sfociano nell’esperienza religiosa dell’uomo. Nella conoscenza pensante e nella creazione artistica egli fa l’esperienza religiosa più pura che vi sia, che è quella di viversi lui stesso come un essere spirituale, divinamente creatore. Goethe ha scritto un pensiero bellissimo a questo proposito: “Colui che possiede arte e scienza ha anche la religione; colui che non possiede né l’una né l’altra, pratichi almeno la religione”.
Nell’esperienza della sacralità assoluta del suo essere uomo, che in modo divino crea nel pensare e ama nell’arte, egli vive al contempo la vera religione. Se per l’uomo non è sacro l’essere umano, non troverà nulla a questo mondo che sia religioso. La religione dell’uomo è la pienezza dell’uomo stesso, tutte le cose diventano sacre e degne di venerazione nella misura in cui si trasformano, grazie alla terapia del pensare e dell’attività artistica, nella bontà religiosissima dell’uomo stesso, intessuto di sapienza e amore.
Rudolf Steiner afferma addirittura che l’essere umano è la religione di tutte le Gerarchie Arcangeliche: tutto l’operare di questi sommi Esseri celesti trova il suo compimento nel microcosmo che è l’uomo, come sintesi del macrocosmo. A nessun angelo è consentito di avere esperienza della libertà pensante, artistica e religiosa dentro il mondo della materia, dentro un corpo fisico, come è concesso all’uomo. Tutti gli Esseri spirituali si inchinano di fronte al mistero dell’uomo. Solo quando questo mistero cessa di essere per l’uomo stesso degno di venerazione, egli cerca la religione in mondi extraumani fatti di pura astrazione, puramente inventati.
La vera religione dell’uomo è la sua responsabilità morale di fronte all’unicità del suo Io, è la responsabilità morale di realizzare la propria individualità come dono d’amore dovuto a tutti gli altri uomini e a tutte le creature, in cambio di ciò che ha ricevuto per poter diventare uno spirito creatore.
Se io ometto di attuare sulla Terra l’umano che si esprime nell’unicità del mio essere, l’umanità viene impoverita perché le viene a mancare quel modo di irraggiare l’umano che può promanare soltanto da me. Se è vero che la religione complessiva degli esseri umani è l’umanità intera, è altrettanto vero che ciascuno di noi è inserito nell’organismo dell’umanità come un membro individuale con funzioni tutte proprie.
Un organismo racchiude entrambe le dimensioni, quella dell’universalità e quella dell’individualità. L’umano è un mistero di sacralità in questo duplice senso: il diventare spiritualmente membri gli uni degli altri comporta al contempo che nessun membro si “adegui” a un altro. La domanda ultima della religione allora è: chi sono io nell’umanità e nel mondo? La risposta a questa domanda non può mai venire dal di fuori. Soltanto io posso dire chi io sono e soltanto tu puoi dire chi tu sei. In questo modo ognuno di noi si vive come dimorante un tempio sacro, come un essere divino che non ammette violazioni o profanazioni dal di fuori.
Non c’è terapeuta al mondo che possa dire al suo paziente dal di fuori chi lui sia e che cosa sia chiamato a fare. Nella religione che ravvede nell’Io umano-divino di ogni uomo la realtà più sacra che ci sia, la terapia più vera e profonda è quella che ognuno compie su di sé comportandosi da essere spirituale, creatore del vero, del bello e del buono. L’uomo diviene religioso nella misura in cui diviene umano a livello del tutto individuale e unico.
Quando Pilato o il sommo sacerdote chiedono al Cristo: “Chi sei tu? Sei tu il Messia? Sei tu il re?”, la risposta non è, come troviamo nelle traduzioni, “Tu lo dici”, perché chi fa una domanda non afferma nulla. La risposta del Cristo è: “Tocca a te dirlo”. Soltanto se fai l’esperienza della tua stessa interiorità umano-divina saprai chi è l’Io Sono. Il Cristo è in ogni essere umano l’esperienza dell’Io, il Cristo in ogni uomo è la realtà unica dell’Io di ciascuno.
Chi sei tu? La domanda rivolta al Cristo è allora la domanda sull’unicità religiosissima e inviolabile di ogni essere umano. E chiedere al Cristo, all’Essere dell’Amore: chi sei tu dentro di me? vuol dire chiedere a se stessi: chi sono io nel mio essere più profondo e essenziale?
La terapia dell’Io è la guarigione quotidiana che ci viene dall’esperienza di essere un Io che pensa, che crea, che ama. Spesso ci rivolgiamo al terapeuta esterno perché ci dica lui chi siamo e che cosa dobbiamo fare. Il Cristo però, il Terapeuta vero e buono, lavora su lunghi archi di tempo; la sua terapia è quella della grande pazienza. Egli si rifiuta di sostituirsi a noi per ottenere risultati immediati e illusori, e ci rimanda amorevolmente a noi stessi. Guarisce ogni giorno solo colui che esercita quotidianamente l’arte suprema di essere Uomo, e che consiste nel guarire sempre di nuovo grazie all’esperienza della verità, della bellezza e della religione.
Torniamo alla polarità che vige tra l’esplicazione dei propri talenti e la soddisfazione dei propri bisogni. I talenti appartengono all’uomo in quanto individualità, perché ogni essere umano è unico nella costellazione delle sue facoltà creative e artistiche. La terapia della vita consiste dunque nel vivere quotidianamente e in modo sempre più autentico l’esplicarsi di tutti i talenti specifici del proprio Io. I talenti veri di una persona sono le intuizioni morali, gli ideali morali assolutamente unici che il suo Io spirituale si è riproposto di realizzare nella vita. La domanda che ogni Io umano si pone è: che cosa sono venuto a fare, questa volta, sulla Terra? Che cosa mi sono proposto, che cosa cosa vuole il mio Io vero per la sua e l’altrui evoluzione?
Dov’è, allora, la comunanza universale dell’umano se ognuno è del tutto unico? Abbiamo tutti in comune proprio l’unicità, perché siamo tutti ugualmente irripetibili! I misteri più profondi della vita si possono esprimere soltanto attraverso paradossi che, se intesi rettamente, non sono parole vuote. Guardando l’altro uomo io so che è un’individualità unica al pari di me. Solo lui può pronunciare dall’interiorità del suo tempio sacro la parola “Io”, la sola che acquista un significato del tutto diverso a seconda di chi la pronuncia. A Mosè la divinità rivelò il suo nome segreto, solo da lei pronunciabile, dicendo: “Io sono ‘Io’!”. La religione dell’uomo è tutta racchiusa nella venerazione del mistero umano-divino dell’Io di ogni uomo.
Questa venerazione riconosce all’altro uomo non soltanto il diritto di essere l’individualità unica che è, ma anche il dovere di attuarla nel contesto dell’organismo dell’umanità e della creazione, perché ciò che egli è divenuto lo deve all’organismo globale dell’umanità. Essere un’individualità unica non è soltanto un diritto, ma è anche il dovere morale più grande che ci sia. Il mio “dovere” è ciò che io “devo” a tutta l’umanità. E ciò che devo all’umanità è proprio il mio essere individuale e unico che da essa ho ricevuto. La somma del dovuto che ogni essere umano ha da rendere all’umanità è proprio la realizzazione della sua unicità.
La terapia del vero è comune a tutti noi, lì viviamo la dimensione della comunione universale: l’essere non effimero della rosa è lo stesso per tutti. La terapia del buono, invece, la terapia della religione, è il quotidiano guarire grazie alla realizzazione della propria individualità umana.
La grande malattia che viene guarita attraverso la comunione nell’oggettività del vero è la solitudine che porta alla depressione. La grande malattia che si vince nella terapia del buono, è l’aggressività, perché l’essere umano diventa aggressivo quando non riesce ad essere se stesso.
Io divento aggressivo quando non concedo agli altri di essere del tutto diversi da me, e ciò come conseguenza del fatto che non ho ancora trovato e amato me stesso, in quanto diverso da tutti gli altri. L’aggressività sorge sempre da una qualche negazione dell’individualità unica di ciascuno. Quando io comprendo che non soltanto è legittimo, ma che è addirittura il senso di tutta l’evoluzione quello di rendere ogni essere umano del tutto individuale, così da riverberare su tutti gli altri esseri un raggio unico dell’umano, cessa in me l’aggressività. L’aggressività è sempre il tentativo di volere gli altri diversi da come sono, perché noi stessi non sappiamo essere sufficientemente diversi dagli altri, non siamo del tutto noi stessi. Chi vive con gioia la propria identità individuale è d’accordo con tutti, non ha bisogno di aggredire nessuno perché ama al contempo la diversità e l’unicità di ogni altro.
La terapia universale della libertà e dell’amore
La polarità che esiste tra l’esplicare i nostri talenti e il venire incontro ai bisogni degli altri si esprime nel rapporto che c’è tra libertà e amore. La duplice terapia della libertà e dell’amore è proprio ciò che hanno in comune le vie del vero, del bello e del buono.
Il cammino del pensare vivente è pura esperienza di libertà, perché il pensiero vuol essere sempre vivace, sempre in movimento di creazione. Ed è pura esperienza di amore, perché non c’è amore più grande che diventare – grazie all’intuizione pensante – spiritualmente una cosa sola con la cosa conosciuta. L’intuizione del pensiero è la forma suprema dell’amore perché è pura comunione spirituale. Tommaso d’Aquino, rifacendosi ad Aristotele, afferma: il conoscente nell’atto del conoscere e il conosciuto nell’atto di venir conosciuto sono una cosa sola. Comunione più profonda di questa, amore più vero di questo non ci possono essere. E Steiner già da giovane scrive: il cogliere l’idea dentro alla realtà è la comunione vera dell’uomo.
Anche la grande terapia dell’arte è intrisa di libertà e di amore. Libera il creato dall’incantamento delle forme effimere perché, amandone la bellezza, ne vede lo splendore essenziale ed eterno. Le forze più profonde dell’amore riconciliano grazie all’arte ciò che giunge all’uomo da fuori (le percezioni, premessa del pensare) con ciò che l’uomo artefice-artista riconsegna al mondo col sigillo della sua esperienza morale. L’arte porta calore al vero universale perché lo incarna nell’opera d’arte che trasfigura tutto il creato.
Libertà e amore nella terapia del buono e del religioso, lo abbiamo visto or ora, si esprimono nella responsabilità nei confronti dell’ “individualismo etico” di cui parla la Filosofia della Libertà di Steiner. Esso affida all’Io vero, spirituale di ognuno la gestione di sé, nella gratitudine che fa risorgere a vita sia l’Umanità smembrata che la creazione incantata.
Ogni malattia è una forma di mancanza di libertà e di amore. Riferendo questa polarità al mistero dei talenti e dei bisogni, risalta l’infinita ricchezza delle relazioni umane. Da un lato ognuno vive la terapia quotidiana della libertà nella gioia di esplicare i propri talenti, dall’altro vive la terapia quotidiana dell’amore altrui, che gli consente di appagare i propri bisogni. Guarire ogni giorno facendo l’esperienza della libertà e dell’amore: è questa l’arte suprema della vita.
Veniamo ricondotti al simbolo centrale dell’organismo, quanto mai denso di significato. Il miracolo d’arte fatto di sapiente verità e di religiosa bontà che si esprime in ogni organismo vivente è dovuto all’esplicazione delle capacità intrinseche e specifiche di ogni organo. Il cuore va incontro ai bisogni di tutti gli altri membri soltanto essendo, nel modo più schietto possibile in un modo purissimo, cuore.
Causa di malattia è il guardare ai propri talenti dimenticando i bisogni degli altri; oppure il guardare ai bisogni degli altri dimenticando i propri talenti. Quando uno vuol esplicare i propri talenti senza curarsi dei bisogni degli altri, sorge l’illusione dell’egoismo. E quando crede di realizzarsi unicamente appagando i bisogni degli altri senza curare i suoi talenti, sorge l’illusione dell’egoismo-altruismo, che è poi un’altra forma di egoismo.
Consideriamo l’esempio di una mamma. L’essere mamma comporta una serie infinita di talenti, di capacità, di attitudini che non sono solo di carattere generale – uguali in tutte le mamme – ma che hanno infiniti risvolti individuali in ogni singola mamma. Come fa una madre a sapere se sta esplicando veramente e bene i suoi individualissimi talenti? Il criterio è la realtà complessa dei suoi figli con tutti i loro specifici bisogni. Si è scelta karmicamente proprio quei figli che in tutti i loro individualissimi bisogni le portano incontro esattamente ciò che stimola in lei l’attivazione dei suoi talenti individuali. Qui si vede che le norme morali generali del passato non bastano più, proprio perché non contengono ciò che è individuale. E si vede anche quanto complesso divenga il discernimento sul da farsi quando si cominci a prendere sul serio la realtà del tutto individuale di ognuno.
Se per leggere in modo giusto la natura dei miei talenti devo fare attenzione ai bisogni delle persone congiunte con me, – e se per leggere in un modo giusto quali bisogni mi interpellino veramente devo conoscere bene i miei talenti –, allora devo dire: il criterio della libertà è l’amore, e il criterio dell’amore è la libertà. Le malattie sorgono perché si cerca la libertà dimenticando l’amore o l’amore dimenticando la libertà.
Ognuno di noi ha il compito della libertà, che è quello di realizzare se stesso e il compito dell’amore, che è quello di aiutare l’altro a realizzarsi. Guarire ogni giorno vuol dire vivere in libertà e con l’amore. L’intento terapeutico di esprimere i miei talenti è l’esercizio della libertà, l’intento terapeutico di appagare i bisogni degli altri è l’esercizio dell’amore.
Il corpo è la sfera dei bisogni e l’appagamento dei bisogni è la condizione necessaria; lo spirito è la sfera dei talenti, è la sfera dell’Io. L’arte della vita è quella di mettere sempre in nuova corrispondenza la sfera dei bisogni degli altri, che è la religione dell’amore, e la sfera dei talenti propri, che è la verità della libertà di ogni uomo.
La verità somma e totale dell’uomo è l’Uomo. Il bello sommo e complessivo dell’uomo è l’Uomo. Il buono, la religione universale dell’uomo, è l’Uomo. L’arte di guarire ogni giorno è l’arte di diventare sempre più umani, sempre più capaci di libertà e di amore.
DIBATTITO dal primo Capitolo
“La malattia:
un invito a inventarsi la guarigione”
Intervento: In merito al tema generale delle conferenze dal momento che si è parlato della positività della malattia, mi chiedo in riferimento a che cosa possa essere immaginaria una malattia.
Archiati: Le malattie dell’anima e quelle dello spirito (nel senso che l’attività disordinata dell’anima soverchia e impedisce l’attività dello spirito) diventano oggi sempre più numerose e gravi, mentre l’intervento terapeutico tende a limitarsi al corpo. E finché una malattia non si manifesta con evidenti ripercussioni sul fisico non è ritenuta reale.
In secondo luogo abbiamo sempre più malattie che sono manifestazioni di ciò che abbiamo chiamato il “senso del vuoto”. Perciò molti si chiedono: sono malattie vere, con una base reale corporea, o sono puramente immaginarie?
Intervento: Perché vedere in chiave negativa l’insorgere di queste nuove malattie? Grazie alla medicina tradizionale sono diminuite le malattie fisiche e molte sono state debellate: questo ha permesso il manifestarsi del senso di vuoto che, a sua volta, ha consentito l’apparire delle malattie che chiamiamo dell’anima e che immettono in nuovi processi.
Archiati: Lei ha ragione. Il termine “immaginario” può venire frainteso. Non perché le malattie psichiche aumentano – dovendo in parte “sostituire” quelle corporee che scompaiono – sono meno reali e concrete di quelle fisiche. Esse sono tutt’altro che immaginarie. Anzi, come dice lei, hanno un carattere tutto positivo, perché stanno a dimostrare che il difficile compito a cui è chiamato oggi l’uomo è il lavoro diretto sull’anima e sullo spirito. Ci si può chiedere: quali passi evolutivi positivi ci vengono offerti grazie al fatto che la vita stessa ci mette nelle condizioni di non fissarci più esclusivamente sul corpo? L’intento delle considerazioni esposte a proposito della scomparsa di molte malattie fisiche mirava proprio a mostrare che, evolutivamente, è riduttivo e illusorio interpretare le conquiste della scienza in sé e per sé come puro progresso.
Intervento: In un’epoca come la nostra in cui la malattia fisica (se escludiamo i fenomeni macroscopici dell’AIDS e del cancro) ha perso il valore di ineluttabilità che poteva avere ancora cent’anni fa, anche la malattia psicologica può dunque offrire un contributo evolutivo all’individualità che la vive?
Archiati: Certo. Chiediamoci a questo proposito: in che cosa consiste l’infanzia? Tra le altre cose, consiste nel non avere ancora la capacità di occuparsi a livello cosciente della totalità di se stessi. Lo spirito umano, nella sua fase di “bambino”, deve impiegare tutte le sue forze a costruire la corporeità. L’operare direttamente sul corpo quando non è in ordine corrisponde a uno stadio infantile della terapia, e l’umanità è uscita da questo stadio. Prendere atto dei fenomeni animici e di quelli spirituali è il processo evolutivo in base al quale diventiamo sempre più adulti.
Le cose, inoltre, si mostrano via via più complesse perché ci rendiamo conto che il corporeo è sempre effetto: può avere un carattere di concausa o di causa in senso riflesso, ma non è mai primo impulso di causa. Non voglio con ciò dire che le malattie corporee scompariranno: intendo dire che nella misura in cui si disattende il cammino dell’anima e dello spirito, sorgeranno malattie corporee di cui noi non conosceremo la causa. Qui è il mistero dell’AIDS, per esempio: da dove viene? Se cerchiamo cause prettamente materiali per spiegare l’AIDS, non ne verremo a capo. Siamo costretti a rivolgerci a fattori dell’anima e dello spirito.
Una domanda ulteriore da porci mi sembra questa: qual è la destinazione ultima del corporeo? È la sua spiritualizzazione. Un corpo spiritualizzato non è più in opposizione alle leggi dello spirito e dell’anima. Le Scritture Sacre cristiane ne parlano col termine tecnico di “risurrezione della carne”. La caduta dell’umanità, il distacco dalla matrice comune spirituale chiamata paradiso terrestre, è consistita nell’entrare in una realtà corporea che oppone resistenza all’evoluzione dell’anima e dello spirito. Ma se questa resistenza non ci fosse, non ci sarebbe la possibilità della libertà in quanto continua liberazione dal non libero. Non ci sarebbe nulla da fare. Il cosiddetto peccato originale è dunque la malattia evolutiva che ci riguarda tutti, voluta proprio per darci la possibilità di guarire nel corso dell’intera evoluzione.
Il bello dell’epoca evolutiva in cui ci troviamo non è allora il corpo già spiritualizzato – perché in quel caso il cammino sarebbe compiuto e si tratterebbe di cominciarne un altro – ma è la graduale e per ora appena incipiente spiritualizzazione del corpo, in quanto processo tuttora in corso. Il nostro livello evolutivo presuppone un corpo che abbia sempre qualcosa da spiritualizzare: quindi sempre un nuovo dato di malattia, di ostacolo, di refrattarietà che ci chiami continuamente all’esercizio della nostra libertà. E ciò che conta è l’esercizio rinnovato della libertà, non la libertà già esercitata ieri.
Intervento: Stiamo dicendo che la causa prima della malattia è nello spirito e ne troviamo gli effetti nell’anima e poi nel corpo. Io voglio qui precisare che lo spirito “organizza” la malattia, ma non ne è la causa, nel senso che lo spirito non può ammalarsi. La malattia è dell’anima.
Archiati: Ciò che lei dice concorda con ciò che io ho esposto. La malattia sorge sia in base alle conquiste che lo spirito vuole compiere, sia in base alle conquiste che lo spirito ha tralasciato di compiere. Queste sono le due possibilità fondamentali: nel secondo caso c’è stata un’omissione, che ora si tratta di recuperare, e come incentivo lo spirito umano si sceglie liberamente una condizione corporea difficile. Nel primo caso, invece, pur non partendo da un’omissione passata, l’uomo si confronta ugualmente con ostacoli, forse anche più difficili, per compiere ulteriori passi. In entrambi i casi è sempre lo spirito a “volere” e il voluto è sempre il positivo. Quando io dico: lo spirito è causa della malattia, intendo affermare che è lo spirito a volere e a scegliere l’occasione che proviene dalla difficoltà. Ogni malattia è una sfida voluta dallo spirito e in questo senso da esso “causata”.
Intervento: Però la malattia sorge nell’anima. La “tentazione” l’abbiamo subita nell’anima, non nello spirito.
Archiati: Certo. L’anima è sentimento. É l’anima che sente e vive il vuoto di ciò che l’uomo, nella sua libertà, ha omesso. È l’anima che sente il desiderio verso ciò che lo spirito si propone di conseguire. Ma non è l’anima l’ambito vero e proprio della libertà, bensì lo spirito. Nello spirito ci sono le grandi omissioni e anche le grandi volontà. L’anima è l’organo che vive e sente sia quel che avviene nel corpo, sia quel che compie lo spirito, ma non origina nulla. Ciò riconduce all’importanza della distinzione fatta tra anima e spirito.
Intervento:1 Riflettevo sul problema da lei posto riguardo all’isolamento nelle case di cura. Questa soluzione non può essere vista anche in un modo positivo considerando che la persona aveva bisogno proprio di una situazione difficile, negativa, priva di collegamenti, per riuscire a conseguire qualcosa di positivo per se stessa?
Intervento: Molti ragazzi drogati, tolti dall’ambiente di famiglia e messi in una comunità guariscono. Sono stati separati dal loro contesto di vita e messi in un altro, ma mi sembra che in sostanza abbia fatto loro bene.
Intervento: Anch’io mi sono chiesto se, nel caso di quel malato preso e portato in una casa di cura, questo stesso fatto non potesse esser parte del suo destino e come tale da intendersi positivamente. Avevo poi pensato alle persone che si ritirano, si isolano volontariamente per dedicarsi allo spirito: la clausura, l’oriente con i monaci tibetani o zen...
Archiati: Il quesito importante è se questo mutamento di contesto esistenziale sia ciò che l’Io vero vuole, oppure no. L’Io superiore può anche non volere un mutamento di ambiente bensì, al contrario, un mutamento del proprio comportamento nello stesso ambiente che la vita gli ha portato incontro, un processo possibile soltanto se vi si resta dentro.
Senz’altro, in un caso specifico individuale, può far parte del compito esistenziale di una persona il doversi allontanare per un certo periodo di tempo dall’ambito consueto: l’affermazione non è che questo spostarsi sia sempre contro il karma. Le mie riflessioni non intendevano dire che andare in una casa di cura o in una comunità terapeutica sia sempre la cosa sbagliata. Intendevano sottolineare il fatto, importantissimo, che molti oggi considerano l’anima una realtà conchiusa e a sé stante, con confini che la separano dal mondo circostante. Ignorano che la realtà oggettiva dello spirito si manifesta nei nessi karmici, esistenziali, reali e oggettivi, come è reale e oggettivo tutto ciò che è spirito. Il compito evolutivo dei nostri tempi è quello di generare forze tali da non aver bisogno di uscire dal proprio karma.
Prendiamo un caso concreto: una madre (o un padre) con bambini piccoli vuole lasciare la famiglia. Possiamo chiederci: e se fosse nel karma di questa mamma l’andarsene? Chi è in grado di dire che non lo possa essere? Resta il lato oggettivo che nei confronti dei suoi figli c’è una responsabilità karmica ben precisa. Affermare che forse questi bambini sono scesi sulla Terra con l’intento di non volere più la mamma a partire dai due anni di vita in poi, è semplicistico, significa rendersi comodo un compito molto complesso.
Le cose vanno in senso ideale se la madre (o il padre) non ha bisogno di fuggire dal contesto familiare; ma se non è capace di farne a meno, lo faccia. Non si tratta di moraleggiare sindacando se sia bene o male. Vorrei sottolineare la parola “bisogno”: un conto è se una madre va via perché è un suo bisogno, perché non può farne a meno – e quindi non è libera, ma costretta e spinta – , un altro conto è se va via perché deve, per qualche motivo. Questo dovere lo può volere liberamente. La non libertà è sempre contro il karma. Più una persona diventa matura e meno si tira fuori dal karma, dalle condizioni esistenziali in cui si trova. Non ha bisogno di cambiare la situazione esterna perché sa di trovare nel suo quotidiano tutti i compiti migliori, e lì parla il suo karma.
Intervento: Che senso ha il carattere degenerativo di ogni malattia rispetto al corpo? Se lo spirito deve progredire, perché va a intaccare proprio il suo strumento terreno?
Archiati: Partirei da un ampliamento della sua domanda: perché l’essere umano edifica la corporeità? Qual è lo scopo? L’essere umano costruisce la corporeità in vista di ciò che si ripromette di fare e di divenire consumandola. Tutto ciò che è animico e spirituale può venir vissuto unicamente logorando il corpo. Il pensare libero, cosciente, quintessenza della libertà che noi esperiamo sulla Terra, come è reso possibile? Noi possiamo pensare soltanto distruggendo materia neuro-sensoriale e perciò abbiamo bisogno, nell’arco di un giorno, di un certo numero di ore di sonno in cui tutti i processi di coscienza vengano sospesi per dare la possibilità al fisiologico-vitale di rigenerarsi. Durante il sonno la coscienza sparisce e perciò non viene consumato l’organismo, che ha così la possibilità di ricostituirsi. A quale scopo? Per darci la possibilità di esplicare durante il giorno l’animico-spirituale, consumando di nuovo il corporeo.
L’evoluzione geologica – nella triplice corporeità minerale, vegetale e animale che è base della corporeità umana – fino alla sua metà è stata vitale in modo ascendente, così come nella prima metà della nostra vita (che ripete in piccolo la totalità dell’evoluzione) prevalgono le energie di crescita. Che cosa significa che a un certo punto la curva s’inverte? Significa che il corpo è stato costruito, costruito, costruito... al fine di dar luogo a un’evoluzione di tipo spirituale che può avvenire solo consumandolo.
Tutti i fenomeni attuali di radioattività erano impossibili prima della svolta geologica evolutiva della Terra che ebbe luogo già molti millenni fa. Da allora la Terra ha cominciato a sgretolarsi, e noi viviamo oggi su un pianeta che è in fase di disgregamento, così come una corporeità umana a quaranta, quarantacinque anni è già nella fase di decadimento. La scelta della libertà consiste nell’avvalersi della polverizzazione di tutta la materia per far sprigionare una “radioattività spirituale”, cioè un pensare e un amare sempre più spiritualizzati; l’alternativa è omettere questo compito. Ma la polverizzazione della materia è comunque in atto, è un evento di natura necessario, voluto da Esseri superiori per l’evoluzione umana e non è reversibile. “I cieli e la Terra scompariranno: le mie parole non scompariranno” è un’affermazione fondamentale del Vangelo. E sorgeranno un Cielo spiritualizzato e una Terra spiritualizzata.
Si potrebbe qui porre la domanda: che cosa vuol dire per una persona di sessant’anni o addirittura di settanta desiderare una corporeità giovane, da trentenne? Significa in fondo che non vuole il cammino dello spirito. La corporeità deve essere fiorente a vent’anni, non a sessanta o a settanta. Se potesse essere fiorente a settant’anni, sarebbe stata creata come fine a se stessa, non come strumento dell’evoluzione dello spirito.
Dire che la corporeità viene edificata per poi poterla distruggere, è come dire che nasciamo per morire! Non è assurdo? Se nasciamo per morire tanto varrebbe non nascere, no? Ma chiediamoci: perché riempiamo d’acqua un bicchiere? Per vuotarlo. Non è assurdo fare qualcosa per poi fare il contrario? No, perché se il bicchiere è già vuoto non posso vuotarlo: solo se lo riempio posso vuotarlo. Così costruisco la corporeità per consumarla, ma non posso consumarla se non c’è. L’evoluzione dello spirito umano è possibile solo nel logorio della corporeità. Il materialismo odierno, invece, consiste nell’adorazione del corporeo come vitello d’oro, come idolo che esaurisce ogni tensione umana. L’essenza del materialismo è, paradossalmente, proprio il disprezzo della materia, perché la svuota della sua dignità vera, che è quella di essere strumento per l’evoluzione dello spirito.
Intervento: Si è parlato dell’insofferenza come atteggiamento comune dell’uomo moderno nei confronti della malattia. È forse l’insofferenza stessa una malattia dell’anima, intesa come rifiuto dell’incarnazione? Possiamo approfondire questo tema?
Archiati: La parola italiana “insofferenza” è una bellissima trovata del genio della lingua. Esprime l’avversione profonda e di principio contro ogni tipo di sofferenza. Se vogliamo analizzare un po’ più da vicino questo fenomeno tipico del materialismo, dobbiamo individuarne l’aspetto conoscitivo nel pensiero, il vissuto animico nel sentimento, e ciò che da essi si traduce come comportamento di vita.
L’insofferente, a livello di pensiero, parte dal presupposto che ogni sofferenza sia un male. Meglio sarebbe secondo lui se non vi fosse nessuna sofferenza. Questo modo di pensare può diventare così automatico che l’insofferente non se ne rende più nemmeno conto.
Non accorgendosi di questo fondamento errato di pensiero, vive ancora più intensamente la ribellione animica contro ogni sofferenza. Vedendo la sofferenza unicamente in chiave negativa, per esempio di castigo per mali commessi nel passato, non riesce a ritenersi così malvagio da averla “meritata” in dose così massiccia. Si adonta e si sdegna come colui al quale continuamente venga fatto un torto. In questo modo si esaspera di fronte a ogni minima sofferenza e così la ingrandisce. Soffre perciò di più rispetto a colui che accoglie con gratitudine le prove della vita, sapendo che ogni dolore può essere un’occasione di crescita interiore.
Infine, in chiave volitiva, l’insofferente vuole due cose: evitare ogni sofferenza, e quando non è possibile sbarazzarsene al più presto. Questo assillo volitivo, proprio nella sua assurdità, gli fa sprecare molte più energie di quanto sospetti. Non si rende conto, per esempio, che proprio la sua insofferenza lo porta a infastidirsi di molte più cose di quanto non accada a un’altra persona che accoglie di buon grado i tanti inconvenienti della vita. Tende a esasperare ogni situazione e così esaspera se stesso.
Prendiamo due persone che al mattino ordinino un caffè in un bar ed entrambe constatino che non è proprio il migliore. L’una lo beve in pace e l’altra smania, reclama, se ne fa portare un altro che poi è più o meno come il primo. Lo sdegno aumenta. Per questa seconda persona la giornata comincia proprio storta... È ben chiaro che soffre più dell’altra, e ciò proprio a causa della sua insofferenza. Ciò non vuol dire che la cosa giusta sia sempre l’acquiescere e il non dir nulla. Il rimedio a un estremo non è mai l’altro estremo. Né qui si vogliono dare facili ricette di comportamento, bensì si tratta di mostrare che tutto promana dall’atteggiamento conoscitivo, dalla valutazione implicita che una persona fa nei confronti della sofferenza in quanto tale. I moti dell’animo e i risvolti comportamentali ne sono la conseguenza.
Intervento: Io ho qualche perplessità su quanto lei diceva in tema di rapporti tra cammino spirituale e legami familiari. Penso a La Mère (Mirra Alfassa Richard) che agli inizi di questo secolo lasciò marito e figli per andare a vivere con Aurobindo e fondò una comunità. Più in generale, anche il Vangelo dice: “Se uno viene a me e non lascia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita non può essere mio discepolo”. A me sembra che il cammino spirituale cominci proprio in senso opposto a quello dei legami familiari, che sono una cosa molto bella, molto umana, ma la cui valorizzazione all’interno di un discorso spirituale mi sembra un artificio dialettico.
Archiati: Il significato fondamentale della frase del Vangelo che lei ha citato è che ogni essere umano nasce in un contesto di sangue (che ai tempi degli eventi di Palestina si riferiva non solo alla parentela più diretta, ma all’intero popolo ebraico) e che questo contesto, proprio perché non è libero, va superato nel corso della vita. Non è previsto nel progetto di vita di nessuna persona di restare del tutto attaccata al padre o alla madre ancora a trent’anni, a quarant’anni, così da non dischiudersi un’area autonoma di autorealizzazione di carattere individuale. È invece nel percorso esistenziale di ciascuno attuare la propria fisionomia unica affrancandosi da tutto ciò che lo determina dall’esterno.
L’esempio che io prima ho portato è opposto a quello che lei ci ha dato: non era il caso del figlio che lascia i genitori, ma del genitore che lascia il figlio piccolo, e ho sottolineato piccolo. I due fenomeni sono polarmente opposti nel senso che, per quanto riguarda la libertà dell’io normale, i genitori vengono dati col compito di affrancarsene e i figli vengono voluti dall’Io vero con l’intento di svolgere nei loro confronti un compito karmico ben preciso. Questa è però la regola, che può senz’altro contemplare eccezioni. Ma se facciamo dell’eccezione un principio veniamo a svuotare del suo significato esistenziale la decisione di diventare genitore. Se l’essere genitore non è voluto dall’Io superiore, perché allora cominciare soltanto a esserlo per poi smettere?
Con questo non voglio assolutizzare l’esempio dicendo che in nessun caso o in tutti i casi ciò sia contro il karma. Ci possono essere situazioni in cui lasciare i propri bambini piccoli non è contro il karma, cioè contro la volontà dell’Io superiore. Intendevo dire che ciò che è essenziale è il rendersi conto che ci si trova in un contesto esistenziale cercato e che lo si sta cambiando. Se io sono convinto che cambiare il contesto di vita ottemperi nel modo migliore il mio compito evolutivo, benissimo: ma devo sapere che questo è un evento di grande importanza e responsabilità.
Se, come dicevo poc’anzi, un’individualità sta cercando fra mille difficoltà di trovare il modo giusto di porsi in relazione con le persone che le sono karmicamente congiunte, non è che sia necessariamente sbagliato darle un mese di cure, magari in montagna; il fatto è che dopo questo mese il compito è tutto da affrontare. Il compito non è stato svolto passando un mese in montagna: lì, forse, glielo auguriamo, quell’essere umano si è rigenerato fisicamente, cosa importantissima; forse ha preso la dovuta distanza anche psicologica dai fenomeni e ora può valutarli con maggiore oggettività. Ma il compito di portare armonia nei suoi rapporti esistenziali resta, e non può risolverlo tirandosi fuori da essi. Questo è il punto fondamentale.
Possiamo porre la domanda anche in un altro modo – ma badi bene che nulla vale in senso assoluto –: in via di regola la cosa voluta dal karma è di risolvere i compiti che mi vengono posti restando là dove ci sono, o di andar via? Se, come regola, la cosa giusta fosse di andar via allora sarebbe una contraddizione il fatto che l’uomo si ponga in una situazione che non lo riguarda tanto da doverla abbandonare. Il suo Io superiore ne avrebbe scelta direttamente un’altra.
Però la sua domanda ha un altro aspetto fondamentale che ci induce a una considerazione più ampia. Quando una persona vuole cambiare ambiente o vita può avere due motivi fondamentali: uno è quello negativo del farla finita con insopportabili condizioni d’esistenza e liberarsene; l’altro è quello positivo: qualcosa di nuovo, un nuovo compito, la chiama. Se questo secondo motivo prevale decisamente in quanto l’intento non è quello di evadere fattori pesanti ma di andare verso qualcosa di positivo che chiama, allora è possibile che si operi in direzione del karma.
Da che mondo è mondo è stato detto: quando i tuoi motivi per cambiare sono determinati dalla negatività della situazione in cui sei, aspetta, perché allontanandoti tu rimarresti lo stesso e porteresti tutti i problemi che tu sei – non che hai, che sei – nella nuova situazione. Se invece il motivo è tutto positivo, allora può trattarsi di una “chiamata” ad attuare i tuoi talenti. E se si tratti dell’uno o dell’altro caso lo può sapere soltanto la persona in questione. Non si tratta di fare del moralismo da fuori dicendo: tu stai tentando di scappare. Anche nel caso di un rapporto coniugale o di relazione profonda, laddove sorga la decisione di cambiare, se il motivo decisivo sono le difficoltà del rapporto esistente, la decisione sarà sempre “sbagliata” perché si scappa via con esse. Ciò non vuol dire che la decisione “sbagliata” sia sempre evitabile. Ognuno impara dai propri sbagli inevitabili.
DIBATTITO dal secondo Capitolo
“Aggressività e depressività:
l’altalena della vita”
Intervento: Lei ha caratterizzato l’aggressività e la depressione come occasioni da non perdere per progredire. Riferendosi in particolare alla depressione, lei ha parlato abbastanza a lungo dell’atteggiamento di chi accompagna come terapeuta o come amico. Io vorrei ascoltare qualcosa di più sull’atteggiamento della persona depressa. Che cosa può fare praticamente affinché questa esperienza non passi inutilmente, come può renderla valida per se stessa?
Archiati: Ho sottolineato il ruolo delle persone che accompagnano il depresso – terapeuta, amici, parenti – perché egli, proprio in quanto depresso, è particolarmente dipendente dalle forze positive che gli altri gli portano incontro. La depressione è infatti la carenza della visione positiva della vita, che va perciò maggiormente ricevuta in dono dagli altri. Chi accompagna il depresso siamo tutti noi, perché ognuno di noi ha sempre accanto a sé persone che vivono fasi depressive della vita.
I pensieri davvero trasformanti nella fase vera e propria della depressione sono, per quanto riguarda il depresso, i pensieri che lui stesso ha pensato prima di entrarci dentro. Se quei pensieri già prevedevano e affermavano la depressione come fattore evolutivo positivo, non dispererà mai. Vediamo qui l’importanza di riconoscere, su tutta la linea, la forza evolutiva della depressione come una delle due grandi polarità necessarie al dinamismo della vita. In altre parole, decisivo per la fase depressiva vera e propria è il convincimento che anche questo fenomeno ha un senso positivo. Però questo pensiero riuscirà a pensarlo durante la fase depressiva solo colui che l’ha elaborato prima, quando era maggiormente aggressivo. E proprio questo fa sì che la fase depressiva possa evolvere nella direzione della fiducia e della speranza.
Intervento Fermo restando che queste fasi alterne, in dose più o meno pesante, fanno parte della vita di tutti, io evidenzierei, come polare alla depressione, anche l’euforia. A me pare che il depresso passi da momenti di sconforto a momenti in cui vive un’ebollizione che non ha l’aria di essere del tutto equilibrata o sana.
Archiati: Si tratta di intendersi anche sulla terminologia. Così come suona nella lingua italiana, “euforia” ha la caratteristica della brevità: un’euforia non può mai durare due anni e può essere polare, magari, a un improvviso spavento superato, a una forte preoccupazione risolta... L’euforia è a breve scadenza, come lo è il suo contrappeso. Invece la fase maniacale che porta alla depressione può essere molto più lunga, come molto più lungo è il cammino verso un recupero dell’aggressività. È insito nella legge di ogni polarità che le sfumature del polare siano infinite e si corrispondano nell’intensità.
Una forma particolarmente forte di aggressività è la violenza vera e propria, mentre una forte depressione approda nel panico, alla paura esistenziale indistinta. Ma anche portando i due fenomeni polari all’oscillazione massima, la legge della polarità non cambia: bisogna avere il coraggio di pensare le cose fino in fondo. La profonda paura esistenziale è una fase depressiva più forte perché il vuoto è più profondo e toglie quasi il fiato; così come l’aggressività che diventa violenza è una compulsione interiore più difficile da dominare e più lunga nel tempo.
Se ci fossimo riferiti fin dal principio alla violenza e alla paura per sviluppare questo tema delle oscillazioni animiche, il compito sarebbe stato un po’ più arduo, perché sottolineando i forti estremi è meno facile cogliere la dinamica più temperata, e perciò quotidiana, dell’atteggiamento aggressivo e di quello depressivo che si richiamano a vicenda. Ma la legge della polarità rimane tale e quale. Io ho inteso enucleare il dinamismo sempre in atto dell’interazione tra i poli, perché questa è la vita. Mi premeva il superamento del moralismo tradizionale della nostra cultura che tende a vedere in negativo sia l’aggressività sia la depressione.
Intervento: Si è detto che sono importanti i pensieri che una persona pensa prima di entrare in uno stato depressivo. Se quei pensieri erano bui, scuri, di paura, allora la paura stessa precede la depressione e la costruisce?
Archiati: La aggrava. Proprio qui ci viene confermata l’importanza dei pensieri sostitutivi del terapeuta o delle persone care. Però la sua domanda ci induce a ulteriori distinzioni. Nella fase precedente la depressione vera e propria non ci possono ancora essere “pensieri bui, scuri, di paura”, perché essi sono propri della fase depressiva in quanto tale. Nella fase precedente c’è dapprima la carenza, l’assenza di pensieri positivi. Il depresso è qui nella fase incipiente della depressione, che è l’atteggiamento spirituale del pessimismo nel senso lato del termine. A livello di pensiero questa mancanza è inizialmente pura negatività, è il male in quanto “nulla”. Quando però questi “buchi” di pensiero investono la sfera del sentimento, allora vengono vissuti come vuoto esistenziale reale. Qui si vive la realtà vera e propria della depressione, che è un fatto eminentemente animico di sentimento. Quando poi questo vuoto animico del sentimento invade la sfera vera e propria delle forze volitive, allora sorge il fenomeno specifico della paura. La paura ha sempre a che fare col misurarsi col mondo esterno – non unicamente con pensieri o sentimenti vissuti interiormente – dove sorge la minaccia di soccombere e di venire inghiottiti. Il punto di partenza, però, di questa triade (pessimismo nel pensiero, depressione nel sentimento, paura nella volontà) è il pensiero. Ogni essere umano ha la possibilità e la capacità di pensare e di coltivare quotidianamente pensieri positivi, e proprio questo compito della libertà è il più importante e il più urgente per tutti.
Intervento: Condivido il suo pensiero che le persone depresse hanno interiormente una carica aggressiva in potenza. Però io ho notato che il depressivo, a volte, è anche all’esterno un violento terribile: con i suoi lamenti, col suo star male semina ricatti e distruzione intorno a sé. E allora?
Archiati: Dobbiamo fare attenzione al linguaggio che ci fa brutti scherzi quando designiamo un fenomeno con i termini propri del suo opposto. Se diciamo che il depresso è l’essere umano più aggressivo che esista, rischiamo di venire fraintesi. Il compito del pensiero è quello di affrontare la complessità della realtà facendo distinzioni sempre più minute per non restare al livello di grandi astrazioni. Per comprendere sempre meglio un fenomeno bisogna articolarlo nelle sue molteplici fasi e angolazioni.
Se diciamo che il depressivo è un aggressivo in potenza, sottolineiamo il dinamismo intrinseco di un estremo che alberga in sé l’insopportabilità e l’insostenibilità della sua stessa posizione unilaterale. Se invece diciamo che il depresso semina violenza, allora o stiamo semplicemente descrivendo la nostra reazione aggressiva nei suoi confronti, oppure non siamo di fronte a un fenomeno di depressione ma a una patologia dell’anima di altra natura.
Intervento: Se l’evoluzione procede per polarità, il periodo di oscillazione, quest’altalena fra aggressività e depressione, di volta in volta dovrà pur diminuire, addirittura fino a scomparire nella calma interiore! O no?
Archiati: La calma interiore la consegue per ora colui che è in grado di godersi l’altalena! Il bambino l’altalena se la gode, mica si vuol fermare! “Se non diventerete come bambini” dice il Vangelo “non entrerete nel regno dei cieli”. Il che non vuol dire che si faccia riferimento alla positività del restare fermi al livello dell’infanzia, ma proprio alla dinamica interiore che riconquista la gioia della processualità. Perché solo un adulto può diventare, coscientemente, come un bambino. Senza movimento tra polarità non sarebbe possibile l’evoluzione nel tempo. Il compito attuale è quello di vincere le manifestazioni estreme, che ci fanno restare troppo a lungo in un polo solo privandoci per un bel po’ del vivace movimento che sta nell’andare avanti e indietro, sempre. Il superamento degli estremi è allora un aumento di movimento e di dinamismo interiore, non un suo decrescere.
Intervento: Ma allora, per evitare che la calma interiore diventi un “cimitero”, come ha detto lei, si dovrà sempre oscillare? Io penso che ci sarà pure un momento in cui si dovrà arrivare a qualcosa!
Archiati: Un equilibrio del tutto statico non esiste, sarebbe un frammento di morte. Un equilibrio statico lo posso trovare nel minerale, e in assoluto neanche lì. Dove c’è il vivente, l’equilibrio è labile ed è sempre presente la possibilità di squilibrarsi in mille modi. La stasi è la morte dell’essere umano: nella stasi non succede più nulla. Ciò a cui si deve “arrivare”, per usare il suo termine, è la gioia del non voler mai essere degli “arrivati”, ma di godersi la strada. A che cosa è “arrivato” un organismo sano? Non è arrivato a nulla, ma vive sanamente, e così va bene. Proprio questa salute del vivente non è mai statica: deve avere la possibilità reale di far sorgere tutte le forme di malattia. Un organismo che non si può più ammalare è morto. La salute non consiste nel non avere malattie, ma nel superare quelle che sorgono e nell’evitare quelle che non devono sorgere. Il superare e l’evitare sono due attività dinamiche che ci mantengono sempre in movimento.
Intervento: Però se questa altalena è molto forte c’è sempre un elemento di schiavitù rispetto alla propria interiorità. Un uomo che oscilli tra la paura estrema e l’estrema violenza non è libero, non ha in mano se stesso. Quindi io capisco che il compito evolutivo non possa mirare a un’immobilità totale, ma mi pare che le dualità tendano al loro stesso superamento nel diminuire graduale del periodo di oscillazione tra i poli. E probabilmente l’essere umano, in seguito, dovrà far fronte ad altre dualità che oggi non sospetta. Si spera che in futuro avremo altri compiti e non per tutta l’eternità oscillare tra l’estrema paura e l’estrema violenza!
Archiati: Lei ha ragione: le grandi polarità dell’esistenza che noi viviamo nella fase mediana dell’evoluzione sono destinate nel corso dei millenni – dei millenni, non dei minuti! – a risolversi. Proprio questa risoluzione segna il compimento di grandi cicli evolutivi.
Goethe diceva: polarità e crescita. Prendiamo i poli dell’individualità e della comunità: se è vero che l’uno diventa sempre più l’approfondimento dell’altro, essi verranno a coincidere sempre di più (coincidentia oppositorum). Io vivo allora sempre maggiore comunione grazie all’esplicazione della unicità della mia individualità, e nella comunione trovo sempre di più l’identità mia assoluta e unica.
Quando la polarità fondamentale di un ciclo evolutivo comincia a risolversi, questo è il segno che il ciclo volge al suo compimento. Se però l’evoluzione in quanto tale deve continuare – e un arresto assoluto non è possibile – allora bisognerà porre alla base dei nuovi cicli evolutivi nuove polarità fondamentali, che consentano il dinamismo proprio di un’evoluzione che avviene nel tempo.
Il compito conoscitivo più profondo e più vasto è proprio questo: cogliere quali polarità abbiano il carattere specifico del cammino medio di questa nostra evoluzione, e quindi portino in sé il dinamismo che va verso la loro risoluzione, e quali polarità siano invece incipienti, perché sorgono proprio tramite la risoluzione delle polarità fondamentali, e saranno alla base di un nuovo ciclo evolutivo. A questo punto delle riflessioni, però, o il pensiero si svolge in modo davvero articolato e profondo, o si entra completamente nell’astrazione.
Intervento: Vorrei una precisazione in riferimento alla temperanza. Lei ha detto che l’estremo nel senso dell’aggressione è l’ascesi, in quanto c’è un attacco contro il corpo fisico, mentre l’estremo verso la depressione è la dissolutezza. Però nelle due precedenti non-virtù – l’esaltazione conoscitiva riguardo alla saggezza e la temerarietà riguardo al coraggio – vediamo due polarità che indicano un’eccedenza, un troppo, rispetto alla qualità di mezzo. Per analogia, ho l’impressione che riguardo alla temperanza l’esuberanza sia più nel senso della dissolutezza, quindi proprio il contrario.
Archiati: Ci rifletta bene: l’aggressivo è colui che si macera; chi si lascia andare alla dissolutezza è tutt’altro che aggressivo, è passivo. Da qui il termine “passione”: le passioni non vengono chiamate “azioni”, proprio perché sono subite. Nella dissolutezza io subisco le leggi di natura della mia corporeità; invece colui che si macera, che si castiga, vuole gestirle totalmente lui, diventando così aggressivo. Il fatto che l’ascesi, la mortificazione, sia stata considerata nella tradizione cattolica come semplicemente positiva indica una forte unilateralità del cristianesimo passato. Non si è sufficientemente compreso che il far violenza alla corporeità è altrettanto disumano quanto l’opposto. Il rapporto giusto con la corporeità è la continua ricerca di un equilibrio fra il troppo e il troppo poco, sia in relazione all’aggressività ascetica che alla passività passionale.
Intervento: A proposito della guerra, espressione estrema e violenta dell’aggressività, è possibile una qualche azione psicoterapeutica o è il caso di lasciare andare le cose come vanno?
Archiati: Quando l’aggressività diventa un fenomeno collettivo si complessifica, perché nella collettivizzazione c’è una perdita dell’individualità. La guerra sorge quando un numero rilevante di individui omette l’esercizio della libertà e ricade nella sfera degli istinti di natura che, essendo comuni alla “specie” umana, operano come una fiumana che trascina e sommerge l’individuo, lo abolisce in quanto tale e lo massifica.
La guerra è un fenomeno di aggressività massima, ma in chiave terapeutica non si può guarire un popolo; una terapia collettiva non esiste, perché non esiste una malattia collettiva. Una malattia può avere dei caratteri generalizzabili, ma sono quelli meno rilevanti. Veramente significativi sono i caratteri individuali. Il compito terapeutico riguarda il modo specifico individuale e personale, in cui l’aggressività del fenomeno generalizzato “guerra” si manifesta in questo individuo, e in questo, e in quest’altro... Volere la pace in senso generale è una astrazione, una comodità sia del pensiero sia della volontà. La pace ognuno la può costruire individualmente nel proprio cuore. Nei cuori umani, intesi in generale, non ci può essere.
Se un terapeuta tratta due persone depresse nello stesso modo, fa delle astrazioni. La terapia è tale nella misura in cui si individualizza; allora vengono veramente ingenerate forze per questa individualità e non solo per l’umanità in generale. L’umanità in generale, tutto sommato, va sempre bene: sono i singoli che possono andare male, perché omettono di fare ciò che solo il singolo è in grado di fare.
Il terapeuta tradizionale durante la sua formazione ha studiato teorie, generalizzazioni, tratti ricorrenti che deve saper riconoscere. E ciò va bene. Ma nella prassi terapeutica egli impara che se applica espedienti tecnici in modo del tutto uguale in casi diversi, non ottiene gli stessi risultati. Il terapeuta è tale se è sempre vivace, attento, in divenire, grazie alla processualità stessa del rapporto. E il rapporto terapeutico non è mai l’applicazione di una teoria, ma è il lavoro di volta in volta diverso del terapeuta su se stesso.
Soltanto quando la relazione terapeutica cambia me come terapeuta e mi rende diverso di caso in caso, è veramente terapia, perché la forza di guarigione è la capacità di trasformarsi. Se non ce l’ho io questa capacità, come posso pretenderla dal cosiddetto paziente? Se l’incontro con il paziente trasforma il terapeuta, allora l’incontro è in grado di trasformare anche il paziente.
Intervento: Perché in una stessa vita alcuni esseri umani cambiano il sesso?
Archiati: Il fenomeno della transessualità ci fa chiedere come mai oggi sempre più esseri umani mostrino disaffezione nei confronti del proprio sesso. Da una parte non va dimenticato che nella nostra cultura manca la prospettiva delle ripetute vite terrene. Per duemila anni l’Occidente non ha avuto la consapevolezza della reincarnazione e quindi è sorta l’aggressività culturale che vuol vivere tutto in una vita sola. Ma anche questa unilateralità è un fattore evolutivo positivo se consente a ognuno la possibilità di riconquistare individualmente la consapevolezza della reincarnazione.
Un aspetto, che ora voglio solo velocemente accennare, è la condanna moraleggiante dell’unilateralità maschile-femminile in quanto tale. Certo che è unilaterale essere soltanto maschio o femmina! Ma una unilateralità non è in sé brutta o cattiva: il compito evolutivo è quello di aggiungere l’altro lato, quando verrà il momento giusto. Essendo andata persa la coscienza della reincarnazione, sono sorte nell’umanità l’impazienza e la condanna di tutte le unilateralità che non si risolvano nell’arco di una vita sola. Quindi, nello specifico, l’impazienza di fronte al fatto che io sono solo maschio o solo femmina, e poi la ribellione contro questa realtà imprescindibile.
In una prospettiva reincarnatoria non ho bisogno di essere tutto e subito. Sono contento di essere uomo per tutta una vita perché solo così posso desiderare, guardare con interesse alla prospettiva di diventare donna in un’altra vita. Se fossi già tutto non potrei desiderare nulla!
La capacità conoscitiva di uno spirito sempre più cosciente di afferrare le leggi fondamentali dell’evoluzione – e la reincarnazione è una di esse – ci dà la forza morale di gioire del fatto di poter desiderare l’altro sesso per tutta una vita. La parte più bella di ciò che ci manca è per certi aspetti il desiderio, non il conseguimento. Guai ai sogni che si avverano, dice la sapienza popolare, perché finiscono di essere sogni! Più forza ho di restare anche a lungo nella posizione dell’anelito, dell’ammirare ciò che io ancora non sono, più godo di restare maschio per tutta la vita, visto che questo mi consente per tutta la vita di non dimenticare l’altro polo. Avrebbero gioia le donne se ci fossero sempre più maschi che non cercano il femminile perché vogliono esserlo loro stessi? E sono felici i maschi di fronte a donne che vogliono competere con loro in fatto di mascolinità?
Intervento: Però, per completare questo discorso, c’è anche il caso di ambiguità in giovane età, di ragazzi che non si capisce bene a quale sesso appartengano. È una malattia, una anomalia, è una situazione karmica?
Archiati: Fino alla pubertà la polarità del maschile e del femminile non è determinante in campo di autoesperienza dell’essere umano. Questa polarità è infatti massimamente determinante a livello corporeo, è una polarità media a livello animico ed è una polarità minima a livello spirituale. Non voglio dire che al livello dello spirito non ci sia più differenza tra maschile e femminile: c’è ancora, ma i poli sono talmente ravvicinati che il movimento dall’uno all’altro è sfumatissimo e velocissimo. E ciò per il fatto che maschile e femminile non ci sono nello spirito, ma sono sempre un riflesso sullo spirito di ciò che viene vissuto direttamente nell’anima. Ciò vale anche per il corporeo: qui la polarità maschile-femminile trova la sua massima espressione, ma è solo nell’anima che può venire vissuta, di riflesso. Nella corporeità il movimento reale che va dal maschile al femminile è così lento che richiede tutta una vita per andare dall’altra parte.
Veniamo di nuovo posti di fronte alle tre realtà fondamentali del corpo, dell’anima e dello spirito. I greci avevano tre parole diverse per la tensione dinamica tra il maschile e il femminile: a livello del corpo ερος (èros); a livello dell’anima ϕιλια (filìa); a livello spirituale αγαπη (àgape). Il nostro linguaggio moderno è più povero da questo punto di vista; ma proprio la maggiore povertà è il presupposto per la libera riconquista individuale della ricchezza.
Il fenomeno di un giovane che sia “incerto” riguardo al suo sesso lo comprendiamo solo in questo triplice contesto. Lo spirito è per natura maschile-femminile ad un tempo. L’anima è o maschile o femminile e ci possono essere, in linea di eccezione, maschi con anima femminile e femmine con anima maschile. In questi casi l’inconsueta sintesi può riversarsi in misura più o meno forte anche nella corporeità.
Ma la sua domanda contiene anche un riferimento all’omosessualità in quanto orientamento di natura. È difficile limitarsi a brevi cenni su realtà che sono complesse. Direi che proprio nel caso dell’omosessualità si mostra quanto noi siamo abituati a moraleggiare, cioè a voler vedere il buono e il cattivo in ciò che è e non in ciò che l’individuo diviene grazie alla sua individualissima interazione con ciò che è. La tendenza omosessuale è in sé e per sé un dato di natura e come tale è un compito evolutivo non meno dell’eterosessualità. É anch’essa una opportunità evolutiva positiva che consente all’individuo una lotta salutare. Ciò che è di troppo – di paralizzante, di lesivo della libertà – nelle forze della generazione offre la possibilità del lavoro evolutivo di purificazione. In questo senso è secondario a quale sesso esse si rivolgano.
Intervento: Volevo ritornare agli aggressivi, ai depressivi e al lavoro del terapeuta. Capisco che il compito del terapeuta è quello di produrre pensieri sostitutivi. Comprendo “l’essere Abele”, nel senso di aiutare la persona a prendersi cura di se stessa. Il problema, però, sorge quando in casi di comportamento estremo il paziente proietta tutto al di fuori e in lui non pare esserci la volontà di prendersi alcuna responsabilità. Amare questa parte del paziente è difficile. Allora volevo qualche consiglio sui pensieri sostitutivi in tale senso. Io posso ben confermare l’importanza del processo nel quale si trova il paziente, faccio più fatica a intervenire quando c’è solo la fase del rifiuto (sia nella forma aggressiva sia nella forma depressiva), e la “colpa” di tutto viene scaricata nel fuori.
Archiati: La grande tentazione del terapeuta, soprattutto nelle fasi più difficili della terapia, è sempre quella di voler gestire l’altro. La soluzione a questo grosso problema è quella di proibirsi di farlo. E in questo consiste l’amore. Amare l’altro significa rifiutarsi di agire in lui al posto suo. E per non farlo, l’ho già detto, bisogna aver fiducia assoluta nella positività della persona. La libertà umana ha, certo, i suoi abissi: se non ci fossero non saremmo davvero liberi. Dar fiducia alla libertà significa essere convinti che non c’è abisso, per quanto tenebroso, che non si possa trasformare in evoluzione positiva. È facile volere una libertà senza rischi.
Il miglior terapeuta è colui che sa sempre pensare questi pensieri: tu hai in te stesso tutte le forze positive che ti consentono di volgere in bene anche le esperienze più difficili. Non hai bisogno di essere dipendente da me perché nella realtà spirituale del nostro karma comune i nostri veri esseri sono da sempre interdipendenti in senso positivo. Si sostengono a vicenda come gli organi di un organismo vivente. Se sei in una fase depressiva è perché nella tua coscienza ordinaria ti sei dimenticato di queste cose, ma prima o poi te ne ricorderai…
Oltre a imputare all’esterno le cause del suo disagio, spesso il paziente cerca la dipendenza. La terapia consiste allora nel non alimentarla e nel confermargli: non sei dipendente, ti illudi di esserlo, cerchi una dipendenza, io invece mi congiungo col tuo Io vero che non conosce autorità cui sottomettersi, ma solo la libertà dell’amore reciproco.
Intervento: Proprio questo, però, porta al conflitto quando la persona comincia a rifiutare la terapia. Il terapeuta dovrebbe essere felice, no? Benissimo, il paziente sta rifiutando la terapia, in un certo senso sta prendendosi in mano! Ma sappiamo benissimo che non è vero. Io so che la persona ha interiormente “la possibilità di”, però, quando continua a interrompere la terapia nel momento in cui diventa necessario trasformare, il mio compito di terapeuta potrebbe essere quello di garantirla, di trattenerla. Non vuol dire gestire, vuol dire non permettere di sprecare. O no? Lascio andare e basta?
Archiati: Quando come terapeuta dico che il paziente “interrompe una terapia” sto moraleggiando, perché in realtà sono io che interrompo lui: ho un’idea di terapia e di come dovrebbe procedere, ma il paziente mi interrompe. Il problema, in questo caso, è la fissità del terapeuta. Come posso io dire che il paziente interrompe la terapia? Che cos’è “la terapia”? Una teoria, una astrazione fatta per confermare una dipendenza, se abbiamo il coraggio di pensare le cose fino in fondo. Un vero terapeuta non ha bisogno né di teorie, né di terapie: gli basta l’altro, gli basta il rapporto. Quando io ho l’impressione, come terapeuta, che l’altro mi interrompa la terapia, sono io a interrompere il rapporto: dimentico il rapporto con lui per coltivare il rapporto con la mia teoria della terapia.
Pensate alla tirannia, profondissima e squisita, di Freud che, avendo avuto sentore del fatto che la libidine gioca sempre là dove c’è l’essere umano, l’ha assolutizzata. Questa è la tirannia. Dire che la componente sessuale c’è sempre negli esseri umani è una verità lapalissiana: l’importante è non mettere mai le teorie al di sopra dell’essere umano stesso. Se posso fare un cenno personale, l’unico psicologo che veramente mi ha convinto quando ero studente è stato Carl Rogers. Leggevo i suoi testi e mi dicevo: ma io queste frasi le ho sempre pensate! Carl Rogers fa molte meno teorie di Jung, per esempio, e le teorie sono in fondo dei dispotismi. Nella terapia si ha a che fare con le persone e allora bisogna essere sempre nuovi, sempre diversi e vivaci. Non il paziente si deve orientare secondo la terapia del terapeuta, ma il terapeuta deve cambiare se stesso e rinnovarsi con ogni paziente. Se è il paziente che si deve adattare, allora chi è il terapeuta? È il paziente, perché deve dimostrare maggiore malleabilità che non il terapeuta!
Intervento: Allargando il discorso alla medicina in generale, per il terapeuta l’utilizzo del farmaco è allora un ausilio tecnico, un espediente che accompagna la vera azione terapeutica, che è molto più profonda. Così come, per il paziente, l’essersi esposto, per esempio, a una sostanza tossica è stato solo lo strumento, l’occasione fisica per prendersi la malattia che gli occorreva per la sua evoluzione. Ma in questo modo il terapeuta, nella sua vita professionale, va a intersecare migliaia di karma e gli arrivano addosso migliaia di retroazioni: e questo che effetto gli fa?
Archiati: Se ci chiediamo quale sia la realtà karmica, esistenziale, che lega il terapeuta al paziente, ci rendiamo conto che il compito terapeutico è tale non in quanto professione, ma in quanto essenza dei rapporti reciproci umani. Ogni uomo sa, nel suo Io vero, che tutti i rapporti umani sono una reciproca terapia. Quando tutti diventano terapeuti, non c’è più bisogno del terapeuta di professione.
DIBATTITO dal terzo Capitolo
“Il materialismo d’oggi:
grande malattia o grande terapia?”
Intervento: Una domanda in merito al primo dogma del materialismo: l’uomo è un animale superiore. Questo mi pare non corrisponda del tutto ad una certa concezione, pure materialistica, che apprezza comunque nell’uomo una dignità speciale, appunto umana, riconoscendo nel darwinismo un processo storico biologico che, sia pure mosso da qualcosa di non definito chiamato “caso”, approda ad un essere che è superiore al cosiddetto animale superiore. Questa concezione, che nasce anche da una religiosità laica, vede nell’essere umano una specificità che lo distingue: non siamo di fronte ad un materialismo così totale come quello che abbiamo descritto.
Archiati: Questa sua domanda è un invito a riflettere ulteriormente sul significato della parola “superiore”. Qual è il contenuto di questo aggettivo? Concretamente, in cosa consiste questa superiorità?
Intervento: Nella capacità di pensare e di comunicare in maniera articolata.
Intervento: Dal punto di vista dell’animalità l’uomo è considerato dal darwinismo l’ultima specie animale, quindi il risultato finale di tutta l’evoluzione.
Intervento: Nel termine “superiore” possiamo inserire il riconoscimento che l’uomo è cosciente e autocosciente.
Archiati: La mia domanda chiedeva implicitamente: siamo ancora nel materialismo se vediamo nel pensiero un gradino evolutivo, una dimensione dell’essere che è del tutto nuova rispetto alle capacità animali, ma che scaturisce essa pure dalla materia? Il pensiero è un prodotto della materia?
Intervento: Secondo i materialisti sì.
Archiati: Allora cerchiamo di seguire questa pista: i pensieri come prodotto della materia, come una sorta di secrezione del cervello fisico. Quando l’uomo muore, che cosa resta di lui? Se il materialismo fosse consequenziale, dovrebbe dire che non resta nulla. L’essere umano sarebbe allora un’effimera manifestazione della cosiddetta materia. Ne seguirebbe che la materia è qualcosa di infinitamente superiore all’essere umano, il quale è semplice epifenomeno, cioè un effetto secondario della materia. Oppure potremmo dire che il fenomeno “uomo” è una delle possibili espressioni della cosiddetta materia. Allora, se lo specifico umano è il pensare (o la coscienza) e il pensare è soltanto un esponente dell’operatività della materia, lo specifico umano è un effetto infinitamente inferiore alla materia stessa che è la causa di tutto. E che cos’è la materia?
Intervento: Secondo la fisica moderna la materia è un concentrato di energia. C’è un’equazione che tutti conosciamo, quella della relatività, che lega l’energia alla massa, quindi alla materia.
Archiati: Così definiamo la materia in termini di “energia”. Là dove la fisica avverte i suoi limiti usa concetti che sono molto “mistici” – come quello di “energia” – e che, paragonati ai concetti degli Scolastici, sono di una nebulosità astronomica. Ma proprio questo ci indica la povertà di pensiero dell’uomo materialistico.
Intervento: Io direi che i fisici hanno totalmente rinunciato a rispondere e addirittura a porsi questa domanda. La materia è andata completamente sgretolandosi sotto le loro mani, e ammettono oggi che la cosa più concreta che hanno sono alcune formule matematiche alle quali non riescono più ad attribuire nessun significato reale. Ma non cercano nemmeno di farlo. Quindi si sono realmente ridotti a un livello estremo di astrazione.
Archiati: E qual è, allora, la realtà concreta di tutto questo cammino di astrazione? È lo spirito umano che ha pensato queste formule, che è arrivato a queste conclusioni. Questa è la realtà concreta: lo spirito umano pensante. La mia provocazione espressa nell’affermazione lo spirito è la realtà più concreta che ci sia e la materia è un’astrazione non era una battuta. Era intesa molto sul serio.
Intervento: Una cosa non ha la materia: il libero arbitrio, non ha decisioni. L’uomo ha decisioni, l’uomo decide ogni giorno migliaia di volte.
Archiati: La materia non ha libero arbitrio perché la materia non esiste del tutto. La materia non è una realtà, è un concetto astratto dell’essere umano. Quando noi parliamo di “materia” dimostriamo la capacità dello spirito umano di astrarre dalla realtà. Ecco perché parliamo di materia. E questa capacità dello spirito umano è reale. È lo spirito umano che dà realtà alla materia, astraendo. Proprio grazie a questo è libero, lo spirito: perché può astrarre da ogni realtà.
Supponiamo di essere d’accordo sul fatto che l’essere umano non sparisca nel nulla quando la sua materia corporea si decompone, dopo la morte: supponiamo che esista ancora, come essere spirituale. Chiediamoci: di tutto questo mondo “materiale”, che cosa esisterà per lui dopo la morte? Nulla, assolutamente nulla. Dov’è allora la cosiddetta materia per i morti? E quando noi dormiamo, ed entriamo nella dimensione animico spirituale, dov’è la materia per noi? È sparita!
Questo tramutamento di dimensioni di coscienza è descritto nel Vecchio Testamento: quando il serpente tenta Adamo ed Eva che cosa dice? “Se mangerete i frutti dell’albero che è nel mezzo del giardino i vostri occhi si apriranno...”. Con queste parole viene espressa la condizione del percepire la materia. Noi parliamo di materia dove viviamo la percezione sensibile: la percezione è l’esperienza di uscire dal reale, dal paradiso. E proprio per questo la percezione è la provocazione a trovare il concetto spirituale che ci fa tornare nel “paradiso”.
La nostra difficoltà risiede nel fatto che diamo per scontato il pensare, e non ci rendiamo conto che col pensiero aggiungiamo la sostanzialità reale alle percezioni. Quando io ho la sola percezione della rosa, che cosa ho della rosa? Nulla. Se io elimino il concetto di rosa e quindi non so che “questa cosa” è una rosa, e mi limito alla sola percezione che mi è resa possibile dalla cosiddetta materia – questa è la materia: la possibilità di percezione –, che cosa ho, di fatto, tramite la percezione? Il nulla della rosa.
A conferma di ciò che ho detto va chiarito che gli animali non sono affatto capaci di “percezione” in senso vero e proprio. È un antropomorfismo dire che un gatto percepisce un essere umano o un colore. Un gatto non può percepire il colore rosso: lo può soltanto vivere, averne la sensazione. In altre parole, l’astralità creata dal colore rosso opera direttamente nell’astralità animica, nel vissuto animico del gatto. Percepire il colore è tutt’altra cosa che vivere il colore. L’essere umano vive il colore perché ha un corpo astrale come l’animale ma, in base all’Io spirituale che è capace di pensiero, ha in più la percezione del colore. Con la percezione si tira fuori totalmente dalla realtà per potervisi rituffare in chiave di pensiero. Quindi solo là dove c’è la capacità del pensiero c’è anche la capacità di percezione: si corrispondono.
La percezione è allora la capacità specificamente umana di prendere le distanze dalla realtà – sospendendone ogni influsso non libero su di sé – onde poter prendere posizione nei suoi confronti con la libertà creativa del pensiero, dicendo di che cosa si tratta.
L’animale che non può pensare non può neppure percepire: si limita a vivere, a esperire la realtà del colore. È del tutto passivo nei confronti dell’operare del colore dentro di lui. Se l’animale fosse capace di percepire il rosso, dovrebbe anche essere capace di dire, in chiave di concetto pensante: quello è rosso. Il fatto che manchi la presa di posizione concettuale ci sta a dire che non c’è neppure la percezione vera e propria, la quale, nel cosmo umano, è propedeutica ad ogni conoscenza.
Noi abbiamo l’abitudine antropomorfica di attribuire agli animali percezioni, mentre essi non hanno questa possibilità di distanziarsi in tutto e per tutto dall’operare della cosa dentro al loro essere per conferirle la realtà in chiave assolutamente libera di pensiero, ed esprimere il giudizio: questo è rosso. Da dove so, io, che è rosso? Come faccio a sapere che è rosso? E perché l’animale non dice che è rosso?
Intervento: Credo che sia un pensato degli uomini l’avere stabilito un codice per cui quello è il rosso. C’è una scala di colori e quindi si memorizza il rosso: lo si riconosce più che viverlo.
Archiati: Quando io vivo il rosso nella mia anima subisco la medesima esperienza dell’animale; la differenza è che io so che è rosso, e sono in grado di dirlo. In altre parole, l’astralità di questo colore agisce, mi fa subire una sua aggressività che mi viene incontro – contrariamente al blu dove si vive, invece, una sorta di risucchio. Io, però, non soltanto subisco questa esperienza, ma la comprendo anche, cioè la interpreto e la definisco in chiave di concetto. Questa è la novità assoluta che subentra grazie al pensiero.
Ed è importantissimo capire che l’attribuzione del concetto “rosso” all’esperienza del rosso non è un arbitrio mio o una faccenda di convenzione: è invece il riconoscimento pensante oggettivo, da parte mia, dell’operare altrettanto oggettivo del rosso. Noi non possiamo stabilire per convenzione che il rosso debba agire risucchiando, perché questo è un errore. Il rosso agisce premendo, in modo aggressivo e io vivo oggettivamente l’aggressività; ne ho inoltre coscienza grazie al pensare e dico: è rosso. Ogni essere dotato di un’anima quando sperimenta questo colore deve sperimentare al contempo un’aggressione che gli proviene dal rosso. Altrimenti non è rosso. Il toro reagisce in modo ben diverso se posto davanti al blu anziché al rosso.
Intervento: Ma è comunque per convenzione che, quando c’è l’esperienza di venire aggrediti, definiamo questa sensazione con il termine “rosso”. In un’altra lingua lo definiscono in un altro modo.
Archiati: Io sto parlando dell’oggettività spirituale del fenomeno, del concetto, non del vocabolo. Inoltre, anche in relazione alla saggezza del linguaggio, in molte lingue europee le consonanti e le vocali testimoniano spesso la stessa esperienza oggettiva. La forza roteante, incedente, espansiva e aggressiva nella “rrrrrrrrrrrr”, il calore avvolgente nella “oooooooo” compaiono nella parola rosso (italiano), rot (tedesco), rouge (francese), rojo (spagnolo), red (inglese: in questa lingua la vocale “e” evidenzia dell’esperienza “rosso” maggiormente il momento dell’impatto, della presa di coscienza) ecc.
Se ci addentrassimo nello studio comparato delle lingue, constateremmo che quando uno stesso fenomeno è espresso con suoni vocalici e consonantici diversi, ciò significa che di questo fenomeno un popolo vive maggiormente un aspetto, un altro popolo ne vive un altro. L’“acqua”, per esempio, la può chiamare con due belle “a” di meraviglia solo chi al sud se la gode bella calda e se la vede distesa intorno in mari tranquilli; nel Mare del Nord, dove è sempre gelida, l’esperienza oggettiva dei brividi fa dire “Wasser”!
Intervento: Tornando agli animali può anche essere che abbiano organi di percezione diversi dai nostri e di conseguenza non vedano proprio il colore.
Archiati: Se parliamo di “vedere” parliamo di percezione attraverso il senso della vista, che è specifico dell’uomo. L’animale attraverso i sensi esperisce, vive, sente, ma non percepisce. E per questo la differenza fondamentale tra l’occhio umano e quello animale, per esempio, consiste nel fatto che quest’ultimo è rimasto molto più vitale rispetto a quello umano, che invece è quasi del tutto morto e opera in modo simile a un apparecchio fotografico. La differenza fondamentale consiste nel fatto che l’animale esperisce tutto ciò che l’essere umano, oltre a esperire, percepisce. L’ape si libra nel sole: tutto il suo essere vibra astralmente in base alla luce e ai colori, in base al calore; si orienta in modo infallibile perché ciò che è esperienza in lei la trasporta. Non può far altro. L’ape non ha “consapevolezza” del calore o del colore.
La presa di posizione conoscitiva propria dell’uomo presuppone una presa di distanza, un tirarsi fuori dal fenomeno per dire che cos’è. Io posso “oggettivare” qualcosa solo quando mi diventa un ob-iectum, che significa: “gettato davanti” (dal latino ob-iacere). Questa presa di distanza per l’animale non esiste: non può mai tirarsi fuori dalla realtà perché questo tirarsi fuori lo può compiere solo lo spirito. In latino c’è la stessa parola per indicare l’anima e l’animale: anima e animal. L’essere umano è l’unico essere nel mondo visibile capace di tirarsi fuori (abs-trahere) dalla realtà e guardarla dal di fuori, oggettivandola. In questo consiste l’astrazione. È il presupposto per divenire cosciente di sé in quanto diverso dal mondo, “posto di fronte” al mondo.
Intervento: E il fenomeno di un cane che percorre chilometri e chilometri per arrivare da un posto lontanissimo alla casa dove si sono trasferiti i padroni? Percepisce pur qualcosa, questo cane!
Archiati: No, esperisce. Ciò che trascina il cane è l’astralità dei padroni nella quale è immerso, non un progetto cosciente di ritorno. Negli animali domestici opera l’istinto della specie, della natura, unito a tutti i condizionamenti – che non sono altro che ulteriori istinti – che l’uomo induce in lui. Lo scoglio in tutto questo dibattito è che noi non distinguiamo sufficientemente tra percepire e sentire, vivere.
Intervento: Vorrei un chiarimento sul concetto della non esistenza della materia. Ho capito che per un’individualità che si sia ormai disincarnata deponendo il suo corpo fisico, o per un’entità angelica, la materia non esiste. Proprio perché non ci sono i sensi fisici per percepirla. Però, se noi andiamo a sbattere contro un muro o consideriamo che ciascun corpo occupa uno spazio non occupabile da un altro, a questo livello dobbiamo pur convenire che la materia esiste. Allora che cos’è il paradosso che la materia non esiste?
Archiati: Ci stiamo muovendo proprio nel campo più difficile che ci sia! Proviamo, comunque, a cercare un altro orientamento. Prendiamo la gravità, che è uno dei caratteri più intrinseci ed evidenti della cosiddetta materia, un fenomeno che ci induce a dire: beh, più chiaro di così! E un sonnambulo che salta da un tetto a un altro, come ce lo spieghiamo? Dov’è andata a finire la gravità? E dov’è la realtà della materia? E perché, se lo sveglio, cade subito a terra? Quando non c’era la coscienza, dentro a questo corpo spariva la gravità: lo sveglio, ritorna la coscienza, ricompare la gravità! Un fenomeno come quello del sonnambulismo pone alla scienza odierna enormi problemi: e perciò viene messo da parte come “anormale”. Ma un sonnambulo, in quanto sonnambulo, è del tutto normale: sono le cosiddette leggi, cioè la povertà del pensiero abituale che non è in grado di spiegare questi fenomeni. Questo è il problema.
Intervento: Accolgo l’invito a tornare su qualcosa di più facile! Parlando dei talenti si fa volentieri riferimento a Dante, a pittori, artisti ecc. Mi sembra che questi esempi potrebbero indurre a pensare che per essere uomini ed esercitare talenti si debba essere geni o comunque artisti. Direi che anche una vita estremamente più modesta possa essere pienamente umana.
Archiati: La sua mi pare un’osservazione importantissima. L’arte e la felicità della vita, cioè l’esplicazione piena dell’essere umano, sta nella realizzazione dell’individualità. Il concetto di individualità è sostanzialmente questo: ogni Io umano viene a incarnarsi con una somma infinita di intenti che sono i suoi talenti, le sue capacità in potenza che vuole tramutare in atto. Questi sono i talenti: facoltà potenziali, immanenti all’Io vero, che vogliono diventare sempre di più facoltà espresse nello stato incarnato. La felicità della vita consiste nell’immetterle nel quotidiano, nelle cose più piccole e più semplici, essendo consapevoli che così esplichiamo le nostre caratteristiche più individuali. Il talento vero e proprio non consiste mai in ciò che si fa, ma nel modo unico e individuale di farlo. L’essere genitore o maestro è comune a molte persone: il talento è nel come, nel modo che sarà del tutto diverso da persona a persona.
Se io sto pulendo una stanza e sono consapevole che la pulisco diversamente da come la pulirebbe ogni altro essere umano, sono pienamente nell’esplicazione dei miei talenti individuali, e sarò anche felice. E questo vale per ogni attività. Qui però va chiarita un’altra cosa: il mio modo individuale di pulire la stanza non consiste in ciò che avviene alla stanza quando la pulisco io, ma in ciò che avviene a me e in me! In questo vissuto individuale si esprime e si vive il talento proprio. Il concetto di Io vero è che ogni Io umano è una sorgente inesauribile di potenzialità evolutive, che hanno tutte un carattere pienamente individuale. Nessun uomo è meno o più “talentato” di un altro, perché i talenti non sono un fatto quantitativo, bensì qualitativo.
Intervento: Mi sembra molto importante l’elemento della coscienza mentre si assolvono compiti modesti. La tradizione buddhista parla, per esempio, del lavare i piatti con una disposizione d’animo che può dare una grande gioia: allora è un’azione umana. Perché un cavallo è obbligato a non lavare i piatti!
Archiati: Due madri di famiglia stanno cucinando un pasto. Supponiamo che ciò che cucinano sia esattamente lo stesso cibo – e questo nel mondo della cosiddetta materia è possibile, perché qui c’è meno variabilità che nel mondo dello spirito. Supponiamo addirittura che se noi avessimo la possibilità di filmare l’uno e l’altro procedimento vedremmo in tutto e per tutto gli stessi gesti che mescolano gli stessi ingredienti. Il lato materiale di queste azioni è però soltanto il lato di percezione; il lato di esplicazione dei talenti sono invece i pensieri, sono le intuizioni morali, è la qualità individualissima d’amore o di non amore che accompagna queste azioni. L’una e l’altra madre percepiranno il cucinare in quanto esplicazione dei propri talenti solo nella misura in cui la qualità individuale del loro Io sarà presente.
La minestra, materialmente considerata, potrà essere teoricamente la stessa, ma le due madri la intrideranno di pensieri del tutto diversi che opereranno non soltanto nella corporeità fisica di chi la mangerà, ma anche nell’ambito delle forze vitali e del vissuto animico. Gli effetti delle due minestre saranno così del tutto diversi. Il nostro materialismo ci dice che sono uguali, ma il materialismo è cieco rispetto allo spirituale. Non è vero che le due minestre avranno gli stessi effetti, perché hanno il sapore di due contesti esistenziali unici e irripetibili. Se una persona cucina con pensieri d’amore e l’altra sbuffando o inveendo, la seconda minestra agirà per certi versi come un veleno sulla compagine complessiva di chi la mangerà. E proprio qui è l’origine di tante malattie.
Ancora un esempio: tutti sappiamo che ci sono esseri umani capaci di far prosperare le piante che sono in casa e altri che, a parità di trattamento esterno, le fanno seccare. Che cosa hanno a che fare i pensieri, che cosa hanno a che fare i sentimenti degli esseri umani con le piante? Hanno moltissimo a che fare. Proprio grazie a queste le cose l’umanità d’oggi può aprirsi un varco alla realtà dello spirito, rendendosi conto che il materialismo è un vicolo cieco.
Intervento: Innanzi tutto voglio esprimere la mia gratitudine per questi ultimi commenti, perché ho ragione di dire che io mi sento particolarmente realizzata in cucina! In secondo luogo, vorrei tornare sull’argomento difficile di prima: mi è rimasto un punto interrogativo sul fatto che quando l’uomo muore scompaia il mondo materiale. Allora mi sono chiesta: a che cosa aspiro, io, quando sono nei mondi spirituali e voglio tornare a reincarnarmi? Che cosa “vedo”? Non desidero tornare in questo mondo materiale?
Archiati: Le do una risposta paradossale, che è però soltanto un invito a continuare a riflettere su queste cose. Il motivo per ritornare a incarnarsi è la libertà, perché nello stadio disincarnato tra la morte e una nuova nascita non c’è la libertà. E perché? Perché le realtà spirituali non consentono “libertà” di stampo terreno in quanto noi (nel dopo morte) siamo dentro lo spirituale e non ce ne possiamo tirare fuori, diventando così autonomi e liberi. La libertà che noi conosciamo, quella di cui parliamo, è la libertà che esiste perché noi non sappiamo quello che combiniamo. Perciò ci crediamo liberi. Grazie all’oscuramento di coscienza che consegue al congiungerci con la materia, noi non siamo più in grado di osservare nel mondo spirituale l’oggettività di ciò che ci procuriamo vicendevolmente nelle relazioni karmiche, per esempio. Perciò parliamo di libero arbitrio. È perché non sappiamo ciò che facciamo.
Quale argomento porta il Cristo incontro al Padre cosmico perché ci perdoni tutto ciò che combiniamo? “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Questo è ciò che noi chiamiamo libertà. Se noi sapessimo quel che facciamo, sarebbe finita la libertà. Avremmo di fronte agli occhi le conseguenze oggettive per noi rovinose di ogni pensiero sbagliato, di ogni egoismo; non saremmo più liberi di pensare pensieri sbagliati, di albergare sentimenti di egoismo, di compiere azioni malvagie... Saremmo “costretti” a pensare pensieri giusti, a coltivare sentimenti d’amore, a compiere azioni d’aiuto reciproco.
Intervento: Ma se parliamo di livelli evolutivi, questa “costrizione” sarà il conseguimento di un livello superiore. Potrebbe essere la perdita della nostra libertà, offuscata a vantaggio di una visione superiore che ci toglie il bisogno del libero arbitrio.
Archiati: È giusto quello che lei dice: il gradino superiore a quello della libertà umana, che è quello divino, comune a tutti gli Esseri divini, è la libertà della scelta tra bene e bene. Faccio un breve accenno a cose che andrebbero ulteriormente approfondite. Possiamo distinguere tre sfere o livelli fondamentali della libertà.
a) La sfera specificamente umana è quella che noi conosciamo della libera scelta tra il bene e il male, dove il bene consiste nella scelta di restare liberi e il male nella scelta di perdere la libertà. Per l’uomo non c’è altro bene che realizzare la libertà e non c’è altro male che perdere la libertà. Una libertà che è ancora capace di perdersi, come quella umana, è incipiente, non è perfetta, ed è questo che lei sottolineava. Noi ritorniamo nella materia per vivere questa libertà specifica dello stadio mediano dell’evoluzione.
b) Ben più perfetta è una libertà che non possa più andar perduta, che sia sempre e solo libera. Questa libertà non è quella di scelta tra il bene e il male, ma tra il bene e il bene. Questa libertà è sovrumana, se noi consideriamo il nostro livello attuale di evoluzione; quindi, sarà la nostra meta evolutiva complessiva. È una libertà a cui non è più consentito di perdersi, perciò è perfetta e perciò è, per ora, più che umana. È una sfera superiore della libertà dove si sceglie unicamente tra infiniti beni.
c) Gli Esseri cosiddetti del male sono, in base a un compito cosmico verso l’uomo conferito loro dagli Esseri divini, ad un gradino inferiore di libertà, dove hanno unicamente la libertà di scelta tra male e male, cioè tra diversi modi di far perdere agli esseri umani la libertà.
Intervento: A proposito degli Esseri demoniaci, sappiamo che prima di diventare inferiori erano sviluppati a livelli angelici, arcangelici, dunque superiori all’uomo. Diciamo allora che fecero una scelta e fu una scelta sbagliata, i cui effetti sono ancora presenti. In questo caso, allora, questi Esseri spirituali non avevano solo la possibilità di scegliere tra bene e bene ma, anzi, proprio la facoltà di rimanere indietro ha permesso loro di occupare un posto fondamentale nella storia della nostra evoluzione.
Archiati: Se compreso bene, è giusto quello che lei dice. Il parlare di angeli decaduti che hanno scelto il male morale è un moralismo umano. Molto più giusta è la prospettiva del Faust di Goethe dove Mefistofele non si accinge a un’impresa malefica, ma riceve un ruolo, una missione dal Padre dei cieli stesso. Per dare all’essere umano la libertà di scegliere anche il male bisognava che ci fossero Esseri, a lui superiori, che compissero una immolazione per tentarlo al male. Questo sacrificio cosmico consiste nell’ispirare all’essere umano unicamente ciò che gli fa perdere la libertà.
Il bene e il male vanno dunque sempre riferiti all’uomo. Il fatto che gli Esseri “maligni” abbiano accettato il compito di offrire all’uomo tutte le ispirazioni che conducono a perdere la libertà, è un ruolo cosmico indispensabile, una condizione necessaria per l’esercizio della libertà umana. Come gli Esseri del bene ci danno unicamente ispirazioni liberanti, così i cosiddetti Esseri del male (cosiddetti, perché qui il male cominciamo a metterlo tra virgolette) hanno il compito di ispirarci ogni schiavitù. E noi abbiamo la scelta tra gli uni e gli altri. Il vero male morale, per quanto riguarda l’uomo, non è né nel Tentatore né nella tentazione, ma unicamente nel soccombere alla tentazione. Ma il soccombere in quanto tale non può mai essere la volontà del Tentatore: la sua volontà è la tentazione. Il soccombere è la risposta dell’uomo che decide liberamente di perdere la libertà. Il male morale è esclusivamente umano perché noi possiamo parlare solo del mondo umano; e il male morale umano può essere soltanto dentro l’essere umano. Fuori dell’uomo ci sono forze e controforze, ma le controforze sono tutt’altro che male: sono ugualmente necessarie per la libertà e per la conseguente moralità umana.
L’abisso dell’evoluzione umana non è un essere umano “cattivo”: un essere umano cattivo non esiste. Il male morale umano è l’omissione dell’umano, l’omissione della realizzazione dell’archetipo umano. Il mistero della “Bestia”, dell’animale di cui parla l’Apocalisse, non si riferisce a esseri umani cattivi che vanno all’inferno eterno. Parla di individualità che hanno omesso di divenire uomini perché non hanno realizzato la loro umanità. Questo è il mistero ultimo del male. Nel corpo mistico del Cristo, avveramento dell’evoluzione positiva, non mancherà nessuno; perché coloro che ne saranno fuori non saranno “uomini”, ma esseri che hanno omesso di diventarlo. E questa è un’altra cosa.
Intervento: Infatti nelle varie rappresentazioni dei Giudizi Universali – penso a quella di Michelangelo – i dannati sono tutti in sembianze animali mostruose, hanno poco di umano.
Archiati: I grandi peccati della libertà sono le omissioni, non le commissioni. Il più grande moralismo che ci trasciniamo dietro è quello di credere che i peccati più grossi siano quelli commessi, siano ciò che l’uomo fa. No, – l’ho ripetuto tante volte – i peccati più grossi consistono in ciò che l’uomo avrebbe potuto fare e non ha fatto, in ciò che avrebbe potuto divenire e non è divenuto. La tragicità malefica del materialismo non è in “qualcosa”: è nel vuoto dello spirito umano.
Se un carpentiere costruisce un tavolo con le gambe di misura differente, questo lo notano tutti. Proprio perché la realtà porta una reazione, sarà costretto a correggere l’errore. Ma se questo stesso carpentiere avesse avuto il compito karmico nei confronti di un altro di costruire un tavolo e non l’ha fatto, chi se n’accorge? Ci vuole molta più attenzione di spirito per rendersi conto di ciò che manca che non per vedere ciò che è fatto male e salta subito agli occhi. Qual è l’essere umano peggiore di tutti? Quello che non sbaglia mai, perché non fa nulla!
Intervento: Come si è posto Rudolf Steiner di fronte alla questione, tuttora dibattuta, degli esorcismi operati per scacciare Esseri negativi che entrano nelle persone?
Archiati: La grande svolta dell’evoluzione è il sorgere delle forze dell’Io, della capacità di libertà e autonomia sempre più piene. In tutte le manifestazioni del mio essere in cui io non mi posseggo sono un posseduto. L’opinione pubblica, per esempio, è una delle forme di possedimento demoniaco più comune nel nostro tempo che ci rende schiavi di pensieri non nostri. Ogni pensiero che mi possiede senza che sia io a padroneggiarlo è una forma di possessione.
Prima di Cristo l’esorcismo avveniva in chiave vicaria proprio perché mancava, o era appena agli albori, la forza dell’Io. Dopo Cristo l’esorcismo – inteso come la cacciata dei demoni compiuta da un essere umano nell’interiorità di un altro che non ha ancora la forza di farlo lui stesso – è sempre più anacronistico. Bisogna far di tutto perché ciascuno sia in grado, da solo, di superare ogni forma di possessione, senza delegare. Che cos’è la libertà? È che io non sia posseduto, ma mi possegga. Le forme di possessione non sono solo quelle estreme: ci sono altre forme di demoni che ci posseggono, ma sono così diffuse che ci abbiamo fatto l’abitudine, non le vediamo. Ogni forma di non libertà è nel senso tecnico della parola una possessione, un’ossessione: non sono io a essere padrone di me stesso, ma altri esseri posseggono e conducono me.
Intervento: Quando il Cristo scaccia i demoni opera secondo l’antico o è già secondo il nuovo?
Archiati: Prima di tutto il Cristo non li scaccia in chiunque e poi, come ho già detto, sottolinea sempre che l’essenziale è l’attività libera dell’uomo. “La tua fede ti ha salvato, ti ha reso sano” è una frase che altrimenti non avrebbe senso. Egli vuol dire: l’importante, per quel che ti riguarda, non è quello che io faccio al posto tuo; l’importante è quello che fai per forza tua. La tua forza interiore soltanto ti può rendere sano: io ti aiuto dal di fuori, ma non posso gestire dal di fuori la tua libertà. È, in altro modo, ciò che dicevo prima: ogni vera terapia è una restituzione di libertà. Altrimenti è un aggravamento della malattia, non una terapia. Il Cristo guarisce sempre rendendo possibile la libertà, mai sostituendosi ad essa.
Intervento: Abbiamo detto che il materialismo è la grande malattia attuale dell’umanità: ognuno di noi è immerso nel materialismo. È una malattia che assume connotati individuali molto diversi, ma nessuno ne è immune. Allora mi chiedo: per chi voglia contribuire a risanare l’umanità rispetto al materialismo, e non sia un terapeuta di professione, quale dev’essere il giusto atteggiamento?
Archiati: Quando sorge in un essere umano l’entusiasmo per lo spirituale, allora tutto va bene. La domanda importante è: in che modo possiamo ingenerare in tanti, anzi in tutti gli esseri umani, la gioia per lo spirito, la gioia del vero, del bello e del buono? Se manca questa felicità interiore dobbiamo ridurci ai comandamenti! Ma i soli comandamenti, la storia lo ha dimostrato, sono adatti per la fase infantile dell’umanità, dove non c’è ancora la libertà.
Intervento: Per quanto riguarda la possibilità di potenziare i propri talenti, c’è un passo del Vangelo in cui il Cristo dice: “A chi ha tanto verrà dato ancora di più, e a chi ha poco verrà tolto”. Può essere questo insegnamento collegato con quello che lei ha detto poc’anzi?
Archiati: La frase evangelica da lei citata vuol dire – tra le altre cose perché i significati sono sempre molteplici – che nella libertà non è concesso di restare fermi: o si progredisce – si ha molto, e si riceve ancora di più –, o si regredisce – si ha poco, e questo poco diminuisce ulteriormente. Non è prevista staticità. In altre parole: ogni atto umano in quanto tale è moralmente rilevante per chi lo compie. O è buono o è cattivo, non può essere mai “neutro”, cioè fattore di natura, senza la moralità che è specifica dell’uomo.
Intervento: Ancora una domanda sul mesmerismo o pranoterapia: il fatto che questa capacità permanga per poco tempo può dipendere dall’uso che ne viene fatto?
Archiati: Dobbiamo ricordare che ogni sostituirsi all’altro deve avere un carattere transitorio. Chi si sostituisce all’altro? Il genitore, il maestro, anche la Chiesa: se la sostituzione è operata bene, queste autorità faranno di tutto per ritrarsi, non assolutizzeranno la loro presenza. Il terapeuta migliore è quello che in quanto tale si rende superfluo per non essere superfluo come uomo. La Chiesa migliore è quella che non intende eternizzarsi, e perciò fa di tutto per promuovere l’emancipazione dei cosiddetti fedeli. La fase infantile dell’umanità non è eterna, ma propedeutica e preparatoria alla dimensione finale, che è quella della libertà. Il mistero del rapporto terapeutico, in fondo, consiste nel fatto che il paziente viene cercando un rapporto di dipendenza e la terapia consiste nel renderglielo superfluo, non più desiderato.
Intervento: Esiste il guaritore spirituale?
Archiati: Certo che c’è: è l’Io superiore di ognuno di noi.
DIBATTITO dal quarto Capitolo
“Guarire con la verità, la bellezza e la bontà”
Intervento: A proposito della scienza sulla quale, a partire da Galileo e da Newton, sempre più si è consolidato il pensiero occidentale, lei ha detto che l’atteggiamento conoscitivo a priori è quello dell’utilitarismo, dello sfruttamento. Posso ammettere senz’altro che questo sia vero nella scienza come applicazione, ma vorrei ritornare all’intenzione primaria che sottende all’azione dello scienziato vero. Nelle grandi menti di coloro che poi realmente portano un contributo creativo alla conoscenza del mondo, l’impulso interiore fondamentale è proprio quello di voler conoscere per capire, per rispondere alla domanda: chi sono io e che cosa ci sto a fare qui? A me sembra, allora, che, paradossalmente, la scienza nasca proprio da questo movimento libero, anche se poi nella traduzione economica, sociale e politica può diventare qualcos’altro.
Archiati: L’essere umano non può che volere la conoscenza come momento evolutivo proprio. Quindi, idealmente, è certamente come dice lei. L’impulso ideale è senz’altro presente in ogni ricercatore e in ogni scienziato, anche se forse non lo sa, anche se lo disattende e porta la ricerca scientifica in tutt’altre direzioni. La grande tentazione consiste nello strumentalizzare questa facoltà pensante che dovrebbe essere per natura puro esercizio di libertà, di conoscenza e comunione con l’essere vero delle cose. È addirittura necessario che questa tentazione ci sia, altrimenti l’evoluzione del pensare sarebbe automatica. Essa è invece secondo libertà proprio perché l’uomo ha la possibilità di usare il pensare sia come fattore di rigenerazione interiore quotidiana, sia come strumento di assoggettamento della realtà, fino a diventarne egli stesso prigioniero.
Ci sono singoli scienziati che si rendono conto di questa adulterazione, che oggi è veramente molto vistosa, riguardo all’uso del pensiero. Però si tratta di rare eccezioni, per di più incomprese ed emarginate nel mondo della ricerca scientifica. La mia affermazione iniziale era piuttosto la constatazione di un dato di fatto da cui evincere il compito terapeutico dell’umanità.
Intervento: Vorrei fare alcune considerazioni a latere. Rudolf Steiner afferma che le forze delle tenebre sono venute massicciamente all’attacco della Terra verso la fine dell’Ottocento, coincidendo con la nuova reggenza dell’arcangelo Michele, tutore del pensare umano. Riscontriamo che proprio alla fine del 1800 c’è stata una grande esplosione della scienza nella ricerca del mistero dell’esistenza della Terra e dell’uomo; è nato indubbiamente un pensiero materialista, perché è il periodo in cui ciò doveva avvenire.
Saltando cento anni in avanti, noi oggi possiamo verificare che la scienza, per quanto vituperata possa essere, ha un livello di evoluzione che procede comunque, con o senza la scienza dello spirito. Ci troviamo di fronte a una nuova alchimia, e tramite essa viene scoperta l’individualità proprio nel microcosmo umano.
Mi riferisco al DNA: è una recente scoperta, talmente affascinante che mette, credo, gli stessi cultori della scienza dello spirituale di fronte a problemi non indifferenti. Quando lei ha asserito che la materia è astrazione al livello limite, mi sono posto veramente molti interrogativi: ma tornando a ciò che vuole essere questa novella alchimia, io vorrei sapere quali sono le Entità spirituali che agiscono nel DNA. Non solo, ma quando andiamo a vedere la composizione della cellula umana essa è di una meraviglia tale che mi trema la voce. Dentro la cellula umana c’è un mondo intero e allora io non posso vituperare la materia chiamandola astrazione.
Chi sono, quali sono le Entità spirituali che agiscono nel microcosmo umano e che identificano un DNA strettamente individuale, visto che non ce n’è uno uguale a un altro? Io non riesco a identificare la materia come astrazione. Se lei mi parla di materia spirituale io capisco, ma se mi parla di astrazione non la seguo più. Perché dobbiamo rendere vacua questa materia? Appropriarci invece dello spirito per capirla, mi va benissimo!
Archiati: L’affermazione che la materia sia un’astrazione non equivale a dire che la materia sia un nulla, perché un’astrazione non è un nulla ma è un fatto reale della coscienza umana. In altre parole, il modo della coscienza attuale di considerare la materia, i pensieri che gli esseri umani generalmente pensano oggi sulla materia sono astratti, illusori. E questa non è un’affermazione sulla materia come tale: è un’affermazione sui pensieri umani riguardo alla materia. Del resto l’essere umano può avere tutte le cose soltanto nella sua coscienza.
Ora, i pensieri della coscienza umana sulla materia sono illusori perché disattendono la realtà spirituale della materia. Qui ci troviamo pienamente d’accordo. Però si potrebbe fare lo stesso discorso riguardo allo spirito, perché la maggior parte dei pensieri attuali sullo spirito sono altrettanto astratti, dato che l’attività spirituale pensante, capace di generare sostanzialità vera nello spirito, è solo incipiente nell’umanità.
L’affermazione fondamentale sull’astrazione non riguarda allora direttamente né lo spirito né la materia: riguarda il gradino evolutivo attuale dell’umanità in quanto fatto di coscienza, di libertà. Noi siamo appena agli inizi di una gestione dei fenomeni di coscienza che diventeranno sempre più sostanziati di realtà, una realtà che può essere soltanto di natura spirituale perché un’altra realtà – come diceva in fondo anche lei – non esiste. Che poi questa realtà la si chiami spirito o materia è questione di terminologia. Il problema vero è in che modo e con quale intensità io riesco a vivere, nel mio spirito, la sostanzialità dello spirito stesso che dà anche alla cosiddetta materia sostanzialità vera. Certo che la materia può ricevere piena sostanzialità dallo spirito: ma dallo spirito vivente e sostanziale, non dal pensiero astratto.
Queste mie riflessioni sono solo un piccolo avvio per ulteriori cimenti conoscitivi; mi preme quindi chiarire soltanto il punto di partenza. Lei ha commentato l’affermazione che la materia è illusione come se l’affermazione fosse sulla materia anziché sul carattere di illusione dei pensieri umani, e come se l’affermazione di illusorietà fosse un’affermazione di nullità. Sono due cose diverse, perché un’illusione è una realtà, è un fatto reale della coscienza umana.
Una vera illusione, in quanto illusione, c’è. È un fatto di coscienza realissimo. E proprio questa è la realtà della materia: la possibilità del pensare umano di ingannarsi così da ricevere il compito della libertà di disingannarsi. Il materialismo è allora il grande inganno del pensiero e come fatto di coscienza è una realtà, dunque un inganno reale. Ciò che lei ha chiamato “la scienza dello spirito” è la metodica del disinganno per la coscienza umana attuale che considera la cosiddetta materia come realtà.
Intervento: Stiamo quindi dicendo che le cose attorno a noi, l’intero cosmo fisico, sono un’apparenza, una parvenza, nel senso che lo spirito – vera e originaria realtà – “appare” sotto molteplici forme ad un livello per l’uomo e solo per l’uomo percepibile e al quale, illusoriamente, l’uomo stesso conferisce una sostanzialità esauriente, costante e primigenia?
Archiati: Sì. E l’uomo non si rende conto che è la sua stessa capacità di percezione, specifica dello stato incarnato, a portarlo erroneamente a ritenere l’essere delle cose coincidente con l’apparenza stessa delle cose. Un Essere spirituale senza organi di percezione fisici non vede la cosiddetta materia, non la sente, non la tocca, non la urta. La cosiddetta materia sarebbe per lui un livello di manifestazione dello spirito del tutto non sperimentabile.
L’altra questione posta sul DNA, invece, è molto più importante. Rudolf Steiner, da lei citato, fa questa affermazione fondamentale: in seguito alla fecondazione dell’ovulo femminile da parte dello spermatozoo maschile non abbiamo una materia diventata più complessa e strutturante bensì una materia che viene, proprio grazie alla fecondazione, del tutto caotizzata. Ogni realtà sovrasensibile strutturante, ogni operare immanente di forze formatrici preesistenti viene espulso da questa materia.
È questo il concetto aristotelico-tomistico di materia prima, non ancora informata. Ogni volta che un’individualità umana si incarna è necessario che il sostrato di materia venga privato di ogni forza formante proveniente dal passato. Ciò avviene per dare la possibilità a questa individualità unica di inserire le proprie forze plasmatrici e strutturanti, del tutto individuali, nella materia caotizzata per costruire un microcosmo tutto a sua immagine. Ed è questo che lei ha detto affermando che non ci sono due soli DNA uguali.
Proprio perché questa individualità che s’incarna è assolutamente unica, anche i tratti che la renderanno simile ai genitori saranno un effetto nella materia, non causati dalla materia. L’idea che l’ereditarietà causi qualcosa è un’illusione, è uno dei più funesti errori del pensiero umano. La causa vera della configurazione unica del DNA è l’essere spirituale individuale dell’Io che si incarna. Le somiglianze con i genitori sono dovute al fatto che i genitori e il nascituro sono tre individualità spirituali che da millenni hanno un rapporto karmico strettissimo e, in base a ciò che spiritualmente sono divenuti nell’intreccio dei loro esseri, hanno creato in sé alcuni tratti spirituali comuni perché si sono sempre spiritualmente fecondati a vicenda. Questi tratti spirituali comuni sono la causa reale del fatto che karmicamente colui che nasce ha in sé certi modi di strutturazione della materia che sono simili a quelli dei genitori. Ma la somiglianza materiale è effetto di una affinità spirituale, non viceversa.
La strutturazione della materia, come lei ha sottolineato, presenta fenomeni di infinita complessità. L’Io superiore che la architetta ha già trascorso millenni di evoluzione e quindi si è via via sempre più individualizzato. Per questo la caotizzazione della materia è la condizione necessaria perché il nascituro possa conferire a questa materia, in un modo del tutto individuale, il sigillo corrispondente al suo essere. Ciò spiega il fatto che non c’è nessun essere umano uguale a un altro, anche nella corporeità.
Questo tipo di spiegazione che io per sommi capi ho riassunto, e che si potrebbe svolgere sotto moltissimi altri aspetti, è un esempio di terapia del vero. Altrimenti, come mi spiega lei l’individualità? Da dove viene? Che la si cerchi nell’ovulo appena fecondato o in un corpo già adulto non cambia l’essenza del fenomeno. La vera origine del carattere individuale di ogni essere umano non può risiedere che nel suo Io spirituale unico e irripetibile, che struttura la materia a sua immagine. È una vera creazione dal nulla.
Il concetto aristotelico-tomistico di creazione dal nulla non dice che la creazione avvenga nel nulla assoluto: il nulla assoluto, metafisico, non esiste, è un’altra astrazione. C’è sempre un sostrato cosmico alla base di tutte le creazioni. Le lingue antiche avevano termini tecnici per indicarlo: la lingua ebraica aveva la parola aphàr per l’elemento fisico e tehòm per l’etericità del cosmo che, condensata in un modo specifico, si fa sostrato per la costruzione di mondi sempre nuovi. I Greci lo chiamavano καος, caos. Aristotele πρωτη υλη (pròte üle), materia prima. La mitologia nordico-germanica usa il termine ginnunga gap (abisso voraginoso). E così via.
C’è “creazione dal nulla” là dove il sostrato di materia termina di avere in sé una qualsiasi forza formante e la creazione torna alla condizione primigenia. Ogni nascita è dunque una creazione dal nulla di causazione da parte del sostrato materiale. L’Io che si incarna non subisce nulla ad opera della materia, altrimenti non sarebbe un Io. La realtà spirituale dell’Io è forza di creazione pura. Il sostrato di materia cessa al cento per cento, grazie alla “fecondazione”, di essere causante o condeterminante la struttura successiva: diventa un nulla di causazione in quanto la sua forza causante è nulla.
Questo concetto preciso di creazione dal nulla c’era in Aristotele, c’era ancora in Tommaso; poi si è perso nell’umanità moderna che ha cominciato ad attribuire alla materia stessa la capacità di causare. Proprio in questo consiste l’illusione del nostro pensiero riguardo alla materia. Il concetto di materia, in una scienza dello spirito, è il concetto di effetto: la materia subisce in tutto e per tutto, altrimenti non sarebbe materia. L’ovulo non ancora fecondato e lo spermatozoo non sono un nulla: perché? Non perché la materia sia una realtà vera e propria e perciò causante, ma perché in essi lavorano come architetti l’Io della madre e l’Io del padre, dunque l’Io di altri esseri spirituali. La fecondazione consiste allora nel fatto che l’Io spirituale dei genitori si ritrae da quella porzione di materia, che è l’uovo fecondato, per far posto all’Io del figlio che si incarna, dandogli modo di plasmarla a immagine sua.
Intervento: Quindi lo stesso DNA è creazione dal nulla?
Archiati: È la prima impronta dell’Io del nascituro sulla materia inerte. L’inizio della Genesi dice che la materia primordiale era “inane” e “vacua”: non si potrebbe meglio esprimere l’assenza assoluta di ogni forza plasmante sia a livello di pensiero (vacua) sia a livello di volontà (inane).
Intervento: Sono stata molto felice di sentire l’affermazione che la libertà consiste nel non copiare nessuno, e la reazione spontanea che ho avuto è stata: soprattutto non copiare se stessi. Credo che, ricollegandoci al fattore del DNA, l’eliminare le forze strutturanti per permettere al nostro Io vero di incarnarsi sempre nuovamente consista proprio in questo: nel non riprodurre e ripetere noi stessi. Ogni volta che vogliamo “andare là”, vuol dire che ci siamo già stati e allora non è interessante. Troppe volte riproduciamo le stesse parole, gli stessi atteggiamenti, gli stessi schemi relazionali...
Archiati: Fa parte della libertà superare la monotonia del ripetersi continuamente, ma l’essere nuovi ogni giorno significa confermare la propria identità, non metterla in questione. Abbiamo anche qui una polarità tra la dimensione di autoidentità costante dell’Io e la dimensione, che lei ha voluto sottolineare, della sua creatività sempre innovatrice. L’Io può rimanere fedele a se stesso unicamente rinnovandosi ogni giorno. La creatività è un confermare se stessi essendo ogni giorno diversi. Ci vogliono ambedue i poli. Qui è l’importanza di pensare in polarità, perché ogni unilateralità viene ogni volta sciolta dall’altra sponda. E l’importanza non è nei due poli, è nel movimento fra i due! Quel movimento continuo è l’arte della vita.
Intervento: Vorrei che affrontassimo il tema della bioetica in relazione ai trapianti. Su cosa fondiamo l’inopportunità del trapianto? Che differenza c’è nel trapianto di organi se il donatore è vivente o è morto? Quale legame karmico si crea tra donatore e ricevente?
Archiati: L’umanità è destinata a diventare un organismo spirituale unico non in senso metaforico, ma in senso reale. Come noi ci siamo smembrati nella prima fase dell’evoluzione, così tutta la seconda fase ci è offerta per rimembrarci gli uni dentro agli altri. Questo processo di riorganazione reale, a livello spirituale, presuppone naturalmente una spiritualizzazione della materia stessa: infatti, al livello attuale, l’interazione con la materia ha fatto sorgere nella coscienza umana l’illusione della separatezza, dell’essere divisi gli uni dagli altri. Il compito della libertà è quello di superare a tutti i livelli questa illusione, comprese tutte le conseguenze esistenziali. Nell’operare reale del karma noi non siamo separati gli uni dagli altri. Dov’è che lo siamo? Nella materia, quindi a livello di illusione: ma è un’illusione reale in quanto fatto di coscienza, come dicevo prima, perché se non lo fosse, non avremmo nulla da superare.
Se è vero che il destino ultimo dell’evoluzione è quello di un rimembramento reale, sostanziale e spirituale di tutti gli esseri – come avviene nell’organismo – ciò significa che non soltanto ci sarà un trapianto parziale, ma ci sarà un trapianto totale.
Dove abbiamo esempi di trapianti totali?
L’essere del Cristo ha rinunciato alla sua corporeità solare di luce per compiere un trapianto totale nella Terra facendone il suo corpo, per essere con noi nel cammino di umanizzazione di questa stessa corporeità. Ha fatto della Terra il suo corpo non in senso metaforico, ma reale. La Terra è il corpo del Cristo. Rudolf Steiner, in una conferenza tenuta a Londra, afferma: in base a questo sacrificio cosmico, a questo trapasso totale di corporeità, il Cristo lavora con le sue forze d’amore già da duemila anni nella Terra (che è il suo corpo), nella corporeità umana (che è la quintessenza del suo corpo) e in ogni spirito umano. Il Cristo è la parte migliore di ciascuno di noi e ogni Io superiore è un frammento, una particola del Cristo.
L’evoluzione cristica di rimembramento degli esseri umani gli uni negli altri è oggi al punto che ci sono già alcune individualità – poche, per ora, ma diventeranno sempre più numerose – che poco prima di incarnarsi e stabilire un rapporto formante con la materia caotizzata, vedendo prospettivamente ciò che li aspetta, si rendono conto che i fattori del loro progredire sono stati tolti ad altri che, perciò, sono rimasti indietro. E allora, volgendosi a un altro essere umano che è stato massimamente danneggiato in base alle molteplici opportunità che non ha preso per sé proprio per lasciarle a lui, decide di prendere su di sé il corpo dell’altro e di dare all’altro il proprio corpo.
In altre parole, in senso biologico reale questa individualità cede all’altra le sue forze plasmanti e fa sue quelle dell’altro. Immaginiamo quali rivolgimenti dovranno avvenire, quali “adattamenti”, per il fatto che il karma resta quello di ognuno, ma la corporeità è stata scambiata e con lei i genitori, l’ambiente ecc. Questa è una realtà di trapianto totale.
appendice
I trapianti di organi
La questione dei trapianti di organi interessa tante persone anche perché è di grande attualità. In questa aggiunta alla seconda edizione cerco di venire incontro al desiderio espresso da molti esponendo alcuni pensieri che collochino la realtà dei trapianti nel contesto più ampio di questo libro.
Una prima riflessione si rivolge alla differenza essenziale – cioè di natura – tra organismo e meccanismo. Il meccanismo è fatto di pezzi in sé morti, di parti estrinseche le une alle altre e perciò in tutto e per tutto sostituibili. Nell’organismo invece subentra una realtà aggiuntiva che chiamiamo vita o, nel linguaggio esoterico, corpo eterico. Queste forze vitali fanno dell’organismo intero una realtà vitale unitaria: i membri di un organismo vivente non sono pezzi meccanici o parti separabili e disinseribili, e non sono perciò sostituibili.
Quando estraiamo un organo da un organismo esso è realmente ancora compenetrato dalle forze vitali individuali dell’organismo da cui proviene, mentre vi rimane solo l’impronta plasmatrice, e non più l’azione attiva diretta, delle forze dell’anima e dello spirito del donatore. Ciò significa che un organo donato è ancora per qualche tempo vivente sul piano fisico, ma è morto dal punto di vista dell’anima e dello spirito.
Il fatto che l’organo sia ancora vivente sul piano fisico apre già a monte la grande e fondamentale questione morale sulla legittimità dei trapianti. L’essere umano a cui si espianta l’organo è fisiologicamente vivo, anche se solo a livello vegetativo, essendone stata constatata la morte cerebrale e l’irreversibilità dei traumi o delle patologie che hanno spento i processi di coscienza. Ma, seppure con l’aiuto delle macchine, l’organismo respira, il sangue circola, l’assimilazione nutritiva avviene ancora: dunque è improprio parlare di trapianto da morto a vivo, mentre è corretto parlare di trapianto da un uomo ridotto alla pura vita vegetativa a un altro ancora in possesso dell’intera compagine costitutiva umana.
Già di per sé questo dato di fatto si pone come motivo di profonda riflessione etica che mette a confronto due interpretazioni conoscitive opposte: una dice che l’espianto è un vero e proprio omicidio, l’altra dice che l’espiantare un organo è da porre sullo stesso piano della decisione di cessare l’accanimento terapeutico, con il vantaggio ulteriore di consentire la vita a un altro essere umano.
Per cercare di rispondere a questo profondo dilemma etico, vorrei qui proporre una terza via di considerazioni.
Trapiantando un organo ancora vivente in un altro organismo immettiamo nel corpo eterico del ricevente forze eteriche che gli sono per natura estranee, e che il suo corpo eterico, il suo corpo astrale (o anima) e il suo Io spirituale non possono far altro che combattere a oltranza, perché per natura sono loro nocive.
Come mai, allora, a volte il trapianto “funziona”, cioè l’organo trapiantato viene “accolto” senza rigetto? Ciò può solo avvenire nella misura in cui l’anima e lo spirito del ricevente – come abbiamo già detto a proposito degli effetti del materialismo – siano così rispettivamente “vegetalizzati” e “mineralizzati” da aver “animalizzato” il corpo fisico. Ciò comporterà nel ricevente la presenza di forze vitali eteriche molto più forti dal lato della “natura non libera” (dunque umanamente più deboli) e di conseguenza più ricettive nei confronti di un organo morto dal punto di vista dello specifico umano. Tant’è vero che la sperimentazione di trapianti fatta sugli animali va di successo in successo.
Come conseguenza il trapianto “ben riuscito” non può che aver accelerato ulteriormente il processo di vegetalizzazione dell’anima e di mineralizzazione dello spirito del ricevente che hanno dovuto animalizzare ancor più le proprie forze fisico-eteriche per adeguarsi alla nuova situazione.
Ciò induce a comprendere che il trapianto fisico di organi in sé e per sé non è mai per il bene vero del ricevente, perché non può che peggiorare la condizione evolutiva del suo strumento fisico-vitale. Dobbiamo allora chiederci per quale motivo l’Io vero si scelga quel tipo di malattia specifica che fa guastare del tutto un organo. L’abbiamo già detto a più riprese: lo fa per darsi la possibilità di lottare contro l’ostacolo e acquisire quelle forze positive che solo la lotta gli può conferire. E allora il trapianto è proprio il tentativo di “risparmiargli” o di impedirgli questa lotta! Ma l’Io vero la vuole e se ci opponiamo alla sua volontà col trapianto dovrà trovare un altro espediente di ripiego.
Se un essere umano ha il cuore danneggiato, la volontà del suo Io vero è di compiere con le proprie forze di libertà e creatività quel che compiono gli Esseri divini quando creano il cuore sano nell’organismo umano. Il cuore sorge in base a pensieri formanti – che lo fanno nascere –; a pensieri-sentimenti di infinite metamorfosi – che lo fanno vivere per tutta la vita –; e a sentimenti-volizioni che lo fanno morire nell’offerta di sé e nell’autoconsumazione a servizio degli altri.
Chi ha il cuore malato vuole, nel suo Io vero, pensare lui stesso coscientemente quei pensieri, vivere quei sentimenti, esplicare quelle volizioni che sono specificamente di natura “cardiaca”. Essi sorgono nell’Io, si trasfondono poi nell’anima, permeano tutto il corpo eterico, il quale crea dentro al corpo fisico il “cuore sano”. Nel caso del cuore i pensieri divini corrispondono alle leggi che reggono l’evoluzione stessa del sole in seno al nostro sistema solare, così come ogni altro organo del corpo umano è un concentrato microcosmico delle forze macrocosmiche che sono all’opera nell’universo (i reni sono il precipitato microcosmico delle leggi evolutive del pianeta Venere, il fegato del pianeta Giove, i polmoni di Mercurio, la cistifellea di Marte, la milza di Saturno…).
L’aiuto terapeutico “giusto”, il vero trapianto di forze che è del tutto in armonia col karma, avviene quando il terapeuta comunica all’Io dell’altro, cioè evoca in lui – da Io a Io! – tutte quelle creazioni spirituali che fanno sorgere il cuore sano. In questo modo avviene un realissimo trapianto – libero e amante – di “forze cardiache”, di natura dapprima animico-spirituale, da un essere umano all’altro. Ma ciò è l’opposto assoluto del trapianto di organi materiali dove, imponendo dal di fuori materia fisica e forze eteriche estranee al ricevente, si fa violenza al suo Io e alla sua anima che non hanno fatto un cammino di trasformazione libero e interiore per generare da sé e in sé le forze a partire dall’Io vero.
Vediamo allora anche qui confermata la nostra affermazione fondamentale che le vere cause – anche le cause che guariscono un organo rovinato! – sono sempre nello spirito e nell’anima e che al livello corporeo non vi sono che gli effetti di ciò che avviene prima nello spirito e nell’anima.
A mezza via, e proprio per non generalizzare, possiamo porre il caso di trapianto “da vivo a vivo” propriamente detto – il trapianto di rene, per esempio. Qui, pur restando valide tutte le riflessioni già fatte, è possibile ampliare lo sguardo più concretamente al contesto karmico del donatore e del ricevente nel caso in cui siano strettamente legati (fratello e sorella, genitore e figlio…). Entrano allora a far parte della vicenda altri fattori di comunione anche animico-spirituale che possono essere letti come un gesto di reciproca assunzione di responsabilità evolutive che, moralmente – cioè umanamente –, sono suscettibili di successiva “re-individualizzazione”. È però sempre questione di livelli di coscienza.
Perciò dobbiamo qui essere onesti con noi stessi fino in fondo. Dobbiamo dirci che il trapianto fisico può essere solo la premessa e l’inizio di ciò che deve avvenire in seguito. O il trapianto avviene per “salvare” la persona cara così da renderci possibile quel pareggio karmico – da spirito a spirito e da anima a anima – che renderà poi il ricevente, anche a livello fisico-corporeo, sempre più autonomo; oppure il trapianto lo si compie ignorando del tutto questo compito di rapporto umano animico-spirituale, o addirittura con l’intento di sostituirlo o di risparmiarcelo. È chiaro allora che, da un punto di vista “morale” e cioè umano, dobbiamo dirci: c’è trapianto e trapianto. Il significato e la realtà morali del primo tipo sono l’opposto di quelli del secondo.
E da qui troviamo il coraggio di tirare l’ultima conseguenza: il caso di trapianto “anonimo”, dove non avviene nessuna interazione d’anima tra donatore e ricevente, è chiaro che non si può valutare moralmente allo stesso modo di un trapianto che sia l’avvio per un comune cammino spirituale. Inoltre, se il donatore è una persona cara, il rapporto personale animico-spirituale col ricevente continua ad essere possibile anche in caso di morte dell’uno o dell’altro: ciò va però vissuto realmente e coscientemente!
Possiamo qui fare anche un accenno alle trasfusioni di sangue: anch’esse possono venir considerate come un “trapianto”. Nella stessa direzione Goethe diceva nel suo Faust: “Il sangue è un succo del tutto speciale!” proprio riferendosi alle forze dell’individualità, e la moderna scienza dello spirito vede nel sangue l’organo fisico dell’Io. Nell’attività e nella composizione del sangue l’Io manifesta se stesso in tutte le sue vicissitudini, momento dopo momento. Per questo ogni 24 ore il sangue di ogni essere umano si rinnova completamente – a differenza dei restanti organi della nostra corporeità che impiegano circa sette anni per lo stesso processo. Questa componente di velocità nella plasmazione dello strumento corporeo privilegiato dell’Io fa sì che “il trapianto di sangue” presenti, almeno esteriormente, rari effetti di rigetto: anche dopo essere stato conservato a lungo nelle celle frigorifere, il sangue del donatore viene immesso con successo nel ricevente.
Cosa significa? Significa che il sangue, proprio perché è l’organo fisico dell’Io, si snatura e muore subito “all’umano” appena viene estratto. Si riduce così alla stregua di un “cibo” per eccellenza animale che, assunto dal ricevente, viene immediatamente umanizzato e trasformato. Può in questo modo entrare in un organismo estraneo non per “impiantarsi” in esso, come si dice appunto nel trapianto di altri organi, ma per essere assimilato e metamorfosato dall’Io del ricevente nel giro di 24 ore.
Però qui dobbiamo chiederci: che cosa avviene in un organismo umano che “si nutre” di sangue umano “morto”? La risposta a questa importante domanda la troviamo ricordandoci che il nostro organismo trasforma tutto ciò che ingerisce in sangue. Deve perciò compiere un massimo di lavoro di trasformazione riguardo ai vari elementi minerali che sono nel cibo: li deve “vitalizzare”, “animare” e “umanizzare” per renderli sangue umano a immagine dell’Io spirituale. Il lavoro è già di meno riguardo ai vegetali: qui restano solo due gradini intermedi per arrivare all’umano. Il mangiare carne animale, infine, indebolisce il corpo fisico umano nella sua qualità umana perché lo esonera dal compiere quel lavoro di trasformazione delle piante (cibo degli animali erbivori) in “cibo animato” perché l’ha già fatto l’animale al posto suo, con forze animiche ovviamente animali.
Quando perciò un corpo umano “si nutre” di sangue umano morto gli viene tolta ogni possibilità di essere umanamente attivo. L’Io del ricevente si appropria di un processo già svolto da un altro Io e da quell’Io stesso interrotto prima di compiere l’ultimo atto per eccellenza umano: quello di trasformare il sangue in forze d’amore, in forze di vita da vivere per gli altri. È questa la suprema sublimazione della materia – il trapasso vero dal fisico all’eterico vivente – che Rudolf Steiner chiama “eterizzazione del sangue”, e che si compì nell’etere di tutta la Terra, in modo archetipico e sommo, al versamento del sangue del Cristo alla sua morte in croce. La trasfusione del sangue come fatto fisico in sé e per sé, senza che venga accompagnata da un cammino dell’anima e dello spirito, rende perciò il ricevente, che già ne ha poche nel suo Io, ancora più povero di forze d’amore. Egli viene per così dire costretto a diventare sempre più istintuale e sempre meno amante.
Inoltre, il fatto che nel “trapianto” del sangue non vi sia sofferenza denota proprio quanto siano “micidiali” l’illusione e l’inganno che ci inducono a pensare che se non si soffre si è “sani”. Ciò contribuisce a confermare e ad aggravare la mentalità materialistica che ritiene che tutto sia a posto quando non c’è sofferenza, quando non c’è lotta, quando non c’è nulla da fare. Abbiamo visto che in base a questa passività interiore l’essere umano viene sempre più degradato ai regni inferiori di pura natura, dove non c’è la libertà.
Questo non vuol dire però che la trasfusione sia in sé e per sé un male. L’abbiamo già detto: l’intervento sul corporeo è buono quando serve a rimettere l’anima e lo spirito in condizioni di esplicarsi in pienezza nella materia. Ma proprio qui è il punto: il materialismo è soddisfatto quando il corpo non fa sentire dolore e questo gli basta, anche se si omettono compiti evolutivi importanti per l’anima e per lo spirito. Non comprende che lo spirito in questo modo viene costretto a escogitare qualche altro tipo di “malattia” perché non sopporta di restare disoccupato.
Significativo, allora, non è mai quanto “sano” sia il corpo, bensì con quale intensità si evolva lo spirito. Uno spirito forte può scegliersi una corporeità forte che gli consenta di fare grandi cose per l’umanità. Ma un altro spirito altrettanto forte può anche scegliersi una costituzione gracile, così da poter lottare maggiormente ed esplicare nei confronti del corpo quelle forze animico-spirituali esuberanti che non possono restare oziose. I nostri corpi sono oggi più deboli e mineralizzati – meno vitali – di quelli degli antichi Greci. È un male, uno svantaggio? Dipende. Se la maggiore debolezza corporea viene vissuta come sfida a far sprigionare maggiori forze animico-spirituali, è un bene. Se viene presa come scusa per fare l’opposto, è un male.
Anche la trasfusione di sangue è moralmente buona se crea il presupposto corporeo per una rigenerazione animico-spirituale da Io a Io. Chi riceve la trasfusione aumenta dapprima la sua labilità e perciò anche la sua capacità di ricevere aiuto. Questo aiuto non lo può conferire il donatore perché donando il suo sangue fisico morto egli “rinuncia” a un suo influsso di tipo animico-spirituale. È colui che fa la trasfusione – il medico o anche l’infermiere – e soprattutto i cari che dovrebbero assumersi questo impegno eminentemente karmico.
Va aggiunto che il fenomeno complessivo dei trapianti è solo il polo estremo di un atteggiamento terapeutico di stampo materialistico, che anela a un uomo fisicamente immortale e che si manifesta anche a livelli meno vistosi. Per esempio i vaccini “contro” questa o quest’altra malattia sono tutti interventi che mirano, secondo la mentalità oggi prevalente, a impedire l’affacciarsi stesso della malattia e il conseguente processo attivo e positivo della guarigione.
Anche riguardo alle vaccinazioni esprimo qui solo alcuni pensieri fondamentali che non intendono certo “risolvere” la complessa e controversa discussione pubblica ancora aperta su questo tema, ma vogliono in tutta semplicità esporre delle prospettive di riflessione per chi le voglia prendere sul serio come iniziali ipotesi di lavoro.
Lo scopo di tutte le malattie – in particolare di quelle infantili – non è soltanto quello di rafforzare l’essere umano nel suo spirito e nella sua anima, ma soprattutto quello di rendere più forte e vigorosa la sua costituzione fisica. L’organismo fisico diventa più robusto non quando evita di affrontare le malattie, ma quando lotta per vincerle. Un corpo fisico che ha vinto più malattie di un altro è in realtà più forte, è capace di maggiori imprese e si potranno esigere da esso molte più fatiche fisiche, se queste saranno necessarie per il cammino spirituale.
Da ciò deriva che l’impedire tramite le vaccinazioni l’insorgere delle malattie – e la conseguente lotta positiva contro di esse – a lungo andare indebolisce la forza di resistenza immunologica dell’organismo stesso. Per esempio, tanto per mostrare uno degli effetti più manifesti, esso verrà reso più soggetto alle molteplici “allergie” che prima della prassi dei vaccini nell’umanità semplicemente non c’erano. Il corpo diventa allergico a tante cose perché è nel suo insieme troppo debole, essendogli stata inflitta la “proibizione” di cimentarsi con tutti quegli ostacoli che l’Io vero desiderava trascorre e superare, in vista del rafforzamento interiore e corporeo.