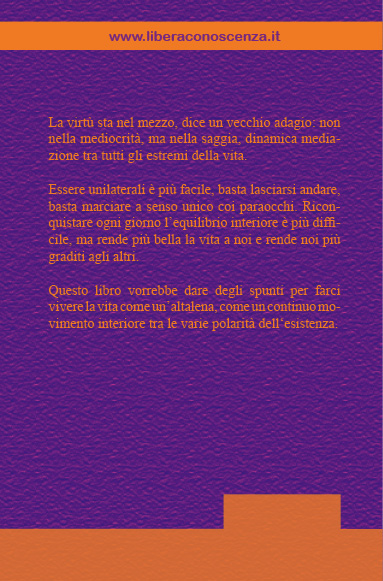Indice
Primo Capitolo
integrazione delle culture
nell’integrità del cuore umano
• Siamo tutti sdoppiati?
• Le due sponde dell’essere e l’equilibrio del ternario
• Libertà strabica nei popoli d’oriente e d’occidente
• Fratellanza miope sia all’est che all’ovest
• Uguaglianza presbite sia in oriente che in occidente
• Le false mediazioni
• La Trinità in noi, tutta per noi
Secondo Capitolo
la virtù sta nel mezzo:
nell’uomo mediatore
• La capacità umana di produrre immagini
• Il processo conoscitivo come continua mediazione
• La ferita di Anfortas
• Il “peccato” originale: un decadimento della coscienza prima che della moralità
• Universalità nel pensare e tolleranza nell’agire
• Tratti fondamentali di ogni mediazione: mobilità, attività, individualità
• L’individualità forte non ha bisogno di alcun potere
• La mediazione che di ogni morte fa una resurrezione
• La tentazione dei salti mortali
• Come mediava Platone
Terzo Capitolo
tecnica e morale:
di pari passo in direzioni opposte?
• Il mio bene, il mio male
• Il sacro e il profano
• Profanazione dell’umano nella scienza, nel diritto e nell’economia
• Tre modi di alienare la persona umana
• Come si costruisce la libertà
Quarto Capitolo
idealità e realtà
nella vita dell’anima
• Egoismo e altruismo: i due mezzi amori
• C’è qualcosa di male ad amare se stessi e pochi altri?
• Come ricomporre le due metà dell’amore?
• La socializzazione dell’egoismo e l’individualizzazione dell’altruismo
• L’amore esteso nel tempo e calato nello spazio
• Fiducia in sé e negli altri
• Il raziocinio analizza e il cuore intuisce
• Pazienza e tempestività nel rispondere alle domande della vita
• Istinti sociali e antisociali nella comunicazione dei pensieri
• Istinti sociali e antisociali nella sfera dei sentimenti
• Istinti sociali e antisociali nella volontà
Quinto Capitolo
ordine naturale e ordine morale:
come rimarginare la ferita più profonda?
• II coraggio di guardare all’intera evoluzione
• L’Io umano alla ricerca di se stesso
• Stiamo tutti imparando a diventare divini?
• Ogni uomo è causa ed effetto di se stesso
• La forza creatrice dello spirito si sperimenta, non si dimostra
• L’abisso dell’involuzione umana
• Il razzismo genetico
• Gli effetti della moralità umana sulla natura
• Una novella buona
A proposito di Pietro Archiati
Primo Capitolo
Integrazione delle culture
nell’integrità del cuore umano
Capire meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo: questo lo sforzo che più ci costa ma che dà anche maggiori soddisfazioni e che non può certo avvenire in base a pure teorie.
Si tratta di dar fiducia alla vita agguantandola, tuffandosi nel quotidiano ad osservare ciò che avviene dentro e attorno a noi. Presenti in ogni esperienza col nostro intero essere per comunicare, sia coi pensieri che con le azioni. Pur nella diversità, i vissuti di tutti noi sono avvolti da quell’aura che chiamiamo lo spirito del tempo – del nostro tempo – e che ci avvolge della sua complicità inenarrabile e accattivante; una tacita intesa che ci fa sentire, a pari diritto, “contemporanei”. Questa comunanza di fondo, che non conosce confini di popoli o nazioni, ci sprona ad approfondirne il carattere, per meglio capire il senso della nostra epoca e dell’evoluzione offerta a ciascuno.
Siamo tutti sdoppiati?
Chi di noi può dire di non essersi mai sentito come spaccato in due, lacerato interiormente dalla tensione che nasce tra i pensieri che vogliono la perfezione e la realtà della vita, piena di mezze misure e compromessi? Questo nodo esistenziale spesso lo esprimiamo con le parole: sì, sarebbe bello, ma... Emerge più che mai oggi, in questo sentire, l’anima moderna che si sente scissa tra un’idealità concepita sempre più sublime e la greve prepotenza delle forze di natura, tesa tra uno struggente desiderio di bontà e di bellezza e il prosaico capitolare di fronte a ogni più piccola difficoltà. Fragili ed evanescenti si mostrano gli ideali più belli di fronte alla durezza degli eventi, alla difficoltà degli incontri, al peso ineluttabile dei “fatti”.
Di più. È proprio caratteristico della nostra natura vedere l’esistenza in termini di contrapposizioni, di polarità che appaiono incompatibili fra loro così da ritenere impossibile qualsiasi riconciliazione. Ci si butta allora dall’una o dall’altra parte per proiettare istintivamente un lato della vita che non riusciremmo ad integrare. Una specie di mondo alternativo, fatto a bella posta per non sentirsi privati di qualcosa.
È sintomatica la serie Harry Potter: un fenomeno culturale quanto mai interessante. Si è fatta la fila davanti alle librerie – cosa mai successa – per comprare il quarto volume, dove continua a venir descritta l’evoluzione di un bambino, in cui scorre sangue di mago. Va a scuola di magia mentre il mondo dei cosiddetti “normali”, dei Babbani cioè, non s’accorge di nulla. E a questo punto nella sua vita si succedono a rotazione fatti e fenomeni solitamente impossibili, e si finisce per venir trasportati in un mondo di fantasia dove il miracoloso, buono o cattivo che sia, diventa normale proprio perché viaggia su binari che esulano del tutto da ciò che ci è familiare.
La matrice culturale laico-borghese e quella religioso-clericale, sono le due principali fonti dei fenomeni d’evasione, creati apposta per riparare, seppur fuggevolmente, i danni di una dura realtà. Infatti la letteratura e l’arte in generale da un lato, e la religione dall’altro, hanno perso sempre più la capacità di trasformare la vita. Separate da essa, vivono come fantasmi in un mondo parallelo a quello reale. Quando si è stufi del tran tran quotidiano, ci si rifugia in quell’altro mondo bello e pulito in cui tutto diventa possibile, compresa una felicità senza tramonti. Tutti ogni tanto andiamo a farci capolino: si comincia per distrarsi un po’, per immaginarsi diversi, e si finisce per cascarci dentro.
Ma ci sono stati tempi in cui la letteratura era vita: un Dante non scherzava con la Divina Commedia! Ma se avesse saputo che pochi secoli dopo milioni di individui l’avrebbero ridotta a un godimento puramente estetico – senza saperci ricavare alcuna forza dirompente per la propria vita – forse gli sarebbe passata la voglia di scriverla (o ci avrebbe sprofondati tutti nel suo inferno). Meno male che non sapeva che tipo di umanità stesse per nascere.
Ed altrettanto nel Faust si trova tutto lo spessore morale della vita di Goethe, la tensione titanica del suo spirito in incessante evoluzione. Chi lo legge non può distrarsi dalla propria esistenza ma, al contrario, viene spinto a ficcarsi in essa con maggiore determinazione.
E così andando ancora più indietro nel tempo – a Shakespeare, per non parlare del teatro greco – vediamo il popolo, e non solo i colti, accalcarsi sulle platee per vivere lo spettacolo e farlo proprio, mentre “il popolo” di oggi ama le fìction, la vita recitata, e lì parcheggia per due boccate d’aria finta.
Analogamente, l’Europa – e con lei tutto l’occidente –, a quella religione che nel passato costituiva il cardine dell’esistenza, concede lo spazio di un’ora soltanto la domenica mattina, e per di più ci si dedicano le poche persone che ancora hanno l’abitudine di andare in chiesa. Oppure l’antico spirito religioso riemerge camuffato in attività di volontariato a carattere sociale che manifesta, sotto altra forma, il bisogno di ritagliarsi quegli spazi di bontà, bellezza e verità, che sembrano non esserci più nel quotidiano, e che bisogna andare a cercare in attività eccezionali. Ritagli, per lo più, brandelli morti che vivono di nostalgie, se non di smemorato rimpianto.
Le due sponde dell’essere e l’equilibrio del ternario
È proprio così. La nostra natura d’uomini tende a farci vedere il mondo scisso in polarità! Ma ci sono contrasti che non è concesso evitare e dove ci tocca per forza essere unilaterali. Detto così, sembra quasi una condanna: sei costretto a scegliere, o di qua o di là, o bianco o nero, o Guelfo o Ghibellino. Se prendi una posizione escludi l’altra. Non c’è scampo e ti tocca perdere l’altra parte del mondo. Se sei maschio non puoi essere femmina; se sei italiano ti puoi scordare di essere tedesco; se appartieni a una razza, le altre non sai dove stanno di casa; se sei un uomo di mondo devi rinunciare ad essere santo e se hai un talento, scopri che te ne mancano mille altri...
Non solo l’esistenza ci si presenta divisa da sponde che ci costringono a scegliere a quale approdare, ma anche ciò che viviamo e conquistiamo ci viene incontro col carattere della parzialità. Ogni scelta di direzione implica dunque un’esclusione, anzi parecchie. È una situazione disgraziata, la nostra?
E c’è da rammaricarsi se la natura o il contesto geografìco-culturale in cui viviamo non sono stati in grado di donarci quell’interezza che va al di là di ogni lacerazione? La risposta è un deciso no. Proprio da queste incompiutezze trae vigore la nostra libertà, come gli ideali più belli e le forze migliori vengono generati da ciò che ancora ci manca.
Ci sono due modi nuovi di vivere la vita e che vengono incontro alla nostra fame d’infinito in quest’inizio di millennio. Uno è quello di ampliare la conoscenza dell’umano col nostro pensare capace di farci comprendere perché, nella vita, ci si presentano spesso situazioni così schizofreniche; l’altro è quello di colmare le nostre lacune, attivando maggiormente la forza di volontà. Sia l’uno che l’altra ci consentono di diventare degli artisti della mediazione fra tutti gli opposti della vita. Una ginnastica interiore che ha lo scopo di mantenerci vivi, rendere più bella l’esistenza e migliorare il nostro cuore.
Nel fiume che scorre tra le due sponde dell’essere – l’ideale e il reale – l’ideale può diventare sempre più reale e questo sempre più ideale. Grazie alla vivezza interiore che scioglie ogni rigidità e fa incontrare gli opposti, sia dentro che fuori di noi. Essi portano all’uno notizia dell’altro, ascoltano i loro reciproci richiami che creano e ricreano equilibri mai statici come tutto ciò che è vivente.
L’essenza del cristianesimo – e per cristianesimo s’intende qui umanesimo, dove il peso morale dell’uomo è posto al centro di tutta l’evoluzione – è una specie di filo d’oro che segna il compito evolutivo dell’essere umano. Quello di mediare fra gli estremi, così come è stato capace di fare il Mediatore per eccellenza, quando si è fatto carne. In lui, e tramite lui, spirito e materia si ricongiungono archetipicamente per conferire l’uno pienezza all’altra. E l’uomo si colloca come pontefice, come artefice di quell’arco di ponte che abbraccia cielo e terra, un arcobaleno invisibile che ci fa procedere avanti e indietro tra un mondo e l’altro.
Si fa umano il mondo della materia quando si apre verso lo spirito e in esso scioglie i suoi determinismi risorgendo a libertà. E umano si fa lo spirito quando cessa di vivere disincarnato, sdegnando quella materia che gli fa paura. E decide di amarla quando scopre in sé la forza di saperla trasformare, e nella materia trova la sconosciuta magia capace di umanizzare lui stesso, perché lo spirito si umanizza unicamente rituffandosi infinite volte in quel mondo visibile che gli sembra estraneo. E il mondo della materia acquista un volto umano nella sua tensione verso lo spirito creatore che s’incarna nell’uomo; ma ciò che consente il loro millenario incontro è la passione degli opposti che si cercano, quel puro amore che può scaturire solo nel cuore degli uomini, fatto esso stesso di carne e di spirito.
Libertà strabica nei popoli d’oriente e d’occidente
Dai tempi della rivoluzione francese hanno fatto ingresso nella cultura tre grandi ideali: quello della libertà di ogni essere umano, quello della fratellanza o della solidarietà di tutti con tutti, e quello dell’uguaglianza, della pari dignità cioè di ogni uomo. Tanto belli sono quegli ideali, quanto è difficile conciliarli fra loro: se si vuole un’assoluta uguaglianza non si deve forse limitare la libertà? E se non si accettano compromessi in fatto di libertà, come sarà possibile vivere in piena fratellanza? Sono così sorte nell’umanità due grandi matrici culturali: una che ha privilegiato la solidarietà a scapito della libertà e l’altra che ha difeso a spada tratta la libertà a scapito della solidarietà.
Sia la lingua russa che quella americana hanno una parola che significa “libertà”. Ma sarebbe un errore pensare che essa venga vissuta in modo similare sia in America che in Russia. La liberty americana è quella dell’imprenditore che trasforma la terra, costruisce macchine, produce merci nella libera esplicazione dei suoi talenti individuali, del tutto dedito alla conquista del mondo visibile, mentre del mondo spirituale poco si occupa, ed a malapena ci pensa. Quando in America infatti risuona la parola spirit, la maggior parte della gente non sa di cosa si tratti, o forse pensa a qualche tipo di alcool.
Se chiediamo invece a un russo a cosa pensa quando pronuncia la parola svoboda (libertà), farebbe fatica a trovare le parole giuste. L’anima orientale – sia quella russa (quella autentica, però, che esce tuttora illesa dalla cappa di piombo del suo pluridecennale ateismo storico), sia quella indiana o cinese... – quando parla di libertà si riferisce alla sua comunione con esseri spirituali, e pensa alla preghiera, e pensa a quella liberazione ultima che è la morte, a quando le scrollerà di dosso ogni pesantezza della terra consentendole di sentirsi davvero libera nei mondi illimitati dello spirito. L’esperienza della libertà è, per l’uomo orientale, il sapersi un essere spirituale in un mondo di spiriti. Un’esperienza parziale però, e che viene vissuta pagando lo scotto di una scarsa maestria, là dove sarebbe necessaria una sapiente organizzazione per incidere sulla realtà terrestre.
Quale di queste due esperienze della libertà è più bella, quale più vera? La risposta è che tutt’e due fanno ugualmente parte dell’umano. Affinché l’umano emerga per intero e non lacerato, vanno riconciliate fra loro. Va creata una vera e propria cultura di mediazione.
Una cultura ancora tutta da inventare perché anche l’Europa, posta com’è tra oriente e occidente, ha vissuto in modo drammatico lo scorrere parallelo – lungo la cortina di ferro – del materialismo occidentale e dello spiritualismo orientale, e insieme la loro incapacità di sapersi abbracciare. Il grande compito che incombe sull’umanità di oggi è quello di operare la sintesi che consenta allo spirito di non rifuggire più dalla materia, bensì operarvi dentro; e insieme trasformare la materia così che non sia più refrattaria allo spirito umano, ma si orienti verso di esso.
Una simile esperienza di libertà, comprendente sia il libero intraprendere nel mondo della materia sia il libero creare nel mondo dello spirito, si è già affacciata, soprattutto nell’Europa centrale, duecento anni fa circa, nell’individualità di Goethe e in quella degli idealisti. Ma si è poi oscurata quando l’Europa ha fatto proprie le teorie di Darwin e di Newton, idee che hanno portato a disconoscere la realtà dello spirito.
Compito di una cultura di mediazione, in cui spirito e materia s’incontrino, è quello di porre al centro dell’esistenza né la realtà della terra, come fa l’occidente, né il puro spirito, come avviene nel mondo orientale, ma l’uomo, che è il luogo d’incontro di questi due mondi. Solo nei pensieri, nei sentimenti, nelle azioni della persona umana, si realizzano, cercandosi a vicenda, terra e cielo. Nell’uomo vive la libertà che percepisce la terra nella sua oscura aspirazione verso lo spirito, e allo stesso modo la libertà dello spirito creatore, nel suo perenne trasformare ogni atomo di materia.
Fratellanza miope sia all’est che all’ovest
L’altro grande ideale dell’umanità moderna è la fratellanza. Tutte le culture e le religioni orientali sono sorte millenni or sono quando l’individuo non sapeva ancora definirsi nella sua autonomia interiore, come poi invece è accaduto in occidente, a partire dal Rinascimento. L’individuo in tempi remoti era in tutto e per tutto a servizio della comunità. E ancor oggi il concetto di solidarietà pone in oriente la comunità al di sopra dell’individuo, chiedendogli di offrirsi sull’altare della causa comune. Basti pensare alla Cina. Che poi l’altare comune sia il partito comunista o la religione taoista è di secondaria importanza.
Al contrario in occidente l’esperienza della solidarietà si colloca da tutt’altro lato. Un imprenditore angloamericano non nega la necessità della reciproca collaborazione insita nella suddivisione del lavoro, ma la interpreta alla maniera di Adam Smith. E cioè secondo le ferree leggi del mercato e le impersonali corrispondenze tra la domanda e l’offerta. I capisaldi del capitalismo occidentale spianano a ciascuno la via per affermarsi secondo le proprie individualissime capacità e ritengono così di creare la migliore delle società possibili. Ponendo in primo piano la libertà, si pensa che ognuno dia il meglio di sé e la loro somma sarà il meglio per tutti.
Questa interpretazione della fratellanza disattende però ciò che avviene a coloro che hanno pochi talenti in quello che viene considerato il solo campo reale ed utile: quello della produzione di merci da immettere nel mercato. Se non sei capace, se non sai difenderti, se non vali come individuo che produce, altro che fratellanza! Verrai abbandonato a te stesso, nessuno si accorgerà di te e la comunità ti ignorerà. Per essa tu sei solo un peso. La comunità, così intesa, si riduce solo alla legge cieca del mercato.
Tra l’individualità dissolta nella comunità e l’emergenza asociale degli egoismi dell’individuo, deve sorgere un tipo d’uomo che sappia mediare tra queste unilateralità. Un surrogato di fratellanza che sacrifica i talenti individuali, impoverisce sempre più la comunità; come la ricerca di una specie di libertà che non ponga argini agli egoismi del singolo, espone lui e la società allo sfacelo. C’è una profonda reciprocità tra il bene comune e quello individuale. Lungi dall’escludersi, l’uno presuppone l’altro.
Uguaglianza presbite sia in oriente che in occidente
Il terzo grande ideale dell’umanità moderna è quello dell’uguaglianza. A tale riguardo sono sorte due culture, in oriente e in occidente, polarmente opposte e reciproca-mente esclusive. E alla fin fine perciò profondamente unilaterali.
L’occidente sottolinea l’uguaglianza dei diritti lasciando in sordina quella dei doveri. L’oriente al contrario insiste sull’uguaglianza dei doveri mettendo fra parentesi quella dei diritti. Dove il sole sorge ci si sente uguali perché si hanno gli stessi doveri, eminentemente morali, nei confronti della comunità e ancor più della Divinità. Si vive una parità di natura morale e religiosa. Dove il sole tramonta, invece, – e tutta la Costituzione americana fa testo – l’uguaglianza si fonda sui pari diritti degli esseri umani.
È un pasticcio non da poco quello sorto all’inizio del secolo scorso in base alla proclamazione del diritto d’ogni popolo all’autodeterminazione. Questo progetto è stato lanciato dall’allora presidente Woodrow Wilson. Non è un’affermazione di per sé sbagliata, ma è di un’ingenuità quanto mai “presbite”, perché appunto come quella orientale, non vede ciò che ha sotto il naso.
Dichiarare che ogni popolo ha diritto all’autoaffermazione è come dire che nel corpo umano ogni organo ha diritto all’autoaffermazione; o che in un matrimonio vige la legge suprema del diritto di ciascuno all’affermazione di sé. Manca del tutto, in questa bella trovata, l’altro verso della medaglia: e cioè che ogni popolo (come ogni membro di una famiglia) ha perlomeno il dovere di rendere possibile agli altri l’esplicazione e l’esperienza dei loro diritti. Se si parte dal concetto che ogni popolo deve tutelare il proprio diritto d’amministrarsi come meglio crede, e il popolo vicino vuole lo stesso, e l’altro accanto pure, è inevitabile che prima o poi questi diritti risultino conflittuali fra loro, e tutto resti lì dov’è. Una bella teoria, astratta e impraticabile.
Esiste però un terzo tipo d’uguaglianza di matrice schiettamente cristiana. Esso abbraccia l’interezza dell’umano e tende a mediare fra gli estremi. Una parità derivante dalla dignità riconosciuta in ogni uomo e in modo uguale, in quanto uomo. Consiste nel fatto che tutti gli uomini hanno da un lato un pari diritto di appagare i propri bisogni e d’esplicare i propri talenti, e dall’altro un ugual dovere di rendere possibile questo anche agli altri. Tutti i diritti che io avoco a me stesso ho il dovere di concederli al mio simile, e in questo consiste l’equilibrio di parità fra i diritti e doveri della persona umana.
L’affermazione di Wilson funziona solo se ogni popolo che vuole affermare i propri diritti dà ugual peso a quelli degli altri popoli. E lo stesso vale per il singolo: non basta affermare che ognuno ha il diritto all’autodeterminazione. Accanto al mio devo riconoscere il diritto dell’altro a decidere per sé, e questo mi pone il dovere di renderglielo possibile. Non potrò dire: che si arrangi, che pensi per sé. L’umano vive nella parità di diritti e doveri. È come un’altalena che si muove fra i due opposti poli dell’esistenza.
L’occidente dice: chi fa per sé, fa per tre. L’oriente risponde: chi fa per tre, fa per sé. La coincidenza degli opposti afferma: tutti per uno, uno per tutti.
Le false mediazioni
Ma ciò che vale per l’oriente e l’occidente, in relazione al carattere fondamentale di una data cultura, non vale per le singole individualità. Proprio perché la cultura nel suo insieme è unilateralmente materialistica, c’è in America, più che altrove, la tentazione per l’individuo di riscoprire una forma di spiritualità del tutto avulsa da una vita fin troppo materialistica. E allora va a cercare tale spiritualità in oriente. La Teosofia, il movimento New Age, sono fenomeni importati. Il risultato è il classico banchiere che, uscendo dalla borsa di Wall Street, va a fare la meditazione yoga, o si avventura in viaggi astrali, per poi tornare in borsa. Due mondi paralleli che non hanno nulla a che fare l’uno con l’altro.
Lo stesso accade in oriente dove – il Giappone ne è un esempio – si diventa più realisti del re nell’occidentalizzarsi, trasferendo poi i connotati orientali della socialità nella dedizione assoluta e ossessiva al servizio verso la propria nazione.
Lo stesso fenomeno era rintracciabile nello stacanovismo russo.
Mentre le due unilateralità del materialismo occidentale e dello spiritualismo orientale costituiscono, nei loro luoghi d’elezione, un modello a suo modo stabile e conchiuso, l’Europa vive in una vera e propria schizofrenia culturale e nel pieno di una profonda lacerazione. E questo perché in sé alberga le due matrici culturali, senza essere pervenuta ad una loro reale armonizzazione.
L’oriente e l’occidente convivono in Europa costantemente paralleli. La vita della scienza, della tecnica, dell’industria, della politica e dell’economia va con l’occidente, mentre il mondo della morale, della religione, dei sogni e degli ideali si è rivestito di tutte le connotazioni orientali. Il cristianesimo, sorto in medio-oriente, è storicamente divenuto il fulcro della cultura europea ma finora è stato vissuto secondo una prospettiva prevalentemente orientale. Non si è radicato nella vita quotidiana sempre più rivolta al progresso tecnico e al dominio della terra. Di fronte alla prepotenza della vita cosiddetta concreta, gli ideali cristiani sembrano sempre più inadatti a trasformare il reale. Si sono talmente impauriti di fronte alle conquiste della tecnica, da essersi come ritirati in sagrestia.
L’ideale della pace valga come esempio. L’occidente pensa di tutelarla stabilendo dappertutto la legge del più forte – cioè la sua –, mentre la pace orientale è una fuga dalle competizioni e dalla lotta stessa per la vita, mirando alla salva- guardia dei propri valori morali. L’Europa non riesce a proporre una terza via, perché di fronte alle lotte inevitabili e connaturali al cammino umano, tende ad assolutizzare sempre di più l’ideale, a volerlo perfetto, inflessibile ed alla fin fine irrealizzabile. Tra l’attivismo frenetico del materialismo e la nostalgia dei mondi sognanti dello spiritualismo, si rischia sempre più di vivere con un sentimento d’irrimediabile lacerazione e fallimento.
Realizzare l’umano, significa rimarginare in modi nuovi questa profonda ferita, rendere la fatica quotidiana sempre più ideale, e questo può accadere proprio incarnando gli ideali in tutti gli episodi dell’esistenza. Ciò può avvenire solo a poco a poco, un passo dopo l’altro. Perché l’ideale non resti un qualcosa campato per aria, ci si deve accontentare di realizzarlo dapprima solo in parte: altrimenti non è un ideale, bensì un’alienazione. Tendere all’impossibile è un modo comodo per rinunciare a tutto. Umano è solo il realizzabile, che non ci costringe a vivere in due mondi alternativi: uno fiondato fra le nuvole e l’altro incuneato nella terra.
La Trinità in noi, tutta per noi
Della Trinità si parla non solo nella cultura cristiana ma anche nelle religioni precristiane. E ciò perché il concetto di Trinità indica ogni tipo di mediazione fra due realtà contrapposte, ogni sorta di riconciliazione fra estremi. L’abitudine a considerarla una difficile faccenda riservata solo ai teologi, ha finora impedito di coglierne la valenza nella comprensione dell’umano stesso, e per l’azione che potrebbe esplicare all’interno della nostra vita quotidiana.
Tutta l’esistenza umana ha infatti una struttura trinitaria, e questo è un concretissimo punto di partenza.
Osservando il modo d’essere e di vivere dell’uomo, riscopriamo nella loro realtà quelle stesse caratteristiche trinitarie che ci rimarrebbero inaccessibili se volessimo coglierle direttamente nella Divinità fuori di noi. Nell’ambito della nostra evoluzione abbiamo a disposizione esperienze reali, tutte percepibili, che ci consentono di porci questa domanda: se vediamo l’umanità procedere secondo una triade di forze – il volere, il pensare e il sentire – è possibile che questo procedere rifletta, a livello umano, le stesse leggi che reggono l’intera evoluzione del mondo?
Le tre qualità supreme del reale, che la tradizione cristiana attribuisce a Dio, sono l’onnipotenza, l’onniscienza e l’amore.
L’essere divino si manifesta come Padre nella sua onnipotenza e volontà suprema. Si esprime in leggi di natura talmente affidabili, che nessuno di noi dubita che domani il sole sorgerà a una certa ora, le piante cresceranno in un dato modo, gli animali seguiranno il loro istinto e che gli uomini continueranno a respirare e a digerire come sempre. E questo riguarda l’intera corporeità della natura, compresa quella umana, nella quale vige la potenza magica degli impulsi volitivi divini – la scienza li chiama leggi di natura – con un’azione diretta che mantiene e regola ogni fisicità.
All’opposto, come manifestazione di una qualità polare, l’essere divino viene chiamato Spirito Santo, che è l’onniscienza di una saggezza essa pure infinita. È un tipo di coscienza che, dal punto di vista dell’uomo inserito nello scorrere del tempo, abbraccia nel presente – con “presenza di spirito” – anche ciò che per la coscienza umana deve ancora venire. Per questo nella tradizione cristiana questa qualità divina si chiama anche “provvidenza”, in quanto tutto prevede. E da essa sono nate tutte le ardue riflessioni umane sul concetto di predestinazione (pensiamo ad Agostino) riferito al nostro stesso essere.
La forza mediatrice, quella che ricrea l’equilibrio tra l’azione magica della volontà e la saggezza luminosa del pensare, viene chiamata Figlio, che ha in sé la forza dell’amore, cioè del movimento di tensione tra i poli della vita. Ed è proprio nel mistero della mediazione, che solo l’amore può compiere, che vive l’essenza dell’umano. Paolo di Tarso scrive: i greci hanno cercato e goduto la sapienza – in Grecia è nata la filosofia e l’impulso umano al pensiero –; i giudei vivono il divino nei portenti di Jahve – il Vecchio Testamento racconta la storia delle sue gesta vittoriose –; noi, continua Paolo, tra la sapienza e la potenza predichiamo l’essere divino che si manifesta in quanto amore. Un amore che è impotente e folle.
Come può l’uomo-Paolo affermare questo sulla Trinità?
Lo può in quanto questa triade di forze si rende manifesta nell’uomo. In noi esiste l’impulso alla potenza – non si può essere uomini senza volere e senza fare tante cose –, la ricerca della saggezza – non si può essere uomini senza cercar di capire le cose – e ben più misterioso l’anelito all’amore, senza il quale non possiamo essere veramente uomini. Non è facile vederlo con gli occhi di Paolo questo amore, nella sua realtà terrena, inerme e folle. Eppure, anche a livello della vita quotidiana, io mi sento davvero amato dall’altro solo quando egli sa rinunciare almeno a un lembo della sua potenza e della sua sapienza.
Amare significa farsi liberamente impotenti per far posto alla libertà altrui. Finché agisco sulla volontà dell’altro, lo tratto come un bambino. Amo veramente l’altro solo quando rinuncio al mio impulso di potere, a volerlo governare, concedendogli così lo spazio necessario affinché sia lui a decidere del suo cammino. Se non abdico a questo mio inconscio potere, finisco per amare non lui bensì me stesso in lui, arrivando ad agire in un certo senso magicamente, con potenza. Ancora, per amare devo essere anche capace di rinunciare a voler indagare cosa sia meglio per lui, quando solo lui può sapere, di situazione in situazione, cosa sia bene per lui. E io sono completamente all’oscuro per quanto riguarda i fatti suoi. Amare vuol dire far posto alla libertà dell’altro nel suo agire e nel suo pensare.
Basandoci su questa esperienza umana accessibile a tutti, comprendiamo meglio l’affermazione fondamentale del cristianesimo. L’uomo non potrebbe vivere la sua libertà se la Divinità non si fosse manifestata amorevole, rinunciando, per quanto riguarda le faccende dell’uomo, alla sua onnipotenza e alla sua onniscienza. L’onnipotenza divina non si ritrae, beninteso, dalla conduzione della natura, ma dall’interiorità umana. Se l’essere divino volesse restare onnipotente fin dentro l’anima umana, nel mondo dei pensieri dell’uomo, dei suoi sentimenti e decisioni volitive, finirebbe per operare al posto suo, come fa nella natura. E l’uomo non potrebbe essere libero. La sua libertà si fonda infatti sulla libera rinuncia divina a essere onnipotente dentro di lui.
Analogamente, se l’onniscienza divina volesse intessere di saggezza l’interiorità dell’uomo, come fa per il suo corpo, potrebbe prevedere e di conseguenza predestinare ogni sua azione e pensiero. Il cristianesimo afferma dunque: alla Divinità sta più a cuore la libertà dell’uomo che non una sua preordinata saggezza. Nei confronti dell’uomo l’essere divino ha unito alla libertà la possibilità dell’errore, della tragedia e dell’abisso. E proprio ciò rende infinito il suo amore. Un amore senza la forza di sopportare gli abissi della libertà dell’amaro è un amore ancora incipiente e che cede facilmente alla tentazione di ritrattare la libertà concessa.
Se è questa la “conduzione” divina della nostra evoluzione, se così agisce l’essere divino quando si volge all’uomo fatto a sua immagine e somiglianza, come risponde oggi l’umanità all’operare divino? La cultura occidentale privilegia unilateralmente l’elemento del potere. Basta guardare alla tecnologia, alla volontà d’incidere sulla terra per dominarla, all’ingegneria genetica che, prima ancora di sapere ciò che fa, rivela il preciso intento di partecipare all’onnipotenza divina, una specie di alchemica magia vogliosa di decidere delle sorti dell’individuo.
All’opposto, in oriente, c’è una cultura che privilegia la saggezza.
Dell’uomo si apprezza il cammino di sapienza, divinamente ispirata, quale unica alternativa e argine all’infinita imperfezione del suo agire.
E l’amore, il sommo mediatore, dov’è allora? Nella leggenda del Parsifal, nata in Europa ma universalmente cristiana ed umanissima, due sono gli attributi dell’eroe: un puro pazzo agli occhi del mondo, un inerme che ha deposto ogni ambizione di potere. L’amore sorge ovunque l’uomo prenda talmente a cuore la libertà, da rinunciare a inchiodare l’altro col suo giudizio, a imporre o a indurre in lui determinate azioni e comportamenti. Come del resto accade all’essere divino che si rivolge all’uomo, così l’amore vero sarà sempre amore per la libertà dell’uomo, e vorrà con gioia spassionata essere inerme e folle.
Anche il genitore viene chiamato prima o poi a far posto al figlio rinunciando alla sua potenza. Gli concederebbe così di trovare il proprio spazio nel mondo, abdicando a voler sapere meglio del figlio quale sia per lui la via giusta da seguire. Questo è amore. Riuscire a decidere di non guidare più, dal di fuori, le proprie creature. E nella vita sociale, quando si tratta di andare in pensione e far posto ai più giovani, è possibile rinunciare a grosse fette di potere solo in una cultura che apprezzi l’elemento di mediazione e riconciliazione tra la potenza e la saggezza, che è amore puro. Non è forse da folli diventare vecchi e inermi e compiacersi di esserlo? Eppure ci sono anziani che ci fanno invidiare questa follia, facendoci desiderare di diventare come loro. Sono pochi, però. E chissà che i giovani d’oggi non riescano fra qualche decennio ad aumentarne notevolmente il numero.
Secondo Capitolo
SPIRITUALITÀ ORIENTALE
E MATERIALISMO OCCIDENTALE:
Verso un incontro o verso uno scontro?
La capacità umana di produrre immagini
Sentirsi in qualche modo interiormente lacerato, non è un male per l’uomo perché, non dandosi pace, viene spronato a conquiste sempre più nuove. Se riconoscersi in una condizione d’esistenza per tanti versi unilaterale è quasi ovvio, questa stessa condizione fa nascere in lui un sincero anelito a una sempre crescente integrazione e integrità.
Ci sono due modi fondamentali di vivere il senso di carenza interiore. Il primo è quello dell’unilateralità: se uno è squisitamente materialista, è perché gli manca, per ora, la capacità di apprezzare tutto ciò che è di natura spirituale. E lo spiritualista disincarnato è un uomo non meno parziale nella sua incapacità di godersi il mondo visibile.
Il secondo modo è quello della sdoppiatura. Questa nasce dentro, quando si vive alternativamente in due mondi diversi e opposti, e che non hanno alcun influsso l’uno sull’altro. Nessuno proibisce al materialista di andare devotamente in chiesa la domenica, ed il più fine spiritualista può non accorgersi affatto di quanto sia preda degli istinti di natura. La doppiezza interiore consiste proprio nel fatto che teoria e prassi si muovono in due direzioni opposte, senza che se ne noti la contraddizione.
Nell’unilateralità e nella sdoppiatura l’uomo perde il meglio di sé. Questo avviene quando, da un lato, cerca il puro spirituale, poiché lo spirituale “disincarnato” lo rende disumano, disdegnoso quasi di un dialogo con il mondo e con gli uomini; e dall’altro, perde se stesso quando si limita al puro materialismo, quando si abbandona cioè alle ferree leggi della fisicità che lo vincolano e lo sviliscono. In entrambi i casi, l’esperienza reale che egli fa, non sempre del tutto cosciente, è in fondo la stessa: perde la sua libertà interiore, il libero movimento tra i vari poli dell’esistenza, che è quel che più d’ogni altra cosa gli dà il senso completo dell’umano.
Un fenomeno oggi molto diffuso è il voler vedere l’invisibile attraverso l’assunzione di droghe. Con tali pratiche si perviene così a visioni di tipo allucinatorio; ma le allucinazioni sono immagini delle forze plasmatrici dei nostri organi fisici che smettono di lavorare dentro alla corporeità, perché a causa della droga vengono come spremute fuori dal corpo e proiettate all’esterno. Immagini che imprigionano chi vi si espone. Essendo poi di natura corporea, e perciò deterministica, hanno la caratteristica di togliere la libertà incatenando l’uomo alla percezione, in un’esperienza di puro incantesimo; mentre la percezione sensoriale ha la caratteristica opposta di lasciarci del tutto liberi. Questo è il primo di tre livelli di “immaginificazione” – proiezione d’immagini –, che l’essere umano ha quando le immagini vengono come estorte dal corpo tramite l’assunzione di droga.
C’è un secondo tipo di formazione di immagini dovuto alla nostra coscienza ordinaria, che ci consente d’associare ad ogni percezione una rappresentazione. Un’immagine che siamo in grado di rievocare anche quando la percezione non c’è più. Camminando vediamo un albero, lo lasciamo alle nostre spalle ma, pur non avendolo più davanti agli occhi, siamo in grado di ricrearne l’immagine mnemonica. La partecipazione del corpo si ferma in questo caso alla pura percezione; il processo di traduzione in rappresentazioni è del tutto interiore: un’attività psichica. Questo tipo di immagine ci lascia perciò molto più liberi che non le allucinazioni.
Nella nostra fantasia, poi, siamo ancor più liberi; qui non abbiamo bisogno di una percezione esterna e neppure di un riferimento più o meno preciso a una percezione del passato, ma ci muoviamo in modo del tutto creativo. È questa, per eccellenza, l’esperienza artistica che ci fa concepire immagini mai prima esistite. I fenomeni dell’anima però, per natura loro, oscillano sempre tra libero e non libero, e come le rappresentazioni mnemoniche ci vincolano al dato di percezione, ma al contempo sono la base per una libera conoscenza della realtà, così le immagini della fantasia possono umanizzare la natura, affascinandoci al punto da sedurci, e così finiamo per chiuderci in noi stessi.
Un terzo tipo fondamentale di proiezione di immagini è puramente spirituale e perciò massimamente libero. Viene qui superato la stadio del “visionario” che si crede più avanti degli altri per il fatto di “vedere” lo spirituale. Il motivo per cui sono ancora pochissimi coloro che godono di una genuina percezione dello spirituale è che questa viene concessa solo ad una condizione: cioè che la sola percezione, anche se spirituale, è un puro nulla che riceve la sua realtà unicamente dall’interpretazione che ne fa il pensiero. Quando io dico che ciò che ho davanti è una rosa, è il pensare in me che lo dice e non la mia percezione. Quando dico che ciò che ho davanti è, per fare un esempio, un angelo di luce, lo dico io col mio pensare, non me lo dice la percezione. E se fosse un cattivo diavolo travestito da angelo di luce? Quale criterio ho io per distinguere l’uno dall’altro?
Il processo conoscitivo come continua mediazione
Di questi tre fondamentali modi umani di produrre immagini – l’allucinazione, la rappresentazione, l’immaginazione – il più comune è il secondo: quello che avviene nella coscienza ordinaria ed è alla portata di tutti. Esso è alla base del processo conoscitivo. La nostra coscienza infatti si fa una rappresentazione di tutto ciò che percepiamo. Attraverso la percezione noi cogliamo il mondo nel suo aspetto esterno, ma subito dopo, con la rappresentazione, lo riproduciamo nella nostra interiorità. Col pensiero escogitiamo invece i concetti delle cose, cioè il loro essere oggettivo indipendente da noi. Il concetto di albero, ad esempio, a differenza della rappresentazione che ne ho, è universalmente valido in quanto oggettivo, libero cioè da ogni particolare percezione e da ogni rappresentazione soggettiva che ognuno se ne può fare. È l’idea di albero, quale è sorta nella mente di chi l’ha creato.
Nell’attività quotidiana di conoscenza noi instauriamo un dialogo ininterrotto fra il mondo della materia e quello dello spirito. Con la percezione mi immergo nel mondo visibile, essa mi viene dal mondo ed è così com’è; non sono io a deciderne la natura. Ma quando accolgo la percezione nella mia realtà d’uomo che pensa, ecco che la intrido di spirito trovandone il concetto corrispondente, che è di natura puramente spirituale.
Un gatto o un cane non possono mai percepire un albero, non possono vederlo come lo vediamo noi, anche se ci sembra scontato che un animale dotato di occhi, orecchi e naso, accolga in sé il mondo nello stesso modo nostro. Solo un essere capace di concetto è capace di una vera e propria percezione: noi percepiamo in funzione del pensare, che l’animale non ha. L’animale (come dice il nome stesso) ha una corporeità che viene pervasa da esperienze animiche e vive quanto l’ambiente suscita in lui. L’uomo in aggiunta possiede la dimensione dello spirito pensante, la cui prima espressione è la capacità di coscienza di sé e la conoscenza oggettiva del mondo esterno.
La percezione è il polo opposto alla capacità d’oggettivare il mondo col pensare. Ob-iectum, dal latino obicere, significa proprio “buttare davanti a sé” le cose, in modo da assumere una posizione frontale nei loro confronti, guardandole bene in faccia. Il gatto, se vede una parete di colore rosso, non ha la percezione oggettiva del rosso ma si limita a sentire ed a vivere l’operare del rosso in lui. È quel senso di aggressività, emergenza e d’impatto che anche noi riconosciamo al rosso quando entrando in una stanza dalle pareti rosse diciamo: che sensazione oppressiva! Sensazione, quindi. Per l’animale c’è solo questa, ma non sa d’averla, mentre il rosso agisce in lui, come in lui agiscono la figura umana, o l’acqua, o il vento... La sua non è una percezione “frontale”, non può tirarsi fuori dal rosso, dalla figura umana, dall’acqua o dal vento per prendere posizione liberamente e dire chiaro e forte cosa sono. Esce dalla sensazione, quando non è più esposto all’oggetto che gliela infonde. Se avesse la capacità di uscirne quando ce l’ha davanti, se riuscisse a diventare del tutto attivo nei suoi confronti, comincerebbe allora a pensare e direbbe: questo colore è rosso, però è un po’ sbiadito, e osservandolo meglio mi piace meno di quello che ho visto un’ora fa...
È dunque specificamente umano vivere la dualità tra materia e spirito, tra esterno e interno, perfino nel più semplice processo conoscitivo. Le cose mi si presentano dapprima come pure percezioni, pura esteriorità, ed io rimargino questa scissione, tra me e il mondo, attraverso il pensare che crea i concetti spirituali delle cose facendomi rientrare in comunione con esse.
La ferita di Anfortas
Qual è il senso di questa ferita che separa me dal mondo, dividendolo in due parti, una “fuori” e l’altra “dentro” di me? Perché da millenni l’umanità tenta di riunificare il suo cosmo spaccato in due, senza giungere mai a una riconciliazione definitiva? Esso non sembra trarre né giovamento né danno da questa nostra attività, come pure non avrebbe gran significato tutta la conoscenza se servisse solo a raddoppiare il mondo tale e quale nella nostra mente. Eppure, i millenni del cammino umano sono segnati proprio dalla fatica del conoscere... C’è da chiedersi, allora, se questa spinta a operare il ricongiungimento tra il mondo e l’io, propria della natura umana, non sia il modo privilegiato in cui l’uomo evolve e costruisce se stesso.
È come se, osservando con occhi attenti il procedere della sua conoscenza, l’uomo giungesse a dirsi: nessun frammento di materia può esistere senza spirito, e lo spirito per farsi umano deve rendersi percepibile nella materia. Io vivo nel mondo cercando di riconciliare fra loro materia e spirito, mi oriento fra percezione e concetto, e così facendo dichiaro che la loro separazione è pura illusione. E allora... non sarà forse che l’apparente estraneità tra spirito e materia anziché riguardare la realtà del mondo, riguardi solo la mia coscienza?
O che sia io ad evolvermi cercando di superare questa condizione di sdoppiamento che s’accende in me e solo da me può essere superata? Non sarà che questo mondo, a prima vista separato da me, sia un incantesimo al quale sono costretto, allo scopo di disincantarmi in modi sempre diversi?
L’antagonismo tra spirito e materia cessa quando ne intuisco l’illusorietà. La realtà torna allora ad essere tutta d’un pezzo, sebbene appaia alla nostra coscienza con due volti distinti.
Nel Parsifal si parla di Anfortas, il re custode del Gral che porta nell’inguine una profonda ferita di lancia che non si rimargina mai, impedendogli sia di vivere che di morire. Solo colui che, con in mano quella stessa lancia, saprà porre la domanda sul senso di tanto dolore, potrà guarire il re. Con queste immagini il medioevo ha narrato la ferita della conoscenza che ogni uomo porta in sé. I due lembi del reale, divisi e sanguinanti – spirito e materia –, sono lì per offrire all’uomo la possibilità di rimarginarli per attività propria, ogni volta che nel suo processo conoscitivo tenta di ricongiungere la realtà scissa; un compito dalle infinite variazioni. La ferita del mondo può richiuderla solo la lancia dell’uomo che l’ha aperta. La ferita della coscienza umana può sanarla solo la conoscenza operata dall’uomo. Solo da questa eroica impresa nascerà il sentimento di quanto sia bella la pienezza dell’umano, verso cui tende da sempre.
Il “peccato” originale:
un decadimento della coscienza prima che della moralità
Tutte le culture del mondo parlano di un “paradiso perduto”, di un primigenio stato aureo dal quale l’umanità s’è allontanata smarrendosi nelle tenebre della terra fino a dissolversi nella pesantezza della materia. Ogni uomo porta impressa nell’anima l’immagine del Serpente mentre tenta la donna a cogliere il frutto dell’albero della conoscenza: “... qualora ne mangiaste si aprirebbero gli occhi vostri e diventereste come dèi”. La donna ne mangia e lo porge anche all’uomo: “Si aprirono allora gli occhi di tutti e due e si avvidero che erano nudi (...) E Dio disse: ‘Ecco, l’uomo è divenuto come uno di noi, avendo la conoscenza del bene e del male. Ora facciamo sì che egli non possa più stendere la sua mano, né cogliere ancora dell’albero della vita per mangiarne e vivere in eterno’. (...) Allora pose dei Cherubini a oriente del giardino dell’Eden, armati di spada fiammeggiante, per impedire l’accesso all’albero della vita.”
Queste immagini archetipiche della Genesi racchiudono in sé la chiave della vicenda evolutiva umana fin dai suoi primordi. La “caduta” è stata davvero una discesa, un precipitare dello spirito umano nel vortice di una coscienza che si oscurava man mano che s’impantanava nelle vicende della corporeità. Attraverso gli occhi – i sensi fisici – penetrano e s’abbattono nell’interiorità umana le leggi immutabili e non libere del mondo visibile. Lo spirito umano – l’Io eterno in ognuno di noi – tende a rifuggire dalla sostanza terrestre a lui ostile, e l’anima cade allora in balia di passioni e d’istinti che provengono dalla fucina del corpo.
E il paradiso perduto dov’era? Certo non un luogo della terra, ma uno stato d’innocenza dove la mancanza di gravità terrestre consentiva agli spiriti umani di riflettere, in beatitudine, la saggezza e la perfezione divina. Uno stato di coscienza dunque, e non un luogo, è il paradiso: la coscienza dei primordi conferita all’uomo direttamente dal Creatore. Adagiati nel grembo della Divinità, gli uomini erano inseriti in un’armonia creata apposta per loro, e che da soli non avrebbero mai potuto turbare.
È quella l’armonia iniziale che l’oriente ancora oggi ricerca con infinita nostalgia, è un po’ quella che rivivono i nostri figli appena nati, quando dormono beati fra le nostre braccia, protetti e ancora senza responsabilità, quando si nutrono di noi, di ciò che sappiamo, di ciò che facciamo per loro.
La lacuna fra spirito e materia, che spesso ci fa vivere ignari della nostra provenienza divina, come potrebbe essere una colpa morale quando precede il sorgere della coscienza individuale, presupposto per la conoscenza del bene e del male? Il testo sacro dice che siamo stati sedotti da un essere spirituale a noi superiore. E com’è stato possibile a quell’essere, simboleggiato nel Serpente, sfidare il divino modificando il destino pianificato per l’umanità? Può mai la Divinità essere messa in scacco da una sua creatura?
Domande antiche come l’uomo queste, ma che oggi possono orientarci verso una nuova lettura del peccato, che lo veda in primo luogo come un fenomeno di coscienza, come una caduta intellettuale prima che morale. È alla mela della conoscenza che Eva, la Madre degli umani, dette il primo morso – e sarà meglio che impariamo a ringraziarla! – spaccando così in due la coscienza umana. La caduta fu dapprima un evento della coscienza, il sorgere della Maya, della Grande Illusione dentro lo spirito umano. Illusione che è vuoto d’essere, assenza di realtà, vedere cioè la materia come svuotata di spirito, e della sua vita. E così l’albero della vita è sparito dalla coscienza umana, restando nel paradiso.
L’amore di una Divinità che rinuncia all’onniscienza e all’onnipotenza dentro l’anima umana, fa spazio al Tentatore, alla controforza necessaria perché nel mondo degli uomini diventi possibile un’evoluzione libera e individuale. Non c’è evoluzione senza contrasti e ostacoli da superare, senza tensioni tra poli opposti, e questo lo sappiamo tutti. Proprio dalla nostra stessa esperienza possiamo trarre la conferma d’esser fatti a immagine e somiglianza di Dio. Così la Divinità apre all’uomo la sua mèta evolutiva: la libertà della creatura che partecipa sempre più alla creatività del Creatore.
Ma la libertà umana, per tutta la prima fase dell’evoluzione che dura fino al punto infimo della perdita di sé, può essere solo una libertà negativa, che sa da cosa si libera, ma non sa cosa la rende libera. È una libertà in gran parte illusoria, un libero arbitrio fatto d’egoismo teso a fruire del mondo e degli uomini, come se fossero esterni a noi, e altri da noi. Ciò che l’uomo sa di sé e del mondo, ciò che sente e che vuole, nasce da un intelletto soggetto all’errore. Percependo l’altro fuori di me, mi sento libero solo svincolandomi da lui. Non mi sento ancora libero nell’esser per lui, e in questo modo anche per me stesso. D’altra parte, proprio a questa esperienza di separatezza ognuno di noi deve la possibilità d’individualizzarsi, emancipandosi dalla matrice universale e paradisiaca.
La caduta dello spirito umano diventa, da un fatto di coscienza che era all’origine, un fatto morale, e questo nella misura in cui tralasciamo di ricomporre l’unità tra spirito e materia, tra noi e gli altri. Oggi la coscienza umana è in grado di meglio comprendere che il suo compito evolutivo, il bene morale nella sua totalità, è quello di diventare uomo in quanto sintesi di spirito e materia, e per libera conquista individuale. Vale a dire costruire se stesso, secondo il suo intero essere, ricreando il mondo in sé e donando sé al mondo.
Il peccato originale, ferita di tutte le ferite, è la formidabile occasione offerta all’uomo di rimarginarla di nuovo, ricucendo coscientemente la simbiosi tra invisibile e visibile, fra dentro e fuori, tra me e te. E la caduta dall’alto in basso trova il suo senso ogni volta che viene trasformata in una caduta verso l’alto.
Universalità nel pensare e tolleranza nell’agire
Se è vero che viviamo in mezzo alle tante contraddizioni della vita, è anche vero che ci è dato sempre più di non subirle, comprendendo meglio come muoverci fra esse in modo da riuscire a renderci sempre più liberi. La libertà viene vissuta proprio nel movimento tra polarità, vivace e continuo, fatto d’infinite sfumature. Le polarità della vita sono simili a maestosi temi di una sinfonia senza fine le cui variazioni sono gl’infiniti modi di ricomporre l’armonia tra loro.
Prendiamo due modalità di vivere antitetiche: quella della persona intellettuale e della persona pratica. L’una pensa, pensa e ancora pensa, mentre l’altra fa, fa e continua a fare... Irrigiditi nelle rispettive posizioni, l’intellettuale e il pratico ad oltranza prima o poi sperimenteranno l’unilateralità mortificante del loro essere: se non altro perché riceveranno dagli altri continue proteste. L’intellettuale si sforzerà di prendere sul serio il fatto che bisogna pur fare qualcosa, passandogli la voglia di tessere strampalate teorie osservando come la pratica offra il miglior insegnamento; mentre l’attivista, il trafficone, prima o poi scoprirà che il fare senza pensare partorisce farraginose approssimazioni ed un mucchio di inutili azioni, se non veri e propri pasticci. Entrambi sperimenteranno così la libertà di ammirare l’altro aspetto dell’esistenza, o almeno ci proveranno, comprendendo che le polarità della vita non son fatte per combattersi, ma per stimolarsi a vicenda.
La tentazione di vedere in ogni polarità un’incompatibile contraddizione, proviene dalla pigrizia interiore, dalla voglia di risparmiarsi la fatica di restare sempre in movimento. Ogni unilateralità è mortificante proprio perché non vive le provocazioni che le possono venire solo dal polo opposto. Chi si gode l’altalena della vita sa che su ogni nuova sponda trova un altro pezzo di sé e riprenderselo è sempre fonte di felicità.
La polarità del maschile e del femminile è nella costituzione fisiologica dell’uomo. Se la natura stessa porta il maschile e il femminile a cercarsi a vicenda come due mondi che non possono esistere l’uno senza l’altro, questa tensione può venir trasformata in autentico interessamento alla prospettiva che l’altro ha sul mondo e su di sé. Nasce così lo sforzo sincero di mettersi nei panni dell’altro, di accoglierlo in noi, ed ogni accoglienza è un arricchimento.
L’umano, in quanto sintesi potenziale di tutte le conquiste resegli possibili, lo si costruisce con processi di graduale ampliamento. Le infinite aggiunte che si conseguono integrano sempre più tutte le sfumature dell’essere. Diventare umani è dunque un processo d’interminabile integrazione.
Tutti gli elementi del cosmo squadernati davanti a noi, l’uno accanto all’altro, costituiscono l’immenso mondo del “fuori di noi”, e aspettano di venire interiorizzati dall’uomo. Tutte le cose sono lì, aspettano d’esser pensate, capite sempre meglio e compito del nostro pensiero è quello di divenire sempre più universale, sempre più onnicomprensivo. E ce n’è da fare! Anche a livello morale costruire l’umano è un processo di graduale riorganizzazione in vista di un grande organismo spirituale – l’Uomo compiuto – che abbraccerà in sé tutti gli uomini e tutte le creature. Amare le cose del mondo vuol dire amare la gioia che sono destinate a procurare a tutti gli esseri umani, ai bambini che vivono in un mondo di meraviglie, agli anziani che scrutano il mondo nelle loro profondità, agli adulti che gioiscono di trasformarlo per renderlo più amico dell’uomo.
Per quanto riguarda il nostro agire, le forze della mediazione ci consentono di amare tutto ciò che noi stessi non sappiamo ancora fare, perché lo sanno fare gli altri. Colmiamo le lacune del nostro agire con l’atteggiamento interiore della tolleranza, che è la tensione verso la mediazione degli opposti. E non dev’essere questo un atteggiamento passivo che lascia fare a ciascuno quel che vuole, ma la capacità di provare gioia di fronte ad ogni modo di esprimersi dell’umano, al desiderio di far di tutto per favorirlo nel suo pieno espandersi.
Se il pensiero ci è dato per integrare contenuti del reale sempre più vasti, nell’azione regna invece l’individualizzazione. È lì che bisogna sapersi specializzare. Quando si tratta di agire, dobbiamo mettere in risalto l’unicità di ognuno. Sono queste libere scelte morali che ciascuno deve compiere individualmente, e qui la totalità dell’umano risulta dall’agire dei singoli uomini messi insieme. L’amore verso le azioni compiute dall’altro – senza invidie, prevaricazioni e senza pregiudizi –, l’amore verso eventi che appartengono alla sua vita e non alla mia, comporta un atteggiamento interiore di profonda tolleranza.
Tratti fondamentali di ogni mediazione:
mobilità, attività, individualità
Nello sforzo quotidiano mirante a riconciliare i poli della vita, ci sono atteggiamenti fondamentali che ricorrono in ogni sforzo di mediazione, consentendo di evolverci sempre più verso la pienezza dell’umano.
Il primo è la mobilità, la flessibilità interiore cioè, la tensione a mantenersi sempre vivi nel proprio animo. L’equilibrio che di volta in volta si stabilisce fra le varie polarità della vita è però sempre labile. Un equilibrio stabile sarebbe uno stato di morta fissità, mentre al contrario la vita è una continua oscillazione. Come lo stomaco non conosce uno stato di stasi assoluta, o si sta riempiendo o sta smaltendo i cibi, lo stesso vale per l’animo che è sempre in movimento e in trasformazione, non meno delle condizioni atmosferiche. Primo compito della motilità interiore è quello di fare attenzione a tutti i cambiamenti atmosferici interiori, seguendo l’alto e basso dei propri umori, portando a coscienza quel che l’animo vive di volta in volta, senza giudicare o censurare. Questa vivacità introspettiva ci aiuta a seguire con attenzione anche i minimi cambiamenti che avvengono nell’altro, per non guardarlo più in base a giudizi fissi, ma per coglierlo nel suo continuo cambiamento, proprio perché anche noi siamo in un identico processo di mutamento.
Dal modo di guardare sé e l’altro, questa vivacità interiore si trasfonde nel modo di comportarci. Se per esempio uno s’accorge di aver fatto troppo a lungo “il duro” con un caro amico, cercherà di dare una botta al cerchio anziché continuare a infierire sulla botte, usando con lui maniere più dolci. Può darsi che dopo un po’ di tempo debba di nuovo invertire la marcia, ma niente di male se questo giova alla salute dell’amicizia. Vivere nel mondo vuol dire adattarsi ad esso, perché il mondo non cambia dall’oggi al domani per adattarsi a noi.
Una seconda caratteristica di ogni movimento di mediazione fra gli opposti è quella di non poter essere inerte o passivo, ma costantemente attivo. Passivo è tutto ciò che sorge in noi senza l’intervento del pensiero e della volontà. Pensieri, sentimenti, impulsi all’azione che scorrono da soli, come l’acqua del fiume che va seguendo le sue correnti e secondo la configurazione del letto. Quando invece son io che decido quali pensieri formulare, quando gestisco coscientemente le mie emozioni, quando prendo liberamente l’iniziativa, posso diventare sempre più attivo anche di fronte alle unilateralità della vita.
Esse non hanno bisogno del mio intervento; di questo c’è però bisogno se voglio appianarle. Una forte antipatia, capace di procurare torto all’altro, può sorgere in me spontanea, come di certo non viene da sé il giusto modo di viverla. Devo lavorare attivamente su me stesso per contenerla, tirando fuori i tratti positivi e buoni dell’altro. In questo modo la mia antipatia, anche se non scompare, può venire equilibrata dalla stima che, pur restandomi antipatico, posso provare per lui. Il fatto che mi sia così antipatico, dice comunque qualcosa di ben più significativo su di me che non su di lui.
Fa parte della gestione attiva della vita sapere quando c’è da aspettare, e quando c’è da prendere l’iniziativa. Anche quella dell’attesa può essere un’attività, perché la pazienza e la calma interiori richiedono dominio su di sé. Una buona parte di ciò che noi chiamiamo “attività” è indotta dal mondo circostante, una sorta di forma di passività interiore. Renderci conto di questa “inerzia” di partenza, è il presupposto per diventare sempre più fattivi e dinamici nei confronti di noi stessi.
Una terza caratteristica di ogni riequilibramento fra il troppo e il troppo poco è l’essere sempre individuale. La cultura in generale sta compiendo un grande trapasso dall’autoesperienza di chi viene guidato da una comunanza di gruppo, popolo o religione, a una individualizzazione sempre più pronunciata. Per diventare sempre più attivi nel ristabilire ogni equilibrio perduto, è necessario vivere coscientemente la propria unicità individuale. Non esiste un modo valido, per più persone, di mediare fra le polarità della vita, perché i tipi di squilibrio da riequilibrare sono tanti quanti sono gli esseri umani.
Ma quando si sottolinea l’individualità, si presenta subito l’altro polo a dare del filo da torcere alla nostra coscienza: la comunità. Se manca uno sforzo di mediazione, individualità e comunità vengono allora vissute in contrapposizione fra loro, come se l’una escludesse l’altra. L’esperienza della comunità la facciamo quando veniamo posti di fronte alle leggi di convivenza sociale, che vanno da quelle generali dello stato, usi e costumi di un popolo, fino alle norme riguardanti il posto di lavoro, alle regole del traffico, usanze di famiglia... C’è insomma una cornice di vita organizzata, senza la quale nessuno di noi può vivere.
Per il bambino piccolo le condizioni di comunanza sono essenziali perché ne è del tutto dipendente e ad esse si affida. Non ha ancora la capacità di prendere posizione nei confronti di ciò che è comune. Anche l’umanità nel suo insieme ha dovuto percorrere una fase infantile guidata da regole e comandamenti validi per tutti e che non venivano messi in discussione.
Oggi, invece, l’individuo acquisisce sempre più rilievo. Nel mondo della scienza e della tecnica, come nel mondo del lavoro, è inevitabile che la complessità richieda sempre più competenza, affidabilità e responsabilità da parte di ogni singolo. Ciò comporta che le norme comuni si limitino a salvaguardare quei presupposti di base approvati da tutti, per permettere una sempre maggiore autonomia da parte dei singoli. Ad essi si chiede di individualizzare il loro modo di esprimere l’umano e di contribuire al sociale.
Per regolare il traffico è necessario un codice stradale che venga rispettato da tutti, e non sarà certo facendosi un codice a modo suo che l’individuo potrà affermare se stesso. Però nessuno guida la macchina con lo scopo di osservare le regole del traffico. Lo scopo infatti di chi guida l’automobile è di andare dove vuole, a fare quel che vuole. L’osservanza della norma comune – l’esperienza della comunità – che in tempi antichi era il tutto della vita, diviene oggi uno strumento, al fine di consentire l’esperienza della creatività individuale.
Chi s’accontentasse di osservare in tutto e per tutto la legge senza creare in sé un nucleo d’azione del tutto individualizzato, si troverebbe ancora nella fase infantile. Un tale adulto sarebbe oggi un anacronismo. Milioni di insegnanti si attengono a delle normative valide per tutti – l’orario delle lezioni, il calendario scolastico, il programma didattico, ecc. – però il senso dell’essere maestro non sta in ciò che uniforma tutti gli insegnanti nell’osservanza delle regole uguali per tutti, ma nel modo unico e irripetibile in cui ogni pedagogo si rapporta ai suoi alunni. Ciò che gli alunni vivono quando hanno a che fare con un insegnante, è del tutto diverso da ciò che sentono quando interagiscono con un altro. Un insegnante che si aspettasse di sentirsi realizzato e felice nell’osservare tutte le regole e i regolamenti di questo mondo, sarà un eterno infelice perché non s’accorgerà di osservar tutto fuorché se stesso e i suoi allievi.
L’individualità forte non ha bisogno di alcun potere
L’intento di stabilire il giusto equilibrio tra individuo e comunità trova la sua più grande sfida quando l’individuo si confronta con la comunità più vasta che ci sia: l’umano nella sua totalità, al di là di ogni particolarità di lingua, cultura, razza o religione. L’universale umano e l’unicità del singolo giocano fra loro in modi sempre diversi. Nell’incontro con l’altro noi cerchiamo infatti sempre entrambi: l’Uomo e questo uomo. Vogliamo vivere l’universalmente umano, ma anche l’unicità di ogni individuo. Fare l’esperienza di come l’umano e il singolo siano fatti per arricchirsi e approfondirsi a vicenda.
È possibile per il singolo considerare i destini riguardanti l’umanità tutta come una sua faccenda personalissima e che gli sta a cuore al di sopra di tutto, capace di suscitargli nell’animo intuizioni morali particolari che solo lui è in grado di concepire. Intuizioni morali su ciò che egli stesso può fare per l’umanità e su ciò che l’umanità può diventare per lui.
L’evoluzione è un immane processo di individualizzazione. Più si va indietro nella storia e meno individualizzazione si trova; più avanti si procede nel tempo e più forte diventa l’aspirazione a essere autonomo, responsabile in prima persona della vita e del mondo. Nessuno nasce già adulto. Diventare sempre più umano vuol dire prendere posizioni sempre più nette nei confronti dei fenomeni del mondo. Nulla più che la contemplazione dell’inesauribile ricchezza dell’umanità può suscitare nell’individuo il senso morale del suo compito. Tutti possono svolgere la stessa professione in modi completamente diversi dentro a questo gigantesco organismo, a seconda del contributo che ognuno è chiamato a dare al cammino dell’umanità.
Chi dà la colpa ad altri perché non si sente realizzato, chi si lamenta del modo di essere degli altri, non ha ancora individuato il proprio. La realizzazione di sé non va pretesa dagli altri. Da essi, come dalle circostanze esterne, mi viene quel che è comune, ciò che io non sono; ma ciò che dev’essere mio posso crearlo unicamente io, e quando mi sento povero e vuoto non può che dipendere da me. Forse ho trascurato troppo a lungo di coltivare quel che sono chiamato a essere.
Ognuno sente in sé l’aspirazione a diventare un Io unico, differenziato per tanti versi dagli altri. Se l’uomo non sentisse questo dinamismo dovrebbe essere felice, pienamente realizzato, grazie a ciò che è di natura comune. E siccome questo elemento c’è già in abbondanza, il mondo dovrebbe essere pieno di persone felici. Invece le cose non stanno così. L’insoddisfazione non scompare finché i passi verso l’individualizzazione non si fanno sempre più sicuri. Dove il tratto inconfondibile d’ogni individualità viene visto e amato come il valore morale supremo, il vivere insieme diventa più difficile ma mille volte più bello, un’opera d’arte. Potremmo così avere un mondo pieno di artisti.
E allora le regole più comuni verranno considerate sacre nella misura in cui esprimono le condizioni per la fioritura di ogni individuo. Il livello di maturità di una società sta nella sua capacità di promulgare norme comuni tali da favorire il libero sviluppo di ogni persona. Quand’è così, le leggi tendono a ridursi al minimo indispensabile perché il loro valore qualitativo diventa massimo agli occhi di ognuno. Esse saranno considerate sacre e inviolabili proprio perché vissute come fondamento del tutto indispensabile per l’evoluzione di ciascuno. Il fine della legge, allora, non sarà più il soggiogamento dell’individuo, bensì il suo assurgere a maturità e pienezza. La ricchezza dei singoli si riverserà a sua volta nella comunità ad arricchire i tesori di ciascun individuo e solo allora l’organismo sociale potrà divenire l’unico paradiso possibile sulla terra.
La mediazione che di ogni morte fa una resurrezione
Ci sono due modi fondamentali di vedere la natura umana; essi riaffiorano in sfumature diverse nel corso dell’evoluzione. Da un lato gli ottimisti che tendono a vedere positivo tutto ciò che fa parte dell’uomo. Quel che la natura o il buon Dio hanno fatto, dicono, non può essere che saggio e buono. Altri invece – chiamiamoli pure pessimisti – vedono uno stato di decadimento nel modo in cui la natura umana si presenta oggi. Parlano del peccato originale come di un evento che ha corrotto l’intima natura stessa dell’uomo. In questo caso, qualsiasi cosa faccia, l’uomo non potrà mai essere davvero buono, essendo decaduto.
Ma se l’essere umano fosse cattivo per natura, non potrebbe farci nulla, e se fosse, sempre per natura, buono, varrebbe la stessa cosa. Nell’un caso e nell’altro, mancherebbe di libertà. Sia la visione positiva che quella negativa sono unilaterali, perché escludono entrambe l’elemento più importante dell’essere uomo, che è il dinamismo evolutivo della libertà. Sta proprio nella sua natura che egli, da “cattivo” che è per tanti versi, possa diventare sempre migliore, e da buono che è per altrettanti versi, possa diventare cattivo. Ciò che lo fa uomo è di essere in continua evoluzione, portando in sé una tensione interiore che resta sempre aperta sia verso il bene che verso il male. L’essenza dell’uomo, in altre parole, è proprio la libertà che si esprime nel corso di una lunga evoluzione e che decide del suo stesso essere ora dopo ora, giorno dopo giorno.
La cosiddetta caduta, il peccato originale che ha portato l’uomo a rivestirsi di materia, non è stato un male morale, ma ha creato i presupposti per l’esercizio della libertà. Se non ci fosse una qualche tensione fra lo spirito e la materia, tra il bene e il male, tra me e te, l’uomo non avrebbe nulla da conquistarsi in termini di una più profonda armonizzazione del suo essere. E c’è qualcosa di molto più bello del ritenersi già del tutto a posto: è il diventare più belli e sempre migliori.
In ciò che la natura gli concede, l’essere umano non è né buono né cattivo, né bello né brutto. È forse un certo moralismo clericale che dice: l’uomo è per natura brutto e cattivo. Ed è forse un certo moralismo laico che controbatte: l’uomo è buono e bello così com’è. Ma la verità come sempre sta nel mezzo: la bellezza e la libertà dell’umano vivono in ciò che ognuno riesce a fare liberamente e a divenire per conto suo. Il bene e il male sono una questione di conquista, appartengono a un divenire aperto e del tutto individuale per ognuno.
L’esperienza della libertà è nel movimento continuo tra le infinite antitesi, tra il punto di partenza e quello d’arrivo, tra ogni incompletezza e la compiutezza cui anela. Solo questo inarrestabile dinamismo interiore offre a ciascuno il senso reale del proprio divenire, gli fa respirare l’aria pura della pienezza, e insieme non gli permette d’arrestarsi mai, perché ogni conquista apre nuovi orizzonti. E lui riparte di nuovo, e batte altri sentieri, facendo di ogni mèta un nuovo punto di partenza. Vive così, in un’incessante crescita delle forze di mente e cuore.
Sì: l’esperienza dell’umano è un’interminabile esperienza di morte e di resurrezione. L’uomo si sente morire ogni volta che considera quel che ancora gli manca e, guardando in faccia la somma di egoismi da smaltire, sente la pochezza del suo amore che seleziona e pone condizioni. Ma può risorgere ogni volta che si riapre all’inesauribilità del suo essere, nell’intento di integrarlo, a brano a brano, nei suoi pensieri che lo amano e nel suo cuore che incessantemente lo pensa.
La tentazione dei salti mortali
Se per un certo verso può sembrare quasi facile questa lettura della coscienza sdoppiata – soprattutto perché l’esperienza ce la mostra a piene mani –, c’è tuttavia un altro modo di vivere scissi interiormente, più difficile da afferrare, non solo perché ci si è immersi fino al collo, ma perché raramente ci se ne accorge. Abbiamo l’illusione di mediare gli opposti, quando in realtà ci si limita ad alternare fra essi.
È la sdoppiatura interiore di cui si parlava, e che qui va approfondita. Prendiamo il caso già citato del finanziere che esce dalla Borsa, va a fare yoga ed è tutto contento; o dell’impiegato insoddisfatto che, fatto l’abbonamento al teatro, ci va tutti i giovedì e si sente meglio; o della casalinga che ogni tanto esce di casa, va a farsi una pizza con le amiche e per due ore non pensa più alla famiglia. È il misantropo che se ne sta da solo, ma ogni tanto si concede agli amici e per questo si sente generoso. Sono io quando vado in vacanza distrutto da un anno di lavoro e mi dico: oh! finalmente. È il miliardario che fa costruire un ospedaletto per i poveri afghani, è la dieta dopo i lauti pranzi natalizi, l’attore che se ne va in ritiro spirituale in Tibet, è colui che inquina i mari coi detersivi e poi se ne va alle Maldive a godersi la natura pulita, è chi, stufo del tran tran della vita quotidiana, si tuffa nella lettura di un romanzo che gli consenta almeno per un paio d’ore di dimenticare, è chi dopo essersi sbranato coi suoi simili per tutta la settimana, la domenica va in chiesa a sentire una bella predica sull’amore del prossimo...
Che cosa c’è di diverso rispetto alle tante altre schizofrenie cui si è già accennato? È che queste, lungi dal far provare la pena, ci fanno sentire meglio. Sono analgesici che nascondono uno stato di malattia. L’alternanza da un estremo all’altro può diventare talmente automatica, così abitudinale da darci l’illusione di vivere il meglio di questi due mondi, anzi di creare una specie di armonia fra loro.
E invece non è così. L’impiegato che va a teatro con quelle premesse interiori non riuscirà a portare il senso dell’arte nel suo lavoro, non riuscirà a comprendere che ogni lavoro è un’arte, e se lo capisse, sperimenterebbe la creatività tutti i giorni, qualunque fosse il lavoro che svolge. Sarebbe soddisfatto di ciò che fa e non avrebbe bisogno di dimenticarselo i giovedì quando va a godersi due ore di spettacolo per poi dimenticarsi quell’arte, che tanto lo ha affascinato, per tutto il resto della settimana. E il miliardario finirebbe di esserlo se accogliesse in sé l’esperienza della povertà che fanno gli altri, capirebbe che mediare nel suo caso significa distribuire, significa far circolare il denaro in continuazione da una tasca all’altra facendolo passare per quelle di tutti, perché povertà e ricchezza, bisogni e capacità di soddisfarli, debbono potersi incontrare in ogni uomo.
Nei Vangeli si parla, in immagini, delle tre tentazioni del Cristo. Nella prima il diavolo gli dice: “Se hai fame, visto che sai fare tutto, trasforma le pietre in pane.” E cioè: buttati nello splendore della materia, considera il mondo fisico che illumina la tua esistenza, datti alla magia di Harry Potter e saprai far sprigionare vita dalla materia morta. Qui il diavolo tenta l’uomo all’unilateralità del materialismo, nella speranza di fargli dimenticare ciò che è spirituale. E infatti il Cristo risponde: “Non di solo pane vive l’uomo, ma ha bisogno anche delle parole alate che gli parlano dello spirito”. Infatti non esiste materia senza spirito e l’uomo non può vivere senza sentirsi spirito.
Il diavolo, sconfitto la prima volta, non molla. “Sollevatolo in alto, gli mostrò in un attimo tutti i regni della terra: – Se tu mi adori, tutta la gloria del mondo sarà tua –”, il che vuol dire: il mondo della materia non ti riguarda proprio, tu sei uno spirito, osserva il mondo dall’alto e disdegna tutto ciò che è materiale. È questa la tentazione dello spiritualismo unilaterale che tiene in poco conto il mondo della materia in cui vede solo gravezza e difficoltà e allora si rifugia nello spirito incontaminato. Il Cristo risponde: “Sta scritto: adorerai il Signore Dio che è in te e servirai a lui solo”. La vera sovranità è quella dell’Io divino incarnato in ogni uomo, e l’Io ama il mondo della materia perché solo sulla terra può compiere la sua evoluzione.
La più micidiale è la terza tentazione in cui il diavolo usa tutta la sua astuzia e gli dice: “Se tu sei il Figlio di Dio, buttati giù dal pinnacolo del tempio, poiché sta scritto: – Ha dato ordini per te ai suoi Angeli affinché ti proteggano –”. Il Tentatore sa che se l’uomo provasse a vivere soltanto nella materia, prima o poi sentirebbe la mancanza dello spirito, e sa pure che se provasse a vivere di solo spirito non tarderebbe a sentire il richiamo della materia.
Allora tenta l’uomo convincendolo a prenderseli tutti e due questi mondi, non insieme però, bensì in alternanza, l’uno sempre senza l’altro. Buttati giù dal pinnacolo del tempio, è come dire: abdica allo spirito. Il tempio è la corporeità umana quale dimora dello spirito, il suo pinnacolo è la testa, la punta “acuta” dove si svolge il pensare. Smetti di pensare dice il diavolo, buttati giù nel mondo degli istinti e vedrai che bel godimento. Potrai ritornare sempre sul tuo pinnacolo, senza nessuno sforzo da parte tua.
E l’uomo se gli dà retta oscilla fra astratta razionalità e cieca passionalità. “Precipitare giù”, è il trasferirsi in un baleno da un polo all’altro, l’assenza d’una sfera intermedia che infonda luce alla materia – al mondo degli istinti – offrendo un peso d’incarnazione allo spirito umano. Il passaggio dalla testa ai visceri, dalla logica all’istinto, può essere così repentino da scavalcare del tutto la sfera del cuore, delle forze d’amore che hanno il compito di riconciliare tra loro le polarità che tendono a escludersi a vicenda.
Come mediava Platone
Anche il grande pensatore Platone osservò le lacerazioni della vita e ravvisò, nello sforzo di mediare fra esse, la virtù somma dell’uomo. In particolare indagò quattro dualità fondamentali della nostra anima, quatto ferite dell’esistenza, e ne indicò il metodo di mediazione. Sono le quattro virtù platoniche che riescono a umanizzare ogni dicotomia trasformando tutti i mali della vita in ciò che è bene per l’uomo.
La prima virtù è la sapienza che si sprigiona dalla luce del pensiero; la seconda la fortezza, che nasce dal calore del cuore; la terza la temperanza, creata dalla forza di volontà; la quarta la giustizia che stabilisce il giusto equilibrio tra il troppo e il troppo poco e che Aristotele ha poi presentato come la virtù di tutte le virtù. Essa è la virtù della mediazione che risana tutte le ferite, tendendo al giusto mezzo fra i contrasti dell’esistenza.
La sapienza illumina la mente facendole evitare le unilateralità del pensiero umano, l’esaltazione e l’ottusità, perché sia l’una che l’altra impediscono la conoscenza oggettiva dei fenomeni del mondo. L’esaltazione porta a essere dogmatici e settari, impedendo così di vedere tutto il resto. L’esaltato offusca la conoscenza col fumo delle proprie emozioni. Ciò che afferma non è detto sia sbagliato; il problema è quel che non vede. Gli sfugge perché è tutto preso da ciò che gli interessa o che vuol difendere a spada tratta.
Dicendo a un dogmatico: ti sbagli, facciamo a nostra volta un grosso sbaglio, ed è come parlare al muro. Non serve confutare le sue affermazioni, andrebbero invece integrate con tante altre che mancano. Da quanti punti di vista si può guardare una montagna? Come descriverla in tutti i crinali, valli, punte e crepacci? Per non parlare poi delle sue infinite piante, e singole foglie. La realtà complessiva di una montagna nella sua oggettività è data dalla somma totale di tutti i punti di vista possibili. Il sentimento di preferenza verso una particolare angolazione della realtà impedisce al dogmatico di scoprire gli altri aspetti di essa, rendendolo intollerante verso chi invece li vede.
L’altro polo che offusca la sapienza – che è l’arte della vastità oltre che della profondità – è l’ottusità, il disinteresse conoscitivo. L’ottusità mentale concede a tutti gli aspetti della realtà di scorrerle davanti senza afferrarne nemmeno uno. È inutile dire a chi è tardo di mente guarda com’è bello questo e com’è interessante quest’altro... Bisognerebbe invece trovare il modo di accendere in lui il moto interiore della voglia di verità.
Tra i due estremi dell’esaltazione e dell’ottusità c’è il movimento libero e individuale di guardare a ogni realtà da punti di vista sempre nuovi. Tradotta in termini moderni, la “sapienza” platonica è l’arte di essere attenti al mondo, interessati ai suoi fenomeni, assetati di conoscenza. La sapienza diventa allora la ricerca incessante d’una verità per natura inesauribile come lo è in fondo la realtà, un cammino senza fine per una mente umana che non conosce soste. Il fanatico si illude di essere in movimento perché in effetti non lo è. Si limita a girare sempre attorno agli stessi dogmi per goderseli, e così facendo si scava un solco in cui precipita sempre più. L’ottuso si trova invece nella posizione opposta, sta fermo. Il mondo gira e lo stordisce, e da questo turbinìo, – un falso movimento perché non vi partecipa – si difende chiudendo gli occhi.
Soltanto un cammino conoscitivo, sempre all’erta e mai concluso, può andare incontro all’inesauribilità del reale che si offre alla mente di ogni uomo. Trova la verità colui che è capace di dare ragione a tutti, ma a ragion veduta. Con l’intento di includere qualcosa di sempre più nuovo, ma non per amor di pace. E questo è possibile solo quando si è duttili nella propria interiorità, sapendo assumere di volta in volta il punto di vista dell’altro per farlo proprio. Perché ogni punto di vista corrisponde a un modo individuale di vedere il mondo, e la realtà dell’altro è un nuovo frammento dell’oggettività del cosmo.
Il relativismo in voga nei nostri tempi, invece di dar ragione preferisce dar torto a tutti. Vuol proibire agli esseri umani la ricerca della verità decretando che se ognuno ha il suo punto di vista, vuol dire che una verità oggettiva non esiste e dunque sbagliano tutti. Il relativismo in campo conoscitivo è un cedere alla tentazione dell’alternanza. Mantiene in parallelo sia il disinteresse verso la verità – una comoda ottusità che generalizza –, sia l’esaltazione nel dogma apodittico della verità oggettiva che non esiste.
La fortezza, seconda virtù platonica, è quella che cerca invece l’equilibrio tra l’aggressività e la codardia, la prepotenza e la vigliaccheria. Interiormente forte è colui che non ha bisogno di essere aggressivo per affermarsi, per sentirsi un Io. Il giusto equilibrio tra l’aggressività e la tapineria è quella fortezza interiore che si manifesta nel coraggio che può permettersi un amore rivolto a tutti, perché ha fiducia nell’esistenza.
La terza virtù platonica, la temperanza, è quella che media fra ascesi e dissolutezza, tra mortificazione e incontinenza. Da un lato ci sono i castighi violenti inflitti alla propria corporeità e dall’altro il capitolare ad essa, abbandonandosi ai propri impulsi. Nell’un caso lo spirito schiaccia e scaccia la materia, nell’altro la materia schiaccia e scaccia lo spirito. La temperanza è invece l’arte di ristabilire un equilibrio che resta labile, perché richiede continui interventi creativi. È la forza dell’anima sempre più cosciente e aperta allo spirito, attraverso cui materia e spirito s’incontrano e si amano a vicenda.
Platone ha visto così profondamente le antitesi del pensare (esaltazione-ottusità), del sentire (aggressività-codardìa) e del volere (ascesi-dissolutezza) che ancor oggi i suoi pensieri ci sono d’aiuto per capire meglio le molteplici ferite della vita e per impegnarci alla loro rimarginazione. Più si è arroccati su una polarità, e più un lieve soffio dell’altra sembra un furibondo uragano. Più si è esaltati e dogmatici e più un semplicissimo dubbio espresso dall’altro ci porta a bollarlo di ottusità, a dirci: quello lì non capisce niente! Più siamo aggressivi e più una sua minima incertezza ci fa gridare: levati di mezzo, tu che non sai fare niente! Più siamo asceti e più un’ombra di piacere può apparirci immorale: vattene, tentazione!, diciamo. Viceversa, l’ottusità s’intensifica di fronte al più banale problema, la codardia si rafforza alla più piccola provocazione, la dissolutezza disprezza ogni minima rinuncia.
Tutti gli sbilanciamenti dell’umano, in ogni campo della vita, tendono o alla fuga dal mondo o alla paralisi della paura. Ma fuga e paura si toccano, come fanno gli estremi; sono le due facce di una stessa medaglia e convivono in parallelo. Così l’esaltazione è una mezza ottusità, la violenza una mezza vigliaccheria, l’ascesi una mezza perversione. Più l’unilateralità è forte e più nel nostro essere preme l’altro polo. Vedendolo comparire appena sfumato all’orizzonte di una nostra possibile diversa esperienza, ci spaventa facendoci scappare a gambe levate, perché destabilizza la nostra illusione di pienezza.
Eppure anche l’unilateralità più brutta può essere piegata al positivo, fino a farne la migliore occasione di evoluzione. Può essere in grado di far spiccare il volo col migliore degli slanci, attivando un movimento pendolare che tenderà a far rimarginare un lembo della ferita. Se prendiamo sul serio la libertà, ci accorgeremo che ciascuno ha in sé la forza per vincere ogni morte, vivendo d’infinite resurrezioni.
Terzo Capitolo
tecnica e morale:
di pari passo in direzioni opposte?
Il mio bene, il mio male
In tempi di crescente differenziazione ed in cui ognuno cerca la sua specifica fisionomia, il bene morale, da semplice che era, diventa duplice. Così alle norme valide per tutti si aggiunge, come si diceva, quel bene che è diverso per ognuno perché consiste nella realizzazione del proprio essere. E questo rappresenta a sua volta un patrimonio comune. Il bene morale non può più ridursi a comandamenti esterni, validi per tutti. Ognuno dovrà realizzare sempre più quel bene che lui stesso è. Il futuro della morale dipende dal coraggio di ogni individuo di farsi dire dalla sua esperienza personale, che cosa gli è d’aiuto e cosa gli fa male. Deve cioè trovare il coraggio di esporsi nell’agire, osservando come gli altri, nelle situazioni più disparate della vita, reagiscono ai suoi atti e che cosa questo comporta per lui. Solo la sua di vita può offrirgli il criterio del bene e del male. Essi allora cessano di essere questioni di pura teoria, diventando un frutto che si coglie dall’albero dell’esistenza.
Chi s’incornicia in un’immagine precostituita del bene, chi vuol esser buono a tutti i costi, rischia di perdere i più importanti treni che gli passano davanti. Il bene morale dell’individuo sta nel coraggio di dar fiducia alla sua insostituibile esistenza, agli irripetibili incontri del suo destino, a tutto ciò che la sua vita gli porge, giorno dopo giorno. In questo bilancio individualizzato, e sempre da aggiornare, si tratta di scoprire di volta in volta cosa mi viene incontro e cosa divento io, reagendo. Ed è proprio tuffandomi nel mondo più complicato e più spietatamente umano possibile, che riuscirò a capire in che modo ciò che mi si offre mi aiuterà a crescere e quanto. Potrò così progettare i miei passi uno dopo l’altro senza assolutizzarli, senza pretendere che siano tutti buoni, ad occhi chiusi. I tentativi moraleggianti d’ipotecare il futuro, di fare affermazioni astratte su quello che ancora non c’è, sono tentativi di rinnegare il nostro anelito verso l’individualizzazione. Quello che c’è da fare è moralmente ben più importante di ciò che si “deve” fare. Il dovere astratto vorrebbe un mondo diverso in cui poter essere sempre e comunque “buono”. Prendere invece per le corna la situazione in cui mi trovo qui e ora, è il modo migliore per realmente diventare buono per me e per gli altri.
Prendiamo ad esempio il matrimonio: ancora oggi lo si celebra per lo più dicendo un “sì” che intende ipotecare per sempre il futuro di due persone. Certo che l’essere umano ha la capacità di tendere verso ideali grandi e duraturi, restandovi fedele per tutta una vita. L’amore stesso è per natura non scindibile. Due persone possono allontanarsi fisicamente, ma se c’è l’amore, nella lontananza esso non fa che approfondirsi. L’indissolubilità del matrimonio ha invece posto l’accento sulla non fiducia, sulla paura che abbiamo di lasciare aperto il futuro. Mettendo in primo piano i diritti e i doveri, si fa scemare l’amore. Esso non conosce né diritti né doveri, perché dà generosamente, senza calcolo né misura. Molte persone che si uniscono in matrimonio pensano che il vincolo più saldo sia la dichiarazione rassicurante di rimanere l’uno accanto all’altra per tutta la vita, una specie di polizza da sottoscrivere come fosse un tipo di assicurazione.
Poi, a mano a mano che emerge la responsabilità individuale, il matrimonio, da assicurazione stipulata una volta per tutte, diventa sempre più una fiducia reciproca che ha senso, e peso, solo se viene rinnovata ogni giorno. Nel finale della fiaba di Goethe Il serpente verde e la bella Lilia viene detto: d’ora in poi sono validi soltanto i matrimoni che vengono celebrati sempre di nuovo nell’oggi. E ciò perché i giorni non sono mai uguali e tanto meno lo sono le persone. Non è da sottovalutare il fatto che Goethe con ciò vuol dire: tutti gli altri matrimoni non sono validi!
L’evoluzione ha un carattere eminentemente inclusivo e non solo nella ricerca della verità, ma ancor più per quanto riguarda le forze dell’amore. Come la verità è frammentata in singoli punti di vista che attendono di venire integrati in una verità organica, così l’amore possiamo immaginarcelo come smembrato in tanti esseri umani e tende a ricostituirsi, nel cuore di ognuno, in un organismo che ci comprende tutti con la “comprensione” propria del cuore. Non solo non è possibile che un essere umano, una volta entrato a far parte del destino di un altro, possa uscirne, ma con l’andar del tempo, entreranno a far parte del destino di ognuno sempre più anche altre persone. E se fa suo il loro destino, esse faranno parte di lui.
Dire “ti amo” a una persona è come dirle: tu fai parte del mio destino, e io del tuo, e gioisco di questo reciproco appartenerci. I modi con cui continueremo a contribuire al nostro divenire, ci riserviamo di sceglierli nell’armonia di altri rapporti che ci sono e ci saranno sempre, in armonia con gli eventi che il destino ci porterà incontro con le sue sorprese continue. La parte più bella della libertà umana è di lasciarsi sorprendere da tutto ciò che non si può prevedere. La libertà ama l’imprevisto poiché si attua proprio nel prendere posizione, di volta in volta, di fronte a quello che ancora non si sa.
La capacità di orientarci a seconda della situazione in cui ci veniamo a trovare di giorno in giorno, è proprio la forza della libertà che ogni uomo ha dentro di sé: un’espressione della sovranità dello spirito umano. La libertà si espone volentieri anche agli sbagli, perché colui che non è capace di aggiustare in continuazione la sua traiettoria deve sbagliare per adattarsi al mondo in cui vive.
Ci sono due tipi di esseri umani: quelli “cattivi”, e lo sono perché ripetono sempre gli stessi sbagli, e quelli “buoni”, che lo sono perché fanno sbagli sempre nuovi! Dobbiamo riconoscerci la forza morale di provare e riprovare perché non sapremo mai in partenza le ripercussioni che il nostro agire avrà sugli altri.
Cosa vuol dire ripetere sempre gli stessi sbagli, e perché in questi casi siamo “cattivi”? Come esiste la possibilità di conoscere e amare gli altri in modi sempre nuovi, è anche possibile volerli amare a condizione che si mantengano sempre nella stessa maniera. Ma questo vuol dire amarli non come sono, ma come erano o come vorremmo che fossero. Il vero amore invece ama l’altro così com’è. È quella tensione interiore che ci consente di entrare nei panni degli altri cercando di unirci a loro con tutta l’anima. Un’inventiva questa che sa escogitare mille modi di comunione, mentre l’ottusità del cuore paralizza la mente impedendoci di sentire chi, bussando alla nostra porta, vorrebbe entrare nel nostro cuore.
Il sacro e il profano
Noi viviamo il sacro quando pensiamo a un mondo di puro spirito. E chiamiamo profana l’autoesperienza opposta, quella che ci fa sentire immersi in un mondo in cui lo spirito non si sa dove sia di casa. L’induismo non conosce la distinzione tra sacro e profano. Per noi, invece, sono due mondi opposti, distanti l’uno dall’altro, quanto lo è il mondo dello spirito da quello della materia.
Questa antinomia è un fatto specifico della nostra coscienza. Soltanto nella coscienza umana può sorgere l’illusione che ci siano due mondi separati. Nella realtà tutto ciò che noi chiamiamo profano è in fondo sacro, perché tutto ciò che chiamiamo materia è permeato di spirito. Viceversa, quel che consideriamo sacro lo è proprio nel momento in cui diventa profano, quando entra nella vita di ogni giorno e s’incarna nella materia. Solo così diviene davvero sacro per noi uomini. Il senso di questa illusoria dualità è, ancora una volta, l’occasione data all’uomo di ricomporre liberamente ogni dicotomia.
L’uomo si sente profano quando non s’accorge della profonda venerazione che tutte le creature hanno verso quell’essere divino che è l’uomo, ed a cui tendono come mèta del loro cammino. Sacra diventa l’esistenza umana in tutte le sue manifestazioni quando l’uomo la vive come un incessante anelito verso il divino. Quel che fa crescere la persona umana è sacro, perché nulla al mondo è più sacro della persona umana; e non c’è nulla di più profano di ciò che profana e banalizza l’uomo. Ogni tentativo di asservirlo a qualcosa che sia fuori di lui, lo dissacra. Riconsacrare l’uomo ogni giorno e in ogni azione, vuol dire considerarlo il valore supremo della creazione.
E Dio? Dio non è forse ancor più sacro della persona umana? Non si è sempre detto che sacro è tutto ciò che ha a che fare con Dio, mentre tutto ciò che ha a che fare con l’uomo è profano proprio perché non fa parte di Dio?
“Dio”, come di solito lo intendiamo noi, non è che un contenuto della coscienza umana. Il concetto di Dio è un prodotto dello spirito umano, come tutti gli altri. È il più vasto, forse, ma perciò anche il più astratto di tutti. Nessun uomo può andare col suo pensare “al di là” del suo spirito, perché il suo spirito non ha nessun “oltre”. Il divino che immaginiamo fuori di noi è una pura finzione della mente. Nulla di reale. Come un triangolo con quattro angoli: non esiste.
Nel passato ci sono stati vari tentativi di spazializzare lo spirito, e in fondo non erano altro che un risvolto del materialismo, della caduta. Anche il paradiso, il cielo, l’inferno, sono tutti contenuti di coscienza umana. Non c’è inferno peggiore di quando ci si distrugge a vicenda o quando si distrugge se stessi; ed è per giunta un inferno umano, in quanto dentro di noi brucia la coscienza dell’uomo, mentre quel che favorisce la costruzione dell’umano in me e negli altri, è paradiso. Ma un paradiso fuori di me, o al di là di me, è un puro nulla per il mio essere. La Divinità va riportata dentro l’uomo se vogliamo che diventi reale.
Non esiste nessun aldilà dell’umano, il nostro spirito non riconosce nulla che sia fuori di lui, perché fuori di lui c’è il nulla. Nel corporeo c’è il dentro e il fuori, ma non nello spirito! Per questo motivo l’induismo non distingue tra il sacro e il profano: il profano è tutto ciò che allontana l’essere umano da sé, sacro è tutto ciò che fa espandere l’umano verso la prospettiva del divino. Alla visione unitaria dell’induismo è seguita nella coscienza umana una lacerazione che ha separato il divino dall’umano, il sacro dal profano.
Dante dice dei Serafini e dei Cherubini – gli Esseri delle gerarchie spirituali più alte, o “Cori”, come li chiamava lui – “...posson quanto a veder son sublimi”. Perché sono in grado di render reale dentro di sé quanto di sublime riescono a vedere col pensiero. E noi uomini, nell’universo dantesco, siamo la manifestazione “meno sublime” dello spirito divino, la più lontana dalla Trinità.
Ma allora, da spiriti infimi dell’universo, non potremo mai avvicinarci alla conoscenza e all’esperienza della Divinità, costretti a riferirci per sempre al nostro piccolo Dio? Ascoltiamo ancora Dante: “Questi ordini di su tutti s’ammirano – e di giù vincon sì che verso Dio – tutti tirati sono e tutti tirano”: Questi Cori celesti, i nove ordini di entità angeliche, si volgono adoranti verso l’alto, e al contempo riversano saggezza e amore verso il basso. Ogni gerarchia riceve dall’alto e dona verso il basso: tutti tirati sono e tutti tirano! Lo spirito non conosce spaccature, non ammette un dentro e un fuori. È assoluto come la luce. Dove c’è, tutto s’illumina, dove non c’è, tutto è buio; non ammette un dentro e un fuori perché non separa gli esseri, ma li integra.
Profanazione dell’umano nella scienza,
nel diritto e nell’economia
Tre modi fondamentali di rendere sacro o profano l’umano sono la scienza, il diritto e l’economia. In essi la cultura e la vita sociale possono sia negligere che coltivare il sacro nell’essere umano.
La scienza dissacra l’uomo quando scarta l’ipotesi che tutta la realtà sia intrisa di spirito. Negli ultimi secoli la scienza si è interessata soltanto al lato materiale delle cose, andando poi a ripescare concetti addirittura mistici con cui rimescolare come in un gran calderone tutto ciò che in qualche modo rimanda allo spirito. Vale a dire i concetti di “energia”, “forza”, “antimateria”. La disaffezione dello scienziato nei confronti di quanto è spirituale è sorta come reazione a una tradizione clericale conservatrice, che ha sempre sostenuto che la realtà dello spirito non si può indagare con la scientificità del pensare umano perché, come si diceva poc’ anzi, si trova “oltre” l’uomo. Essendo dunque lo spirito immaginato troppo a lungo come qualcosa fuori dell’uomo, la scienza moderna è andata avanti ignorandolo, mettendo così da parte anche quella morale che si rifaceva a un fantomatico spirito extraumano.
Il curriculum degli studi medici d’oggi, ad esempio, non prepara a porsi di fronte all’uomo, ma unicamente di fronte a un corpo fatto di materia. È vero che la psicologia indaga la psiche, ma la vede essenzialmente come un risultato dei vari chimismi corporei.
Al sacerdote per contro è lasciato lo spirito, esistente solo per chi ancora ci vuol credere. Eppure, è evidente che il processo di individualizzazione dovrà sempre più incidere anche sulla costituzione corporea. Come le norme generali valide per tutti cessano di essere il tutto della morale, così diventerà sempre più anacronistico credere di conoscere una malattia limitandosi ai sintomi corporei. Noi parliamo di epatite, per esempio, pensando che sia un fenomeno puramente corporeo, perché un fegato è un fegato, a chiunque esso appartenga. Di tutte le sfere dell’umano, infatti, il corpo è quello più generalizzabile, è fondamentalmente lo stesso in ciascuno. In ogni corpo però c’è un’anima, e c’è uno spirito del tutto individuale e profondamente diverso da ogni altro.
L’enorme influsso dell’anima fa sì che il decorso dell’epatite sia, a un’osservazione più attenta, del tutto diverso da persona a persona. Tutto il peso delle esperienze personali scritte nella propria biografia incide in modo sempre più individuale sulla salute o sulla malattia del corpo. Il medico avrà sempre meno a che fare con l’epatite in generale, e avrà sempre più a che fare con l’epatite specifica di una data persona, in quanto del tutto diversa da quella di un’altra. Il successo di una terapia dipenderà dunque meno dall’aver imparato un metodo uguale per tutti nel caso di una certa patologia, e più dalla capacità di attenzione nel cogliere i risvolti del tutto personali sia del decorrere di una malattia, che degli effetti di una determinata terapia.
Così la sfera del diritto, che fissa i reciproci doveri e diritti dei cittadini, diventa arbitraria quando non si orienta alla pari dignità degli esseri umani, ma cede alla legge del più forte lasciandogli dettar legge. Molti pensano che non esistano diritti e doveri intrinseci alla persona umana in quanto tale, ma solo convenzioni sociali, accordi che variano di nazione in nazione e di cultura in cultura.
Ma in che cosa consiste, concretamente, la dignità della persona umana, cosa profana questa dignità e cosa no? E poi, quando comincia a valere questa dignità, dal momento della fecondazione come vuole la chiesa cattolica, al momento dell’annidamento dell’ovulo come vuole la legge inglese, o al momento della nascita? Una delle ferite più dolorose nella vita dell’uomo moderno è la crescente contrapposizione tra diritto e morale. E sono sempre più numerosi coloro che sostengono che la morale non abbia nulla da dire in fatto di diritto, in quanto non esiste una morale normativamente valida per tutti.
E così per l’economia, il modo in cui può perdere di vista il senso del bene e del male si manifesta con la pressione che il suo potere esercita a tutti i livelli. Più si è potenti, più si taccia di ricatto chi cerca di difendere i diritti della singola persona, e meno si vogliono tollerare le istanze morali che mettano in questione il proprio dominio economico. Soprattutto quello delle grosse ditte internazionali che si emancipa sempre più da ogni tipo di diritto perché può aggirare sempre meglio le leggi dei vari Stati. Quella del mercato non è altro che la legge del più forte. In un mondo in cui ci si sbrana a vicenda, non ci si può certo aspettare che si consideri sacro l’essere umano.
Il più forte dice: tu hai il problema di essere più debole, affari tuoi. Cosa vieni a predicarmi con la morale? Se ti riuscisse d’esser più forte, faresti lo stesso con me. In economia vige la legge della giungla. Il leone deve divorare gli altri animali: che c’è di male? E se ci sono degli uomini-leone che si comportano in modo analogo con gli altri uomini, che male c’è?
Tre modi di alienare la persona umana
Una delle più profonde ferite dell’anima è l’alienazione da se stesso. E una prima forma di alienazione è un certo modo di concepire l’onnipotenza divina. Quando Dio è visto come a sé stante e fuori dell’uomo, il suo operare viene vissuto come un destino che si impone dall’esterno ciecamente, contro cui l’uomo nulla può fare. “Deus lo vult”, è Dio che lo vuole, adduceva Pier Damiani come motivazione insindacabile delle crociate. La cosiddetta volontà di Dio è servita innumerevoli volte non solo ad ostacolare, ma ad annientare la volontà dell’uomo. Eppure questa “volontà di Dio” non è mai stata altro che la volontà di certi uomini imposta a quella di altri.
La versione laica o cosiddetta scientifica dell’onnipotenza divina ha fatto sorgere la seconda grande alienazione della persona umana. Il cosiddetto determinismo della natura. Volendo proibire la libertà individuale, non c’è nessuna differenza fra la struttura mentale del teologo quando dice che tutto viene deciso dall’onnipotenza divina, e la struttura mentale dello scienziato che afferma come tutto venga deciso dalle leggi di natura. Che l’inesorabile venga chiamato “Dio” o “natura”, è solo una questione di vocabolario, dunque. Nell’uno e nell’altro caso il risultato concreto è che l’essere umano non si sente libero, o per lo meno gli si vuol proibire d’esserlo.
E c’è pure un terzo modo tutto moderno di alienare l’uomo da sé proibendogli la libertà. È la corrente culturale che negli ultimi decenni ha fatto fiorire l’esoterismo (e non solo nelle librerie!). Paradossalmente, molti cultori dell’esoterismo moderno, nell’intento di superare i limiti imposti da una teologia spiritualistica o da una scienza materialistica, hanno scoperto un terzo modo di negare la libertà. Lo chiamano “karma” (destino). Non sono pochi ad affermare: chi ti determina, ti fa essere cioè così e in nessun altro modo, chi ti ha procurato questa disgrazia o malattia, non è il Padreterno e nemmeno la cieca natura, ma il tuo karma! Se tu sapessi tutto ciò che hai fatto nel tuo lungo passato – e chi non ne ha combinate di tutti i colori – capiresti che la legge del pareggio karmico richiede nel tuo caso che tu ora ti pigli questo, e poi questo e ancora quest’altro! La colpa non è né di Dio, né della natura, ma tutta tua.
Queste tre visioni della vita – l’onnipotenza di Dio, della natura e del karma – hanno in comune il fissarsi sul passato. Lo ritengono determinante per tutto il presente e il futuro. Ma allora la libertà c’è o non c’è? L’essere umano è libero o no? Il porre la domanda in questi termini ci induce a negare la libertà. Se l’essere umano fosse già libero per natura, lo sarebbe necessariamente, e questo è proprio l’opposto della libertà. E se fosse per natura non libero, anche in questo caso non lo potrebbe mai diventare.
La domanda così posta è il risultato di un preconcetto: che la libertà ci sia o non ci sia. E questa è una falsa alternativa. L’essenza della libertà può risiedere solo nella capacità di diventare sempre più liberi. L’essere umano ha la possibilità di diventare sempre più libero ma può anche omettere di diventarlo. In altre parole, è potenzialmente libero. La libertà, cioè, esiste in ciascuno nella misura in cui la esercita. Ognuno di noi è tanto libero quanta è la libertà che riesce a realizzare ogni giorno della sua vita.
Ma nessuno di noi, si dirà, è libero di fare tutto quello che gli piace! Al che si può rispondere: se ciò che piace fare è possibile, si è liberi di farlo. Se non è possibile, basta non cercare la libertà dove non sta di casa. C’è stato una volta un giovane che si voleva suicidare perché non sopportava di essere costretto a respirare: voleva essere libero di vivere senza respirare! Lo salvò un amico che lo indusse a riflettere: attento, che se ti ammazzi sei costretto a essere morto, mica sei libero poi di tornare in vita. E riuscì a convincerlo.
La libertà è l’arte del possibile e noi la neghiamo quando vogliamo, illusoriamente, l’impossibile. Ogni essere umano ha in ogni momento davanti a sé moltissime cose che gli sono offerte e che fanno perciò parte della sua libertà. Quanti si rendono conto, per esempio, che si è sempre liberi di pensare tutto quello che si vuole? Qui siamo del tutto liberi, ma purtroppo ci pare poco.
Se fossimo noi a fabbricare la natura umana potremmo decidere di mettere la libertà anche in campi dove ora non c’è. Daremmo all’uomo la libertà di lavorare con quattro mani e magari venti dita (o anche di più), lo faremmo volare (e senza aereo, che è anche meglio). Peccato, però, (o per fortuna) che non siamo liberi di ideare l’uomo come ci piace. C’è sempre stato chi ha pensato che colui che ha creato la natura umana abbia messo gli spazi della libertà al posto giusto. E ciò perché gli uomini più liberi sono quelli che hanno cercato la libertà dove la si può esercitare, e non dove non c’è. Ed erano del parere che ce n’è d’avanzo.
Come si costruisce la libertà
Profano, anzi prosaico, diviene l’uomo nella misura in cui si lascia fare dalla vita, facendosi travolgere dagli avvenimenti. Ora in balìa di quello che dicono i giornali, ora della televisione. Sacra, anzi divina, diventa la sua vita e la sua persona, nella misura in cui diviene creatore nel suo pensare e libero nel suo agire.
La libertà è davvero l’arte più bella della vita, anzi è l’arte per eccellenza. Per essere liberi bisogna diventare sempre più artisti a tutti i livelli e in tutte le situazioni. La capacità di diventarlo ce l’ha ognuno, perché ognuno può afferrare in vere e proprie immagini ricche di significato la natura della sua situazione e può altresì intuire i nessi che la strutturano. Il pensare umano è capace di cogliere quali spazi di creatività sono insiti in ogni evento della sua vita.
Ognuno ha la capacità di intuire un modo del tutto individuale e libero di comportarsi nelle varie situazioni in cui si viene a trovare. Questo non è determinato dalla situazione: sta a me concepirlo intuitivamente e tradurlo in pratica. Siccome la situazione in cui mi trovo, se guardo alla realtà interiore delle persone coinvolte, è sempre del tutto nuova, essa mi stimola a inventarmi modi d’essere e di comportamento sempre nuovi. Come non esistono nella vita situazioni che si ripetono, così il mio modo di comportarmi deve assumere sfumature diverse. Solo così individualizzo ciò che fa bene a me e lo fa anche all’altro, senza dover andare a cercare fuori di me astratte norme di comportamento da poter applicare in tutti i casi.
Ognuno è dotato di fantasia morale e artistica, che gli permette di cogliere modi nuovi di rimarginare la grande ferita morale, facendo collimare il mondo ideale e quello reale. La libertà umana è fatta per colmare il divario tra l’idealità nella sua purezza e la realtà nella sua concretezza. L’ideale puro è il godimento della mente, e fare il più piccolo passo verso di esso è godimento anche per il cuore. La libertà è fatta di grandi ideali e di piccoli passi. I grandi ideali da soli, senza i passi che ci avvicinano ad essi, possono scoraggiarci finendo per gettarci nella depressione. Come compiere passi a vanvera, senza ideali che li orientino, ci può frustrare fino al punto di renderci aggressivi contro tutto e tutti.
La fisiologia moderna distingue tra nervi sensori e nervi motori. Nel nostro sistema nervoso, dice, ci sono nervi atti alla percezione, all’attività sensoria, ed altri devoluti a movimenti di reazione. Nell’antichità questa distinzione non si faceva. Tutti i nervi si pensava fossero della stessa natura, vale a dire sensori. Alcuni di essi servono a percepire – non a causare! – i nostri stessi movimenti portandoceli a coscienza. La differenza di prospettiva che nasce da queste due posizioni conoscitive è enorme. Quella della scienza d’oggi, che parla di nervi motori, nega la libertà in quanto afferma che ogni movimento dell’uomo è causato dalla materia dei suoi nervi e non dalla libera volontà dello spirito. Nell’altra prospettiva, invece, i miei movimenti sono causati da me, dal mio spirito. I cosiddetti nervi “motori” servono solo a farmeli percepire, affinché io li porti a coscienza.
Il concetto di materia, in ogni filosofia precedente all’evo moderno, è proprio quello di un’incapacità assoluta di causare, di totale passività. Il concetto di spirito è sempre stato invece quello di causazione primigenia, di creatività assoluta.
Duecento anni fa, ai tempi di Goethe e di Hegel, ci fu una lotta titanica tra lo spirito dell’Europa centrale e lo spirito dell’occidente incarnato dall’Inghilterra prima, e dall’America poi. L’idealismo centro-europeo aveva raggiunto la sua somma vetta raccogliendo duemila anni di cristianesimo nella realtà dell’Io quale espressione massima della densità intellettuale e morale dello spirito umano. Per questi idealisti l’Io era la realtà suprema, e lo spirito umano ideatore e creatore.
Di questa lotta vorrei dare un cenno prendendo spunto da un passo dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche di Hegel; nella seconda parte, nella filosofia della natura, si trova un’invettiva violenta contro Newton a difesa di Goethe per quanto riguarda la natura della luce. Goethe, nella sua teoria dei colori, aveva avversato violentemente Newton perché vedeva in lui un piatto materialismo, privo di ogni capacità di cogliere la realtà dello spirito. Per Newton la luce era un composto di colori. E perché mai gli improperi di Goethe e di Hegel contro questa teoria della luce? Venivano dalla consapevolezza che la luce è la prima rivelazione dello spirito nel mondo della fisicità e come tale non può essere un composto, un effetto cioè di un processo di sommazione. La luce per Hegel e per Goethe era un essere originario e unitario. Tutto ciò che nasce per aggregazione di singoli elementi evidenzia leggi opposte a quelle dello spirito: un passivo effetto della composizione degli stessi elementi di partenza. Perciò lo spirito non può essere composto da elementi diversi, è lui che crea tutti gli esseri e le parti che costituiscono il mondo. Se fosse composto sarebbe il risultato delle sue componenti, sarebbero queste a farlo venire all’essere e non viceversa.
La polarità da comprendere nel fenomeno dei colori è quella che c’è fra ciò che è composto (la materia) e ciò che è indiviso (lo spirito). Nella lotta gigantesca che Zarathustra scorgeva tra luce e tenebra (il risvolto visibile della lotta tra il bene e il male), s’immettevano nella luminosità elementi oscuri. Così nascevano i colori. Luce e tenebra sono esseri spirituali in lotta fra loro, stando a Zarathustra, e anche a Goethe e Hegel. La tenebra è composta, il cosmo disgregato. La luce pura è invece semplice, e solo come unità primigenia può essere creante e causante.
E i colori come spuntano fuori? Non spuntano fuori dalla luce che non li contiene in sé, come erroneamente pensava Newton. Vengono creati dall’incontro, anzi dallo scontro, fra luce e tenebra. Il prisma ha in sé più tenebra dove è di spessore maggiore e meno dove esso si riduce. I diversi gradi di tenebra (e cioè i diversi gradi di spessore del prisma) suscitano, opponendosi alla luce, i vari colori. Essi sono quindi livelli diversi di oscuramento della luce, di mancanza di luce, operati dalla tenebra. Ben lungi dall’essere contenuti nella luce, come sostiene Newton, provengono dai gradi diversi della sua assenza, creati dalla tenebra.
E che c’entra tutto questo con le ferite della vita? Se ci riferiamo alla luce come effetto della somma di colori, se crediamo che anche la volontà sia un effetto dei nervi motori, questo equivale a dire che il nostro pensiero (la luce in noi) e la nostra volontà (l’amore in noi) non sono nelle nostre mani, ma in quelle della natura. La ferita che ci portiamo dentro è proprio quella che oppone spirito e materia, immaginando lo spirito del tutto impotente nei confronti di essa. Facendo invece l’esperienza originaria della luce purissima del pensare, rimarginiamo questa ferita perché comprendiamo come l’origine di ogni realtà materiale sia lo spirito. Facendo l’esperienza di una volontà che è libera, non indotta cioè da sensi cosiddetti motori, il nostro amore trova la forza di trasformare il mondo intero in amore.
Quarto Capitolo
idealità e realtà
nella vita dell’anima
Egoismo e altruismo: i due mezzi amori
Il significato tutto positivo dei contrasti della vita risalta dalla possibilità che essi offrono all’uomo di riequilibrarsi sempre con arte e con inventiva. L’amore di sé e l’amore verso l’altro, egoismo e altruismo, sono una delle più profonde polarità dell’esistenza. La loro riconciliazione ideale viene espressa nelle memorabili parole: ama il prossimo tuo come te stesso. La virtù platonica della giustizia, del giusto mezzo, ci dice essere illusorio amare l’altro senza amare se stessi, e amare sé senza amare gli altri. E se è facile cogliere l’unilateralità dell’egoismo, lo è un po’ meno cogliere quella dell’altruismo.
Ambedue gli atteggiamenti, che sembrano contrastarsi a vicenda, sono il risultato di una profonda lacerazione interiore che abbiamo chiamato “la caduta”. Con la cacciata dal paradiso si aprono all’uomo due nuove vie: una verso l’amore di sé, verso l’autonomia intesa come indipendenza dagli altri, e un’altra verso il ricongiungimento con gli altri e col mondo, che si esprime non solo nell’attrazione fra i sessi ma anche in tutte le forme d’amore che oggi riconosciamo nei legami familiari, di popolo, o nel rispetto comune delle norme che tutelano la comunità.
Il dramma di questo amore spaccato è che ingenera una delle forme più sofferte di schizofrenia interiore. Infatti per amare noi stessi sembra necessario respingere l’altro, e per amare l’altro ci sembra quasi di dover annullare noi stessi. Per questo, egoismo e altruismo non si trovano in partenza equamente distribuiti nell’essere umano; ognuno di noi mostra, e alternativamente, una prevalenza dell’una o dell’altra forza nella propria anima e soprattutto nel modo di agire. La libertà, la creatività interiore, viene vissuta nei continui aggiustamenti che pongono rimedio ai disagi causati dall’una e dall’altra unilateralità.
L’umanità è oggi frammentata in miliardi di “io” chiusi ciascuno in se stesso. Ognuno guarda la vita dal proprio punto di vista che vorrebbe spesso imporre anche agli altri ritenendo il suo oggettivamente il migliore, se non addirittura l’unico giusto. In quanto egoista, l’uomo ama il suo piccolo mondo perché non gli appare per nulla piccolo; infatti lo riempie di sé, ed è questo il suo metro di misura del reale, la sola felicità che conosce. Esiste unicamente ciò che lo riguarda e che gli interessa. Di ogni evento, di ogni incontro, di tutto l’ambiente che lo circonda, coglie soltanto ciò che conferma e rassicura il suo stesso esistere. Ma attraverso l’amore di sé sperimentiamo anche la solitudine, in quanto dando al mondo un’accentuata impronta del proprio sé viene suscitata una grande paura del mondo e degli altri. Ed è proprio la solitudine a far sentire nella propria individualità il vuoto procurato dalla mancanza degli altri, e il loro richiamo.
Essere egoisti significa che ci si è adoperati per promuovere in sé intelligenza, ingegno e capacità operativa, significa aver dato fiducia a se stessi come singoli individui. Il limite, la carenza dell’egoista, sta nel fatto che finché non perviene all’integrazione di sé nel mondo e del mondo in sé (che vuol dire: ama il prossimo tuo come te stesso), egli strumentalizza gli altri e le cose, oppure prendendone le distanze, si difende da tutto ciò che non gli serve o che non riesce a controllare. Nell’uno e nell’altro caso egli non si crea amici, e questo lo fa sentire ancora più solo.
La parola egoismo ci fa pensare spontaneamente a qualcosa che per lo meno non è del tutto a posto. Invece, quando diciamo altruismo, pensiamo subito a qualcosa di lodevole e di buono. Non ci vien fatto di pensare a una qualche carenza o unilateralità come nei riguardi dell’egoismo. Perché mai questa differenza tra l’amore di sé e l’amore dell’altro? È forse il precipitato nella memoria di un’atavica censura rispetto all’egoismo?
L’altruismo, quello che ci viene spontaneo quanto l’egoismo, quello che ci è dato per natura, proviene da una sorta di nostalgia di quel mondo paradisiaco dove non esisteva lo stato di frammentazione che pone gli esseri umani uno accanto all’altro e fin troppo spesso uno contro l’altro. È una nostalgia che conferisce all’altruismo vari gradi di passività e in questo senso ognuno, in quanto altruista nato, tende a guardare il mondo con gli occhi degli altri. O meglio: di alcuni altri, verso i quali vive una misteriosa tensione al ricongiungimento, che può assumere la dimensione del “servizio”. Anziché cimentarsi come soggetto che sgomita in proprio e si assume le proprie responsabilità, l’altruista preferisce la consolante protezione dell’ “essere insieme”. Questo tipo di altruismo non è caratteristica esclusiva delle persone deboli, e non è necessariamente una forma di parassitismo. Bensì è il primo modo spontaneo di orientare la vita, seguendo le scelte e le necessità altrui. Nella tensione con le forze dell’egoismo, l’altruista vive un’autentica dedizione, fino al sacrificio, perché solo cosi ha davvero qualcosa d’individuale da dedicare agli altri.
In quanto impulsi di natura, egoismo e altruismo hanno in comune la mancanza di libertà. E proprio questa mancanza ci permette a malapena di distinguerli l’uno dall’altro: si è altruisti per motivi in fondo egoistici, e si è egoisti, spesso senza saperlo, in vista di un miglior servizio agli altri. L’esperienza della libertà è invece nel dover scegliere. Posso mettere in primo piano me stesso, solo mettendo in secondo piano l’altro, e viceversa. Ed è questo esser costretti ad alternare, che rende possibile da un lato il moto pendolare di ogni evoluzione e dall’altro la carenza tipica di ogni unilateralità. Come una fame e una sete che non si possono soddisfare una volta per tutte. La mèta dell’evoluzione dev’essere quindi un tipo di comunione (altruismo) che renda perfetta ogni individualità singola, e insieme un tipo d’individualità grazie alla quale venga a perfezione l’organismo dell’umanità intera.
L’amore istintivo per l’altro dà una percezione di sé come di rimando. È la paura di sentirsi persi, il giorno in cui potremmo rimanere soli con noi stessi. E come l’egoista ha paura degli altri, della comunione cioè, l’altruista ha paura di sé, dell’autonomia. Nell’essere sempre un po’ in secondo piano, in questo dedicarsi agli altri, egli si protegge dal dover tirar fuori da se stesso l’impulso al vivere. E gioisce quando qualcuno gli dice: come farei senza di te? Il mondo gli sembra troppo grande perché non riesce a penetrarlo col nerbo del suo io, e preferisce perciò affrontarlo attraverso la vita di coloro ai quali si sente particolarmente legato e che lo rassicurano. Il vero limite di questo altruismo di natura sta nel fatto che il prossimo da amare è quello fisicamente vicino e al quale ci si può appoggiare. Non è l’interessamento libero dell’Io a rendere gli altri più “prossimi”, cioè vicini, ma è la presenza, l’operare degli altri a creare la vera prossimità.
La figura tradizionale della madre di famiglia (o quella del soldato che offre la vita per la sua patria) s’illumina in gran parte di luce riflessa. Sa riempirsi delle gioie altrui come mai l’egoista potrebbe immaginare. L’amore vissuto come rifugio e come antica culla, ha in sé tutte le unilateralità di ogni gruppo: dal più piccolo – due persone – nell’innamoramento, alla famiglia, al popolo e, ancora oltre, a tutto ciò che è settario e che per natura tende a escludere “il resto” degli uomini e del mondo.
C’è qualcosa di male ad amare se stessi e pochi altri?
Il lavoro di libertà che viene a colmare la lacuna insita in ogni egoismo sta nel capire che è illusorio pensare di poter bastare a se stessi, senza accorgersi che l’umanità intera aspetta di condividere la gioia e i frutti della propria conquistata autonomia. Lo stesso vale per l’altruismo che va benissimo come tensione verso l’altro, perché questa tensione al ricongiungimento c’è, ed è un’esigenza reale.
C’è un moralismo annoso, di natura prevalentemente clericale, che condanna l’egoismo come se l’amore di sé fosse solo qualcosa di negativo. Invece, l’adagio che dice “ama il prossimo tuo come te stesso” indica l’amore di sé come modello per l’amore del prossimo, evidenziando quanto esemplare esso sia. L’amore dell’altro va infatti conquistato liberamente, e il cosiddetto egoismo ha risvolti negativi solo nella misura in cui gli manca l’amore dell’altro.
Ma c’è un altro moralismo, un potente corollario del primo, anche se più recente e di estrazione laica, e dice: il cosiddetto altruismo è un’illusione. Un’illusione, perché parziale e soprattutto interessato, visto che seleziona talmente bene quali siano “gli altri” ai quali dedicarsi, da sapere poi ignorare tutto il resto dell’umanità. Perché l’uomo, anche quando crede di essere altruista rivolgendosi a qualcuno con amore, è solo ed esclusivamente egoista. Anzi, l’altruista si ama ancor più dell’egoista, perché si prodiga nella speranza che tutti gli gettino le braccia al collo manifestando eterna gratitudine! L’altruismo, dicono certuni, non è che un egoismo più raffinato: tutto nell’uomo è egoismo. Irrimediabilmente.
Questi due moralismi, presi insieme, concorrono a celare all’individuo la sua reale condizione di scissione. Il primo annulla la positività dell’amare se stesso, il secondo vanifica la generosità dell’amare qualcun altro, riconducendo il tutto a puro egoismo, già bollato in partenza. E così la condanna è completa.
Il sentiero dell’egoismo ci fa sbucare sulla via maestra che ci riconduce all’umanità. E questo è descritto magnificamente nella parabola del figliol prodigo. Egli va via dalla casa del padre per dedicarsi a sé, sperperando ogni bene. Alla fine, dopo aver mangiato le ghiande dei porci in una stalla, pieno di dolore e di solitudine riprende la via verso la casa paterna dove sarà accolto con grande festa. Perché? Perché sono le sue gambe; irrobustite da anni di solitario cammino, a ricondurlo nella comunità. È un ritorno che avviene anche per amor di essa, perché il figliol prodigo porta alla comunità la ricchezza di tutto ciò che è diventato.
Al contrario, in fondo alla via dell’altruismo c’è il nostro Io ad attenderci. È questo che narra la parabola dei talenti. Il padrone, prima di partire, affida ai suoi servitori dei talenti e uno dei servi, per paura di perderli, li seppellisce sperando che basterà poi riconsegnarli, tanti quanti erano. Continua perciò a servire fedelmente la comunità secondo le rassicuranti leggi del padrone, come sempre ha fatto. Quando, al suo ritorno, il padrone gli chiede più di quanto ha dato – ciò che la libertà umana deve aggiungere alla grazia divina – scopre che quel servo non ha avuto l’ingegno di moltiplicare i talenti ricevuti. Ordina agli altri servi di cacciarlo fuori, dov’è “pianto e stridor di denti”. Diversamente dal figliol prodigo, che ha ricavato dal suo stesso egoismo la sofferenza che lo ha ricondotto alla comunità, per arricchirla, il servitore, da altruista pigro, riceve dalla stessa comunità la sofferenza che lo rinvia a fare i conti con la sua chiamata alla libertà che ha trascurato, o forse temuto.
Come ricomporre le due metà dell’amore?
Come si fa a rimarginare la duplice ferita dell’egoista e dell’altruista in questa vita che abbiamo a disposizione? Se sono un egoista senza rimedio, come farò ad amare l’altro? Come faccio a sapere se ciò che compio lo favorisce e lo aiuta per davvero? La risposta, già accennata, dice: guarda al modo in cui ami te stesso. Certo, non saprò mai con esattezza cos’è in partenza che mi fa bene, però è una vita che ci provo. Tutto quel che faccio è nell’ottica di garantirmi il meglio, non certo di danneggiarmi o impoverirmi. Se costruisco per gli altri con lo stesso interessamento e la premura che non desiste mai, se provo per loro lo stesso desiderio di bene che rivolgo a me, sarà facile trovare le intuizioni giuste. E l’opposto vale per l’altruista. Dagli altri riceverà l’incoraggiamento a dedicare pure a sé tutte le attenzioni che rivolge ad essi, per realizzare quella pienezza del proprio essere di cui hanno bisogno.
Al fiume della vita, che scorre fra le due sponde dell’amore, non sarà mai permesso di uscire dal suo alveo; tutto ciò che l’uomo fa con amore è infallibile. Come la navicella che affidandosi alla corrente non sbatterà contro le sponde, così più mi lascerò condurre nell’amare un’altra persona, meglio saprò farle del bene.
La socializzazione dell’egoismo
e l’individualizzazione dell’altruismo
Si è accennato alla polarità fra individuo e comunità (una variazione della polarità amore di sé-amore per l’altro). Anche qui, colui che insiste sull’individuo sminuendo l’importanza della comunità, ritiene che si escludano a vicenda, che con l’aumentare di un polo debba per forza diminuire l’altro. Più c’è comunione, e più l’individuo rinuncia a se stesso, e più ognuno si occupa di sé più la comunità va a ramengo. Così ragiona.
Ma la realtà della vita, se osservata bene, c’insegna che è vero l’opposto. L’individuo acquista sempre più autonomia e valore unicamente grazie alla dedizione agli altri; e viceversa la comunione di tutti diventa ricca e profonda unicamente grazie al contributo unico dell’individualità di ciascuno.
Il dinamismo della libertà umana consiste proprio – come avviene in ogni organismo vivente – nel favorirsi a vicenda e nella solidarietà comune. E la meta finale di questo dinamismo deve essere quella di diventare spiritualmente membri gli uni degli altri, creando un organismo fatto di tanti organi del tutto individualizzati.
Quant’è ancora lontana questa pienezza che il singolo e la comunità si donano reciprocamente! Ad essa non possiamo che tendere incessantemente. Ed è proprio in questa tensione che facciamo l’esperienza delle due sponde dell’amore che, interagendo fra loro, è come se fiorissero, e arricchendosi di una verde vegetazione e di tant’altri colori, diventano più belle. Amando l’altro capisco la pienezza che lui desidera contemplare in me; amando me stesso curo i doni che ho da portare incontro agli altri.
Se sono un egoista, posso cominciare ad aver cura di me accennando un timido gesto d’amore verso quel prossimo che si attende di ricevere ricchezza e non povertà. Ma se resto interiormente povero, distribuirò solo povertà attorno a me. Proprio perché non ho il diritto di presentarmi agli altri a mani vuote, l’amore di me diventa inesorabilmente amore per il prossimo. E per l’altruista filantropo vale in fondo lo stesso. Il suo incessante prodigarsi per gli altri farà di lui un incontenibile mulino a vento se non si darà una calmata nel mettere un po’ d’ordine dentro di sé; ma insieme anche quel po’ di ricchezza che gli consentirà di star bene da solo, quando gli altri desidereranno d’esser lasciati in pace.
In quale modo, concreto, amando l’altro posso amare me? Mi amerò ogni volta, che amerò l’azione stessa che sto compiendo nei confronti di un’altra persona. Posso star certo, allora, che anch’io, contemporaneamente, ne sarò arricchito; e proprio nel compiere questa azione. Perché se amo l’azione in sé vuol dire che non mi attendo un tornaconto dall’altro o dalle circostanze. L’amore non crea mai crediti o debiti, altrimenti sarebbe un esercizio di pura ragioneria.
Supponiamo che una persona cara desideri respirare un po’ e voglia staccarsi da me perché io, in questo momento, le tolgo l’aria. Solo per un breve periodo. Potrei cercare di trattenerla perché mi piace starle accanto, (è così che il mio egoismo cercherà di ricattarla), oppure potrei a mia volta chiudermi in me e dirle scontrosamente: vai vai, non ho certo bisogno di te (così “si vendica” il falso altruismo). Il libero movimento vorrebbe instaurare un’amicizia tra gli opposti e direbbe invece: amo lasciarti andare, concederti tutto lo spazio che vuoi perché solo tu puoi sapere ciò che è meglio per te. E proprio questa azione di farti spazio mi realizza sommamente in quanto essere amante. Perciò dico questo non per amore ma con amore, e mi riempio di gioia.
L’arte della vita sta dunque nel capire sempre meglio il senso di tutte le polarità dell’esistenza per poi, nell’azione, vivere l’un polo dentro l’altro. La carica di altruismo di ognuno diventa così la molla ad amare sempre meglio se stesso, e la buona dose di egoismo che ognuno ha, diventa il miglior movente per amare il prossimo per quel che è.
L’amore esteso nel tempo e calato nello spazio
Per guardare ancora più concretamente alle tensioni che ognuno vive nel quotidiano, faccio riferimento a un testo fondamentale di Rudolf Steiner – La scienza occulta – nel quale egli analizza, tra l’altro, quattro cammini di crescita interiore che consistono nel ristabilire sempre di nuovo il giusto equilibrio tra esigenze di vita opposte, ma altrettanto legittime. L’ottica fondamentale è quella appena espressa: trovare l’autenticità di ogni aspetto di un determinato fenomeno, non nell’escludere il suo lato opposto, ma nel favorirlo.
La prima polarità riguarda l’importanza di coltivare una ricca vita interiore che sa proteggersi dal frastuono del mondo, da un lato, e l’importanza dell’apertura verso il mondo esterno, e dell’interessamento a ciò che avviene attorno a noi, dall’altro. Alcuni tendono per natura all’introspezione, a rimuginare sugli eventi: sono gli introversi. Si trovano a proprio agio nel vivere in se stessi e fanno fatica a prestare attenzione agli altri, a entrare in un dialogo con essi. Interagire col mondo non gli viene spontaneo e perciò può essere oggetto di conquista della libertà il riuscirci, senza per questo rinunciare alla vita interiore, bensì rendendola più genuina.
Altre persone tendono invece ad essere estroverse, a cercare il contatto con gli altri e sentono come un peso l’occuparsi della propria interiorità. Non c’è dubbio che viviamo in un mondo sommerso dalla comunicazione: immagini, stampa, spettacoli, Internet... Tante persone, soprattutto giovani, quando si trovano ad avere un po’ di tempo, non sapendo cosa fare mettono su un CD. Occuparsi del proprio mondo interiore, mettere ordine nella propria anima, diventa per loro, non riuscendogli per nulla spontaneo, una conquista della libertà.
Il giusto equilibrio tra le antitesi della vita ognuno deve trovarselo da solo. Possiamo immiserirci se non lavoriamo alla nostra interiorità e possiamo perdere una buona fetta dell’umano non coltivando una vivace interazione col mondo esterno. Anche l’anima, come il cuore, fra una diastole e una sistole alterna un respiro tra il mondo interno e quello esterno.
La metafora del dentro e del fuori, un’immagine spaziale, diventa più concreta se vi aggiungiamo la realtà del tempo. Se rimango chiuso troppo a lungo in me, senza vivere, allo stesso tempo, in comunione col mondo fuori di me, ebbene questa esperienza mi farà sentire sempre più solo, sempre più estraniato dagli altri. Se invece vivo per troppo tempo fuori di me, senza attingere alla mia interiorità, finirò per svuotarmi, sentirmi annullato nel collettivo.
Il senso della tensione interiore che mi fa tornare in me dopo essere stato coinvolto con il mondo, è il desiderio che ho di ordinare le esperienze vissute. Mentre le faccio, non posso al contempo rifletterci sopra più di tanto, perché essendoci dentro, non posso guardarle oggettivamente. Certi sostengono che facendo jogging meditano meglio che stando fermi. Ma ciò non convince perché l’agire – e il correre è un agire – è sempre in un rapporto di sana tensione col riflettere.
Quando sono in relazione con il mondo, vivo maggiormente fuori di me. Ritorno in me, quando esco dall’esperienza diretta. Si tratta di capire in che modo i due poli, pur alternandosi, si favoriscono a vicenda – se vissuti in modo sano. Ma la differenza principale, fra l’idealità e la realtà, sta proprio nel fatto che ciò che per il pensiero è contemporaneo, nell’esecuzione attiva dell’agire richiede l’alternarsi delle posizioni l’una dopo l’altra.
Ma allora quell’alternare che si era presentato come una tentazione diabolica adesso va bene? Se è vero che la perfezione dell’umano sta nel vivere al cento per cento tutti gli opposti, ciò vuol dire che essi non potendo esser vissuti contemporaneamente, devono alternarsi. Inseriti nello spazio come siamo, limitati dalle leggi del corporeo, ci viene incontro lo scorrere del tempo concedendoci di vivere le cose l’una dopo l’altra. E vivere nel tempo vuol dire vivere in un continuo dinamismo interiore. Ed a questo diamo il nome di libertà.
Cosa mi dice il fatto che quando sono rivolto verso l’esterno devo rinunciare ad essere del tutto incentrato in me? Mi dice che devo saper creare dei momenti in cui chiudere la porta per elaborare le esperienze fatte, ordinarle. Potrò confrontare opinioni ed esperienze opposte: lì ho pensato una cosa, là il contrario. Come mai? Potrò riflettere sul mio modo di reagire; verso l’uno ho provato simpatia, verso l’altro il mio comportamento è stato dettato dall’antipatia. Come mai? L’introspezione è un esercizio di osservazione oggettiva, imparziale. L’anima respira alternando introversione ed estroversione. Se rimanessi sempre chiuso in me, fuggirei dalla vita, dalla palestra della mia libertà, dal destino. Se fossi al contrario sempre fuori di me rimarrei inchiodato a quello stesso destino, subendo tutto senza mai prendere posizione.
Quando mi rivolgo verso l’esterno devo saper dare importanza alle minime percezioni, perché tutto attorno a me ha qualcosa da dirmi. Ogni fiore, ogni sorriso, ogni luce e ogni ombra. Non esistono percezioni insignificanti. Solo se la nostra testa è fra le nuvole e il nostro cuore è vuoto possono esserlo. Prestare attenzione a tutte le impressioni che ricevo, significa prendere sul serio il mio destino; perché non è a caso che io, in questo momento e luogo, venga percorso da questi precisi stimoli. Chi va in cerca di percezioni sempre nuove, “sensazionali”, lo fa spesso perché i suoi sensi sono diventati ottusi e il suo cuore si è chiuso ai mille miracoli che avvengono attorno a lui. Quando le emozioni quotidiane non ci scuotono più, andiamo in cerca dell’eccezionale. Eppure, il senso di una sensazione non ce lo possono mai dare i nudi sensi, ma solo una mente attenta, e un cuore che ama. Le percezioni, anche le più insignificanti, sono tutte eccezionali per una mente e un cuore d’eccezione.
Un esempio. Uno scopre all’improvviso un brutto difetto in una persona che ama. Se si limita alla percezione e all’immediata “sensazione” si sentirà probabilmente deluso e amareggiato. Però può anche scavare dentro di sé e chiedersi: che cosa mi vuol dire questo difetto? Mi dice forse che debbo smettere di stimare il mio amico? No, i momenti di riflessione servono a farmi capire che vivere nel tempo vuol dire fare le cose una dopo l’altra; mai tutte insieme. Ciò vale anche per il mio amico che non può possedere tutte le virtù in una volta sola, ma ne potrà coltivare alcune, mettendo in secondo piano altre. E le virtù messe in secondo piano, facendo torto a noi e agli altri, le chiamiamo “difetti”.
Se uno è un bravo ingegnere, capace di emergere nel suo lavoro tanto da essere chiamato di qua e di là a costruire strade, ponti o grattacieli, potrebbe stupire, in negativo stavolta, il collega che osservandolo per la prima volta fra le mura domestiche, s’accorgesse di come si comporta. Che magari trascura i figli, ignora la moglie, e per ogni contrarietà casalinga s’innervosisce oltre misura. I difetti dell’altro, a rifletterci bene, non saranno comunque un motivo sufficiente per cessare di stimarlo, bensì un motivo in più per capirlo meglio.
Fiducia in sé e negli altri
Un’altra bella polarità è quella tra la venerazione rivolta a un’autorità esterna, e la fiducia nella propria capacità di giudizio. Ogni devozione vera, in ultima analisi, è devozione verso la verità. Però agli occhi del bambino la verità s’incarna non solo nella bellezza stimolante delle cose, ma anche negli esseri umani; magari in uno in particolare, al quale rivolge tutta la sua fiducia e da cui si attende una guida sicura. E soltanto nella misura in cui ognuno di noi ha vissuto nell’infanzia queste forze di venerazione, sviluppando la capacità di ammirare qualcosa di grande e di bello, sarà poi in grado, da adulto, di costruire qualcosa di altrettanto grande e bello dentro di sé, e di rivolgere quella stessa fiducia verso il proprio essere.
Un animo capace di commozione di fronte a un cielo stellato, di riempirsi di meraviglia per i misteri insondabili della creazione, ebbene quello stesso animo saprà vivere in sé un senso non meno profondo della bellezza dell’anima umana. La fiducia nella propria interiorità nasce dall’esperienza di venerazione verso tutte quelle meraviglie del mondo, e che solo una mente e un cuore divini possono aver creato. La vita è fatta per interiorizzare pezzo dopo pezzo un mondo fantastico, e meravigliosi diventano mente e cuore quando si riempiono di meraviglia. L’adulto ha ragione di fidarsi della sua mente e del suo cuore, e di dipendere sempre meno da autorità fuori di lui.
Devozione verso il mondo esterno e fiducia in sé sembrerebbero escludersi. In realtà si richiamano e si rafforzano a vicenda. Si vivono inizialmente dilazionate nel tempo, per rincontrarsi poi nell’animo saggio dell’adulto. Più una persona sente venerazione e devozione verso il creato, più acquista fiducia in sé, accogliendo l’affidabilità del mondo nella propria mente e nel proprio cuore.
Il raziocinio analizza e il cuore intuisce
Una delle ginnastiche più appassionanti della vita è quella che si vive ascoltando la mente e il cuore proprio perché parlano due linguaggi del tutto diversi, anzi polarmente opposti. Di fronte a ogni decisione ci sono in noi come due distinti tribunali, che spesso emettono verdetti contrastanti. Da un lato c’è la reazione spontanea dell’anima che va per intuizione, e dall’altro quella razionale dell’intelletto che soppesa il pro e il contro. A quale dei due dobbiamo dare ascolto quando non vanno d’accordo?
L’animo femminile si fida spesso più delle premonizioni intuitive che vengono dal cuore; mentre una buona percentuale di maschi preferisce ragionare sulle cose, fidandosi della razionalità, del giudizio, specie quando si tratta di prendere decisioni importanti. E la vita diventa bella per tutti, quando ogni intuito del cuore stimola il lavoro lucido del pensiero, quando la dedizione a un pensare vivace accende il cuore di un amore sempre più profondo. Meno bella è invece la vita quando si vuol essere del tutto razionali di fronte a eventi che la premonizione dell’anima sa cogliere in modo ben più profondo, o quando si resta preda di confuse emozioni laddove sarebbe meglio usare il sano raziocinio che procede con i piedi di piombo.
Di fronte a un evento improvviso, o inconsueto, il giudizio può dire: comportati così e così. Ascoltando però attentamente la voce del cuore, la si sente mormorare: è pericoloso, sta attento, non farlo... Quale delle due voci ascoltare? Solo l’esperienza può trovare di volta in volta la giusta risposta a questa domanda. Già il fatto di sapere che a volte va ascoltata l’una, e a volte l’altra, ci dà il coraggio di provare ora l’una ora l’altra. Solo provando s’impara. L’importante è restare eterni discepoli della vita, disposti a imparare, e fino alla morte.
Certo che la voce della ragione parla in modo più chiaro, ma è perciò anche più superficiale. La voce del cuore è più misteriosa in quanto proviene da profondità non accessibili alla coscienza ordinaria. Sgorga da un risuonare imperscrutabile che sussurra di me e del mondo in me, ma con cui non sono ancora del tutto identificato. Proprio per questo devo prendere sul serio questa voce, perché la capisco ancora troppo poco. Prestarle attenzione è il modo migliore per comprenderla sempre meglio.
L’aiuto che la mente dà al cuore sta nel non confondere l’intuizione con il richiamo degli istinti, oscuri per natura e inconsci. In noi albergano due istanze, oltre quella della ragione. Una, più saggia, viene dal profondo del nostro essere spirituale, ed un’altra meno saggia, nasce dalla costituzione fisiologica in noi e operando con l’imperiosità dell’istinto tende a soffocare ogni moto di libertà.
Pazienza e tempestività
nel rispondere alle domande della vita
Una quarta forma di dinamismo interiore che media fra gli estremi riguarda specificamente il cammino della conoscenza. Ognuno porta in sé il desiderio di capire sempre meglio la vita e il mondo che lo circonda. Ma cosa vuol dire capire, cosa vuol dire conoscere?
Bisogna distinguere anzitutto tra sapere e capire. Quando uno mi dice: io so tutto di te – e supponiamo pure sia vero –, non per questo mi sento compreso da lui. Sapere è più una questione di quantità, di quante cose cioè si sanno; capire ha invece a che fare con la qualità. Un computer “sa” molte più cose di me, ma questo non vuol dire che capisca la vita e il mondo meglio di me. In un’epoca di eccesso d’informazioni, manca una profonda comprensione delle cose, e se ne sente fortemente il desiderio, magari non del tutto conscio.
Per conoscere qualcosa a fondo bisogna ristabilire di continuo l’equilibrio tra due tendenze opposte: quella dell’impazienza che pretende una risposta immediata ed esauriente a domande che riguardano tutto e tutti, e quella dell’insicurezza interiore che non ce la fa a pronunciare nessun giudizio conoscitivo, e preferisce perciò rivolgersi al consiglio altrui. La virtù del mezzo viene esercitata nel saper fare tutte e due le cose, a seconda delle situazioni di vita in cui ci si trova.
Da un lato è importante avere la pazienza di aspettare il tempo necessario a ricevere la risposta a una determinata domanda. E questa capacità di saper aspettare, proviene dal convincimento che gli enigmi della vita non si sciolgono in base a risposte che vengono dal di fuori, bensì dal di dentro. Grazie a una lenta maturazione interiore. D’altro canto ci sono situazioni in cui la vita chiede una risposta qui e ora, e allora bisogna avere il coraggio di fidarsi del proprio giudizio e dare una risposta. Sebbene non riesca ad esprimere il giudizio più maturo e perfetto che ci sia, è però la risposta di cui c’è bisogno ora per far fronte alle circostanze.
Istinti sociali e antisociali
nella comunicazione dei pensieri
Possiamo considerare l’antisociale istintivo e il sociale libero quando ci comunichiamo dei pensieri, quando viviamo dei sentimenti e quando mettiamo in moto la nostra volontà passando all’azione.
Ciò che avviene quando scambiamo dei pensieri passa per di più inosservato perché noi facciamo attenzione quasi unicamente al “che cosa” diciamo, e disattendiamo il “come”. Quando una persona mi dice qualcosa, in realtà cerca di far addormentare il processo pensante gestito da me per costringermi al suo. Non siamo ancora capaci di essere desti contemporaneamente nel proprio e nell’altrui processo pensante.
Ci tocca alternare l’uno con l’altro, in un’altalena che è una delle più appassionanti della vita.
Per fare attenzione ai pensieri di un altro, per capire la concatenazione dei ragionamenti che fa, debbo interrompere il mio processo pensante. È proprio così. Quando due persone parlano fra di loro, chi esprime un pensiero pretende che l’altro “lo segua”. Tanto è vero che quando non siamo sicuri se l’altro ci sta ascoltando, lo sollecitiamo chiedendogli: mi segui? Chi parla vuol convincere l’altro e il convincere è proprio un “vincere insieme”, conseguente al fatto che chi ascolta deve allearsi con chi parla per vincere con lui, per dargli ragione del fatto che, sì, viste dal suo punto di vista, le cose stanno proprio come dice lui. Ciò presuppone che chi ascolta lasci perdere almeno per un istante il suo punto di vista. Se il processo pensante dell’altro che mi parla non addormentasse il mio, non potrei capire quello che mi dice perché continuerei a pensare per conto mio.
In ogni comunicazione di pensieri c’è dunque una tendenza a sopraffare, anche se ciò non sempre si manifesta a livello emotivo. E questo tentativo di sopraffare ci vuole, perché dà, a chi ascolta, l’occasione buona per opporsi al tentativo dell’altro di farlo sparire come pensatore autonomo, mostrandogli che sa pensare a modo suo e non meno di lui. Lo fa “controbattendo” i pensieri dell’altro con i propri. E spesso non lo lascia neppur finire andando a sua volta all’attacco. In men che non si dica prende posizione, e gli risponde a tono. Così nasce la cosiddetta botta e risposta. La botta è proprio una botta mentale: A esprime un pensiero intendendo dire “Guai a te se non mi dai ragione, saresti un deficiente”. E ascoltandolo, B si vede costretto a lasciar da parte i propri pensieri, per dar ragione a quelli di A. Ma subito dopo reagisce a questo piccolo omicidio e riafferma se stesso dando la sua mazzata con una forte risposta.
Questo raffinatissimo ammazzarsi a vicenda e in modi velocissimi, è proprio il segno d’una socialità ancora tutta da conquistare. Ma niente di male! Il male sarebbe se questo modo di comunicare fosse visto come il più perfetto esistente, e non si facesse nulla per imparare a entrare nel processo del pensare altrui senza uscire dal proprio. Ogni singolo pensiero non può essere che unilaterale, non può racchiudere tutto il pensabile, ed esprime solo un frammento del reale. E siccome questo “frammento del reale” sei tu che mi parli, io, per salvare me stesso, per non farmi risucchiare dalla tua unilateralità, ti metto accanto il mio pensiero successivo. Sì, però, ma...è anche vero che... forse non consideri... Quando nella risposta c’è un “però”, ciò che viene detto prima del “però” non è importante. È invece importante quel che viene dopo, il tentativo cioè di affermare se stesso, aggiungendo qualcosa di suo. Quello che dici è giusto, però... Però è giusto quello che dico io!
La comunicazione a livello dei pensieri è un vero gioco di tennis dove la palla va avanti e indietro nel tentativo di mettersi d’accordo. Altra bella parola: accordo. Viene dal latino cor – cordis, cuore, e sta a dire che due si mettono d’accordo quando dalla sfera della testa scendono a quella del cuore, dove ognuno prende cioè a cuore quel che dice l’altro, senza bisogno di dargli ragione per forza. I tedeschi fanno più fatica a mettersi d’accordo, perché l’uno non chiede all’altro: “sei d’accordo?”, ma gli chiede: “einverstanden?”, che vuol dire: hai finalmente capito o no? (Verstand è l’intelletto). Non si mettono d’accordo finché non si sono capiti...
E cosa fa l’accordo, sia in musica che nella conversazione? Parte dal riconoscimento della pari dignità dei due spiriti pensanti, non avverte il bisogno di difendersi, sopraffare, mettere l’altro all’angolo di un ring, ma si lascia andare volentieri alle sue affermazioni, magari per integrarle con le sue. Quante volte ci sentiamo dire: tu non ascolti quello che dico! Qualche volta può essere anche vero, ma il più delle volte sappiamo bene che saremmo in grado di ripetere per filo e per segno quello che l’altro ha detto. Da cosa nasce allora la sua protesta? Dal fatto che non ha sentito “amato” il suo pensiero. Col nostro affrettarci a rispondere, a dire la nostra sull’argomento, abbiamo omesso di onorare la dignità del suo spirito.
Ciò che rende sempre più sociale una comunicazione di pensieri è l’equilibrio di forze che nasce dal riconoscersi a vicenda quali esseri dotati di facoltà pensante, capaci di dar ragione, se c’è da dar ragione, e capaci d’integrare le unilateralità, quando si presentano. Capaci, insomma, di mettersi d’accordo. E se l’altro è meno agile nel rilanciarmi la palla, l’equilibrio non sta certo nella sua capitolazione di fronte a me – che sarebbe la fine del gioco – ma nel trovare quel giusto movimento che consenta a tutte e due un dialogo alla pari.
Istinti sociali e antisociali nella sfera dei sentimenti
Di tutt’altro tipo è la tensione che si crea quando viviamo o esprimiamo dei sentimenti. Il mondo dei sentimenti è sempre presente in noi, anche se in certi frangenti poniamo maggior attenzione ai pensieri, in altre al fare.
In questo campo, il gioco di forze viene dato dal fatto che il sentimento – a differenza del pensiero – non può mai essere oggettivo. Esso è per sua natura sempre soggettivo. Il sentimento mi fa vivere e godere emozioni, voglie e passioni che sono tutte cose mie. E nel rapporto la caratteristica dal sentimento è che serve a falsare inesorabilmente la percezione e la valutazione dell’altro. Di fronte all’altro sorge sempre della simpatia o antipatia. Un animo che resti assolutamente neutro nei confronti di un’altra persona, non esiste. Non sarebbe un animo, perché il concetto di animo è proprio quello della pura reattività soggettiva, piacevole o spiacevole, alle persone ed agli eventi.
Tocca al pensiero comprendere la natura del sorgere dei sentimenti, per essere in grado di gestirli ragionevolmente man mano che germogliano. E la prima cosa che va capita è che è pericoloso fidarsi di essi quando si tratta di conoscere l’altro. Il sentimento mi dice cosa vive in me quando sono esposto a lui, ma non dice proprio nulla circa l’essere dell’altro. Provare simpatia o antipatia, significa vedere l’altro migliore o peggiore di quello che è, mai come si presenta nella realtà.
Allora mi chiedo: come mai nei confronti di questa persona provo simpatia e di quest’altra antipatia? Da dove provengono questi orientamenti del mio animo che mi lavorano dentro senza poterci far nulla? Nessuno di noi li costruisce liberamente; emergono come fatti di natura.
Quando io noto in me una forte antipatia mi dico: ora debbo rimboccarmi le maniche. Il significato di questo incontro è che mi porge l’occasione di lavorare su me stesso per vincere questa ostilità. Ben lungi dal dirmi qualcosa di oggettivo sull’essere dell’altro, l’antipatia è simile a un compito che mi vien dato per lavorare su me stesso. E siccome questo lavoro costa fatica, ci vogliono anche momenti di riposo, e questi mi vengono dati dalle persone che ovviamente mi sono simpatiche. Basta che poi mi rimetta di nuovo al lavoro.
Istinti sociali e antisociali nella volontà
Dal fatto che ognuno è per tanti versi “forte” (egoista) e per altri versi “debole” (altruista) risulta un’estrema complessità in ciò che avviene nei rapporti fra gli uomini, sia nel campo della volontà che dell’azione. Quelle che a livello del sentimento erano pure realtà interiori di simpatia e di antipatia, si riversano ora all’esterno in forma di un’attrattiva o di un’avversione che possono travolgere e sommergere. Il sentimento si traduce in comportamento, evidenziando in modo drammatico tutto il lavoro che ognuno deve fare su di sé per rimarginare le ferite del proprio essere.
Ogni individuo tende a fare agli altri ciò che piace a sé. È questa la più elementare forma d’amore, sulla quale ognuno deve costruire tutto il resto «Il punto di partenza sta nell’analizzare meglio questo tipo-di amore spontaneo, al fine di renderci conto che in esso c’è sempre una buona dose di autoillusione, la cui correzione offre alla libertà le più belle conquiste. E cosa ha d’illusorio l’amore che si accende spontaneamente tra persona e persona? È il fatto che per lo più non si ama l’altro, bensì l’immagine che dell’altro si porta in sé. E si cerca il rapporto al livello della volontà, del fare insieme, perché ci si ripromette il godimento che la presenza dell’altro e la collaborazione con lui suscita in noi.
La maggior parte di ciò che comunemente si chiama amore è autogodimento. Quel che uno prova stando accanto all’altro, e che gode facendo qualcosa con lui, è solo e unicamente questo: ciò che egli vuole. Il senso di una dichiarazione d’amore è la “delizia” che uno sente nel farla. Il vivere e il fare con gli altri, centuplica la possibilità di amare se stessi.
L’intensità massima della chiusura ce la fa raggiungere non l’egoismo, ma l’illusione che ciò che è amore di sé, sia puro amore per gli altri. A questo punto l’autismo, la ferita che ci separa dagli altri, rischia di non rimarginarsi, proprio per il fatto che il pensiero non sa più distinguere tra amore di sé e amore dell’altro, in quanto vede nel primo il secondo. Ritenendo a questo punto di essere già pieno d’amore per l’altro, farà poco o nulla per conquistarselo. Ma il presupposto per poter amare sempre di più l’altro è che non ci si illuda di farlo, confondendo l’amore che abbiamo per noi stessi, con l’amore per l’altro.
L’amore naturale è esclusivo per sua natura, perché pensa in fondo solo a sé. Ogni madre non può che amare la sua creatura più di tutte le altre. E non serve a nulla disquisire se il suo sia egoismo o altruismo, lo si può chiamare come si vuole. L’importante è se questa mamma imparerà ad amare anche altri bambini come i suoi figli, o per lo meno comincerà ad interessarsi a loro un po’ di più di quanto non riesca la natura in lei.
Quinto Capitolo
ORdINE naturale
e ordine morale:
come rimarginare la ferita più profonda
II coraggio di guardare all’intera evoluzione
Nel mondo in cui viviamo c’è un ordine naturale e un ordine morale. L’ordine della natura ci appare regolato secondo leggi fisse e a prima vista immutabili. Nessuno si aspetta che gli uccelli precipitino a terra, le pietre prendano a ruzzolare dal basso all’alto, o che il sole decida di non sorgere al mattino. Siamo certi che non cambierà dall’oggi al domani il modo di comportarsi dei minerali, delle piante, degli animali e della natura entro l’essere dell’uomo. Sulla sua affidabilità abbiamo finora costruito la nostra stessa evoluzione.
L’altro ordine, quello morale, che ci portiamo dentro, è invece del tutto aperto e dipende completamente da come si orienta la libertà dell’uomo. Dove si tratta del bene e del male, dagli ideali più sublimi alla malvagità più abissale, lì avvertiamo che non abbiamo niente a che fare con l’ineluttabilità delle leggi di natura, ma con la libera creatività delle menti e dei cuori degli esseri umani.
Se consideriamo che l’umanità, nel suo insieme, comincia appena ora ad esercitare un pensiero davvero libero, capace di orientarsi in modo individuale circa il senso complessivo dell’evoluzione, ci vien fatto di concedere che l’evoluzione umana, nel suo insieme, si trova in una sua fase centrale, o meglio forse a un punto di svolta. L’opera della prima metà, scorsa nel porre i fondamenti dei regni della natura, è adesso manifesta nella sua possanza e già compiuta sotto i nostri occhi. Mentre l’opera gigantesca della libertà, atta a trasformare tutta la natura in attività di pensiero e in calore d’amore degli uomini, è appena iniziata. Abbiamo fatto, stando a ciò che possiamo osservare attorno a noi, appena uno o due piccoli passi – due millenni – a partire dalla grande svolta. E la grande svolta nei destini della terra e dell’uomo non può che consistere in questo: la conduzione degli eventi termina di essere in mano alla natura, per passare poco alla volta nelle mani della moralità dell’uomo.
Il paradiso l’abbiamo lasciato alle nostre spalle, ma la meta ultima del divenire appare ancora lontana. Il carattere inconfondibile del nostro stadio attuale è la ferita millenaria che ha scisso l’ordine morale da quello naturale. È questa la ferita che più ci fa male e più di tutte ci provoca al sommo bene, che è poi il nostro sforzo di tirar fuori il carattere divino della libertà umana, capace di ricreare il mondo, rimarginando così la ferita.
Proviamo a paragonare fra loro un evento naturale, con un fatto morale. Come ad esempio un violento temporale con l’idea di pace, o un devastante terremoto con quella di giustizia. La natura dispone di forze titaniche incontrastate, riesce a schiantare, metter tutto sottosopra e quando vuole, a seppellire nel suo grembo, con i terremoti, infinite creature, come pure a trasformare un piccolo seme in una quercia maestosa.
E i nostri valori morali? Cosa sono capaci di fare i nostri bei pensieri che sembrano bolle di sapone a paragone degli uragani e delle tempeste? Cos’hanno cambiato finora gli ideali sorti nelle menti e nei cuori degli uomini? Il dovere morale chiede la pace, ma gli uomini sono sempre in guerra gli uni con gli altri. L’ideale aspira alla giustizia e nel mondo invece c’è sempre più prevaricazione.
Non è una grande ingiustizia questa vorace discrepanza tra l’onnipotenza della natura e l’impotenza dei nostri ideali? L’uomo moderno, stanco di soffrire questa millenaria ferita, ha escogitato un anestetico che, pur non sapendo rimarginare questa lacerazione interiore, almeno ne attenua il dolore. Ed ecco divulgarsi a macchia d’olio una scienza che afferma come i cosiddetti “valori morali” non siano altro che anomale suppurazioni del dato di natura, segno appunto di un organismo malato o profondamente ferito. L’ingegneria genetica ritiene che modificando la composizione del sostrato di natura, intervenendo cioè sul DNA, mutino anche i pensieri dell’uomo, la sua ideologia, il suo modo di vedere le cose ed anche gli ideali morali. E i grilli parlanti della morale, i vecchi rimorsi di coscienza, verranno finalmente messi a tacere da un’ingegneria genetica capace di congegnare un corpo ben più sano – in quanto non crea problemi – di quello inventato dalla natura.
Questo tipo di scienza non conosce due mondi diversi – quello della natura e dello spirito – né l’atavica dicotomia che li contrappone e che ci fa star male nell’anima. Nella materia vede la sola realtà esistente: quella che suscita ogni fenomeno inerente all’umano, compresa la cosiddetta vita interiore. Come diceva Cabanis: il cervello secerne i pensieri allo stesso modo in cui il fegato secerne la bile e le ghiandole salivari la saliva...
Eppure questo tipo di soluzione del dilemma invece di dar pace al cuore umano sembra renderlo ancor più triste, e la sua ferita sanguina oggi più che mai. Egli vede tragicamente radicalizzarsi quella schizofrenia culturale in cui il fatto di natura, grazie alle conquiste della scienza e della tecnica, trasforma la sua potenza in strapotenza, mentre il fatto morale urge, sì, ma è sempre più inafferrabile per le forze della coscienza umana. Come non bastasse, la tecnica moderna pare aver raddoppiato la potenza della natura dimezzando la forza dello spirito umano.
In questa prospettiva evolutiva, è utile indagare più a fondo la lunga storia del rapporto tra questi due mondi, per comprendere meglio com’era all’inizio, come si è svolto in seguito, fino a giungere alla situazione in cui ci troviamo, e quale potrà diventare nel futuro. È prevista una riarmonizzazione di questi due regni che oggi appaiono inconciliabili? Se sì, in quali modi concreti può avvenire? Sullo stato attuale d’antagonismo tra spirito e materia non c’è alcun dubbio. Quando ci affidiamo alle forze della natura sembra che in noi si oscurino gli ideali, e i nostri valori morali spesso non hanno la forza di trasformare la vita reale.
Il rapporto originale tra spirito e materia, stando a tutte le cosmogonie antiche, era quello della sovranità creatrice dello spirito nei confronti della natura. Tutte le mitologie, tutte le religioni concordano. Spiriti divini hanno “creato” il mondo visibile dando ai loro pensieri e progetti spazio e tempo: lo spazio ci presenta i pensieri divini gli uni accanto agli altri e il tempo consente a noi uomini di pensarli gli uni dopo gli altri. Grazie a questi “spostamenti” di spazio e di tempo, il mondo dei pensieri divini è diventato per noi percepibile nello spazio e pensabile nel tempo. E così noi vediamo le cose poste una accanto all’altra e siamo in grado di pensarle di seguito, una dopo l’altra.
In un mondo come il nostro, fatto di spazio e tempo, spirito e materia si pongono di fronte come due universi contrapposti che, nella mente e nel cuore dell’uomo, generano quella dolorosa ferita interiore che da sempre si sente chiamato a rimarginare. Ricevendo ogni percezione separata dal suo concetto, egli si adopera a ricongiungerli, e questo, quando riesce, gli procura una grande gioia perché racchiude in sé la certezza che la grande ferita che divide i due mondi potrà venir risanata. Il senso dello “squarciamento” del mondo in cui viviamo, è il presupposto per la gioia infinita che possiamo trovare nel ricomporne l’armonia.
L’Io umano alla ricerca di se stesso
Fin dai primordi lo spirito umano anelava a diventare cosciente di sé. È questa la tensione evolutiva che ha infuso in lui lo spirito divino. Nella mente divina, il nostro spirito esiste da sempre, ma solo sulla terra può diventare consapevole di sé. Il mondo della materia è sorto proprio perché noi, osservandolo, ci si renda conto della nostra identità portandoci ad esclamare: io non sono materia, ma spirito! Ognuno può conoscere se stesso solo distinguendosi dall’altro, da ciò che non è. Ogni identità presuppone un’alterità.
Il lungo cammino della presa di coscienza da parte dello spirito umano dentro il mondo della materia, ha dunque come presupposto la “materializzazione” – se è lecito chiamar così la creazione – dello spirito divino. Innumerevoli esseri spirituali, all’opera nella natura, mantengono costanti e sempre disponibili per l’uomo le condizioni della sua esistenza fisica. La sua caduta intellettuale, lo stato di coscienza più illusorio che si possa immaginare, sta nel supporre che la stabilità delle leggi di natura, quelle che la scienza va indagando con sempre maggior precisione, sia il prodotto di una casuale organizzazione della materia stessa. E il senso di questa caduta intellettuale è proprio la sua futura inversione. Una sorta di ascensione che porterà l’uomo a iniziare lui stesso a dettar legge in fatto di natura ritrasformando tutto ciò che è materiale in una realtà spirituale. La sua responsabilità morale è vasta quanto la creazione divina. È questo l’immenso campo d’azione che farà sorgere una nuova creazione a partire dalle forze interiori della sua libertà e del suo amore senza limiti. E la creazione che l’uomo è in grado di fare non è un fastidioso dovere, ma appunto una vera e propria “ricreazione” del suo spirito.
L’egoismo è l’inizio della libertà. È quell’amore di sé, infuso nell’uomo dal Creatore divino, affinché serva da modello per l’amore che lui può rivolgere agli altri. Egli ricrea interiormente il mondo secondo l’adagio: “Ama ogni prossimo tuo liberamente, così come naturalmente ami te stesso”. La libertà umana deve passare per la cruna dell’ago dell’egoismo. Solo chi si sia prima chiuso in se stesso, chi si senta staccato dagli altri, ha la possibilità di vincere questa illusione prendendo coscienza di quanto profondamente gli altri intessano il suo stesso essere. Nessun amore può diventare libero se prima non ha vissuto le mille strettoie e gl’infiniti limiti delle preferenze, dello schierarsi, del difendersi dall’invasore, dell’aver cura di pochi altri.
Lo spirito umano sta attraversando in questa epoca una specie di pubertà. Il singolo è ancora tutto intento – basti pensare al sistema del capitalismo – ad afferrare la sua autonomia, la sua piena indipendenza sia nel pensiero che nell’azione. L’umanità si è atomizzata in tanti voleri contrastanti, cominciando appena a rendersi conto di quanta poca libertà sia possibile se a ciascuno interessa solo la sua. Dobbiamo ancora imparare che la libertà propria si consegue solo nella misura in cui si ama quella di tutti.
La perfezione verso cui tende l’evoluzione è creare armonia, un equilibrio organico tra i due grandi valori morali dell’umano che sono da un lato le singole individualità, uniche e liberamente creatrici, e dall’altro la loro comunione che costituisce un organismo spirituale in cui nessuno può esistere senza gli altri. All’inizio dell’evoluzione c’era la comunione, senza individuazione però, – lo stadio a cui “l’altruista” naturale vorrebbe tornare. Nel suo bel mezzo, che è ora, ci ritroviamo con tante individualità desiderose d’affermarsi a scapito della comunione, perché non si sono ancora accorte che così facendo agiscono a scapito proprio – è la struttura dell’“egoista” che vorrebbe restare allo stadio intermedio dell’evoluzione.
La perfezione dell’ordine morale non può essere che un equilibrio perfetto in cui ogni spirito individuale, e l’intero organismo dell’umanità, si danno vita a vicenda. La comunione di tutti con tutti può avverarsi solo grazie al crescere della forza pensante e amante di ogni individuo. E diventare sempre più libero e creatore significa, per il singolo, ricomporre nella propria mente e nel proprio cuore l’umanità dispersa, sì da farne un organismo invisibile non meno meraviglioso di come l’ha concepito la fantasia divina ai primordi dell’evoluzione.
Ogni spirito umano rappresenta un’intuizione morale unica e insostituibile dello spirito creatore universale. E la Divinità stessa ha infuso in tutti gli Io umani il dinamismo interiore che tende a far di tutti gli uomini un solo cuore e un’anima sola, portando così a compimento – e non annullandoli – la libertà e l’amore di ogni singolo. Nella terminologia del cristianesimo, l’Umanità in quanto organismo unitario viene chiamata “il corpo mistico del Cristo”. In ogni organismo ciascun componente ha la sua identità e una funzione specifica che gli permette di contribuire alla salute degli altri organi e dell’organismo intero. Più ogni essere umano diventa se stesso e più si scopre come un elemento vivente, che per quanto lo riguarda infonde salute alla complessa struttura dell’umanità.
Stiamo tutti imparando a diventare divini?
Ogni spirito umano era all’inizio come un’idea, un progetto nella mente divina, un particolare intuito grazie al quale gli esseri divini plasmavano il mondo della natura. Spiriti superiori a quello dell’uomo reggevano l’evoluzione delle forme corporee rendendole sempre più complesse, nel modo che la scienza naturale ben conosce. E nella loro mente tutto ciò avveniva in vista della creazione che poi l’uomo avrebbe potuto fare. La differenza tra l’umano e il divino è una differenza di ampiezza e profondità di coscienza.
Paragonati con gli esseri che hanno creato il mondo, noi siamo ancora molto “umani”. Paragonati agli animali, alle piante e alle pietre, siamo già un bel po’ “divini”, e proprio perché siamo chiamati a ricreare il mondo a nostra immagine, visto che Dio stesso ci ha creato a immagine sua.
Nel piano di creazione degli esseri divini, si trattava di far evolvere le forme naturali fino al punto in cui potessero diventare la dimora dell’uomo, e farne uno strumento adatto che consentisse al suo spirito di prendere coscienza di sé ed afferrare con le proprie mani le redini del divenire della natura. Questo ebbe inizio quando la corporeità dell’animale raggiunse una struttura adatta (simile all’attuale scimmia) a venir compenetrata e ulteriormente trasformata dallo spirito umano. Non appena la Divinità infuse l’anima umana dentro al corpo animale, l’uomo gli conferì le forze evolutive che da sempre porta in sé: la capacità di orientamento, di parola e di pensiero. Le forze di orientamento dettero al corpo la posizione eretta, la facoltà del Verbo, della parola, ne strutturò la laringe affinché potesse articolare i suoni e parlare, mentre le forze di pensiero cesellarono il cervello per farne uno strumento di conoscenza e autocoscienza.
Fu quindi lo spirito dell’uomo a configurare il cervello per farne lo strumento del pensare, a trasformare la sfera ritmica in modo che la parola potesse risuonare, e fu sempre lui a innalzare la spina dorsale per potersi muovere da sovrano nel mondo.
Se vediamo così l’evoluzione, è assurdo dire che il nostro spirito sia un mero prodotto di processi corporei. L’uomo allora proviene dalla scimmia o da Dio? In base alle riflessioni fatte possiamo rispondere: da tutte e due. Il suo organismo fisico rappresenta un’ulteriore trasformazione del corpo animale della scimmia. La forma del nostro corpo ha dietro di sé tutti gli stadi evolutivi, dai molluschi agli invertebrati ai primati, quali si ripetono ogni volta nei vari stadi embriologici che l’uomo passa nel grembo materno.
Tutt’altra cosa è invece l’evoluzione dello spirito dell’uomo. L’essere umano ha un corpo ma è uno spirito. Quando nel corso dell’evoluzione la corporeità animale raggiunse una complessità tale da poter accogliere lo spirito umano, questo vi entrò per cominciare a lavorarci da dentro. Da allora fu in grado di plasmare direttamente la materia del corpo.
L’incarnazione, l’ingresso nella carne del nostro corpo, ci consente ogni volta di formare e trasformare il nostro corpo dal di dentro, per plasmarlo a immagine del nostro spirito. All’inizio il nostro Io era ancora avulso dalla corporeità, viveva nel “paradiso”. Incarnandosi, lo spirito umano divenne il luogo degli infiniti incontri tra il fatto di natura e il fatto morale. È nella nostra libertà elevare dalla materia melodie sempre più belle che siano espressione di sapienza e amore.
Se fossimo rimasti esseri puramente spirituali, paradisiaci, non avremmo potuto distinguerci, non avremmo potuto diventare individui autonomi. La materia è quell’elemento in cui gli esseri hanno la possibilità di individualizzarsi. La caduta originale è avvenuta nell’elemento che ci separa gli uni dagli altri e il suo senso è che venga trasformata in mille modi in una “caduta verso l’alto”. Ciò avviene quando “innalziamo” il nostro corpo alla posizione eretta, quando eleviamo l’umano verso il divino e ogni frammento di materia verso i mondi dello spirito.
Ogni essere umano è responsabile del suo divenire. Ognuno di noi è uno spirito eterno che ha dietro di sé tutta l’evoluzione; le fasi pregresse dell’interazione tra materia e spirito, tra regno di natura e regno della moralità, le abbiamo percorse tutte.
Bonum est diffusivum sui, dicevano gli scolastici medievali: il bene è buono proprio perché tende a parteciparsi. Gli esseri divini vogliono che ogni spirito umano diventi a sua volta divino, sempre più creatore proprio perché vogliono darci il meglio di sé, la forza di creare, in modo tale però che ce la possiamo conquistare liberamente.
Questo è il motivo per cui l’uomo non poté venir creato “creatore” già in partenza: per dargli la possibilità di diventarlo un po’ alla volta, con l’esercizio della sua libertà. La grazia degli esseri divini sta proprio in questo. Dà con gioia all’essere umano tutte le facoltà che, se sviluppate e applicate, lo renderanno sempre più creatore. Non gli dice: lo devi diventare per forza!, ma lo lascia libero. Le gerarchie celesti rappresentano i vari gradi della creatività divina, e quando noi avremo svolto il compito di tutta l’evoluzione, ci troveremo al gradino successivo – quello al quale la terminologia cristiana ha dato il nome di “angeli”. E gli angeli non temono la nostra concorrenza; non solo perché siamo ancora ben lontani dal fargliela, ma perché saranno ancora più felici quando cominceremo a farlo. Non sono egoisti come noi, godono del nostro bene non meno che del loro, per questo sono “angeli”.
Ogni uomo è causa ed effetto di se stesso
Su sei miliardi di persone al mondo non ci sono due volti uguali. Chi sono gli architetti che improntano la materia in modo così individualizzato? Sono i nostri Io a farlo; non da soli però. Vediamo bene che con i nostri pensieri siamo in grado di fare e disfare, ma solo nel regno morto del minerale. Per quante macchine ingegnose abbiamo inventato, non sappiamo costruire nulla di vivente o di animato; neppure un fiorellino o un filo d’erba. Questo vale per ciò che è conscio; ci deve essere però in ognuno di noi un’altra realtà – chiamiamola subconscia, o forse meglio sovraconscia – che è stata capace di formare il mio corpo, non solo vivificandolo e animandolo, ma dandogli quella forma unica, diversa da quella di tutti gli altri, che deve essere a immagine del mio essere spirituale. Di questo mio essere spirituale, ne sono solo in parte consapevole, perché se lo fossi interamente saprei compiere tutto ciò che sa far lui, e mi ricorderei inoltre di come ho sudato per esempio nel grembo materno, affinché niente andasse storto nella costruzione di questa mia bella casa vivente, dove abiterò per tutta un’esistenza.
Ma come faccio ad esser sicuro che in me c’è ben più di quel che porto a coscienza? Se guardo non solo al corpo, ma anche alla biografia di un uomo, come faccio a dire che quella è la sua, se non suppongo che corrisponda a “lui”, in quanto regista di essa? E se l’architetto della biografia non è la coscienza ordinaria – che difatti non lo è –, allora deve essere una coscienza più vasta, chiamiamola pure superiore, fermo restando che questa coscienza è individualizzata e libera. In altre parole, questa coscienza superiore non può essere che l’uomo stesso nella totalità del suo essere, una totalità ben più vasta di quanto contenga la sua coscienza ordinaria. E il senso di questa “coscienza ristretta” sarà quello di potersi ampliare liberamente. E nella misura in cui lo fa, verrà poco alla volta a coincidere con la coscienza che ora è subconscia – o sovraconscia. In tempi passati la si chiamava Io superiore, Io vero di ogni persona. E c’era la convinzione che questo Io spirituale creasse di sana pianta il suo corpo. Noi riusciamo a malapena a modificarlo un po’ e ci riesce invece meglio farlo ammalare o rovinarlo, perché a guastare qualcosa sono capaci tutti. Infatti per costruire un muro come si deve ci vuol bravura, ma per buttarlo giù basta prenderlo a picconate.
Il segreto dell’evoluzione starebbe allora nell’imparare sempre meglio, dal nostro Io superiore, l’arte di plasmare e trasformare il mondo fisico. E per far questo bisogna diventare simili a lui, bisogna conoscerlo, cosa che ci riesce studiando per bene le sue opere principali – che sono appunto da un lato il nostro corpo e dall’altro la nostra biografia. Sono queste le principali manifestazioni del nostro spirito.
La forza creatrice dello spirito si sperimenta,
non si dimostra
Se la religione ha sempre sostenuto che lo spirito crea il mondo della materia, la scienza moderna sostiene che è la materia a creare quel che viene visto come spirito. Chi dei due ha ragione? Hanno ragione tutte e due, ognuna dal suo punto di vista. Però hanno anche torto tutte e due, quando negano la legittimità del punto di vista altrui. Pur restando vero che lo spirito può essere all’opera in ogni frammento di materia, resta altrettanto vero che la materia, per esempio lo stato di salute o di malattia del nostro corpo, provoca di riflesso infiniti echi nel nostro animo. In questo modo la materia diventa con-causa di ciò che avviene nella nostra anima. In errore è allora il teologo che nega ad essa ogni tipo di causazione, non meno dello scienziato che, non sapendo dove stia di casa lo spirito, nega che esista.
E siccome l’essere umano è per natura libero, è altrettanto libero di diventare più o meno attivo nei confronti della sua costituzione fisica. Se “si lascia andare”, se non usa il suo spirito per servirsi del corpo, sarà il corpo a decidere indisturbato quel che avviene nell’anima. In altre parole, essendo lo spirito umano libero nei confronti della materia, ha la possibilità di viversi sia come effetto, sia come causa, può sentirsi servo o re. Proprio in questo sta la libertà, se no in cosa consiste?
Se non faccio l’esperienza della forza creatrice dello spirito – che i miei pensieri cambiano il mondo, che la mia volontà può comandare il corpo – nessuno potrà mai dimostrarmi in modo convincente l’esistenza dello spirito creatore umano. A che serve volerla dimostrare, se in me non esiste o quasi? Non posso far finta che sia mia l’esperienza di un altro che afferma: “Lo spirito c’è, eccome!”. La realtà dello spirito, della sua forza capace di forgiare la materia, deve diventare un’esperienza personale, non un’affermazione astratta, e del tutto teorica, che ci giunga dall’esterno. Spiriti umani creatori non hanno mai sprecato tempo a dimostrare la realtà dello spirito: l’hanno mostrata nella loro vita, determinando essi stessi le sorti del mondo senza subirne i determinismi. Ciascuno può coltivare in ogni momento il proprio spirito se vuole, può rafforzarlo, provarne la forza creatrice al punto di non aver più bisogno di alcuna dimostrazione teorica della sua realtà: perché ne fa un’esperienza che basta e avanza.
E da che tempo è tempo, gli uomini che hanno vissuto la creatività inesauribile del loro spirito, hanno sostenuto che la vita diventa mille volte più bella se la si vive da artisti che fanno d’ogni cosa che toccano un’opera d’arte. Mai nessuno è riuscito a convincere che una vita, in cui lo spirito capitoli di fronte ai determinismi della materia, sia una vita più bella. Qualcuno dunque deve aver pur messo una pulce nell’orecchio degli spiriti umani, visto che innegabilmente esiste in loro una tensione a vivere sempre più da spiriti creatori, divenendo tristi quando debbono soggiacere alle ferree leggi di natura. Però tutt’e due le possibilità di vita devono rimanere aperte, altrimenti verrebbe abolita la libertà umana. Tocca a ciascuno decidere quale tipo di vita vuol vivere.
L’abisso dell’involuzione umana
Nella misura in cui ometto d’intensificare la creatività del mio pensare e del mio volere, mi vedo sempre più governato dal dato di natura che si ripete monotonamente all’infinito, secondo leggi uguali per tutti. L’abisso dell’evoluzione umana si spalanca quando l’evoluzione dello spirito viene trascurata e la libertà omessa. Se è vero che è insito nella natura della libertà il poter attuare tutte le creazioni possibili, è altrettanto vero che deve restar sempre aperta anche l’altra strada: quella dell’involuzione, che avviene quando l’uomo, non coltivando i suoi talenti, si lascia andare. L’uomo è stato creato dalla Divinità come essere orientato verso una libertà sempre più grande. Nessun uomo può cancellare questa irresistibile vocazione, impressa nella sua natura. Ognuno tiene invece nelle proprie mani l’attuazione sempre più piena di questa libertà fatta di desideri e di ideali.
E se non esercita la libertà che gli è resa possibile, resterà ugualmente capace di libertà? La sua potenzialità naturale rimarrà intatta? No, essa può decrescere fino a scemare, non meno di qualunque altra capacità che non venga esercitata. Se sono un promettente pianista ma poi non suono per quarant’anni, se conosco la lingua russa ma poi non la parlo, se oggi so usare bene il computer e poi lo lascio stare per decenni... in tutti questi casi vedrò disfarsi, a poco a poco, la mia iniziale capacità. Tutte le nostre facoltà sono luoghi d’incontro fra il mondo della natura e quello morale, perché rappresentano ciò che è possibile conquistare nel mondo della materia, nella condizione d’esistenza incarnata. Se è vero che la Divinità è coraggiosa e conseguente fino in fondo nel conferirci l’esercizio della libertà, deve insieme dare all’uomo la possibilità di disfarla fino a non essere più capace di libertà.
Il disfacimento dell’umano è descritto nell’Apocalisse, che in evoluzione prospettiva è l’ultimo testo della Bibbia cristiana. In immagini enigmatiche l’Apocalista parla tra l’altro della Bestia. Con essa ci vuol dire che il decadimento ultimo dell’uomo è quello di discendere al livello dell’animale. La differenza essenziale fra l’animale e l’uomo è che l’essere umano, per essenza, è capace di libertà – i pensatori medievali dicevano libero “in potenza” – mentre l’animale non ha facoltà di libertà. La via della libertà umana deve restare aperta fino in fondo in tutte due le direzioni, altrimenti dovremmo supporre che esista un punto di discesa oltre il quale gli esseri divini non ci lasciano andare, perché quegli abissi sono insopportabili anche per loro e si sentiranno costretti a rimangiarsi la libertà che ci hanno dato. Il rischio divino della libertà umana richiede un bel coraggio, ed è bello pensare a un Dio audace, sì da giocarsi tutta la creazione, gettando nel mondo il dado fatidico della libertà umana.
Il razzismo genetico
Nel suo libro Il Secolo Biotech Geremy Rifkin, parlando della “sociologia genetica”, si riferisce al convincimento sempre più diffuso che nell’uomo prevalga la predisposizione genetica su tutto ciò che può dare l’ambiente esterno e l’educazione. Fin dalla nascita ognuno è socialmente improntato dalla sua stessa costituzione materiale. Questo pensiero non è che la traduzione moderna della predestinazione agostiniana. Agostino si preoccupava di salvare l’onnipotenza divina di fronte al quesito che stava allora affacciandosi nella mente umana: se l’uomo è libero, come si concilia la sua libertà con l’onnipotenza divina? Gli scienziati moderni invece di predestinazione parlano di predisposizione genetica: ma in fin dei conti è la stessa cosa. Prima la necessità veniva da Dio, oggi dai geni, dalla biologia. La tua corporeità decide di te, si dice, stabilisce i limiti di quello che potrai o non potrai essere o fare.
Rifkin riporta nel suo libro l’affermazione di James Watson che dice: “Abbiamo sempre creduto che il nostro destino fosse nelle stelle, ora sappiamo che risiede in massima parte nei nostri geni”. La causazione dall’alto, così lui pensa, era un’illusione dell’umanità bambina e ancora sognante. Adesso, divenuti adulti e rigorosamente scientifici, sappiamo che la causazione viene dal basso, dalla natura. E Geremy Rifkin si domanda, preoccupato: siamo forse alle porte di un razzismo genetico? Sorgeranno caste sociali indotte dalla manipolazione genetica? Verrà introdotta nei prossimi anni o decenni una carta d’identità genetica per cui non saranno più importanti la nazionalità, o la data di nascita, o il curriculum di una persona, ma il suo DNA? In Inghilterra si comincia a concedere per legge alle ditte di fare analisi genetiche prima di assumere i dipendenti. È questo l’inizio della segregazione genetica?
Gli effetti della moralità umana sulla natura
Ai primordi, dicevamo, non c’era alcuna separazione fra il regno di natura e quello della morale: lo spirito umano era immerso nel divino, veniva guidato dalla Divinità in quel paradiso dove ogni fatto morale, ogni pensiero, era allo stesso tempo un fatto di natura. Poi sopravvenne la “caduta” in cui l’aspetto fondamentale era proprio la scissione tra il dato di natura e il fatto morale. L’uomo cominciò a sentirsi sempre più impotente di fronte alle forze travolgenti della natura.
Nella coscienza umana il cosmo si è spaccato in spirito e materia, per dare all’uomo la possibilità di ricreare la materia stessa, liberamente. In altre parole, di ricondurla a sé.
Perciò dobbiamo dapprima sentirla estranea, contrapposta al nostro spirito, cioè alla nostra facoltà di pensare, conoscere e decidere. Se avessimo già un’esperienza unitaria dello spirito e della materia non avremmo il compito di ricongiungerli. E come nel processo conoscitivo ognuno di noi sperimenta che tutti gli esseri sparsi nel mondo sono riunificabili – e in questo modo si sana la ferita intellettuale –, così nell’amore ognuno di noi sperimenta che gli uomini, smembrati nella loro moltitudine, sono tutti da amare – e in questo modo si rimargina la ferita morale.
Ma oggi i fatti della nostra coscienza sono ben lontani dall’incidere più di tanto sulla natura. Se i nostri pensieri, i nostri ideali agissero direttamente sulla natura, non potremmo essere liberi. Ogni pensiero sbagliato, brutto o cattivo, causerebbe automaticamente nel corporeo un qualche difetto e noi inorridiremmo talmente da essere costretti solo al vero, al bello, al buono. La libertà si fonda proprio sul fatto che, per nostra fortuna, quello che ci frulla per la testa si guarda bene dallo scompaginare più di tanto il mondo visibile. Già ci sentiamo terribilmente a disagio quando la vergogna ci tradisce facendoci arrossire. Il fatto che l’influsso dello spirito sul corpo sia così limitato, ci permette di fare col nostro spirito un po’ quello che ci pare.
Ciò non significa che esso sia diventato in assoluto incapace di forgiare la materia. La dicotomia tra spirito e materia è relativa alla nostra coscienza che vive essa stessa nel tempo e nello spazio. Nello spazio, l’abbiamo già visto, viviamo il dentro e il fuori, viviamo le distanze e le contiguità; nel tempo invece i nostri pensieri si rincorrono l’un l’altro, le emozioni si accavallano le une sulle altre. In retrospettiva, è l’intensità della nostra memoria a decidere realmente la misura del tempo, e in prospettiva il tempo è lungo quanto riesce ad abbracciare dei nostri progetti, dei nostri ideali più grandi. Tempo e spazio sono dunque fenomeni della nostra interiorità, della coscienza umana.
Che il tempo sia uno scorrere perché è la nostra stessa coscienza che si dipana in esso creandolo, è forse un’affermazione scontata; ma che lo spazio, percorribile esternamente, sia anch’esso un fenomeno della coscienza, ci risulta solo se capiamo meglio come funziona il nostro processo conoscitivo. Esso unisce il concetto alle percezioni che ce ne danno i sensi, e così il mondo di fuori entra dentro la nostra coscienza, e ricongiungendosi a noi, viene “compreso” nel senso che “lo prendiamo con noi”. Del resto, anche nel linguaggio comune si dice che la conoscenza è “fare spazio” al nuovo. Uno spazio interiore e, come tale, assume i connotati del tempo. Infatti nel conoscere trasformiamo l’immagine spaziale di ciò che è materiale in un fattore di evoluzione interiore che avviene nel tempo che impieghiamo a trovare i nessi fra le cose. Gli oggetti dello spazio (e per oggetti s’intende tutto ciò che è esterno a noi) diventano nella nostra mente rappresentazioni, concetti, facendoci evolvere nel trasformare lo spazio nel tempo, e il tempo nell’eternità. Questo fa capire come il dato morale e di natura non siano separati in assoluto, ma si sono soltanto spostati nel tempo, uno rispetto all’altro, per dare la possibilità all’uomo di riavvicinarli, al punto di farli coincidere.
Ora dobbiamo però fare un altro passo avanti: se nel processo conoscitivo la natura agisce sull’uomo attraverso le percezioni e l’uomo le accoglie in sé comprendendone il senso, questa conoscenza, alla base del suo agire morale, tornerà a incidere sulla natura? Essa, offrendosi al nostro eros conoscitivo, porge allo spirito di ciascuno l’occasione migliore per evolversi, arricchirsi. E, di rimando, questo nostro spirito non ripagherà i doni che riceve dalla natura, non la renderà a sua volta più bella? Sì certo, ma poco alla volta, col passare del tempo appunto. Quel che l’essere umano diventa interiormente, e moralmente, col tempo si trascrive nella natura, e soprattutto nella sua natura corporea. Per i cambiamenti accidentali bastano le ore o gli anni, mentre per quelli sostanziali ci vogliono i secoli, addirittura i millenni. Tra la decisione umana di bere un bicchiere d’acqua e l’effetto che l’acqua fa sul corpo passa poco tempo, ma tra l’ingiunzione divina di trasformare la posizione orizzontale dell’animale in quella verticale dell’uomo scorrono ere.
In altre parole, per rendere possibile la libertà umana, la provvidenza divina ha frapposto il fattore tempo fra le cause spirituali e i loro effetti naturali. Ciò che l’essere umano diventa nella sua interiorità si trasforma in fatto di natura solo in un periodo successivo, poco a poco. I nessi fra le cause e gli effetti si fanno così infinitamente complessi, cosa che non solo dà al pensiero parecchio filo da torcere, ma anche parecchia soddisfazione alla sua sete di conoscenza.
La nostra libertà d’oggi è davvero una libertà di arbitrio poiché in larga misura non sappiamo quel che facciamo; il nostro agire morale di oggi ricadrà sulla nostra corporeità e sulla natura in un lontano futuro, secondo modi e leggi a noi ancora del tutto ignoti.
Non sarà che la nostra evoluzione consiste proprio nell’intensificare il processo di trasformazione del nostro spirito sulla natura, raccorciando così il tempo che intercorre tra ogni causa e il suo effetto? Al Creatore viene attribuito un operare talmente magico che causa ed effetto sono per lui contemporanei: “Dio disse: la luce sia, e la luce fu”. Nella misura in cui l’uomo si riconquista questa contemporaneità, fa sparire il tempo riconducendo la creazione nel regno dell’eternità.
La differenza tra l’operare divino e quello umano sta allora proprio nel fatto che il divino opera e vive nell’eternità, il che significa contemporaneità e compresenza, senza un qui e un là nello spazio, un prima e poi nel tempo. La parola divina crea istantaneamente gli esseri. Invece il fatto morale umano è ancora così debole, così poco divino, che soltanto con trasformazioni successive, e con l’aiuto di altri esseri spirituali, ne sarà poi visibile il risultato nel corporeo. Mille anni di evoluzione umana sono come un attimo al cospetto di Dio. Man mano che l’uomo si evolve, il suo cuore si fa più vasto, tanto da abbracciare lo spazio, e anche il pensiero si fa più veloce, sì da vincere lo scorrere del tempo.
Una novella buona
Duemila anni fa alcuni uomini hanno affermato: “Noi siamo convinti che i fatti cui abbiamo assistito rappresentino il fenomeno primigenio dell’umano, nel senso che hanno anticipato qui sulla terra, davanti ai nostri occhi, tutta la prospettiva evolutiva divina che ci aspetta. Noi vi raccontiamo quello che abbiamo visto e toccato con mano; sta a voi interpretarne il significato. Vi assicuriamo di essere stati testimoni della riconciliazione tra il fatto morale e il fatto di natura. Alla morte di quell’Essere che chiamiamo Messia in ebraico, Cristo in greco, la natura ha reagito magicamente come ai primordi della creazione; la terra ha tremato e il sole si è oscurato!”.
Allo scienziato materialista moderno verrà forse da sorridere di fronte a tale affermazione, ma è affar suo. È stato dichiarato, e resta comunque dichiarato al mondo intero, che degli uomini hanno assistito a un evento morale accompagnato da fenomeni di natura inconsueti. I testimoni di quegli accadimenti insistono: “Per noi è stato come se tempo e spazio, in quel momento, venissero cancellati; come se il Logos divino, congiuntosi ad uomini nell’esperienza terrena, riportasse al divino l’uomo e la terra, suggellando così il senso compiuto della loro evoluzione. Era come se la terra con tutte le sue creature avvertisse l’inizio della liberazione da quell’incantesimo che da millenni la tiene prigioniera dello spazio e del tempo. Come se quel Dio così umano, morendo, intridesse d’amore la terra intera, rendendo divina anche lei. Davanti ai nostri occhi la luce del sole si oscurò. Quel sole cui l’umanità da millenni aveva guardato come alla dimora del Verbo divino; così distante nello spazio e così a lungo atteso dai cuori degli uomini. Era come se quell’Essere di luce planasse sulla terra! Abbandonando il sole fino a spegnerlo, lo vedevamo scendere a inondare la terra di un’aura di luce. In quel momento fu come se tempo e spazio venissero sospesi nell’abbraccio tra lo Spirito della terra e il suo corpo di carne. Una novella più buona di questa non fu mai più udita ne mai si udirà”.
Se il nostro spirito è in grado di porre la domanda sui destini comuni del regno della natura e del regno dello spirito, sui destini della terra e della moralità umana, deve essere anche capace di rispondere con i fatti a quella domanda. E l’evoluzione resterà aperta, finché ogni minimo frammento di natura non sia diventato moralmente buono nel cuore dell’uomo che lo pensa e lo ama.